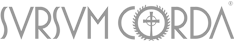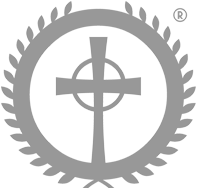Comunicati e Note
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, ancora per due settimane proseguiremo con l’abituale studio della «Vita di Gesù Cristo» redatta dall’Abate Ricciotti, per poi fermarci durante il periodo immediatamente natalizio e riprendere, a Dio piacendo, dopo l’Epifania. Oggi parliamo della predizione del rinnegamento di Pietro.
• § 549. La cena era finita con la recita della seconda parte dell’Hallel (cfr. hymno dicto; Matteo, 26, 30; Marco, 14, 26) e con la consumazione della quarta coppa. Ma la comitiva s’intrattenne ancora molto tempo nella sala della cena, come si usava nella notte di Pasqua (§ 75); durante questo lungo indugio avvenne, secondo san Luca (22, 31 segg.) e san Giovanni (13, 36 segg.) la predizione della dispersione degli Apostoli e del rinnegamento di Pietro, che secondo san Matteo e san Marco sembrerebbe avvenuta dopo l’uscita dalla sala. A un certo punto Gesù, rivoltosi agli Apostoli, mestamente dice loro: «Voi tutti prenderete scandalo in me in questa notte; sta scritto infatti “Percoterò il pastore, e saranno disperse. le pecore del gregge” (cfr. Zacharia, 13, 7). Ma dopo che io sia risorto, vi precederò nella Galilea». Era un’altra ancora di quelle tetre previsioni che davano tanto sui nervi agli Apostoli. La loro insofferenza apparve subito sul viso a parecchi, e specialmente all’impetuoso Pietro. Ma Gesù non cambia tono; anzi, voltandosi proprio verso Pietro, soggiunge: «Simone! Simone! Ecco il Satana cercò di voi (altri), per vagliar(vi) come (si vaglia) il grano. Ma io pregai per te affinché non venga meno la tua fede; e tu, una volta tornato addietro, conferma i tuoi fratelli». Al bravo Pietro queste parole non piacquero affatto: egli voleva un gran bene a Gesù e, qualunque tentativo avesse fatto Satana, non avrebbe mai commesso contro il maestro alcuna vigliaccheria da cui sarebbe tornato addietro. Il dispiacere di Pietro si colorì anche di un certo risentimento, e in un dialoghetto con Gesù di cui gli Evangelisti riportano frasi staccate egli disse fra altro: «Se tutti si scandalizzeranno in te, io non mai mi scandalizzerò! - Signore! Con te sono pronto ad andare in carcere e a morte!». Nessuno, certamente, avrebbe pensato a richiamare in dubbio la sincerità di Pietro quando parlava così; tuttavia Gesù, calmo e paziente, gli dette la seguente risposta, riportata da san Marco (14, 30) che l’avrà udita centinaia di volte da Pietro stesso quando predicava: «In verità ti dico che tu oggi, questa notte, prima che il gallo abbia cantato due volte, mi avrai rinnegato tre volte». Questo era troppo per Pietro! Un fiume di proteste e d’attestazioni eruppe allora dalla sua bocca. San Marco, volendo forse usare un certo riguardo al suo padre spirituale, accenna a questo fiume dicendo che Pietro parla in maniera sovrabbondante e ripeteva che, seppure avesse dovuto morire insieme col maestro, non lo avrebbe rinnegato. Altrettanto, più o meno, dicevano anche gli altri Apostoli. Gesù dal canto suo mostrava di non avere troppa fiducia, non già sulla sincerità, ma sulla sodezza di tutte queste attestazioni, e continuò ad esortarli affinché, come avevano avuto fiducia in lui nel passato, l’avessero anche nella durissima lotta che allora stava per cominciare (Luca, 22, 35-37). A questa esortazione, la focosità bellicosa degli Apostoli divampa anche più. Se è venuto il momento di lottare e combattere, essi sono tutti pronti: o vinceranno a fianco al maestro, o cadranno tutti con le armi in pugno! E passando subito dalle parole ai fatti, rivolgono al loro capitano ciò che sembra quasi un invito a passare in rivista il loro armamento. C’erano in quella sala, forse a caso, due spade. Mostrandole a Gesù, essi gli dicono: «Signore, ecco qui due spade!». E Gesù con infinita pazienza, forse con un mesto sorriso, risponde: «Basta (così)». Quante cose rimanevano velate sotto quel «Basta così!». Fino all’ultimo momento, né gli Apostoli smentivano la loro grossezza di mente nel comprendere, né Gesù abbreviava la sua longanimità di cuore nel tollerare.

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, sono reperibili su Amazon e presso l’autore due libri di cui consigliamo la lettura e la diffusione; 1) «Il Papa eretico: Appunti sulla questione del cosiddetto “Papa eretico”». Dossier giornalistico in cui l’autore prova a fornire risposte ad alcune frequenti domande: 1) Chi ha parlato del cosiddetto «Papa eretico»? 2) Cosa ha scritto a riguardo? 3) È vero, come vogliono alcuni intellettuali moderni, che quasi nessuno ha studiato l’ipotesi? 4) È vero che l’uomo eletto dal Conclave (o designato) può essere veramente Pontefice e, nel contempo, eretico? 5) Che significa «essere Pontefice», che significa «essere eretico» e che significa semplicemente «divulgare eresie»? L’autore intende restituire giustizia e verità ai nostri eruditi, fornire altresì puntuali riferimenti per poterli studiare con zelo cristiano. Finalmente intende esporre con estrema chiarezza le sue conclusioni e rispondere alla fatidica domanda: L’eretico è Papa?. 2) «Il Limbo: Semplice e breve compendio di dottrina sul Limbo». I bambini morti senza Battesimo hanno il peccato originale, e quello solo. Essi muoiono prima dell’uso di ragione senza il Battesimo di acqua, non sono capaci di ricevere quello di desiderio e se non ricevono quello di sangue col Martirio passano all’altra vita col peccato originale, privi della grazia di Dio e del diritto al Paradiso. D’altra parte, non avendo ancora l’uso di ragione, non commisero alcun peccato attuale, né mortale né veniale, per il quale si richiede l’avvertenza della mente ed il consenso della volontà, di cui sono incapaci. Essi, quindi, al momento della morte hanno soltanto il peccato originale. Non meritano il Paradiso, non meritano l’Inferno e né il Purgatorio. Morti senza Battesimo e prima dell’uso di ragione non possono essere né premiati con la visione intuitiva e con la felicità del Paradiso, né puniti con le pene dell’Inferno. Perciò sono destinati al Limbo, dove non hanno né esigenze né gioie soprannaturali, ma godono tutta quella felicità naturale di cui è capace la natura umana. I genitori hanno l’obbligo gravissimo di far amministrare al più presto il Battesimo ai loro neonati, per assicurare loro la felicità soprannaturale del Paradiso, nel caso dovessero morire.
• Veniamo allo studio della Sacra Scrittura con l’aiuto dell’Abate Ricciotti: «Gesù istituisce l’Eucaristia». § 544. A questo punto, il banchetto pasquale doveva esser molto avanzato, e prossimo alla fine: forse la seconda coppa era quasi consumata, e fra poco si doveva mescere la terza coppa (§ 75). A un tratto Gesù compie un’azione insolita, non contemplata dal rito della cena pasquale. Prese egli una focaccia di pane azimo e, dopo aver pronunziata una formula di benedizione, ne staccò dei pezzi che distribuì agli Apostoli dicendo: «Prendete, mangiate; questo è il corpo mio, che per voi (è) dato. Ciò fate nel mio ricordo». Poco dopo, probabilmente quando fu versata alla fine della cena la terza coppa rituale, egli prese un calice pieno di vino temperato e, avendo parimenti reso grazie, ne fece bere a tutti dicendo: «Bevete da esso tutti. Questo calice (è) il nuovo testamento nel sangue mio, che per molti (è) versato. Ciò fate, quante volte (ne) beviate, nel mio ricordo». Quale impressione facesse personalmente sugli Apostoli questa doppia azione di Gesù non ci vien detto dai Sinottici, ma ciò non significa gran che; d’assai maggior importanza è invece l’impressione e l’effetto permanente che ne ricevette tutta la primissima società cristiana, la quale fu l’interprete sotto ogni aspetto più autorevole di quella doppia azione di Gesù e delle parole che l’accompagnarono. E qui, per riscontrare i fatti storici, abbiamo a nostra disposizione due eccellenti specole d’osservazione, poste a una certa distanza l’una dall’altra. Circa venticinque anni dopo l’ultima cena di Gesù, san Paolo scriveva ai cristiani di Corinto quella sua lettera (I Cor., 11, 23-29) ove l’Eucaristia è presentata come rito stabile e abituale, come rito per cui il fedele che vi partecipava mangiava veramente il corpo e beveva veramente il sangue di Gesù, come rito infine ricollegato direttamente con la doppia azione di Gesù nell’ultima cena e con la sua morte redentrice. Nessun dubbio che questo insegnamento di Paolo, da lui già trasmesso negli anni precedenti ai fedeli di Corinto (ivi, 11, 23), fosse stato trasmesso anche alle altre comunità da lui catechizzate e si trovasse in pieno accordo con la catechesi degli altri Apostoli; questa, insomma, era la maniera in cui la catechesi primitiva e la liturgia primitiva interpretavano e rinnovavano la doppia azione compiuta da Gesù nell’ultima cena. Un quarantennio più tardi della lettera di Paolo incontriamo un’altra specola che funziona in maniera differente ma non meno precisa: è il IV Vangelo, il solo Vangelo che non racconti l’istituzione dell’Eucaristia. Già sappiamo che questo silenzio è più eloquente, in qualche modo, di un racconto effettivo (§§ 378-383); ma qui si può aggiungere un’altra considerazione. Anche dato e non concesso che autore del IV Vangelo sia, non l’apostolo Giovanni, ma uno sconosciuto mistico solitario, questo autore molto probabilmente conosceva la lettera di Paolo, indubbiamente conosceva gli scritti dei Sinottici, certissimamente era edotto della liturgia eucaristica diffusa alla fine del secolo I ovunque vi fosse una comunità cristiana; egli dunque, della fede dei suoi tempi, è un testimonio silenzioso ma non meno efficace, in quanto serba silenzio sull’istituzione ma ne mette in sommo rilievo gli effetti spirituali col suo discorso sul pane vivo (§ 387 segg.): del resto oggi ciò è ammesso anche da studiosi radicali (§ 373, nota). In conclusione l’autore del IV Vangelo (san Giovanni) concorda pienamente con la catechesi di Paolo e con quella dei Sinottici, e le conferma accettandole in parte silenziosamente, e in parte mettendole in accurato rilievo.
• § 545. Tornando ora agli Apostoli e all’impressione immediata che ricevettero dalle parole di Gesù, bisogna riconoscere che fu un’impressione meno nuova di quanto sembrerebbe a prima vista; anzi, in qualche modo, essa fu la risoluzione di un vecchio enigma che s’agitava nelle menti di quegli uomini. L’antico discorso sul pane vivo non solo non era stato giammai da essi dimenticato, ma piuttosto di tempo in tempo aveva dovuto riaffacciarsi alle loro menti come un’arcana promessa rimasta tuttora inadempiuta. «In verità, in verità vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell’uomo e beviate il sangue di lui, non avete vita in voi stessi... La carne mia è vero nutrimento, e il sangue mio è vera bevanda: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue in me rimane e io in lui... chi mangia me, egli pure vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo», ecc. Affermazioni di questo genere aveva fatto Gesù a Cafarnao molti mesi prima, ma fino all’ultima cena egli non aveva offerto maniera ai suoi discepoli di eseguire questo comando così essenziale per avere vita in se stessi. E in qual maniera, poi, avrebbe egli reso «molle» un discorso così duro (§ 382)? In qual maniera avrebbe reso umano e spirituale un banchetto che sembrava da antropofagi? La «durezza» delle affermazioni aveva scandalizzato molti discepoli di Gesù, i quali lo avevano abbandonato: i dodici invece gli erano rimasti fedeli, perché «il maestro aveva parole di vita eterna»; tuttavia nei molti mesi trascorsi quelle parole ancora non erano state avverate, e certamente i dodici più d’una volta si saranno domandati dubbiosi se il maestro non si era dimenticato della promessa, ovvero in che maniera l’avrebbe mantenuta. Improvvisamente, quella notte, essi vedono il maestro distribuire pane e vino, dicendo «Questo è il mio corpo»; «Questo è il mio sangue». Con tale doppia azione e doppia affermazione il vecchio enigma era risolto, l’antica promessa era mantenuta, e il vero significato dell’azione e dell’affermazione appariva mirabilmente chiaro alla luce del discorso sul pane vivo: l’apparente pane e l’apparente vino allora distribuiti erano in realtà il corpo e il sangue del maestro. Chi pertanto abbia presente lo stile sentenzioso e riflesso di Giovanni troverà possibilissimo che, quando egli afferma aver Gesù amato i suoi «(sino) in fine», con questa frase alluda appunto all’istituzione dell’Eucaristia da lui non raccontata (§ 541).
• § 546. Un’azione così importante di Gesù, compiuta da lui in circostanze così solenni, e per dippiù divenuta la base della vita religiosa della Chiesa fin dalla prima generazione cristiana, non poteva non attirare la particolarissima attenzione degli studiosi radicali. Gesù ha realmente compiuto la doppia azione e pronunziato la doppia affermazione dell’ultima cena? Ciò che i Sinottici e san Paolo narrano su questo argomento è realmente storico, ovvero ha di storico soltanto un piccolo nucleo, ingrandito più tardi e travisato dall’elaborazione della prima generazione cristiana? Ebbe Gesù intenzione d’istituire un vero rito stabile da rinnovarsi in seguito dai suoi discepoli, ovvero fece una semplice azione simbolica la quale valeva solo in quanto fatta da lui in quelle circostanze, ma senza ch’egli comandasse di rinnovare l’azione in seguito? Queste ed altre domande concomitanti che furono proposte non riguardano soltanto l’Eucaristia in sé ma investono l’intera operosità di Gesù, che sarà valutata differentemente a seconda di come si risponde a queste domande. Se si accetta infatti il racconto dei Sinottici e di san Paolo come sta, bisogna riconoscere che Gesù attribuiva alla sua morte un valore di redenzione («il corpo mio che per voi è dato; ... il sangue mio che per molti è versato»); bisogna anche ammettere che egli intendeva fondare una particolare religione, con un suo ben distinto rito, il quale ricordasse perennemente la morte redentrice del fondatore («ciò fate... nel mio ricordo»). Ora, queste ed altre conseguenze smentivano più o meno ampiamente le interpretazioni che della figura e opera di Gesù davano le teorie contemporanee, da quella della Scuola liberale a quella degli escatologisti: il mellifluo predicatore dell’universale paternità divina immaginato dai liberali (§ 204 segg.) non pensava certamente alla sua morte come a un vero sacrifizio di redenzione per l’umanità; tanto meno il visionario ritrovato dagli escatologisti poteva preoccuparsi di fondare una particolare religione con un ben distinto rito che sopravvivesse alla catastrofe del «secolo» presente (§ 209 segg.). Per salvare dunque le teorie bisognava dimostrare che Gesù non ha affatto istituito l’Eucaristia; e per ottenere ciò bisognava sottoporre a una vigile interpretazione i racconti dei Sinottici e di san Paolo. Ora, noi già sappiamo che le “vigili interpretazioni” degli studiosi radicali si riducono, immancabilmente, a ripudiare come aggiunti e tardivi quei passi che non s’inquadrano in una preconcetta teoria; ma in questo caso, meglio forse che in ogni altra questione dei Vangeli, appare chiaramente la ferrea necessità della logica per cui, quando in siffatti testi si cominci a negare una parte, si finisce inevitabilmente a negare e ripudiare tutto quanto.
• § 547. Si cominciò dunque col negare che Gesù avesse comandato agli Apostoli di rinnovare in seguito il rito, rendendolo un rito perenne; poiché infatti il gruppo di san Matteo e di san Marco non riferisce le parole «ciò fate... nel mio ricordo», se ne concluse che tali parole erano un’aggiunta posteriore introdotta dal gruppo di san Paolo e di san Luca, e quindi da ripudiarsi. Rimaneva però ancora molto, cioè che il corpo di Gesù «per voi è dato», che il calice del suo sangue è «il nuovo testamento» ed è «per molti versato»: rimaneva insomma l’idea della morte redentrice del Cristo. Ma anche questo molto fu man mano ripudiato con lo stesso procedimento: si decretò che erano tutte aggiunte posteriori, dovute all’influenza delle elaborazioni teologiche di san Paolo. È vero che pure nel gruppo di san Matteo e di san Marco (nei due rispettivi Vangeli, ndr.) si trova che il sangue del Cristo è «il sangue del (nuovo) testamento» e che «per molti è versato in remissione di peccati». Ma ciò che dimostrava? Nulla. Anche questo era da ripudiarsi, come un’aggiunta dovuta all’influenza di Paolo. (Per i modernisti ed i novatori, ndr.) rimanevano quindi, come primitive, le sole parole: «Questo è il corpo mio; Questo è il sangue mio», pronunziate alludendo al convito messianico, presentando il pane e il vino come simbolo di quel convito, ma senza relazione alla sua imminente morte. Eppure, anche dopo queste amputazioni, restavano ancora seri dubbi. Erano proprio primitive e genuine ambedue quelle affermazioni risparmiate? Ci si ripensò sopra, e si finì per concludere che non potevano essere risparmiate ambedue. Alla nuova amputazione offrì pretesto il fatto che, tra la congerie di codici antichissimi e tutti sostanzialmente uniformi, ve n’era uno - il disputatissimo «codice di Beza» - suffragato da pochi altri di antiche versioni, nel quale il racconto di san Luca è ridotto a queste parole: «E preso il pane, avendo reso grazie (lo) spezzò e dette loro dicendo: “Questo è il corpo mio”»; tutto il resto è ivi omesso, compresa la distribuzione del vino e le relative parole. Questo - si disse - era il racconto primitivo: la sola presentazione del pane, senza alcuna contrapposizione del pane-corpo al vino-sangue, ossia senza l’idea della morte, e naturalmente senza il comando di rinnovare il rito in seguito. Rimaneva così il pane insieme con la sua presentazione. Eppure anche questo rudere superstite non soddisfece, se non altro perché troppo esiguo ed insignificante. Che cosa, insomma, aveva Gesù inteso fare presentando il pane come suo corpo? Non aveva egli mangiato centinaia di volte il pane insieme con i suoi discepoli? Ovvero quella volta il pasto comune aveva un significato particolare come pasto di haberūth, di «colleganza» (§ 39)? Ma in tal caso il suo significato particolare gli proveniva dalla morte imminente di Gesù, e quindi si ritornava alla già respinta relazione con la morte. No, con tutte le precedenti amputazioni non si era ottenuto nulla di sicuro; per trovare un terreno storico più “sodo” e spazioso bisognava scendere alla liturgia della Chiesa primitiva, e ricercare che cosa intendessero fare quei primi cristiani compiendo il rito dell’Eucaristia e attribuendone l’istituzione a Gesù. (L’Abate Ricciotti sta facendo del sarcasmo sugli “eruditi” studi dei modernisti, ndr.). E, in primo luogo, era un rito di provenienza giudaica o straniera? Si ricercò nel giudaismo tardivo, ma non se ne trasse nulla di soddisfacente. Fu applicato il metodo della Storia comparata delle religioni (§ 214). Si pensò a primitivi riti di totemismo e di teofagia; più accuratamente s’investigarono i riti di Iside ed Osiride, e l’emofagia dei culti di Sabazio e di Dioniso; un’attenzione anche maggiore si portò ai misteri Eleusini e ai banchetti di Mithra. Certamente si trovarono notizie peregrine e si fecero osservazioni importanti su questi riti pagani; ma quando si giunge al vero nodo della questione, ossia alle loro relazioni col rito eucaristico del cristianesimo primitivo, si presero anche lucciole per lanterne e si affermò che una zanzara è uguale in tutto a un’aquila dal momento che ambedue hanno le ali e volano e si nutrono di sangue. Soprattutto, poi, queste “dotte” ricerche parvero come tanti voli fatti in aria, lontano dal terreno della realtà storica: prima di pensare a Iside ed Osiride e ad altre infiltrazioni orientali, bisognava infatti fare i conti con san Paolo e vedere se egli lasciava il tempo materiale al penetrare di tali infiltrazioni nel cristianesimo.
• § 548. San Paolo infatti scrive la sua Lettera ai Corinti nell’anno 56, ma egli stesso dice di avere ammaestrato oralmente i Corinti sul rito eucaristico in precedenza (§ 544), ossia quando aveva fondato quella comunità cristiana. Ciò era avvenuto nell’anno 51. Ma anche quest’anno è troppo tardivo per la nostra questione, perché in quel tempo Paolo possedeva già riguardo all’Eucaristia la sua dottrina ben definita e certamente concorde con la catechesi e con la dottrina delle altre comunità: ossia egli la possedeva già prima del 50, a meno d’un ventennio dall’ultima cena di Gesù. Ma anche da questo ventennio sono da togliersi altri anni. Solo verso il 36 Paolo, fino allora intransigente fariseo, passa nel numero dei perseguitati discepoli del Cristo; ma naturalmente ancora per parecchio tempo egli rimane nella penombra e mena una vita o del tutto solitaria o semipubblica fra l’Arabia, Damasco e Tarso. Soltanto col primo grande viaggio missionario Paolo diventa una figura di primo piano nel cristianesimo primitivo, ma è il viaggio che comincia tra il 44-45 per terminare nel 49; siamo con ciò al periodo, testé accennato, in cui Paolo già possedeva una dottrina ben definita riguardo all’Eucaristia. Ora, troppe e troppo inverosimili cose sarebbero da ammassarsi, secondo l’ipotesi radicale, in questo decennio che va dal 36 al 45 circa, per potersi ammettere quell’ipotesi. In primo luogo che Paolo, indomabile avversario dell’idolatria ieri come Fariseo e oggi come discepolo del Cristo, prenda appunto dall’idolatria quello che sarà il fondamentale rito liturgico del cristianesimo; inoltre che egli abbia, in quei suoi primi anni, tanta autorità da diffonderlo nelle chiese cristiane della più diversa origine; poi, che egli riesca così rapidamente in questa diffusione da ottenere che già prima del 50 il rito fosse comune, fondamentale, unico. No: questa non è storia; sono voli di fantasia, guidata da preconcetti ma non dai documenti. La pagina di san Paolo sull’Eucaristia è tale documento da troncare tutti codesti voli; essa, debitamente illuminata dall’operosità dei primi anni cristiani di Paolo, dimostra che l’Apostolo ha desunto la sua dottrina eucaristica dalla chiesa di Gerusalemme, verso la quale egli ha tenuto sempre fisso lo sguardo e nella quale si è recato anche più volte in persona nel decennio suddetto. E la chiesa di Gerusalemme era quella dov’era avvenuta l’ultima cena di Gesù. La forza di questo elementare ragionamento è stata sentita anche nel campo degli studiosi radicali, almeno dai più logici e franchi tra essi. E allora non è rimasto altro che fare l’ultimo passo nella via della negazione, ricorrendo al solito metodo di dichiarare aggiunta e tardiva anche la pagina di san Paolo. E anche questo passo è stato fatto (dai modernisti, ndr.): il racconto paolino dell’Eucaristia è stato dichiarato falso e interpolato, per la sola ma decisiva ragione che non si accorda con la (loro) teoria preconcetta (§ 219). Qualunque studioso sereno giudicherà sul carattere scientifico di questi procedimenti. Da «Vita di Gesù Cristo», Abate Giuseppe Ricciotti, Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941. Ricciotti giustamente fa polemica contro le esegesi moderniste (principalmente quella di Alfred Loisy). I suoi splendidi lavori sul Testo sacro, di carattere piuttosto conservatore, dimostrano una solida preparazione storica e filologica, nonché una gran fede!

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, approfondiamo la questione di «Giuda il traditore», di cui già si è detto in passato.
• § 541. Che in quella cena pasquale di Gesù sia avvenuto qualcosa di straordinario, Giovanni lo esprime con quella sua maniera singolare fatta di velate allusioni, che però era capita benissimo dagli esperti uditori della sua catechesi: «Sapendo Gesù che venne l’ora di lui affinché passasse da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi, quelli (ch’erano) nel mondo, (sino) in fine li amò» (Giov., 13, 1). Queste parole possono considerarsi come un nuovo piccolo prologo che Giovanni premette al racconto della passione: Gesù, che ha sempre amato i suoi, adesso dimostra il suo amore (sino) in fine, non solo cronologicamente sino alla fine della sua vita, ma molto più intensivamente sino al fine raggiungibile, sino all’estremo limite possibile dell’amore stesso. Accennando all’amore (sino) in fine vuole forse l’Evangelista spirituale alludere all’istituzione dell’Eucaristia che egli solo non narra? È possibilissimo (§ 545). D’altra parte anche l’Evangelista discepolo di San Paolo accenna a questo amore, quando narra che a principio della cena Gesù, vedendosi circondato dai suoi discepoli, esclamò verso di essi: «Di (gran) desiderio desiderai mangiare questa Pasqua con voi prima che io patisca. Vi dico infatti che più non la mangerò fino a che (essa) sia compiuta nel regno d’iddio» (Luca, 22, 15-16). Torna qui l’idea che la passione è per il Messia la condizione necessaria per il suo ingresso alla gloria: questa gloria, poi, sarà il trionfo del regno di Dio simboleggiato in un banchetto eterno. Nell’ultima cena fu certamente seguito il solito rito della cena pasquale - che descrivemmo altrove (§ 75) - con le quattro coppe rituali di vino, con il pane azimo, le erbe agresti e l’agnello arrostito, sebbene non tutte queste cose siano ricordate dagli Evangelisti. Gesù in quella comitiva fungeva da padre di famiglia; perciò benedisse egli la prima coppa, ed aggiunse: «Prendete ciò e dividete (lo) fra voi; vi dico, infatti, non berrò da adesso del prodotto della vite fino a che il regno d’Iddio sia venuto» (ivi, 17-18). In relazione al precedente simbolo del banchetto eterno, il regno di Dio è qui simboleggiato in un simposio eterno. La cena era pertanto cominciata, ma non tutti i convitati erano pienamente soddisfatti: non sarebbero stati uomini della loro nazione e del loro tempo, se parecchi di loro non si fossero mostrati scontenti del posto che occupavano a tavola desiderandone uno più onorifico (§ 457). Quella brava gente aveva tutta una grande stima «di sé, e avvenne anche una gara fra loro, riguardo a chi di essi appaia esser maggiore» (ivi, 24); la disputa non era nuova, ma un vago accenno di Giovanni (13, 2-5) potrebbe far sospettare che questa volta la disputa fosse provocata da pretensioni di Giuda Iscariota: appunto il traditore avrebbe suscitato la gelosia degli altri Apostoli pretendendo uno dei posti più onorifici, e ciò conforme a un fenomeno frequente nei traditori che, spinti dalla dissimulazione, pretendono preferenze e particolari riguardi. A quella umiliante scenata Gesù dovette rispondere a parole come più o meno già aveva risposto alle altre contese di preminenza avvenute nel passato fra gli Apostoli (§ § 408, 496), ma questa volta volle aggiungere anche una risposta con i fatti (Giovanni, 13, 4 segg.). Vedendo che nonostante le sue esortazioni all’umiltà i brontolii ringhiosi di quei materialoni non cessavano, egli si leva dal suo divano, depone le vesti, si cinge al grembo d’un pannolino, e preso un catino con acqua comincia a lavare i piedi ai commensali: i più umili schiavi erano incaricati di questo ufficio, e potevano compierlo agevolmente perché i commensali erano distesi sui divani col busto verso la tavola e i piedi sporgenti dall’altra parte all’infuori (§ 341). Al vedere il maestro abbassatosi a quel servigio, gli Apostoli rimasero interdetti e accettarono passivamente la lavanda come un’umiliazione: neppure Giuda osò protestare. Solo Pietro, che probabilmente fu il primo a cui si rivolse Gesù, protestò dicendo: «Signore, tu mi lavi i piedi?». E Gesù a lui: «Ciò che io faccio, tu adesso non sai; lo saprai in seguito». Ma Pietro non cede: «Non mi laverai i piedi in eterno!». Gesù replica: «Se non t’avrò lavato, non avrai parte con me». A questa risposta l’irruente Pietro salta all’altro eccesso: «Signore, lavami non solo i piedi, ma anche le mani e il capo!». Gesù allora conclude: «Chi si è lavato non ha bisogno di lavarsi (se non i piedi), ma è mondo interamente; e voi siete mondi, ma non tutti». Trasalì Giuda a quest’allusione? Forse no; il traditore dovette contentarsi all’udire che il suo delitto restava ancora occulto ai suoi colleghi. Ma la cosa non fini lì.
• § 542. Terminata la lavanda dei piedi, Gesù indossò nuovamente le sue vesti e riprese posto a tavola sul suo divano. Egli occupava certamente il posto più onorifico, e la contesa testé sorta fra gli Apostoli era stata motivata del desiderio di occupare i divani più vicini a lui. Poiché la tavola era a semicerchio e i divani erano disposti radialmente all’esterno del semicerchio, si può ragionevolmente congetturare che Gesù occupasse il divano centrale al vertice del semicerchio; ma da quanto accennano gli Evangelisti risulta che i divani più vicini a Gesù erano occupati da Pietro, Giovanni e Giuda Iscariota. Immaginandosi pertanto i commensali sdraiati sui divani e appoggiati col gomito sinistro verso la tavola, Gesù ch’era al centro doveva avere alle sue spalle Pietro, che così occupava il secondo posto nel grado onorifico; dall’altro lato, cioè davanti al petto di Gesù, doveva stare sdraiato Giovanni, che così poteva appoggiare il capo sul petto del maestro; Giuda Iscariota sta subito appresso a Giovanni, di modo che Gesù stendendo il braccio poteva senza difficoltà giungere a dargli un boccone di cibo. Schematicamente, dunque, la posizione dei commensali attorno alla tavola doveva presentarsi così: Ripresa la cena, non c’era tuttavia serenità fra i commensali: gli Apostoli erano rimasti turbati dall’affermazione di Gesù che essi non tutti erano mondi, e desideravano qualche schiarimento in proposito. Anche Gesù dal canto suo desiderava tornar sopra quell’argomento, non tanto per la giusta curiosità di coloro ch’erano mondi, quanto per la non richiesta purificazione di colui ch’era l’unico immondo: con quell’infelice bisognava ancora fare un tentativo, offrirgli un ultimo salvataggio. Perciò, quando si riprese a mangiare, Gesù parlando ancora genericamente citò un passo del Salmo (41, 10 ebr.): «Chi mangia il pane mio alzò contro di me il suo calcagno (Giov., 13, 18; cfr. Marco, 14, 18). E, detto ciò, egli fu turbato nello spirito, aggiungendo senza nominare alcuno: In verità, in verità vi dico, che uno di voi mi tradirà». Fu uno sgomento generale. Proprio in quella serata così solenne e così affettuosa, si poteva parlare di tradimento? Proprio fra quei dodici uomini che si erano dati anima e corpo al maestro, si poteva dissimulare un traditore? Tutti allora con veemenza impetuosa, non senza una punta di sincero risentimento, domandarono a gara al maestro: «Sono forse io, Signore?». Gesù confermò nuovamente senza dir nomi, ma facendo risaltare la qualità particolarissima del traditore: «Uno dei dodici! Chi intinge con me nel vassoio!» (Marco, 14, 20). Tutti i commensali infatti, stendendosi dal loro divano, in tingevano il pane e le erbe amare in vassoi comuni che contenevano la salsa pasquale (§ 75), e ciascuno poteva servire a circa tre persone: probabilmente quello in cui intingeva Gesù serviva pure a Giovanni e a Giuda. Ma anche quest’ultima indicazione fu interpretata in senso vago dagli Apostoli, quasicché equivalesse alla precedente espressione «uno dei dodici» e designasse in genere chi intingeva in un vassoio qualsiasi della tavola comune: invece, probabilmente, Gesù aveva alluso al vassoio suo proprio. Ad ogni modo fra i commensali c’era colui che aveva ben capito, e appunto riferendosi a lui Gesù aggiunse parole che vollero essere l’ultimo spasimato grido di esortazione, l’estrema segnalazione dell’abisso: «Poiché il figlio dell’uomo se ne va, conforme è scritto circa lui: guai però a quell’uomo da cui il figlio dell’uomo è tradito! Buona cosa (sarebbe) per lui, se non fosse nato quell’uomo!».
• § 543. A questo punto Giuda non poteva più tacere; il suo silenzio, fra l’ansia trepidante dei molti, l’avrebbe da se stesso denunziato. Calmo, misurato, ma non senza un leggiero tremito nella voce, egli allora domandò come tutti gli altri: «Sono forse io, Rabbi?». Il traditore era sdraiato poco distante dal tradito; le teste dei due, rivolte verso la tavola, erano anche più vicine che non il resto dei loro corpi. Alla domanda di Giuda, che dovette passare inosservata ai più dei commensali, Gesù fece il supremo tentativo per la salvezza di lui; colse forse un momento in cui Giovanni, commensale intermedio, era sollevato col busto e badava altrove, e allora rispose sommessamente a Giuda: «Tu (l’)hai detto!». Era un modo ebraico per dare una risposta affermativa. Oramai non c’era più nulla da fare; il traditore sapeva di essere conosciuto come tale. Scegliesse lui: o consumare il tradimento svelato, o implorare il perdono dal sempre venerato maestro (§ 533). La sommessa risposta data da Gesù a Giuda era sfuggita agli altri commensali, salvo forse a Giovanni. Perciò il desiderio di sapere qualcosa di preciso sul tradimento e sul traditore era vivissimo in tutti, e specialmente nel generoso Pietro. Costui non osò interrogare Gesù, per timore forse di ricevere una risposta severa come altre volte; tuttavia per giungere al suo intento egli trovò sagacemente la via buona, rivolgendosi a Giovanni. Il discepolo prediletto occupava il divano immediatamente a destra di Gesù cosicché, stando ambedue sdraiati ed appoggiati sul gomito sinistro, Gesù rivolgeva il petto verso Giovanni e di costui si poteva dire che «era adagiato... nel seno di Gesù» (in Giov., 13, 23); Pietro invece stava sul divano a sinistra di Gesù, e Gesù gli volgeva le spalle né lo vedeva direttamente. Però Pietro, approfittando della sua situazione, fece un cenno a Giovanni incitandolo a domandare a Gesù chi fosse il traditore di cui parlava; la manovra del resto era semplicissima, perché Pietro si era alzato sul busto, e attirata così l’attenzione di Giovanni gli avrà espresso il proprio desiderio a cenni, fatti più in alto della persona di Gesù ch’era ripiegato sul gomito sinistro. L’Evangelista giovanetto comprese subito il desiderio di Pietro, e a sua volta fece una piccola manovra suggeritagli dal suo confidente cuore d’amico prediletto; giratosi egli per metà sul suo corpo, si puntò non più sul gomito sinistro ma sul destro, e così ritrovandosi anche più vicino al divano di Gesù appoggiò confidenzialmente la sua testa sul petto del maestro e stette a guardarlo negli occhi dal sotto in su, come un bambino reclinato sul seno del babbo e che aspetti una grazia. Quindi, sommessamente gli domandò: «Signore, chi e?». La domanda del piccolo amico prediletto fu esaudita, ma per il disgraziato amico che franava verso l’abisso si ebbe ancora un ultimo riguardo. Nei pasti comuni degli Orientali antichi - e anche dei moderni - era un gesto di cortesia offrire a un commensale un boccone bell’e preparato, cioè un frammento di pane che, chi usava la cortesia, staccava dalla focaccia comune, arrotolava, intingeva nel vassoio ove tutti intingevano, e così porgeva al convitato avvicinandoglielo alla bocca. Alla richiesta dunque di Giovanni, Gesù rispose: «È quello a cui io intingerò il boccone e glie(lo) darò». E staccato un pezzo di pane, lo intinse e dette a Giuda. Il traditore ancora non era stato svelato, se non segretamente al fido Giovanni, e a quella cortesia di Gesù egli poteva ancora rinsavire; ma, impassibile, Giuda trangugiò il boccone senza dir nulla, mostrando con ciò d’aver fatto la sua scelta definitiva. «E dopo il boccone - commenta qui il testimonio oculare e consapevole di quella scena - allora entrò in lui il Satana». Tuttavia Giuda stesso non resisté più oltre; si alzò dal suo divano per uscire. «Gli dice pertanto Gesù: “Ciò che fai, fa’ presto”. Ma nessuno dei commensali capì ciò, a che (scopo) glie(lo) disse. Alcuni infatti credevano che, siccome Giuda teneva la cassetta (§ 502), Gesù gli dicesse: “Compra le cose di cui abbiamo bisogno per la festa”, ovvero, che desse qualcosa ai poveri. Preso pertanto il boccone, colui uscì subito. Era notte». E il traditore, uscito fuori, s’immerse nella sua doppia notte.

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, in data 22 novembre 2019 abbiamo donato ai cristiani poveri della Caritas di Potenza i seguenti prodotti: - Numero 40 giocattoli / peluche per bambini; - Numero 2 paia di scarpe da donna; - Un assortimento di foulard e calze da donna. Veniamo alla Sacra Scrittura. L’Abate Ricciotti in questa lezione ci parla della questione cronologica dell’ultima cena.
• § 536. Quanto al giorno della settimana non sorge alcun dubbio, perché tanto i Sinottici quanto Giovanni mettono l’ultima cena al giovedì e la morte al venerdì seguente. La divergenza sta nella collocazione di questi due giorni nel mese Nisan, perché dai Sinottici risulterebbe che il giovedì dell’ultima cena era il 14 Nisan e perciò il venerdì della morte era il 15, mentre da Giovanni risulterebbe che il giovedì era il 13 Nisan e il venerdì il 14. I Sinottici infatti mettono l’ultima cena nel giorno quando immolavano la Pasqua (Marco, 14, 12; cfr. Luca, 22, 7), ossia in cui si faceva l’immolazione dell’agnello pasquale che era prescritta per il pomeriggio del 14 Nisan (§74) perciò l’ultima cena sarebbe stata la cena dell’agnello pasquale celebrata da Gesù al giorno prescritto; essendo poi egli morto il giorno seguente, questo giorno sarebbe stato il 15 Nisan in cui cadeva la Pasqua ebraica. Giovanni invece narra che Gesù morì nella parasceve della Pasqua (Giov., 19, 14), ossia nel giorno precedente alla Pasqua e prima che in quel giorno i Giudei avessero celebrato il rito dell’agnello e mangiato la Pasqua: «Essi infatti non entrarono nel pretorio (di Pilato) per non contaminarsi ma per mangiare la Pasqua» (Giov., 18, 28), riuscendo in quello stesso giorno a far condannare Gesù e ad ucciderlo; in tal caso Gesù morì il 14 Nisan, e l’ultima cena da lui celebrata la sera precedente non era legalmente la cena dell’agnello pasquale. (...)
• § 537. Senonché i Sinottici stessi, con talune loro fuggevoli allusioni, inducono a fare ulteriori ed importanti considerazioni. Stando alla loro cronologia, Gesù fu arrestato nella notte fra il 14 e il 15 Nisan, e le varie peripezie del suo processo terminate con la condanna e l’esecuzione di questa cominciarono già alle prime ore del 15 Nisan per prolungarsi fino al pomeriggio di quel giorno. Ora, tutto ciò s’imbatté in una difficoltà gravissima ed evidentissima, cioè nel carattere supremamente festivo che aveva quella notte e quel giorno: in quella notte si mangiava l’agnello pasquale col solenne cerimoniale già visto (§ 75) e da turbe innumerevoli affluite a Gerusalemme da ogni paese; e in quel giorno poi, che era la Pasqua (15 Nisan), era rigorosamente prescritta l’astensione da ogni lavoro (Esodo, 12, 16; Levitico, 23, 7), e valevano per esso le norme del riposo del sabbato anche se in realtà quel giorno non fosse un sabbato. È pertanto storicamente inconcepibile che gli avversari di Gesù, per quanto colmi di odio contro di lui, trascurassero la cena pasquale di quella notte e violassero il riposo festivo di quel giorno per compiere tutto ciò che era necessario al processo, alla condanna e alla sua esecuzione. E infatti la sconfinata meticolosità che vedemmo più volte applicata al riposo sabbatico non avrebbe permesso varie azioni che troviamo compiute in queste poche ore: ad esempio che coloro i quali in quella notte arrestarono Gesù trasportassero armi ed altri oggetti (Matteo, 26, 47), e che accendessero il fuoco proprio in casa del sommo sacerdote (Luca, 22, 55); ovvero che durante quel santissimo giorno di Pasqua vi fosse un uomo come Simone il Cireneo che veniva dal campo, dove era stato certamente a lavorare (Marco, 15, 21); oppure che si comprasse una sindone, come fece Giuseppe di Arimatea (Marco, 15, 46); o anche che si preparassero aromi ed unguenti, come fecero le pie donne (Luca, 23, 56). Tutte queste azioni erano altrettante violazioni del riposo festivo; se perciò si considerano sommate tutte insieme, portano alla conclusione che quella notte non era sacra e quel giorno non era santissimo né di riposo per molti Giudei - se non per tutti - e quindi che costoro non avevano mangiato l’agnello pasquale la sera del giovedì come Gesù, né celebravano la Pasqua il venerdì. Questa conclusione è tanto più importante, in quanto estratta da informazioni offerte dai soli Sinottici. Si aggiunga a conferma un’altra osservazione. Gesù muore nel pomeriggio del venerdì, che secondo i Sinottici sembra essere il giorno di Pasqua (15 Nisan). Appena egli è morto, Giuseppe di Arimatea si affretta a seppellirlo in quello stesso pomeriggio, perché col tramonto sarebbe cominciato il riposo del successivo sabbato (Marco, 15, 42 segg); così pure dal canto loro le pie donne prepararono in quel pomeriggio gli aromi e gli unguenti per la venerata salma, ma giunta la sera passarono inoperose il sabbato conforme il comandamento (Luca, 23, 56). Tutto ciò sarebbe regolarissimo riferendosi al riposo del vero sabbato settimanale: ma se in quel venerdì ormai tramontato, in cui era morto Gesù, era anche caduta la Pasqua, questa solennità portava con sé egualmente il riposo festivo; e allora come mai e perché mai affrettarsi tanto nel pomeriggio di quel venerdì, se già in esso vigeva un riposo anche più solenne in virtù della solennità pasquale? Quindi anche da questo lato, ed egualmente per notizie offerte dai Sinottici, ritornerebbe la conclusione che pure Giuseppe di Arimatea e le pie donne non celebravano la Pasqua in quel venerdì, il quale perciò non era per essi il 15 Nisan. In realtà la divergenza fra i Sinottici e Giovanni, stando ai semplici dati ricavati da essi, è inconciliabile; se si seguono i Sinottici Gesù sembra morto il 15 Nisan, se si segue Giovanni è morto il 14 Nisan.
• § 538. I tentativi per comporre la divergenza sono stati molti, sebbene parecchi di essi non avessero neppure l’ombra di fondamento storico. In tale condizione si ritrova, ad esempio, l’ipotesi secondo cui in quell’anno i Giudei avrebbero ritardato di un giorno la Pasqua trasportandola al 16 Nisan, per aver agio di processare ed uccidere Gesù, mossi unicamente dall’odio contro di lui, mentre Gesù avrebbe mangiato l’agnello pasquale al tempo prescritto; questa ipotesi, proposta già in antico da Eusebio di Cesarea e recentemente da alcuni moderni, ha il torto di essere antistorica in quanto dimentica il tenacissimo attaccamento che gli avversari di Gesù avevano alle loro tradizioni, e che non avrebbe ceduto il passo neppure al loro odio contro Gesù e ciò, senza rilevare l’assurdità che siffatto spostamento della Pasqua in odio a Gesù sarebbe stato decretato in poche ore, imposto a folle enormi che non conoscevano neppure di nome Gesù, e perfino a persone a lui benevole quali Giuseppe di Arimatea e le pie donne. Altra soluzione che non risolve nulla è quella secondo cui Giovanni, allorché dice che i Giudei «non entrarono nel pretorio per non contaminarsi ma per mangiare la Pasqua», alluderebbe alla consumazione delle altre offerte del ciclo pasquale, ma non a quella dell’agnello che i Giudei avrebbero già mangiato nella stessa sera che Gesù. Senonché, anche astraendo dal fatto che rimarrebbe egualmente la difficoltà del riposo violato, questa soluzione è dimostrata falsa dall’uso rabbinico dell’espressione «mangiare la Pasqua», la quale si riferisce costantemente all’agnello pasquale. Fra quegli studiosi moderni che vogliono trovare nel IV Vangelo tutte narrazioni allegoriche ha incontrato molta fortuna la soluzione che ritiene come storica soltanto la cronologia dei Sinottici e considera invece la cronologia del IV Vangelo come risultato di una accomodazione dogmatico-allegorica; Gesù sarebbe morto in realtà il 15 Nisan, giorno della Pasqua ebraica, giorno dell’immolazione dell’agnello pasquale, soltanto per significare che egli è il simbolico agnello pasquale del Nuovo Testamento che ha definitivamente sostituito l’antica vittima della Pasqua ebraica, conforme al principio dogmatico di San Paolo: «(Quale) nostra Pasqua fu immolato Cristo» (I Cor., 5, 7). Senonché, chi non si lasci abbagliare dalle apparenze, questa soluzione apparirà non meno antistorica di altre. Essa infatti passa sopra, con fallace indifferenza, agli importantissimi accenni che già rilevammo dagli stessi Sinottici, i quali su questo argomento sono considerati storici dagli stessi seguaci di tale soluzione. Se Gesù morì il 15 Nisan e se quel giorno era Pasqua, perché mai molti Giudei non osservavano in quel giorno il riposo festivo come incidentalmente ma sicuramente abbiamo appreso dai Sinottici? Sarebbero forse allegorici in altra maniera anche i Sinottici? O non piuttosto la presunta cronologia allegorica del IV Vangelo è storica non meno di quella dei Sinottici? Quanto all’unica ragione positiva addotta, cioè la coincidenza della immolazione dell’agnello pasquale con la morte di Gesù, è ragione più speciosa che soda; anzi, esaminata più da vicino, sembrerebbe piuttosto una difficoltà in contrario che una ragione in favore. Se Gesù è morto secondo i Sinottici il 15 Nisan ed ha celebrato la cena pasquale la sera del 14, Giovanni aveva ogni motivo allegorico per conservare questa cronologia e non già per mutarla; infatti, secondo essa, Gesù avrebbe istituito l’Eucaristia proprio mentre i Giudei celebravano la cena pasquale, ed è appunto l’Eucaristia il rito unico e perenne che nella Chiesa cristiana ha sostituito i vari riti sacrificali del giudaismo; perciò Giovanni, che giustamente è riconosciuto anche dagli avversari come l’Evangelista del Cristo «pane di vita» (§ 373, nota), poteva attenersi tranquillamente alla cronologia dei Sinottici ritrovandovi pienamente appagata la sua inclinazione dogmatico-allegorica. E invece, secondo il suo solito, Giovanni ha ritoccato in parte quella cronologia, mettendo in miglior luce quanto era stato accennato vagamente dai Sinottici stessi. In tal caso non parlerebbe in lui il testimonio oculare e prediletto, piuttosto che il presunto allegorizzante?
• § 539. In questa vecchia e intricata questione i recenti e proficui studi degli antichi documenti rabbinici hanno aperto una nuova via, che è forse la buona. Già avemmo occasione di rilevare quanto fossero empirici ed incerti i mezzi con cui ai tempi di Gesù si fissava il calendario giudaico, e come questo calendario fosse di una elasticità appena concepibile per noi moderni (§ 180); ebbene, appunto da questa elasticità potrebbe dipendere la divergenza fra i Sinottici e Giovanni, consistendo essa nel collocare il venerdì della morte di Gesù o al 14 o al 15 Nisan. Se quel venerdì fu insieme il 14 e il 15 Nisan - ossia se alcuni Giudei lo computavano come il 14 e altri come il 15 - sarebbe conciliata la divergenza, perché i Sinottici si riferirebbero ai Giudei che consideravano quel venerdì come 15 Nisan, mentre Giovanni si riferirebbe agli altri che lo consideravano come il 14 Nisan. Troviamo infatti che, ai tempi di Gesù, si agitava una seria controversia fra Sadducei e Farisei a proposito della data della Pentecoste, e per conseguenza anche della Pasqua essendo le due feste ricollegate fra loro. I partigiani della famiglia di Boeto (§ 33), influentissima nel ceto sacerdotale e sadduceo, sostenevano che la Pentecoste doveva celebrarsi sempre di domenica; ma poiché i 50 giorni d’interstizio fra la Pasqua e la Pentecoste (§ 76) si cominciavano a contare da quel giorno dell’ottava Pasquale nel quale si offriva nel Tempio il primo manipolo di spighe, perciò essi sostenevano che l’offerta del manipolo doveva farsi sempre nella domenica di detta ottava. I Farisei al contrario sostenevano che la Pentecoste poteva celebrarsi in qualunque giorno settimanale; quindi l’offerta del manipolo doveva farsi sempre al giorno immediatamente successivo alla Pasqua, cioè al 16 Nisan, qualunque giorno settimanale esso fosse. Stante questa divergenza i Boetani e in genere i Sadducei usavano spostare il calendario, specialmente nei casi in cui la Pasqua (15 Nisan) fosse caduta di venerdì ovvero di domenica. Nel caso di Pasqua al venerdì, essi posticipavano il calendario d’un giorno e facevano cadere in quel venerdì l’immolazione dell’agnello e la cena pasquale (14 Nisan), nel sabbato la Pasqua (15 Nisan), e nella domenica l’offerta del manipolo (16 Nisan). Nel caso di Pasqua alla domenica anticipavano d’un giorno e facevano cadere in quella domenica l’offerta del manipolo (16 Nisan), nel precedente sabbato la Pasqua (15 Nisan), e nel precedente venerdì l’immolazione dell’agnello (14 Nisan). Questo spostamento di calendario si otteneva facilmente, anche mediante piccoli sotterfugi, approfittando dell’empirismo con cui si regolava la fissazione del calendario e di cui già trattammo (§ 180). A questa accomodazione dei Sadducei non acconsentivano però i Farisei; i quali, non preoccupandosi del giorno settimanale in cui cadeva la Pentecoste, celebravano il rito dell’agnello, quello della Pasqua e quello del manipolo, nei giorni in cui effettivamente cadevano. Si produceva quindi una scissione fra coloro che celebravano questi riti. La gran massa del popolo, dominata dai Farisei, li seguiva anche nella fissazione cronologica di questi riti. Al contrario le classi aristocratiche, più legate al ceto sacerdotale, seguivano la fissazione dei Boetani e dei Sadducei. Ogni gruppo seguiva la propria cronologia, non curandosi del gruppo opposto; tuttavia non dovevano mancare molti individui i quali o per ragioni di comodità seguivano la cronologia del gruppo non loro, ovvero non appartenendo a rigore a nessun gruppo sceglievano fra le due alternative quella che meglio piaceva.
• § 540. Ora, applicando questi dati al caso di Gesù, si trova una corrispondenza sorprendente. L’anno in cui Gesù mori, la Pasqua cadeva regolarmente al venerdì. Perciò i Sadducei, conforme alla loro norma, posticiparono il calendario d’un giorno per ottenere che l’offerta del manipolo cadesse alla domenica. I Farisei invece si attennero al calendario regolare, respingendo la posticipazione dei Sadducei e celebrando l’offerta del manipolo al sabbato. Il popolo si divise fra le due correnti. [Il Ricciotti a questo punto pubblica una] tabella [che] mostrerà nelle prime due colonne la differenza di datazione della festività pasquale tra i Sadducei e i Farisei, nelle ultime due colonne le rispettive posizioni degli Evangelisti (cfr. tabella al § 536): Si noti come Giovanni concordi col calendario mensile dei Sadducei, e invece i Sinottici concordino con quello dei Farisei. Infatti l’ultima cena di Gesù fu certamente la cena legale dell’agnello, e fu tenuta al giovedi nello stesso tempo che la tenevano i Farisei e in maggioranza quei del popolo; i quali consideravano quel giorno come il 14 Nisan, e il seguente venerdì come il 15 ossia la Pasqua. Ma la preponderanza del Sinedrio, che condannò Gesù, era composta di Sadducei (§ 58); i quali perciò consideravano quel giovedì come il 13 Nisan, e di conseguenza ritardavano la cena dell’agnello al venerdì seguente e la Pasqua al sabbato seguente. Così si comprende anche perché nel venerdì della morte di Gesù non osservassero il riposo festivo, sebbene quel giorno cadesse la Pasqua; era Pasqua per i Farisei, ma non per molti altri che per una ragione o l’altra seguivano il calendario dei Sadducei. In conclusione, i Sinottici si riferiscono al calendario mensile seguito da Gesù in accordo con i Farisei, pur accennando chiaramente al disaccordo di altri; Giovanni invece si riferisce al calendario seguito dai sinedristi Sadducei; condannatori ufficiali di Gesù, pur supponendo già noto che il calendario seguito da Gesù era differente. È assolutamente sicura questa spiegazione della vecchia questione? No, giacché rimangono ancora taluni punti oscuri, che qui sarebbe eccessivo elencare. Tuttavia a noi sembra la più fondata storicamente, soprattutto perché tiene conto della elasticità del calendario contemporaneo; la quale elasticità è una realtà storica di primaria importanza perché essa, come entra per qualche parte nelle famose controversie sorte nel cristianesimo primitivo a proposito della celebrazione della Pasqua cristiana, così ancora oggi spiega le divergenze cronologiche che si riscontrano a proposito di costumanze islamiche fra Arabi, anche di regioni confinanti, formandosi il loro calendario sull’osservazione diretta della luna.

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, sul nostro sito abbiamo pubblicato il prezioso libro «Il Santuario di Loreto. Notizie critico-storiche». Per leggerne il contenuto e per richiedere una copia fotostatica rilegata visitare il link: https://bit.ly/2QoA8Qd. Con il dotto Abate Giuseppe Ricciotti oggi studieremo: «I preparativi dell’ultima cena».
• § 535. Spuntò il giovedì, che era il «primo giorno degli Azimi quando immolavano la Pasqua» (Marco, 14,12); perciò in quel giorno si dovevano provvedere le cose necessarie alla celebrazione del solenne rito anche da parte della comitiva di Gesù (§ 495), giacché per questo rito Gesù avrebbe dovuto rimanere quella notte a Gerusalemme e rinunziare a ritirarsi a Bethania sul monte degli Olivi come le notti precedenti. «Gli dissero quindi i discepoli: Dove vuoi che andiamo a preparare affinché (tu) mangi la Pasqua?». Gesù allora inviò Pietro e Giovanni (Luca, 22,8) dicendo loro: «Andate nella città e vi si farà incontro un uomo che porta una brocca d’acqua; seguitelo, e dove egli sia entrato direte al padron di casa: “Il maestro dice: Do v’è la mia stanza ove (io) mangi la Pasqua insieme con i miei discepoli?”. Ed egli vi mostrerà una sala superiore grande, provvista di tappeti, pronta; e ivi preparate per noi» (Marco, 14, 13-15). Il segno dato ai due Apostoli era abbastanza singolare, perché l’ufficio di attingere e trasportare l’acqua era riservato ordinariamente alle donne. I due s’attennero al segno: entrando in città, certamente per la porta situata sopra la piscina del Siloe (§ 428) e di fronte al monte degli Olivi, incontrarono effettivamente l’uomo dalla brocca; avendo poi essi seguito costui alla casa ov’era diretto, il padrone mise a loro disposizione la sala di cui Gesù aveva parlato. Non c’è da dubitare che quel padrone fosse persona affezionata a Gesù; probabilmente l’aveva ricevuto altre volte a casa sua. Chi sarà stato questo ignoto discepolo? Più che al cauto Nicodemo (§§ 288, 420) o a Giuseppe di Arimatea (§ 615), il pensiero corre al padre o ad altro parente di San Marco, la cui casa dopo la morte di Gesù diventò luogo abituale d’adunanza per i cristiani di Gerusalemme (§ 127); se poi si potesse provare che quel misterioso giovanetto il quale sfuggì nudo di mano alle guardie del Gethsemani era appunto Marco (§ 561), si avrebbe conferma che il padrone della casa era suo parente, tanto più che questo racconto della preparazione della Pasqua è più minuto e circostanziato nel Vangelo di San Marco che in quello di San Matteo. Se il nome di questo discepolo fu tenuto occulto dagli Evangelisti è ben possibile che ciò avvenisse per una ragione prudenziale, analoga a quella per cui i Sinottici omisero l’intero racconto della resurrezione di Lazaro (§ 493). Così pure, per una elementare prudenza, Gesù inviò a preparare la cena Pietro e Giovanni, ma non Giuda, l’amministratore comune a cui sarebbe spettato quell’ufficio: il traditore era occupato nel frattempo a ordire il suo tradimento, e questa sua tenebrosa cura non doveva essere ancor più facilitata dalla prematura indicazione del luogo ove doveva tenersi il supremo convegno. Del resto l’opinione secondo cui l’ultima cena ebbe luogo nella casa di San Marco non è nuova, ed ha pure in suo favore una rispettabile tradizione. Verso il 530 l’arcidiacono Teodosio descrivendo la sua visita a Gerusalemme, quando parla della chiesa della Sancta Sion ritenuta universalmente come il luogo dell’ultima cena, afferma fiduciosamente: «Ipsa fuit domus sancti Marci evangelistae» (De situ Terrae Sanctae, p. 141). E questa affermazione doveva fondarsi su un’antica tradizione; infatti nello stesso secolo VI, il monaco cipriota Alessandro comunica che una tradizione già antica ai suoi tempi affermava che la casa in cui ebbe luogo l’ultima cena fu appunto quella di Maria madre di Marco, ove il maestro era solito albergare ogni volta che veniva a Gerusalemme, e inoltre che l’uomo della brocca sarebbe stato appunto Marco. È questo il luogo ove la tradizione, già dal secolo IV, ha collocato l’odierno Cenacolo, all’estremità sud-occidentale della Città Alta. Compiuti durante la giornata i preparativi, in quella stessa sera si tenne la cena. Ma qui s’incontra una famosa questione cronologica che riguarda sia il giorno dell’ultima cena, sia quello successivo nel quale avvenne la morte di Gesù; è la questione di sapere quali giorni, non della settimana, ma del mese fossero questi due giorni.

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, il venerando Abate Giuseppe Ricciotti ci accompagna finalmente alla settimana di Passione.
• § 532. Giunse pertanto il penultimo giorno avanti la Pasqua, ossia il mercoledì. Il tempo, per i sommi sacerdoti e i Farisei, stringeva e bisognava decidersi ad agire. Nonostante le ripetute deliberazioni prese nei giorni precedenti, ancora non si era fatto nulla, perché Gesù era protetto dal favore popolare e quindi si permetteva di girare impunemente in Gerusalemme e perfino di predicare nel Tempio. Ma non c’era dunque modo di farlo scomparire occultamente, senza che il popolo se ne avvedesse? Certo non bisognava perdere altro tempo, e la questione doveva essere risolta in maniera definitiva prima della Pasqua, per evitare conseguenze che potevano esser gravissime. Le feste in genere, e soprattutto la Pasqua, a causa delle enormi affluenze di folle eccitate, erano considerate dal procuratore romano come periodi di convulsione sismica, ed allora più che mai egli sbarrava tanto d’occhi e raddoppiava la vigilanza per timore che un nonnulla facesse saltare tutto in aria: perciò in tali occasioni - come riferisce occasionalmente Flavio Giuseppe (Guerra giud., II, 224) - la coorte romana di presidio a Gerusalemme si schierava lungo il portico del Tempio, «giacché nelle feste essi fanno sempre la guardia armati affinché la folla adunata non faccia sedizioni». Che cosa dunque non poteva accadere con quel Rabbi galileo in giro per la città e nel Tempio, attorniato da gruppi d’entusiasti che lo credevano Messia? Al primo subbuglio che fosse accaduto, il cavaliere Ponzio Pilato avrebbe scatenato i suoi soldati sulle folle dei pellegrini cominciando davvero a distruggere il luogo santo e la nazione, come si era temuto (§ 494). No, no, assolutamente bisognava scongiurare questo pericolo e far si che per la Pasqua tutto fosse a posto. Ma come? In quel mercoledì si tenne un nuovo consiglio per discutere tale questione. «Allora si radunarono i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo nel palazzo del sommo sacerdote chiamato Caifa, e deliberarono di catturare Gesù con inganno e d’uccider(lo). Tuttavia dicevano: “Non nella festa, affinché non avvenga tumulto nel popolo”» (Matteo, 26, 3-5). Era dunque pacifico per tutti i partecipi dell’adunanza che Gesù dovesse esser soppresso; tuttavia alcuni più cauti facevano notare il pericolo che l’arresto fosse eseguito durante la festa pasquale quando molti pellegrini, o Galilei o favorevoli a Gesù, potevano insorgere per proteggerlo; d’altra parte neppure sarebbe stato opportuno rimandare l’arresto a dopo la festa, perché nel frattempo Gesù poteva allontanarsi con i pellegrini che tornavano alle loro case e così sfuggire alla cattura, come aveva già fatto dopo la resurrezione di Lazaro: perciò bisognava agire subito, prima della Pasqua e in segreto. A questa sollecitudine e segretezza mirava l’osservazione dei cauti consiglieri. Ma appunto qui stava la difficoltà. Alla Pasqua mancavano solo due giorni, e Gesù passava tutta la sua giornata in mezzo al popolo; com’era possibile agire in sì poco tempo e in maniera che l’arresto si risapesse solo a cose fatte? L’aiuto venne donde meno si aspettava. «Allora uno dei dodici, quello chiamato Giuda Iscariota, andato dai sommi sacerdoti disse: “Che cosa mi volete dare, ed io lo consegnerò a voi?”. E quelli stabilirono trenta (monete) argentee. E da allora (Giuda) cercava un’opportunità per consegnarlo». Questa è l’informazione di San Matteo (26, l4-l6), con cui concordano gli altri due Sinottici, i quali non precisano la somma pattuita ma aggiungono la ben comprensibile notizia che i sommi sacerdoti si rallegrarono della proposta di Giuda. E infatti adesso, con tale cooperatore, arrestare sollecitamente e segretamente Gesù diventava impresa facile.
• § 533. Ma quale ragione spinse Giuda al tradimento? La primitiva catechesi non ci ha trasmesso altra ragione che l’amore al lucro. Quando gli Evangelisti presentavano Giuda come ladro e amministratore fraudolento della cassetta comune (§ 502) preparavano in realtà la scena di Giuda che si reca dai sommi sacerdoti per chiedere: «Che cosa mi volete dare...?». Ma, anche fuori dei Vangeli, quando Pietro parla del traditore ormai suicida, non accenna ad altro profitto del tradimento se non all’acquisto d’un campo «con la mercede dell’iniquità» (Atti, 1, 16-19). La ragione del lucro è dunque sicura; tuttavia insieme con essa non è escluso che ve ne siano state altre di cui la primitiva catechesi non si occupò, e qui il campo è aperto a ragionevoli congetture. Anche astraendo dai voli fantastici fatti su questo campo sommamente tragico da drammaturghi o da storici d’ispirazione romanzesca, resta sempre l’inaspettato contegno tenuto da Giuda soltanto due giorni dopo: visto che Gesù è stato condannato, il traditore improvvisamente si pente di aver venduto il sangue di quel giusto, e riportatone il prezzo ai sommi sacerdoti va ad impiccarsi (§ 574). Ebbene, questo non è il contegno di un semplice avaro: un avaro tipico, un uomo che non avesse avuto altro amore che per il denaro, sarebbe rimasto soddisfatto del lucro ottenuto, qualunque fosse stata la sorte successiva di Gesù, e non avrebbe pensato né a restituire il denaro né ad impiccarsi. Avaro e cupido Giuda fu certamente, ma oltre a ciò era qualche cosa d’altro. Esistono in lui almeno due amori: uno è quello dell’oro, che lo spinge a tradire Gesù; ma a fianco a questo esiste un altro amore che talvolta può anche essere più forte, perché a tradimento compiuto prevale sullo stesso amore dell’oro e spinge il traditore a restituire il lucro, a rinnegare tutto il suo tradimento, a compiangerne la vittima e infine ad uccidersi per disperazione. Qual era l’oggetto di questo amore contrastante con quello dell’oro? Per quanto ci si ripensi, non si trova altro oggetto possibile se non Gesù. Se Giuda non avesse sentito per Gesù un amore tanto grande che talvolta prevaleva su quello per l’oro, non avrebbe né restituito il denaro né rinnegato il suo tradimento. Ma se egli amava Gesù, perché lo tradì? Certamente perché il suo amore era grande ma non incontrastato, non era l’amore generoso, fiducioso, luminoso di un Pietro e di un Giovanni, e conteneva pur nella sua fiamma alcunché di fumoso e di tenebroso: in che consistesse però questo elemento oscuro non sappiamo, e per noi rimarrà il mistero dell’iniquità somma. Riseppe forse Giuda di essere stato denunziato a Gesù come frodatore della cassetta comune, e non tollerò di essere decaduto dalla stima di lui? Ma anche Pietro come rinnegatore di Gesù giudicherà di esser decaduto dalla stima di lui, eppure non dispererà. Forse, più accortamente degli altri Apostoli, Giuda comprese dalle rettifiche messianiche di Gesù che il suo regno non avrebbe apportato né gloria né potenza mondane ai futuri cortigiani, e in quel previsto fallimento provvide da avaro qual era ai propri interessi? Ipotesi possibilissima; la quale tuttavia non spiega da sola perché mai Giuda, dopo essersi staccato da Gesù mediante il tradimento, si senta ancora legato a lui da pentirsi ed uccidersi. Forse, accoppiando l’amore del lucro con l’ansia di veder presto Gesù a capo del regno messianico politico, Giuda lo tradì con la sicurezza di vederlo compiere portenti su portenti di fronte ai suoi avversari, e così di costringerlo a inaugurare subito quel regno che si faceva troppo aspettare? In tal caso però il traditore non si sarebbe dovuto uccidere prima della morte di Gesù ma tutt’al più dopo, perché egli non sapeva quando il Messia sarebbe ricorso ai suoi massimi portenti, tanto più che proprio all’inizio della sua operosità di traditore Giuda aveva assistito nel Gethsemani al portento delle guardie atterrate (§ 559). E le ipotesi si potrebbero facilmente moltiplicare, senza però che ne rimanesse schiarito con sicurezza il mistero dell’iniquità somma.
• § 534. Inoltre, tale iniquità non consisté soltanto nel vendere Gesù, ma più e soprattutto nel disperare del suo perdono. Giuda aveva visto Gesù perdonare a usurai e prostitute, aveva udito dalla sua bocca le parabole della misericordia compresa quella del figliuol prodigo, lo aveva inteso comandare a Pietro di perdonare «settanta volte sette»: eppure dopo tutto ciò egli dispera del suo perdono e s’impicca, mentre Pietro dopo il suo rinnegamento non dispererà ma scoppierà a piangere. Anche questo disperare del perdono dimostra che Giuda aveva per il giusto da lui tradito un’altissima stima, la quale gli faceva misurare l’abissale nefandezza del delitto commesso: ma era anche una stima incompleta e quindi ingiuriosa, perché davanti alla responsabilità del tradimento si fermava a mezza strada e ingiuriosamente riteneva Gesù incapace di perdonare al traditore. Ben più che dal tradimento di Giuda, Gesù fu ingiuriato dal suo disperare del perdono: qui fu l’oltraggio sommo ricevuto da Gesù e l’iniquità somma commessa da Giuda. La mercede stabilita dai sommi sacerdoti per il tradimento fu di trenta (monete) argentee. Il solo San Matteo comunica questa cifra perché, sollecito qual è di segnalare che in Gesù si sono adempite le antiche profezie messianiche, scorge qui adempita una profezia di Zacharia (§ 575); tuttavia Matteo, né in questo punto né in seguito (27, 3-10), dirà il nome individuale delle monete e parlerà sempre di «trenta argentei». Non c’è dubbio che l’innominata moneta fosse il siclo (§ 249) ossia lo statere (§ 406), il quale valeva quattro dramme ossia quattro denari (§ 465); non era quindi il denarius romano (§ 514); ma una moneta di valore quattro volte maggiore: perciò, parlando tecnicamente, l’espressione usuale di «trenta denari di Giuda» è falsa perché l’intera somma di 30 sicli era costituita da 120 «denari». Nel valore odierno (anno 1940, ndr.) essa corrisponderebbe a circa 128 lire in oro. Era norma della legge ebraica (Esodo, 21, 32) che quando un bove avesse ucciso cozzando uno schiavo, il padrone del bove dovesse pagare al padrone dello schiavo a risarcimento del danno subito 30 sicli d’argento: quindi in pratica il valore medio d’uno schiavo doveva computarsi circa sui 30 sicli. Può darsi che i sommi sacerdoti s’ispirassero a questa norma della Legge nello stabilire la mercede a Giuda, perché così ottenevano il doppio scopo di mostrarsi osservatori la lettera anche in quel caso e insieme di trattare Gesù come uno schiavo qualunque. San Luca, il quale ha terminato il racconto delle tentazioni di Gesù dicendo che «il diavolo si allontanò da lui fino a tempo (opportuno)» (§ 276), inizia qui il racconto del tradimento dicendo che «entrò Satana in Giuda, quello chiamato Iscariota», il quale andò ad accordarsi per il suo delitto con i sommi sacerdoti (Luca, 22, 3 segg.). Cosicché per l’Evangelista discepolo di Paolo la passione di Gesù è il tempo (opportuno) preaccennato, e rappresenta in qualche modo una ripresa delle tentazioni a cui Gesù era stato sottoposto da Satana all’inizio della sua vita pubblica: terminando adesso Gesù la vita intera, Satana gli muove l’ultimo e più potente assalto e lo sottopone alla suprema prova, dopo di che egli entrerà nella sua gloria. «O stolti e lenti di cuore...! Non doveva forse patire queste cose il Cristo (Messia) e (così) entrare nella sua gloria?» (Luca, 24, 25-26) (§ 630).

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, inizia il mese di novembre, nel quale si commemorano particolarmente i fedeli defunti. Le condizioni per l’indulgenza plenaria sono: 1) Adempiere l’opera prescritta, con l’intenzione (almeno abituale e generale) di guadagnare l’indulgenza. 2) Confessione (anche nella settimana che precede o segue l’opera prescritta) e comunione (la vigilia o la settimana che segue l’opera prescritta). 3) Visita, se richiesta, di una chiesa o oratorio pubblico; si può fare dal mezzogiorno del giorno precedente. 4) Pregare in qualunque modo, secondo le intenzioni dei SS. Pontefici, cioè: a) Esaltazione della Fede; b) Estirpazione delle eresie; c) Conversione dei peccatori; d) Pace tra i prìncipi cristiani. 5) Essere in stato di grazia. Prosegue qui.
• L’Abate Ricciotti oggi ci spiega: «La parabola delle vergini. L’ultimo giudizio». § 530. Essendo assolutamente ignoto il giorno della parusia, coloro che aspettano la consumazione finale del regno di Dio dovranno tenersi pronti sempre, perché sempre potrà giungere quel giorno e cadere quell’ora. L’ignoranza del tempo porta con sé il pericolo di una neghittosa trascuranza, al quale dovrà provvedersi con una incessante vigilanza. Questo è l’insegnamento della parabola delle vergini, riportata dal solo Matteo (25, 1-13) e soggiunta al discorso escatologico. La parabola si riporta alle costumanze delle nozze giudaiche, di cui già trattammo (§ 281). Dieci vergini sono state invitate alle nozze di una loro amica, per farle corteggio la sera dei nissū’īn (§ 231); sono uscite dalle loro case munite ciascuna della propria lampada di terracotta, non tanto per far chiaro lungo la strada fino alla casa della sposa, quanto per accrescere la giocondità della festa allorché giungerà lo sposo. Si prevede tuttavia, essendo un matrimonio di lusso, che lo sposo si farà attendere alquanto, dovendo egli a sua volta ricevere una fila interminabile di visitatori. Perciò cinque di quelle vergini, ch’erano prudenti, portarono seco oltre alla lampada accesa anche un orcioletto pieno d’olio per rifornire la piccola lampada quando il suo contenuto fosse esaurito; le altre cinque invece, ch’erano disavvedute, non si preoccuparono delle ore lontane e portarono soltanto la lampada, non ripensando ch’essa non poteva restare accesa se non per un tempo relativamente breve. Ciò che le vergini avvedute hanno previsto, avviene di fatto: lo sposo, trattenuto a casa sua, tarda molto a giungere. Frattanto in casa della sposa la comitiva ivi radunata cambia gradualmente il suo contegno; quelle ragazze, da vivaci ed irrequiete ch’erano alla prim’ora, divengono man mano inerti, svogliate e come rassegnate; il chiacchierio s’acquieta, qua e là appaiono segni di noia; ancora più tardi qualcuna sbadiglia e appartatasi in un angolo comincia a lottare fiaccamente contro il sonno che la invade; e le ore seguitano a passare monotone senza che nessuno giunga, cosicché «indugiando lo sposo, s’appisolarono tutte e dormivano. Ma a metà notte ci fu un grido: “Ecco lo sposo! Uscite(gli) incontro!”. Allora sorsero tutte quelle vergini ed acconciarono le lampade loro. Le disavvedute dissero pertanto alle prudenti: “Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!” Ma le prudenti risposero dicendo: “Mai più! Non basterebbe a noi e a voi (insieme)! Andate piuttosto dai venditori e compratevene”. Allontanandosi quelle per comprare venne lo sposo, e quelle pronte entrarono con lui nelle nozze e fu rinserrata la porta. Alla fine però vengono anche le restanti vergini dicendo: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispondendo disse: “In verità vi dico, non so (di) voi!”». La ripulsa dello sposo fa scaturire la morale della parabola, la quale si conclude con l’ammonizione: «Vegliate dunque, perché non sapete il giorno né l’ora!». Veramente la parabola ha taluni tratti che si discostano dalla realtà contemporanea, ad esempio l’invito di andare a comperare l’olio a mezzanotte quasicché a quell’ora le botteghe fossero aperte. Ma tali astrazioni di tempo e luogo sono ammissibili in una comparazione ampia, la quale converge tutta su un punto particolare non soffermandosi su lineamenti secondari. Qui il punto preso di mira è duplice: l’ignoranza del giorno e dell’ora ch’è rilevata dalla conclusione finale, e insieme anche il pericolo dell’impreparazione e dell’attesa ch’è rilevato in tutta la parabola. L’attesa prolungandosi diventa insidiosa, perché fa trascurare la preparazione che eventualmente esisteva da principio e fa dimenticare la realtà della «venuta»; d’altra parte l’essere stato preparato soltanto alla prima ora non giova nulla a chi non si ritrovi preparato anche all’ultimo minuto, quello della «venuta». Nella lingua dei papiri greci la «venuta» e «presenza» di un re si trova espressa col termine parusia.
• § 531. Egualmente il solo Matteo (25, 31-46) presenta il gran quadro in cui il «secolo» presente si chiude e il «secolo» futuro s’inaugura ufficialmente, il quadro del giudizio finale. Questo tema era stato trattato già dagli antichi profeti, ma sotto altra luce e con altri intendimenti; qui invece la mira principale è di far risaltare i rapporti morali che legano il «secolo» presente con quello futuro, cioè la ripercussione etica che la vita presente avrà nella vita futura. Se nel passato il giudizio finale era stato presentato come il trionfo della nazione ebraica su nazioni pagane o di un partito onesto e pio su un partito malvagio ed empio, qui invece esso riveste un carattere morale riguardante i singoli individui dell’umanità intera senza discriminazione alcuna: inoltre, questo carattere morale è riassunto nella carità, come se la nota distintiva del regno di Dio e la tessera per entrarvi sia la carità (§ 550) e il giudizio finale sia il trionfo della carità. «Quando venga il figlio dell’uomo nella gloria sua e tutti gli angeli con lui, allora sederà sul trono della sua gloria. E si raduneranno davanti a lui tutte le genti, ed (egli) separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai montoni e collocherà le pecore alla sua destra e i montoni alla sinistra. Allora dirà il re a quelli della sua destra: “Venite, i benedetti del Padre mio! Possedete il regno a voi preparato dalla fondazione del mondo! Ebbi fame, infatti, e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, forestiero ero e mi accoglieste, nudo e mi ricopriste, fui ammalato e mi visitaste, in prigione ero e veniste a me”. Allora gli risponderanno i giusti dicendo: “Signore, quando ti vedemmo aver fame e nutrimmo, ovvero aver sete e demmo da bere? E quando ti vedemmo forestiero ed accogliemmo, ovvero nudo e ricoprimmo? E quando ti vedemmo ammalato ovvero in prigione e venimmo a te?”. E rispondendo il re dirà loro: “In verità vi dico, quanto faceste ad un solo di questi fratelli miei minimi, faceste a me”. Allora dirà a quelli alla sinistra: “Partitevi da me, maledetti, nel fuoco eterno, quello preparato al diavolo e agli angeli suoi! Ebbi fame, infatti, e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, forestiero ero e non mi accoglieste, nudo e non mi ricopriste, ammalato e in prigione e non mi visitaste”. Allora risponderanno anch’essi dicendo: “Signore, quando ti vedemmo aver fame ovvero aver sete ovvero forestiero ovvero nudo ovvero ammalato ovvero in prigione, e non ti servimmo?”. Allora risponderà loro dicendo: “In verità vi dico, quanto non faceste a uno solo di questi minimi neppure a me (lo) faceste”. E andranno questi in supplizio eterno, i giusti invece in vita eterna (cfr. Daniele, 12, 2)».
Ndr.: Anche quest’ultimo passo della Sacra Scrittura viene abitualmente abusato dai modernisti e fanatici della cosiddetta “accoglienza” - gli stessi che ostentano esecrandi peccati e sostengono di non credere nell’inferno «supplizio eterno» - per losche finalità filantropiche od elettorali. Non lasciamoci ingannare. Le loro rivendicazioni poggiano sulla falsa scienza, sulla falsa esegesi, finalmente sull’apostasia. Per una corretta conoscenza della dottrina cristiana sull’immigrazione e sulla vera accoglienza rimandiamo almeno ai seguenti approfondimenti: 1) «Esposizione della dottrina cristiana sulle migrazioni»; 2) «Exsul Familia Nazarethana in italiano. La Magna Charta di Pio XII sull’immigrazione». Buono studio!

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, la scorsa settimana ci siamo salutati con la sentenza: «In verità vi dico che non passerà questa generazione fino a che tutte queste cose avvengano» (Marco, 13, 30). Così termina la nostra prima parte dell’erudito studio dell’Abate Ricciotti sul discorso escatologico di Gesù. Proseguiamo, dunque, da qui.
• § 526. Passando ora ai riscontri storici noi troviamo che, sullo scorcio del previsto quarantennio, si svolge un periodo il quale fu definito, da uno storico romano che lo conosceva assai bene. Dal canto suo Flavio Giuseppe, occupandosi particolarmente della Palestina, ci fornisce quelle notizie sulle agitazioni interne e soprattutto sul ribollimento del messianismo politico che ricordammo occasionalmente più volte. La conclusione di tutto fu la catastrofe del 70, ove perirono Tempio, capitale e nazione. Quanto ai discepoli di Gesù, durante questa «grande tribolazione» essi subirono quelle persecuzioni dentro e fuori la Palestina che sono attestate sia dagli Atti e altri scritti del Nuovo Testamento, sia dagli storici romani, e che erano mosse tanto da connazionali e da congiunti quanto da estranei e da pagani; ma coloro che ressero alle lusinghe dei «falsi profeti» e alle violenze dei persecutori, allorché videro il Tempio di Gerusalemme profanato dai sanguinari Zeloti (Guerra giud., IV, 151 segg., 305 segg., 381 segg.), si attennero all’ammonizione del discorso escatologico e fuggendo dalla città si ritirarono a Pella in Transgiordania, come narra Eusebio (Hist. eccl., III, 5, 3).
• § 527. Fin qui Gesù ha risposto soltanto al primo punto della domanda rivoltagli dai discepoli, descrivendo i segni che precederanno la distruzione del Tempio; un netto e preciso distacco, a guisa di conclusione, si ritrova infatti al termine di questa sezione ove Gesù finisce ammonendo: «Voi quindi guardate: (io) vi ho predetto tutte le cose» (Marco, 13, 23). Adesso manca che Gesù risponda al secondo punto della domanda, comunicando i segni della fine del mondo. La nuova sezione (Marco, 13, 24 segg.) comincia con le parole: «Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole s’oscurerà, ecc». Qui l’espressione «in quei giorni» è la solita formula, impiegata frequentissimamente nell’Antico e nel Nuovo Testamento, per introdurre un nuovo argomento ma senza un preciso valore temporale, significando tutt’al più in un certo tempo..., a suo tempo..., in una data epoca. In questa epoca imprecisata, che si svolgerà dopo la «grande tribolazione», avverranno insieme la fine del mondo e la parusia, che sono descritte con termini presi in gran parte dall’Antico Testamento e comuni alla letteratura apocalittica (§ 84 segg.): il sole e la luna s’oscureranno, le stelle cadranno, le potenze dei cieli saranno scosse, e allora comparirà sulle nubi il figlio dell’uomo che verrà con possanza e gloria e invierà i suoi angeli ai quattro venti a radunare gli eletti; con ciò il «secolo» presente è chiuso e il «secolo» futuro è inaugurato. Questa descrizione dei segni della parusia è più breve, in tutti e tre i Sinottici, della descrizione dei segni della «grande tribolazione». Quanto poi all’indicazione del tempo in cui avverrà la parusia, la troviamo subito appresso all’indicazione del tempo assegnato alla «grande tribolazione»; ma, mentre per quest’ultima l’indicazione è stata precisa e netta - ossia «la presente generazione» - per l’altra è totalmente negativa: «Circa poi a quel giorno o all’ora nessuno sa (alcunché) né gli angeli». Nei secoli IV e V, ai tempi delle focose dispute ariane e cristologiche si usò ed abusò largamente di questo passo per misurare la scienza del Figlio divino confrontata con quella del Padre, e per attribuirgli una certa ignoranza. Ma appunto la difficoltà della frase, che sembra affermare questa ignoranza nel Figlio, è una ragione di più per considerarla autentica frase di Gesù pervenutaci nella forma più precisa e genuina: come pure la stessa difficoltà fu probabilmente la ragione per cui tutta la frase fu omessa da San Luca nel suo Vangelo, e per cui l’allusione al Figlio scomparve anche nel passo corrispondente di San Matteo (24, 36) da vari codici greci e dalla Vulgata latina, volendosi evitare una spiacevole sorpresa nei rispettivi lettori. Ma, superate le controversie ariane e cristologiche, si convenne generalmente nell’interpretare la frase come una fin de non recevoir da parte di Gesù, che non vuol essere interrogato su questo punto perché il rispondervi non entra nella sua missione: Gesù, che già aveva risposto ai figli di Zebedeo non esser compito suo ma del Padre assegnare i seggi nel glorioso regno messianico (§ 496), in questa occasione dixit nescire illum diem quia in magisterio eius non erat ut per eum sciretur a nobis, mentre invece entrava nella sua missione appunto il tener nascosto quel giorno; tamquam enim magister sciebat et docere quod proderat et non docere quod oberat (S. Agostino, Enarration. in Psalm. XXXVI, sermo I, 1). Ai nostri giorni la difficoltà è stata ripresa in pieno dalla scuola escatologica (§ 209 segg.), secondo cui Gesù era sicuro che la parusia sarebbe avvenuta nel corso della generazione (sua) contemporanea, sebbene confessasse di non conoscere il preciso giorno e la precisa ora (§ 529).
• § 528. Presentato in questa maniera - (e non alla maniera della scuola escatologica, ndr) - il discorso escatologico è chiaro, in quella misura che può essere concessa dal suo argomento. La sua prima sezione tratta dei segni della «grande tribolazione», cioè degli avvenimenti che precedettero ed accompagnarono la distruzione di Gerusalemme, la seconda sezione tratta dei segni della parusia e della fine del mondo. Dopo le trattazioni dei «segni» vengono le fissazioni dei rispettivi tempi: per la «grande tribolazione» è fissata la «generazione contemporanea» (di Gesù), mentre per la parusia è riserbato un arcano silenzio. Ma la difficoltà sta in questo, che la fissazione di ciascun tempo non è soggiunta immediatamente appresso alla rispettiva trattazione dei «segni» - cioè la «presente generazione» appresso alla «grande tribolazione», e il silenzio appresso alla parusia - bensì ambedue le fissazioni dei tempi sono relegate assieme in fondo, dopo ambedue le trattazioni dei «segni». Perché mai questa collocazione che sembra violenta e tale da provocare equivoci? Appunto qui è da scorgere l’opera redazionale degli Evangelisti e l’influenza delle circostanze in cui si svolgeva - come accennammo (§ 524) - la primitiva catechesi della Chiesa. Questa collocazione simultanea in fondo, che a noi oggi sembra violenta e tale da provocare equivoci, era invece prudentissima quando scrivevano i Sinottici, quando cioè non si sapeva nulla non solo del tempo della parusia ma neppure del preciso tempo della «grande tribolazione»: Gerusalemme infatti ancora era incolume e prospera, e nulla faceva umanamente sospettare che dopo pochi anni essa sarebbe ridotta a un ammasso di macerie. Neppure risultava chiaramente in quale relazione stessero fra loro la «grande tribolazione» e la parusia, che almeno idealmente apparivano ricollegate fra loro: la prima non sarebbe forse la preparazione immediata della seconda, e la venuta del Messia glorioso non sarebbe l’immediato premio a chi aveva superato la grande prova? Molti cristiani infatti ritenevano imminente la parusia, e la risposta di Gesù in proposito, se non implicava necessariamente tale opinione, neppure la escludeva con evidente chiarezza: il figlio dell’uomo poteva comparire inatteso in ogni momento, «come ladro notturno». Ma anche se fra la «grande tribolazione» e la parusia doveva cadere un interstizio, chi poteva dire se questo interstizio sarebbe stato breve o mediocre o lungo o lunghissimo? Di tutto ciò nessuno sapeva alcunché con certezza, prima di quel tragico anno 70; oggi invece, edotti da venti secoli di storia, noi siamo perfettamente informati della «grande tribolazione» che culminò nel 70 e dell’interstizio ch’è di una durata incalcolabile, mentre ci è rimasto impenetrabilmente occulto il tempo della parusia. Per queste ragioni gli Evangelisti sinottici, nell’oscurità che li avvolgeva, divisero il discorso escatologico secondo la materia in esso trattata, collocando prima i «segni» e poi i tempi, e lasciando alle opinioni dei lettori il ricollegamento delle singole parti fra loro: tanto più che, su questa palpitante questione della parusia le singole comunità ricevevano particolari ammaestramenti dai loro direttori, come per la comunità dei Tessalonicesi apprendiamo occasionalmente da San Paolo (II Tessal., 2, 5) e per le comunità dell’Asia Minore da San Pietro (II Pietro, 3, 1 segg.); e quindi i lettori dei Vangeli potevano e forse dovevano rivolgersi per schiarimenti a tali autentici interpreti, sempre in virtù del principio che la catechesi scritta non pretendeva mai di sostituire la catechesi orale, bensì la presupponeva in più modi (§107).
• § 529. La moderna scuola escatologica desume i suoi principali argomenti da questo discorso, ma appunto confondendo dati e referenze, e attribuendo all’unico avvenimento della parusia ambedue le fissazioni cronologiche, sia quella della «presente generazione» sia quella «del giorno e dell’ora». Già rilevammo che siffatta teoria è in contraddizione con le testimonianze storiche pervenuteci da quell’epoca (§ 212); qui sarà opportuno spendere appena una parola sull’attribuzione «del giorno e dell’ora». I suddetti studiosi sono costretti a interpretarli in senso rigoroso, ossia giorno per 24 ore e ora per 60 minuti: cosicché Gesù avrebbe confessato di non conoscere in quale gruppo di 24 ore e in quale gruppo di 60 minuti sarebbe avvenuto il cataclisma universale, pur essendo certo che sarebbe avvenuto nella generazione a lui contemporanea. È serio tutto ciò? È serio che un presunto “visionario”, tutto vibrante nell’aspettativa che entro breve tempo il mondo intero vada in pezzi, si rammarichi di non sapere il preciso momento in cui avverrà la conflagrazione? I veri visionari, appunto perché tali, non sono calcolatori così sottili, ritrovandosi totalmente assorbiti dalla visione principale: un “visionario” di questo genere è come un uomo che abbia sotto i piedi una mina con la sua miccia accesa, e non possa in alcun modo fuggire; la certezza assoluta dell’imminente scoppio gli fa totalmente dimenticare l’incertezza del preciso momento in cui lo scoppio avverrà. Gesù invece è un calcolatore sottile, e distingue nettamente le sue due fissazioni di tempi in rapporto alle due precedenti descrizioni dei «segni». Ecco pertanto nella sua integrità il passo relativo ai tempi, nel quale ognuno può riconoscere il netto distacco che riporta ciascuna fissazione di tempo alla rispettiva descrizione dei «segni»: «In verità vi dico che non passerà questa generazione fino a che tutte queste cose avvengano. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Circa poi a quel giorno o all’ora nessuno sa (alcunché), né gli angeli in cielo né il Figlio, se non il Padre» (Marco, 13, 30-32; cfr. Matteo, 24, 34-36). Da «Vita di Gesù Cristo», Abate Giuseppe Ricciotti, Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941. Fine.

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, «oggi ricorre il 75° anniversario dello sterminio di 200 bambini milanesi, avvenuto il 20 ottobre 1944 ad opera delle bombe angloamericane nel quartiere di Gorla. Nessun presidente della repubblica italiana e ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia si sono recati in questi 75 anni sul luogo dell’eccidio. (Il Centro Studi Giuseppe Federici ha pubblicato) l’elenco delle vittime senza voler alimentare odio o vendette: tutte le anime delle vittime e dei carnefici sono state giudicate da N. S. Gesù Cristo, che ha dato a ciascuna di esse “secondo i meriti, il premio o la pena eterna” (dall’Atto di fede)». Approfondimenti sul sito del Centro Studi Giuseppe Federici. Finalmente l’Abate Ricciotti ci illustra il famoso Discorso escatologico di Nostro Signore Gesù Cristo. Suddivideremo la dotta dissertazione in due parti, la prima verrà pubblicata adesso, mentre la seconda la prossima settimana.
• § 523. La giornata volgeva oramai al tramonto; Gesù s’avviò per uscire dal Tempio e passar la notte fuori della città, come soleva fare in quella settimana (§ 510). Attraversato l’atrio dei gentili, egli fiancheggiò le sottocostruzioni che s’elevavano lungo la valle del Cedron ed offrivano uno spettacolo di vera potenza e magnificenza. A quella vista tornarono spontaneamente alla memoria dei discepoli che lo seguivano le ultime parole di lui, pronunziate poco prima contro i Farisei e ch’erano balenate come tetra minaccia: «Ecco, è lasciata a voi la vostra casa deserta». La prima e più amata casa di ogni buon Israelita era la casa del Dio Jahvè, il Tempio della città santa e unico di tutto il mondo; quel Tempio non poteva non essere eterno come era richiesto dalla fede comune e anche dimostrato dalla grandiosità delle sue costruzioni. In che senso, dunque, aveva Gesù potuto dire che quella casa sarebbe rimasta deserta? Si ricollegava forse questa predizione con le altre angosciose predizioni fatte nel passato dal maestro? Ci fu qualche discepolo che volle scandagliare il pensiero di Gesù: senza darsene l’aria, gli si avvicinò mentre la comitiva sfilava lungo le sottocostruzioni del Tempio e cominciò ad esaltare quell’edificio gigantesco con termini entusiastici, non dissimili certamente da quelli che si ritrovano nelle ampie descrizioni di Flavio Giuseppe (Antichità giud., XV, 380-425; Guerra giud., V, 184-226). Le lodi del resto non erano esagerate perché, stando a questo testimonio oculare, appunto quelle sottocostruzioni e le parti del Tempio rivolte verso il Cedron presentavano il seguente aspetto: «Il tempio inferiore, nella parte più bassa, fu dovuto tener su con muri di 300 cubiti (circa 150 metri) e in certi posti anche più: tuttavia l’intera profondità delle fondamenta non appariva, perché (i costruttori) colmarono buona parte dei burroni volendo livellare le stradicciuole della città. Nella costruzione (delle fondamenta) furono (impiegate) pietre di 40 cubiti di grandezza (20 metri) ... Di tali fondamenta erano degne anche le fabbriche sovrastanti. Doppi erano infatti tutti i portici, e sostenuti da colonne di 25 cubiti d’altezza (metri 12,50), ch’erano monoliti di marmo bianchissimo ricoperti con impalcature di cedro; la loro magnificenza naturale, la levigatura e l’aggiustamento offrivano uno spettacolo ammirevole ...» (Guerra giud., V, 188-191). Senonché le parole entusiastiche dei discepoli non riuscirono a scuotere la pensierosità di Gesù; solo dopo qualche tempo egli, rialzando il capo e dando uno sguardo fugace alle decantate costruzioni, rispose gravemente: «Non vedete tutte queste cose? In verità vi dico non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sarà distrutta». E subito si chiuse nel suo silenzio. I discepoli rimasero come fulminati da quelle parole; la pensierosità del maestro si diffuse sui discepoli, e la comitiva proseguì, oramai muta, il cammino, attraversando il Cedron e poi risalendo sull’opposto pendio del monte degli Olivi. Quando fu sulla cima del monte, Gesù si sedette di fronte al Tempio (Marco, 13, 3) e rimase lì muto a guardare: lo si sarebbe detto un pilota che dalla riva riguardi accoratamente la sua amata nave su cui ha navigato lunghi anni, ma che ha dovuto abbandonare perché sa che di lì a pochi momenti sprofonderà per sempre. Gli sgomentati discepoli approfittarono di quella sosta per tornare sull’argomento di prima e domandare al maestro qualche schiarimento sulla sua nerissima predizione. Lo interrogavano privatamente Pietro e Giacomo e Giovanni e Andrea; e Gesù rispose con quello che comunemente è designato come il «discorso escatologico».
• § 524. Il discorso escatologico è riferito dai soli Sinottici (Matteo, cap. 24; Marco, cap. 13; Luca, 21, 5-36) ma con le solite divergenze che si riscontrano anche altrove fra loro; inoltre Luca ha già anticipato al cap. 17 vari elementi di questo discorso (§ 474 segg.), e lo stesso in minor parte sembra aver fatto anche Matteo (10, 17-23). È dunque palese anche qui l’intervento redazionale dei singoli Evangelisti, del quale il lettore odierno deve tener conto per una retta esegesi del discorso. Ma bisogna aver presente anche un altro fatto importante. Le tre redazioni del discorso presso i Sinottici dipendono come al solito dalle rispettive catechesi ch’essi rappresentano (§ 110 segg.), e rispecchiano perciò l’animus Ecclesia; ora tale animus, nel presente caso, si trovava in condizioni di delicatezza estrema essendo pervaso da quella perplessità e ansia dubbiosa che molti punti del discorso avevano suscitata nella mente dei primitivi cristiani, non esclusi gli Evangelisti. Si confronti infatti l’impressione che il discorso fa in un lettore odierno con l’impressione ch’esso faceva nei fedeli della prima generazione cristiana, e si ammetterà senza esitazione che la giusta interpretazione del discorso è oggi assai più facile di allora. In realtà il tempo è spesso un ottimo coefficiente per una retta esegesi; e il lettore odierno, che ha a sua disposizione venti secoli di storia, può oggi comprendere bene almeno alcuni punti del discorso escatologico, mentre quei primitivi cristiani non avevano questo prezioso aiuto. Il discorso, infatti, tratta di due grandi avvenimenti, ambedue futuri in un tempo più o meno remoto, ma idealmente ricollegati in qualche maniera fra loro. Come futuri, questi avvenimenti erano ambedue velati di mistero per chi aveva ascoltato il discorso dalla bocca di Gesù o degli Apostoli; poco più tardi, durante la stessa prima generazione cristiana, il meno remoto dei due avvenimenti accadde di fatto e allora una parte del mistero fu svelata tuttavia, per contraccolpo, l’altra parte s’avvolse in un’oscurità più ansiosa e palpitante. Se si era avverata così puntualmente la prima predizione che appariva idealmente ricollegata con la seconda, non si avvererebbe presto anche la seconda? Il primo avvenimento non era come l’immediato precursore del secondo? E su queste domande i primi cristiani rifletterono trepidanti per molti anni. Oggi si riconosce concordemente che il primo dei due fatti si è avverato durante la prima generazione cristiana, ma non sorgono più le ansie di quella generazione riguardo al susseguirsi immediato del secondo fatto: i venti secoli di storia hanno attribuito il loro giusto valore alle parole di Gesù che ponevano tra i due fatti un interstizio di tempo incommensurabile. Fatta però la luce sul primo fatto e sull’interstizio, l’oscurità si è raccolta oggi tutta sul secondo fatto, riguardo al quale il lettore odierno è non meno dubbioso della prima generazione cristiana, sebbene non ansioso come quella. Confrontando poi accuratamente fra loro le tre recensioni del discorso, e anche i tratti paralleli solitari, appare molto probabile che la sua forma più antica e meno sottoposta a redazione sia quella trasmessaci da Marco, ossia la forma della catechesi di Pietro (§ 128 segg.): prendendo questa per guida, senza perdere d’occhio le altre testimonianze, possiamo riassumere la sostanza del discorso nella maniera seguente.
• § 525. La domanda rivolta a Gesù dai quattro discepoli sulla cima del monte era consistita in queste parole: «Dicci, quando saranno queste cose, e quale (sarà) il segno allorché stiano per conterminarsi tutte queste cose?» (Marco, 13, 4). L’espressione «queste cose» si riferisce la prima volta alla distruzione del tempio, di cui Gesù aveva predetto che non sarebbe rimasto pietra sopra pietra; ma la seconda volta ha certamente un significato più ampio, e si riporta alla catastrofe addirittura universale in cui dovevano aver termine tutte queste cose, cioè il «secolo» o mondo presente, come suggerisce anche il termine «conterminarsi» che è tipico per designare la fine del mondo (§ 638). Ciò del resto è messo fuor d’ogni dubbio dal parallelo Matteo (24, 3), ove la domanda dei discepoli suona: «Dicci, quando saranno queste cose, e quale (sarà) il segno della tua “parusia” e della conterminazione del “secolo”?». I discepoli dunque, al sentire annunziata da Gesù la distruzione del Tempio, avevano ripensato alle varie promesse da lui fatte che il regno d’Iddio sarebbe venuto in possanza (§ 401) e che nella rigenerazione si sarebbe assiso il figlio dell’uomo sul suo trono di gloria (§ 486), nonché ai vari accenni delle parabole, e spontaneamente avevano fuso tutto insieme, contemplando o simultanei o almeno in una immediata concatenazione di tempo ambedue gli avvenimenti, sia quello della distruzione del Tempio sia quello della parusia e della fine del «secolo». Gesù pertanto dovrà rispondere ad ambedue i punti della domanda, quando sarà la distruzione del Tempio e quando la fine del mondo; inoltre dovrà descrivere i segni precursori dell’uno e dell’altro avvenimento. Egli infatti comincia col mettere in guardia i suoi discepoli contro insidie ingannevoli, e perciò nella prima sezione della sua risposta descrive i segni che precederanno la distruzione del Tempio (Marco, 13, 5-23). - Si faranno avanti molti predicatori menzogneri spacciandosi per il Messia e attireranno in errore molti, così pure avverranno guerre, sedizioni, terremoti e carestie in luoghi diversi: «ma tutto ciò non (è) ancora la fine», bensì soltanto «l’inizio delle doglie»; la grande tribolazione infatti si scaricherà direttamente sui discepoli di Gesù, che saranno deferiti a sinedri, sinagoghe e governatori, saranno battuti e imprigionati, saranno traditi dai più stretti parenti, e odiati universalmente a causa della loro fede: ma ciò nonostante e appunto durante questo tempo «in tutte le genti dapprima dev’esser predicata la “buona novella”». Infine la «grande tribolazione» entrerà nella sua stretta finale: l’abominio della desolazione predetto da Daniele (9, 27) sarà stabilito nel Tempio, e Gerusalemme sarà circondata da armate; allora i discepoli rimasti fedeli a Gesù si diano immediatamente alla fuga per salvare le loro vite. Quelli saranno «giorni di vendetta affinché siano adempiute tutte le cose scritte nei libri sacri» (Luca, 21, 22), e sarà «tribolazione quale non è stata siffatta, dal principio della creazione che creò Iddio, fino adesso e non sarà» (cfr. Daniele, 12, 1), sebbene la sua durata sarà abbreviata per far sì che ne scampino gli eletti (Marco, 13, 19-20). Fin qui, come si sarà notato, il discorso non ha fatto alcun accenno al tempo ma solo ai segni della «grande tribolazione». Che poi questa si riferisca alla distruzione del Tempio e di Gerusalemme è dimostrato dai termini impiegati, ed è inoltre confermato dall’importante rilievo che pure Flavio Giuseppe, accingendosi a narrare lo stesso fatto, impiega espressioni somigliantissime, dicendo: «In realtà le sventure di tutti i secoli mi sembrano restare al di sotto confrontate con quelle dei Giudei» (Guerra giud., I, 12), e definisce anche la guerra tra Roma e la Giudea «la più grande non solo di quelle del nostro tempo ma quasi anche di quelle che udimmo per fama esser scoppiate fra città e città o fra nazioni e nazioni» (ivi, I, 1). Né fa ostacolo la condizione che, alla distruzione del Tempio, «in tutte le genti dapprima dev’essere predicata la “buona novella”»; altrettanto affermava, come di cosa fatta, San Paolo egualmente prima che Gerusalemme fosse distrutta (§ 401). Ora, la distruzione di Gerusalemme avvenne nel quarantennio successivo al discorso, ossia nello spazio di tempo computato dai Giudei come una «generazione». Troviamo infatti che Gesù in seguito - quando ha finito di descrivere i segni e passa a parlare dei tempi - afferma: «In verità vi dico che non passerà questa generazione fino a che tutte queste cose avvengano» (Marco, 13, 30). FINE DELLA PRIMA PARTE.

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
L’Associazione Sursum Corda O.d.V. il 15 ottobre scorso ha donato alla Caritas diocesana di Potenza i seguenti prodotti ad uso dei cristiani indigenti: -5 giubbotti per bimbo; 1 zainetto scuola per bimbo; 1 occhiali per bimbo; 12 prodotti assortiti e gioco per bimba; 2 borselli per donna; 1 set tazzine per gioco; 2 scarpe per donna adulta; 1 elettroutensile per la cura della persona; 7 scarpe per bimbo e bimba; 75 capi d’abbigliamento assortiti per bimbo e bimba; alcuni capi abbigliamento per adulto; altri prodotti nuovi o usati ma di qualità e conservati ottimamente. Alla maggior gloria di Dio!
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, segnaliamo il nostro canale Youtube, dove è stato caricato un nuovo video di dottrina sui miracoli e sugli esorcismi: https://youtu.be/D8auMkKrQfs. Molto ricca è l’odierna lezione del venerando Abate Ricciotti, il quale ci parlerà dell’«elenchos» contro gli Scribi ed i Farisei, successivamente dell’offerta della vedova.
• § 518. I Greci antichi avevano chiamato èlenchos quella parte dell’orazione forense in cui, esponendosi le accuse addotte contro l’avversario, si corredavano delle rispettive prove; era dunque un biasimo dimostrativo del disonore altrui, come nei tempi più antichi (presso Omero) èlenchos aveva significato sia «biasimo» sia «disonore». In quel tempestoso martedì, consumato da Gesù in buona parte a battagliare contro Scribi e Farisei, non poteva mancare un èlenchos contro questi avversari che riassumesse ed integrasse le accuse già formulate in precedenza. Difatti tutti e tre i Sinottici riportano tale requisitoria di Gesù in questo giorno, ma con le solite divergenze: Marco (12, 38-40) è brevissimo; così pure Luca (20, 46-47), il quale però ha già riferito un ampio formulario d’accuse in occasione del pranzo offerto a Gesù dal Fariseo (§ 447). Lunghissimo è invece Matteo (cap. 23), il quale incorpora quasi tutto il formulario di Luca accrescendolo di altre accuse. È probabile che Matteo, come ha già fatto per il Discorso della montagna (§ 317), abbia riunito qui per motivi redazionali alcune sentenze di Gesù pronunziate occasionalmente altrove: e questa conclusione è suggerita anche dall’esame letterario dell’èlenchos, ch’è diviso simmetricamente in tre parti (23, 1-2; 23,13-32; 23, 33-39), ed ha la seconda parte suddivisa in sette Guai a voi!... (§ 125); tuttavia la collocazione di Matteo è nel suo complesso preferibile a quella di Luca, e il nucleo principale del discorso dovette esser pronunziato da Gesù appunto in questo scorcio di sua vita come del resto confermano vagamente gli altri due Sinottici. Riproduciamo qui integralmente l’èlenchos di Matteo, rinviando per le parti già viste a quanto già se ne disse in precedenza. «Sulla cattedra di Mosè si sedettero gli Scribi ed i Farisei. Perciò tutte quante le cose che vi dicano fate ed osservate, ma conforme alle opere loro non fate, giacché dicono e non fanno. Legano infatti carichi pesanti e (li) impongono sulle spalle degli uomini, ma essi col loro dito non vogliono rimuoverli. Fanno poi tutte le opere loro per esser rimirati dagli uomini: allargano infatti le loro filatterie e ingrandiscono le loro frange, amano poi il primo divano nei conviti e i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze e l’esser chiamati “Rabbi” dagli uomini. - Voi invece non vi lasciate chiamare “Rabbi”: uno solo infatti è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” vostro (alcuno) sulla terra: uno solo infatti è il Padre vostro, quello celeste. E non vi lasciate chiamare “direttori” perché direttore vostro è uno solo, il Cristo. Invece chi di voi è maggiore, sarà inserviente di voi; chiunque poi s’innalzerà sarà abbassato, e chiunque s’abbasserà sarà innalzato». In questa prima parte del discorso Gesù traccia i lineamenti caratteristici dei Farisei, e tornano perciò alcuni tratti delle sue precedenti discussioni con essi: parlando qui egli alla folla del Tempio, passa subito appresso ad esortare affinché quelle caratteristiche non siano imitate e si faccia precisamente il contrario. La vanagloria dei Farisei si esercitava fra l’altro nelle filatterie, le quali consistevano in bossoletti ove stavano arrotolate strisce di pergamena su cui erano scritti alcuni passi dei Libri sacri (cioè Esodo, 13, 1-10; 13, 11-16; Deuteron., 6, 4-9; 11, 13-21): durante la preghiera l’Israelita applicava (ed applica ancora) le strisce sulla fronte e sul braccio sinistro, intendendo di eseguire letteralmente la prescrizione contenuta in Deuteron., 6, 8 (cfr. Esodo, 13, 9). I vanagloriosi si procuravano strisce più ampie e vistose, per dare più sull’occhio; altrettanto facevano con le frange del mantello che avevano anch’esse un significato religioso ed erano portate pure da Gesù, come già vedemmo (§ 349).
• § 519. La seconda parte del discorso costituisce il vero èlenchos: «Guai però a voi, Scribi e Farisei ipocriti, perché rinserrate il regno dei cieli in faccia agli uomini: voi infatti non entrate, né gli entranti lasciate entrare. Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti, perché girate per mare e per terra per fare un solo proselita, e quando sia divenuto (tale) lo rendete figlio di Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche che dite: “Chi abbia giurato per il santuario, è nulla; ma chi abbia giurato per l’oro del santuario, è obbligato”. Stolti e ciechi! Chi è infatti maggiore, l’oro oppure il santuario che ha santificato l’oro? E (dite anche): “Chi abbia giurato per l’altare, è nulla; ma chi abbia giurato per il dono che (sta) sopra a quello, è obbligato”. Ciechi! Che cosa infatti è maggiore, il dono oppure l’altare che santifica il dono? Chi dunque ha giurato per l’altare, giura per esso e per tutte le cose che (stanno) sopra a quello; e chi ha giurato per il santuario, giura per esso e per chi l’abita; e chi ha giurato per il cielo, giura per il trono d’Iddio e per chi vi è assiso sopra. Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta e della finocchiella e del comino, e lasciate le cose più gravi della Legge, il giudizio e la misericordia e la fede! Invece, queste cose bisognava fare e quelle non tralasciare. Guide cieche, che filtrate il moscerino e inghiottite invece il camello! Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti, perché mondate l’esterno della coppa e del vassoio, mentre l’interno è riempito di rapina e sfrenatezza! Fariseo cieco, monda dapprima l’interno della coppa affinché diventi puro anche l’esterno di essa! Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti, perché rassomigliate a sepolcri imbiancati, i quali al di fuori appaiono belli, al di dentro invece sono ripieni d’ossa di morti e d’ogni impurità! Così anche voi all’esterno apparite giusti agli uomini, all’interno invece siete colmi d’ipocrisia e d’iniquità. Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti, perché costruite i sepolcri dei profeti ed abbellite le tombe dei giusti, ed esclamate: “Se fossimo stati ai giorni dei padri nostri, non saremmo stati loro complici nel sangue dei profeti!”. Cosicché attestate a voi stessi che siete figli di quei che uccisero i profeti. E voi colmate la misura dei padri vostri!». L’èlenchos ha denunziato i fatti; tale denunzia serviva già da prova, perché tutti gli uditori sapevano per esperienza che i casi mentovati corrispondevano alla realtà. Un quarantennio più tardi, dopo la catastrofe del 70, lo stato delle cose cambierà alquanto: i Farisei rimarranno le guide sole e incontrastate del residuo della nazione e moltiplicheranno a piacer loro norme e prescrizioni; ma rinunceranno del tutto all’ansioso proselitismo qui accennato, e di cui già vedemmo alcuni risultati ottenuti fra i Greci (§ 508).
• § 520. All’annunzio che i Farisei hanno colmato la misura dei padri loro segue la deplorazione, come nella procedura forense alla dimostrazione del delitto seguiva la pena; è la terza parte del discorso: «Serpenti, razza di vipere, come (avverrà che) sfuggiate al giudizio (condanna) della Geenna? Per questo ecco io invio a voi profeti e sapienti e scribi: di essi ucciderete e crocifiggerete, e di essi flagellerete nelle vostre sinagoghe (§ 64) e perseguiterete di città in città, affinché venga su voi tutto il sangue giusto versato sulla terra, dal sangue di Abele il giusto fino al sangue di Zacharia figlio di Barachia che uccideste fra il santuario e l’altare. In verità vi dico, verranno tutte queste cose su questa generazione! - Gerusalemme, Gerusalemme, uccidente i profeti e lapidante gl’inviati ad essa! Quante volte volli coadunare insieme i tuoi figli, alla maniera che una gallina coaduna i pulcini sotto le ali, e (voi) non voleste! Ecco, è lasciata a voi la vostra casa deserta. Vi dico infatti, non (sarà che) mi vediate da adesso fino a che diciate: “Benedetto il Veniente in nome del Signore!”». Questa ultima parte, più che una minaccia, è in realtà una deplorazione. Gesù deplora che i suoi reiterati tentativi di salvare città e nazione siano stati frustrati, e che l’intero edificio costruito man mano da Dio per la salvezza d’Israele venga demolito man mano dalla pervicacia degli uomini: ciò ch’è avvenuto a al tempo della Legge quando i profeti di Jahvè finivano lapidati, avverrà anche al tempo del Messia i cui inviati finiranno in maniera analoga; ma in tal modo tutto il peso dei delitti anche più antichi graverà su quei che compiono l’ultimo delitto, perché costoro scalzano le ultime fondamenta dell’edificio di Dio, e colmando la misura attireranno su se stessi la vendetta totale. È dunque una minaccia salutare, un supremo angoscioso grido affinché le guide cieche della nazione eletta s’arrestino sull’estremo orlo dell’abisso. Dei delitti antichi sono ricordati per nome solo due, l’uccisione di Abele e quella di Zacharia, probabilmente perché erano narrate l’una al principio del primo libro della Bibbia ebraica che è il Genesi (4, 8), e l’altra sulla fine dell’ultimo libro che sono le Cronache (II Cron., 24, 20-22). Vecchia, poi, è l’altra difficoltà offerta dall’appellativo paterno di Zacharia chiamato qui «figlio di Barachia», mentre nelle Cronache è chiamato «figlio di Jojada»; al contrario appare come figlio di Barachia il profeta Zacharia (Zach., 1, 1. 7), che è tutt’altra persona dallo Zacharia qui ricordato. È notevole però che l’appellativo paterno manca nel passo parallelo di Luca (11, 51) e anche nell’autorevolissimo codice Sinattico di Matteo: ciò potrebbe far sospettare che «figlio di Barachia» sia un’antica glossa infiltratasi nel testo greco ma assente nell’originale semitico di Matteo (§ 121), salvo che la divergenza si fondi su altre ragioni che a noi oggi sfuggono. I due Sinottici, che soli riportano quest’apostrofe di Gesù a Gerusalemme, mostrano con ciò di conoscere i reiterati tentativi di Gesù per salvare la città e quindi i suoi ripetuti viaggi alla capitale, sebbene questi viaggi siano oggetto della narrazione di Giovanni e non dei Sinottici: quindi la tradizione sinottica implicitamente conosce quella giovannea, sebbene non se ne serva (§ 165).
• § 521. Ma con questo appello, angoscioso e minaccioso, i tentativi di Gesù finiscono. Quando sia avvenuta l’ultima ripulsa e consumato l’ultimo delitto, la loro casa sarà abbandonata ad essi deserta, priva dell’aiuto di colui che hanno respinto. Né essi rivedranno mai più lui, se non in tempi d’un futuro remotissimo allorché l’aberrante nazione si sarà ravveduta del suo errore e farà ricerca del respinto: «Una voce sulle nude colline si ode, il pianto supplichevole dei figli d’Israele: ché aberrarono dalla loro via, dimenticarono Jahvè loro Dio; saranno giorni, quelli, in cui non si esclamerà più oltre “O Arca dell’alleanza di Jahvè!”, non starà (più) a cuore, non si penserà ad essa, non sarà rimpianta né costruita più oltre; e agli aberranti sarà rivolto un invito: “Ritornate, o figli ribelli, guarirò io le vostre ribellioni!” ed essi risponderanno: “Eccoci, noi veniamo a te, perché tu sei Jahvè nostro Dio!... Davvero, in Jahvè nostro Dio sta la salvezza d’Israele!”» Geremia, 3, 16... 23, con inversioni. Questa visione dell’antico profeta è contemplata nuovamente da Gesù ma sullo sfondo d’un tempo del tutto nuovo ed ancor più remoto, quello dell’ultima parusia; allora Israele, riconciliato col già respinto Messia, potrà nuovamente vederlo perché gli andrà incontro rivolgendogli l’acclamazione già rivoltagli nel breve trionfo di due giorni prima: Benedetto il Veniente in nome del Signore! (§ 504). Qualche anno più tardi il fariseo Paolo di Tarso, divenuto «schiavo del Cristo Gesù», contemplerà anch’egli il remotissimo tempo in cui i suoi connazionali, presentemente accecati, riacquisteranno la vista e così l’intero Israele sarà salvato (Romani, 11, 25-26). Dopo l’èlenchos contro Scribi e Farisei, ci è dato assistere ad una umile ma nobilissima scenetta che è precisamente l’opposto del mondo spirituale degli Scribi e dei Farisei: la scenetta è descritta da Luca (21, 1-4) ma anche più vividamente da Marco (12, 41-44); Matteo invece, inaspettatamente, la omette. Forse si tratta di un elemento della catechesi di Pietro, trasmesso a Luca per mezzo di Marco.
• § 522. Quel martedì era quasi trascorso; Gesù, terminata l’accorata deplorazione contro i suoi avversari, entrò nelle parti interne del Tempio spingendosi fino all’«atrio delle donne», e ivi si sedette di fronte all’attigua aula del Tesoro (§ 47). All’ingresso di questa erano collocate, per raccogliere le offerte, tredici casse chiamate «trombe» dalla forma allungata dell’imboccatura nella quale si gettavano le monete; in occasione di grandi feste, come questa di Pasqua, le offerte erano abbondantissime perché molti pellegrini approfittavano di questa loro venuta per pagare il tributo prescritto per il Tempio (§ 406) e tutti in genere facevano oblazioni spontanee: perciò vicino alle casse stavano di guardia alcuni sacerdoti, che certificavano il pagamento del tributo e sorvegliavano il regolare svolgimento delle operazioni. Seduto lì di fronte, Gesù guardava. Molti ricchi venivano alle casse e con molta ostentazione gettavano dentro manciate di monete, sicuri con ciò di essere apprezzati assai, oltreché dagli uomini, anche da Dio; frammezzo a costoro, non avvertita né curata da alcuno, venne una povera strascicata di vedova che lasciò cadere nella cassa soltanto «due minuzzoli che è (un) quadrante» (§ 133), cioè neppure due centesimi. Allora Gesù, «chiamati a sé i suoi discepoli disse loro: In verità vi dico che questa vedova, povera, gettò più di tutti quei che gettano nel tesoro; tutti infatti gettarono (traendo) dal sovrabbondante ad essi: questa invece (traendo) dalla sua indigenza gettò tutto quanto aveva, l’intera sua sussistenza» (Marco, 12, 43-44). Anche con questa osservazione il maestro dello spirito si opponeva ai maestri dell’esteriorità, suoi avversari.

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, «Instaurare omnia in Christo». Tra una settimana si svolgerà la quattordicesima «Giornata per la Regalità Sociale di Cristo». La giornata ha come finalità la formazione dei cattolici militanti, militanti del regno di Cristo nella vita privata (e quindi vivere abitualmente in stato di grazia, osservare i 10 comandamenti ed i precetti della Chiesa, assistere ogni domenica alla Messa ed accostarsi frequentemente ai Sacramenti), nella vita familiare e nella vita professionale (mettendo Dio al primo posto, secondo il motto di Santa Giovanna d’Arco: «Dieu premier servi»). Per chi, poi, è impegnato in associazioni culturali o movimenti politici, considerare la religione cattolica il fine principale del proprio impegno e non secondario, a partire dal punto oggi fondamentale: la questione dell’autorità nella Chiesa.
• Don Francesco Ricossa sarà il docente del seminario di studi: «Gli amici e i nemici della regalità di Cristo», che prenderà in esame tre anniversari legati al 1919, considerati alla luce del Magistero. Di particolare interesse la rivista «Fede e Ragione», fondata e diretta da don Paolo de Töth - l’ultimo dei cattolici integrali - per continuare la «buona battaglia» antimodernista e antimassonica. La rivista rappresenta una miniera di articoli (anche di mons. Umberto Benigni) che non hanno perso la loro attualità, poiché basati sui princìpi della verità eterna, che meritano di essere letti e studiati. Appuntamento, quindi, alle ore 10 di sabato 12 ottobre nei saloni del M. B. Center di Modena: Cliccare qui. Video di presentazione della giornata: Cliccare qui. Comunicato tratto dalla pagina Facebook di don Ugo Carandino.
• Dalla «Vita di Gesù Cristo» dell’abate Ricciotti oggi studieremo il capitolo: «Il massimo comandamento. Il Messia figlio di David». § 517. L’alternativa di Farisei e Sadducei continuò ancora in quel giorno operosissimo per Gesù. La risposta data ai Sadducei piacque a uno Scriba presente alla discussione, il quale perciò si fece avanti e propose a Gesù una questione che corrispondeva bene ai metodi rabbinici: «Qual è il comandamento primo di tutti?» (Marco, 12, 28) o come è riportata da Matteo (22, 36): «Qual (è il) comandamento (più) grande della Legge?». La Legge scritta infatti, ossia la Torah, conteneva secondo i rabbini 613 precetti (§ 30), dei quali 248 erano positivi perché comandavano una data azione, e 365 erano negativi perché proibivano di fare alcunché: gli uni e gli altri, poi, erano ripartiti in precetti “leggieri” e precetti “gravi” a seconda dell’importanza che si attribuiva loro. Ora, fra tutti questi comandamenti vi sarà pure stata una specie di gerarchia, e fra i precetti “gravi” ve ne sarà stato uno gravissimo che superava per importanza tutti gli altri. Ciò appunto voleva sapere da Gesù questo Scriba. La risposta di Gesù fu quella già data al dottore della Legge per cui fu pronunziata la parabola del buon Samaritano: Gesù recitò l’inizio dello Shemà (§ 438). «Il primo (comandamento) è: “Ascolta Israele! Il Signore Iddio nostro è Signore unico; e amerai il Signore Iddio tuo con tutto il cuore tuo, e con tutta l’anima tua, e con tutta la mente tua, e con tutta la forza tua”. (Il) secondo (comandamento è) questo: “Amerai il prossimo tuo come te stesso”. Maggiore di questi, altro comandamento non è». Veramente lo Scriba aveva interrogato circa un solo comandamento, il massimo fra tutti; Gesù ha risposto recitando il comandamento dell’amore di Dio, ma quasicché tale comandamento non sia da solo integro e pieno - almeno nel campo pratico - vi aggiunge l’altro dell’amore del prossimo: questi due precetti, che si riconnettono l’un l’altro, formano per Gesù il comandamento «massimo». Le stesse idee erano già state espresse nel Discorso della montagna (§§ 327, 332).
• Lo Scriba approvò cordialmente la risposta di Gesù riscontrando da parte sua che il doppio amore di Dio e del prossimo valeva più che tutti gli olocausti e i sacrifizi del Tempio. In premio di questa sua replica Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno d’Iddio». Gli mancava, infatti, soltanto di credere nella missione di Gesù ad imitazione di Pietro, di Giovanni, e di tanti altri. Se ciò poi avvenisse, non sappiamo. Dopo questa discussione finita con l’accordo dei due, ci si dice che «nessuno più osava interrogarlo» (Marco, 12, 34). Gesù però venne per conto suo alla riscossa. Avvicinatosi nel Tempio stesso a un altro gruppo di Farisei, intavolò una questione riguardo al Messia: Da quale stirpe sarebbe disceso il Messia? Di chi sarebbe egli stato figlio? Gl’interrogati, d’accordo con tutta la tradizione ebraica, risposero: Di David. Gesù allora fece osservare che nella sacra Scrittura David stesso, il cui nome figura nell’iscrizione in cima al Salmo 110 ebr. (Vulg. 109), si esprime ivi così: «Oracolo di Jahvè al mio Signore: “Siedi alla mia destra, finché Io ponga i tuoi nemici (quale) sgabello per i tuoi piedi!”». Da questo passo Gesù argomentò: «Se dunque David lo chiama “Signore”, come è figlio di lui?». La forza dell’argomentazione poggiava su due punti ammessi anche dai Farisei: in primo luogo, che nel Salmo parlava David come mostrava la sua iscrizione; in secondo luogo, che il Salmo trattava del futuro Messia, come risulta dal largo impiego in questo senso che se ne fa nel Nuovo Testamento (più di quindici volte) e che presuppone il consenso della parte avversaria. Perché mai, dunque, David chiamava «Signore» il futuro Messia che era suo discendente? Ciò dimostrava, secondo Gesù, che il Messia era più che un semplice «figlio di David» e racchiudeva in sé qualità che lo rendevano più che Giona e più che Salomone (§ 446) e anche più che David; ma Gesù voleva avere dai Farisei la spiegazione di questa apparente incongruenza. Quei Farisei però non poterono rispondere nulla. Più tardi, dal secolo II in poi, i rabbini risolsero la questione sostenendo che il Salmo non si riferiva al Messia, bensì ad un altro personaggio: che di solito era creduto Abramo, talvolta David stesso (!), e secondo la solitaria notizia di Giustino (Dial. cum Tryph., 33 e 83) il re Ezechia. Questa mutazione di riferimento fu evidentemente determinata dalla polemica anticristiana (cf. Testi rabbinici in Strack e Billerbeck, Op. cit., vol. IV, pagg. 452-465) .

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, oggi (29/9) ricorre la Festa di San Michele Arcangelo: il campione di Dio nella battaglia contro Lucifero e gli angeli ribelli (Apoc. 12, 7-8), il custode del corpo di Mosè (Giuda, 9), il difensore di Maria Santissima (Apoc. 12, 5-6); è il primo Angelo onorato dai fedeli e invocato come medico delle malattie. Il culto liturgico in Oriente si trova all’inizio del secolo IV, in Occidente qualche decennio dopo. Nel secolo VI, a Roma, il 30 settembre si celebrava l’anniversario della dedicazione della chiesa dedicata a San Michele Arcangelo sulla Via Salaria, dedicazione che più tardi diede origine alla festa attuale. In questo giorno San Michele è onorato come «il principe della milizia celeste»; e perciò la liturgia intende festeggiare tutti gli Angeli. A San Michele si attribuiscono tre funzioni: a) guida e conduce le anime in cielo (Off. della Messa dei Def.) dopo averle pesate sulla bilancia della giustizia divina; b) difende la Chiesa e il popolo cristiano (All.); c) in cielo presiede il culto d’adorazione della Santissima Trinità e offre a Dio le preghiere dei Santi e dei fedeli (Off.). Segue la preghiera che la Chiesa recita a San Michele alla fine di ogni Santa Messa: «Sancte Míchaël Archángele, defénde nos in proélio: contra nequítias et insídias diáboli esto praesídium. Imperet illi Deus, súpplices deprecámur: tuque, Prínceps milítiae coeléstis, Sátanam aliósque spíritus malígnos, qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo, divina virtúte, in inférnum detrúde. Amen». Fra le tante mostruosità e blasfemie compiute contro la Santa Messa, i modernisti hanno anche censurato questa importante orazione.
• Adesso finalmente parliamo di Sacra Scrittura con l’Abate Ricciotti - Dio lo abbia in gloria! § 515. L’insidiosa questione del tributo a Cesare era finita con una sconfitta dei Farisei interroganti, i quali «avendo udito furono presi d’ammirazione e lasciatolo se n’andarono» (Matteo, 22, 22). Di questa sconfitta si compiacquero i rivali Sadducei, i quali si fecero subito avanti a ritentare per proprio conto una nuova partita; questa avrebbe riguardato l’argomento della resurrezione dei corpi, tenacemente negata dai Sadducei (§ 34) e oggetto di vecchie dispute fra loro e i Farisei. Si presentarono pertanto a Gesù per sottoporgli non la questione astratta della resurrezione, ma un caso concreto, uno di quei «casi» che formavano la delizia delle accademie giudaiche. Cominciarono col citare la legge del «levirato», con cui Mosè prescrive che, se un Ebreo muoia non lasciando figli, il fratello del morto sposi la vedova di lui per procurare una discendenza al defunto (Deuteronomio, 25, 5 segg.). Ricordata questa legge, essi presentarono il «caso». C’erano stati sette fratelli, il primo dei quali era morto non lasciando figli, cosicché il secondo fratello aveva sposato la vedova del primo; ma anche costui era morto non lasciando figli, e la donna era stata sposata dal terzo; altrettanto era avvenuto con tutti i successivi fratelli fino al settimo, e dopo la morte del settimo era morta anche la donna. Ora - chiedevano quei Sadducei - di chi sarebbe stata moglie quella donna, quando fosse risorta insieme con tutti e sette contemporaneamente? Tutti e sette, infatti, avevano egual diritto su di lei. Il caso era tipicamente accademico; ma in fatto d’astruseria e di manierismo si andava oltre, come appare dal seguente «caso» conservato nel Talmud. - C’erano 13 fratelli, e 12 di essi morirono senza figli. Le 12 vedove citarono allora il superstite fratello davanti al Rabbi (Giuda I, morto sui primi del sec. III) affinché le sposasse in forza della legge del «levirato»; ma il superstite dichiarò che non aveva mezzi finanziari per mantenere le 12 aspiranti. Esse allora, tutte d’accordo, dichiararono che ciascuna avrebbe provveduto al mantenimento durante un mese all’anno, e così si sarebbe provveduto a tutti e 12 i mesi. Senonché il futuro marito delle 12 aspiranti fece cautamente osservare che nel calendario ebraico i mesi dell’anno erano talvolta 13: ciò infatti avveniva circa ogni 3 anni, quando si intercalava un tredicesimo mese per eguagliare l’ufficiale anno lunare con l’anno solare; ma il generoso Rabbi rispose che nel caso di mese intercalato egli avrebbe provveduto al mantenimento. E così avvenne. Dopo 3 anni le 12 vedove rimaritate si presentarono alla casa del Rabbi recando complessivamente 36 bambini, e il Rabbi li mantenne tutti per quel mese.
• § 516. I Sadducei che proposero il loro «caso» a Gesù non s’interessavano di questioni finanziarie, ma di quella della resurrezione. Secondo essi il caso proposto dimostrava che la resurrezione era impossibile, giacché risorta che fosse quella donna avrebbe dovuto essere nello stesso tempo moglie di tutti e sette i risorti mariti: ma poiché ciò era manifestamente una sconcezza e un’assurdità, per questo la resurrezione si dimostrava impossibile. Se poi Gesù avesse tentato di difendere la resurrezione, nello sciogliere il caso proposto si sarebbe cacciato in un ginepraio di ridicolaggini perdendo così ogni credito sulla folla. Questo modo di ragionare presupponeva un concetto della resurrezione molto crasso e materialesco, il quale anche per tale ragione era respinto dai Sadducei mentre tra i Farisei era predominante sebbene non universale; questo concetto immaginava la resurrezione come il ridestarsi di un dormiente, il quale svegliato che sia si ritrova nelle stesse condizioni naturali di prima che s’addormentasse. Perciò ai risorti si assegnavano le antiche attività di mangiare, bere, dormire, generare, ecc.; anzi sembrava conveniente che queste attività fossero accresciute e rafforzate, tanto che un cinquantennio dopo Gesù l’autorevole Rabban Gamaliel sentenziava che nella vita futura le donne partoriranno ogni giorno come le galline (in Strack e Billerbeck, Op. cit. nei precedenti Comun., vol. I, pag. 889, insieme con altre testimonianze più crude). Gesù taglia corto a tali fantasticherie puerili, e risponde: «Errate, non sapendo le Scritture né la potenza d’Iddio. Nella resurrezione infatti (i risorti) né sposano né sono sposati, ma sono come angeli nel cielo». I risorti saranno bensì gli stessi uomini di prima, ma non già nelle stesse condizioni di prima: la loro nuova condizione sarà come quella degli angeli nel cielo. Continuò poi Gesù: «Riguardo alla resurrezione dei morti, non leggeste ciò che fu detto a voi da Iddio affermante “Io sono il Dio di Abramo e il Dio d’Isacco e il Dio di Giacobbe”? (Esodo, 3, 6)? Non è Dio di morti ma di viventi». Il passo citato da Gesù fa parte della Torah, l’unica Scrittura sacra accettata dai Sadducei (§ 31); questa sembra la ragione - come notò già San Girolamo - per cui Gesù, tralasciando altri passi delle Scritture che attestano più chiaramente le fede nella resurrezione dei morti (§ 80), argomenti da questo passo che a differenza degli altri non poteva essere rifiutato dai Sadducei. Ad ogni modo l’argomentazione è condotta secondo i metodi delle scuole rabbiniche, e presuppone il patrimonio ideale dell’ebraismo: il Dio dei patriarchi ebrei è Dio non di morti ma di viventi; dunque quei patriarchi vivono anche dopo la loro morte corporea, e la resurrezione è attestata dalle sacre Scritture.

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, in data 19 settembre 2019 abbiamo consegnato ai cristiani poveri della Caritas di Potenza numerose scarpe da donna (più di 10 paia) e capi d’abbigliamento (più di 50 pezzi). Questa iniziativa fa seguito alle ben più rilevanti campagne che si sono concluse nei giorni 20 e 21 giugno scorsi. Ci auguriamo, per il 2019, di poter procedere almeno con un’altra consegna di beni od alimenti ai cristiani più poveri e sfortunati: San Giovanni di Dio ci protegga! Relazionata - per mere necessità burocratiche e mai per ostentazione filantropica - la nostra piccola opera di misericordia corporale, possiamo proseguire con la consueta erudizione sulla Sacra Scrittura a cura del defunto Abate Giuseppe Ricciotti: «Il tributo a Cesare».
• § 514. Anche quella volta, dunque il favore popolare aveva funzionato da ostacolo protettivo di Gesù di fronte ai maggiorenti; costoro perciò, fremendo dal desiderio di concludere la lotta che si prolungava serrata da troppo tempo, decisero di aggirare quel fastidioso ostacolo compromettendo Gesù in maniera tale che il favore del popolo non avrebbe potuto giovargli. Tenuto breve consiglio sul da farsi (Matteo, 22, 15), i Farisei inviarono a Gesù alcuni dei loro discepoli insieme con taluni Erodiani (§ 45) per proporgli, in pubblico e in maniera che la folla ascoltasse, una particolare questione. La presenza degli Erodiani già induceva a prevedere che si trattava di una questione politica, cioè di un argomento che Gesù aveva sempre evitato. Gl’inviati s’avvicinano pieni d’ostentato rispetto, come se non avessero nulla in comune con i precedenti interlocutori e venissero da tutt’altra parte, e untuosamente dicono a Gesù: «Maestro, sappiamo che sei veritiero ed insegni la via d’Iddio con verità e non tieni conto di nessuno, perché non guardi in faccia agli uomini; dicci dunque, che cosa ti sembra: è lecito dare censo a Cesare o no?» (Matteo, 22, 16-17). La domanda, come già ha avvertito l’Evangelista, era un tranello che consisteva in questo: se Gesù avesse risposto ch’era lecito, si sarebbe attirato l’odio del popolo, perché colui che figurava come Messia ed eroe nazionale non avrebbe mai potuto dichiarare lecito il riconoscere un’autorità politica straniera e il pagarle un tributo qualsiasi; se poi Gesù avesse risposto ch’era illecito, siffatta dichiarazione era bastevole per denunziarlo al procuratore romano come ribelle e istigatore di sommosse, tanto più che la grande ribellione di Giuda il Galileo, avvenuta un trentennio prima, era stata provocata dal censimento romano intimamente riconnesso col pagamento del tributo (§ 43). I Farisei, da persone esperte, trovarono che il dilemma era rigorosamente cornuto, e quindi che Gesù sarebbe rimasto vittima di una delle due alternative: probabilmente s’aspettavano ch’egli dichiarasse illecito il pagamento del censo, e in tal caso la denunzia subito presentata dai testimoni Erodiani avrebbe fatto colpo sul procuratore romano. Ma le previsioni fallirono, perché il dilemma fu rivolto contro gli interroganti. «Disse infatti Gesù: “Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del censo”». Gli fu porto un denarius romano d’argento, che valeva poco più di una lira in oro odierna: serviva da moneta corrente per il pagamento delle imposte, ed era stato coniato fuori della Palestina perché era di metallo prezioso e recava impressa un’effigie umana, mentre le monete coniate in territorio giudaico erano soltanto di bronzo e non recavano alcuna effigie umana in omaggio alla nota prescrizione del giudaismo (§ 23). Se il denarius porto a Gesù era - come sembra assai probabile - quello di Tiberio allora regnante, esso recava sul retto l’immagine dell’Imperatore coronato e attorno ad essa l’iscrizione TI.(berius) CÆSAR DIVI AUG.(usti) F.(ilius) AUGUSTUS.
• Alquanto strana era parsa la richiesta di Gesù di vedere una moneta del censo quasicché non le avesse mai viste, ma anche più strana sembrò la sua domanda quando ebbe la moneta sott’occhi: «Di chi è questa immagine e iscrizione?». Ma come, non lo sapeva? Anche l’ultimo ragazzo palestinese sapeva che effigie e nome erano di quell’imperatore che stava laggiù a Roma a comandare sul mondo intero e - purtroppo - anche su Gerusalemme. Meravigliati di quella ignoranza gli risposero: «Di Cesare». Ma l’ignoranza era simile a quella già usata da Socrate nel suo metodo interrogativo, la quale mirava a far enunciare una data verità all’interrogato stesso. Con la risposta ottenuta, che effigie e nome erano di Cesare, Gesù aveva ottenuto quanto voleva; egli allora ne concluse: «Rendete dunque le cose di Cesare a Cesare, e le cose d’Iddio a Iddio». La conclusione scaturiva, per una logica rigorosa, dalla risposta dei Farisei. Era di Cesare quella moneta? Ebbene, la rendessero a Cesare, giacché per il semplice fatto che essi accettavano quella moneta e se ne servivano correntemente mostravano di accettare la sovranità di chi l’aveva battuta. E così la questione politica era risolta senza che Gesù fosse entrato nell’evitato campo politico, ma solo in virtù della confessione che la moneta era di Cesare. Tuttavia, affermando il solo dovere verso Cesare, la questione non era totalmente risolta secondo Gesù. La sua missione tendeva al regno di Dio, non a quello dell’uno o dell’altro Cesare, e quando gli uomini avessero reso al rispettivo Cesare quel che gli spettava avrebbero compiuto solo una parte, e non la più importante, del loro dovere. Perciò alla prescrizione di rendere a Cesare, Gesù soggiunge l’altra di rendere a Dio, e l’aggiunse come elemento non solo integrativo di tutta la risposta ma anche rafforzativo della prima prescrizione. Gesù infatti non conosce di persona nessuno dei Cesari di questo mondo, e non sa se essi si chiamino Augusto oppure Tiberio, Erode Antipa oppure Ponzio Pilato: sa soltanto che essi sono investiti di un’autorità la quale dev’essere rispettata. Ma perché questa sudditanza a Cesare? Appunto in virtù della sudditanza a Dio. I doveri verso Cesare formano solo un piano del gran quadro in cui Gesù contempla il regno di Dio: chi appartiene al regno di Dio compia, in forza di questa sua appartenenza, i suoi doveri verso il proprio Cesare; ma subito appresso, appena sdebitatosi verso Cesare, risalga egli nei piani superiori e spazieggi nei dominii imperituri del Padre celeste. Da «Vita di Gesù Cristo», Abate Giuseppe Ricciotti, Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941.
• [Nota di Sursum Corda: Come abbiamo imparato, questo passo della Scrittura viene erroneamente utilizzato dai moderni per propugnare la laicità di Stato, piuttosto che la cosiddetta separazione Chiesa-Stato. In verità queste ultime due massoniche pestilenze - già ampiamente condannate dalla Chiesa in quanto contrarie alla Regalità Sociale di Cristo (cfr. Quas Primas: tanto per citare un documento dogmatico) - non hanno nulla in comune con l’insegnamento del Maestro e neppure possono esserne conseguenza positiva. Gesù ordina di rispettare la legittima autorità, poiché quest’ultima deve a Dio la sua condizione (cfr. Immortale Dei, anche Diuturnum Illud). Parimenti, sempre il Maestro, insegna che l’adempimento del dovere del buon cittadino non deve mai confliggere con l’ordine di Dio. Più tardi il Pontefice San Pietro pronuncerà la famosa sentenza: «Oboedire oportet Deo magis quam hominibus» - «Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini». Sta a significare che l’uomo pio e devoto, in caso di contrasto manifesto fra l’ordine temporale e la legge di Dio, prudentemente osserverà la seconda mentre rigetterà la misura iniqua (cfr. Sapientiae christianae). Devo fermarmi per ragioni editoriali, tuttavia non prima di aver evidenziato che il principio di laicità (prima la legge dello Stato ... poi, forse, quella di "dio") è davvero il contraddittorio dell’insegnamento dato da Gesù in questo passo evangelico (prima la legge del vero e unico Dio ... per conseguenza quella dello Stato). Per approfondimenti cliccare qui - C.d.P.].

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, sul sito abbiamo pubblicato in copia anastatica i preziosi opuscoli: 1) La Charité de la Vérité - R. P. Guérard Des Lauriers O. P.; 2) I funesti pericoli degli eccessi nella moda; 3) La verità sui Testimoni di Geova. Letture che potete trovare in home page per almeno due settimane. È in pubblicazione, probabilmente domani 15 settembre, anche l’opuscolo «Libri» sui pericoli della cattiva stampa, ovvero della falsa cultura. Quanta tristezza dobbiamo provare ogni volta che sentiamo i Governi e le Amministrazioni proclamare investimenti per la cultura, oppure in cultura! Ordinariamente si tratta di dilapidazioni del danaro proveniente dalle nostre tasse per sponsorizzare amici e per favorire i cattivi libri e gli spettacoli indecenti: peste dell’anima, caligine della mente e rovina della società. E quanti altri Editori, fra cui molti si pregiano del nome di Cattolici, in verità pubblicano e diffondo solo spazzatura, testi di falsa scienza e pervertimento, insomma materiale che anche il più moderato degli inquisitori avrebbe destinato al rogo! Il mondo è cambiato, ci dicono che è diventato laico, ci accusano di essere arretrati e intolleranti, rivendicano cultura per ogni flato infernale che viene in mente al primo sciagurato che passa: noi diciamo NO, grazie! Preghiamo il buon Dio di conservare la fede anche rifiutando di leggere e di fare propaganda a questa moderna epidemia che molti si ostinano a chiamare cultura.
• Ed ora il consueto appuntamento con la preziosa «Vita di Gesù Cristo» dell’Abate Giuseppe Ricciotti: «L’autorità di Gesù. La parabola dei due figli» e «La parabola dei vignaiuoli omicidi». § 512. In quella mattina del martedì Gesù si recò al Tempio dove il popolo l’aspettava ansioso (§ 510) e si mise ad insegnare; ma ben presto si presentarono anche sommi sacerdoti, Scribi ed Anziani del popolo, cioè i rappresentanti dei vari gruppi del Sinedrio (§ 58), cosicché si ritrovarono riunite tutte insieme le forze in azione: Gesù da una parte, i maggiorenti giudei dall’altra, e in mezzo il popolo che proteggeva Gesù. Per allora c’era equilibrio tra le due forze contrastanti, ma quando l’ostacolo intermedio - ossia il favore popolare - fosse venuto a mancare, l’equilibrio sarebbe stato turbato e le due forze sarebbero venute in urto. E appunto a rimuovere l’ostacolo mirarono quella mattina i maggiorenti, i quali lì davanti alla folla domandarono a Gesù: «Con quale autorità fai queste cose? O chi ti dette questa autorità perché (tu) faccia queste cose?» (Marco, 11, 28). Il tono della domanda era da inquisizione tribunalesca, e quei maggiorenti trattavano Gesù come se già fosse stato deferito al loro tribunale; ma nello stesso tempo, con quella domanda, essi volevano screditarlo davanti al popolo e fargli perdere il favore di questo: probabilmente speravano che Gesù parlasse sprezzantemente di Mosè, della sua Legge o simili cose, urtando i sentimenti popolari. Gesù, invece, accettando battaglia anche questa volta e precisamente sul terreno scelto dal nemico, seguì un metodo di discussione molto impiegato dai dottori della Legge, il quale consisteva nel rispondere facendo alla propria volta un’interrogazione quasi per stabilire un punto ammesso da ambedue le parti. Gesù però disse loro: «V’interrogherò in un solo punto; rispondetemi, e allora vi dirò con quale autorità (io) faccio queste cose: - Il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? - Rispondetemi!». La domanda di Gesù era assai imbarazzante per i destinatari, specialmente lì davanti alla folla, a causa dell’atteggiamento che essi avevano tenuto di fronte a Giovanni il Battista (§ § 268, 292); il loro imbarazzo è descritto dall’Evangelista con queste parole: «E ragionavano in se stessi dicendo: “Se diciamo: - (Era) dal cielo - (egli ci) dirà: Perché dunque non credeste in lui? - E allora diremo - (Era) dagli uomini?”. (Ma non dissero ciò, perché) temevano la folla; tutti infatti ritenevano che Giovanni realmente era un profeta. E rispondendo a Gesù dicono: “Non sappiamo”. E Gesù dice loro: “Neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose”». La battaglia era finita, certo non con la vittoria di chi aveva scelto il terreno. I Sinedristi avevano sperato far forza sul consenso popolare, per poi aver nelle loro mani Gesù abbandonato dalla folla; e invece la folla aveva protetto ancora una volta Gesù, il quale inoltre aveva nuovamente ricollegato la propria missione con quella di Giovanni il Battista. Nessuna meraviglia che i Sinedristi non accettassero la missione di Gesù, dal momento che avevano respinto quella del suo precursore. Per confermare la propria vittoria e schiarire sempre più il collegamento della propria missione con quella di Giovanni il Battista, Gesù soggiunse una parabola. - Un uomo aveva due figli, che impiegava nel coltivare la sua vigna. Un giorno egli disse al primo: «Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna!» - Quello rispose: «Si, signore, vado». - E invece non andò affatto. Più tardi il padre dette lo stesso comando al secondo figlio, il quale rispose: «Non voglio andare!» - Tuttavia in seguito, pentendosi della sua risposta, andò. E Gesù concluse: «Chi dei due fece la volontà del padre?». Gli risposero: «L’ultimo». Gesù allora applicò la parabola al caso storico: «In verità vi dico che i pubblicani e le meretrici precedono voi nel regno d’Iddio. Venne infatti a voi Giovanni in via di giustizia e non credeste in lui, mentre i pubblicani e le meretrici credettero in lui; voi al contrario, dopo aver veduto, neppure più tardi vi pentiste sì da credere in lui» (Matteo, 21, 31-32). Dunque gl’inappuntabili Scribi e Farisei erano adombrati in quel figlio che a parole obbediva ma a fatti era ribelle; al contrario lo scarto della nazione eletta, cioè pubblicani e meretrici, avevano indubbiamente errato ma poi erano rinsaviti accettando la missione di Giovanni il Battista, e così avevano imitato il figlio dapprima ribelle e poi obbediente. Tra i due figli, colui che dopo aver fatto il male «cambia di mente» e passa a fare il bene, è da preferirsi a colui che non si decide mai a fare il bene pur dichiarandosi sempre pronto a farlo.
• § 513. La precedente parabola era stata una sentenza di riprovazione per coloro che allora si stimavano le guide e i più insigni rappresentanti della nazione eletta; ma Gesù ne soggiunse un’altra, egualmente di riprovazione, in cui volle riassumere l’intera storia d’Israele confrontata con l’economia prestabilita da Dio riguardo alla salvezza umana. L’insegnamento velato in questa nuova parabola era eguale a quello impartito da Gesù poche ore prima, con l’azione simbolica (realmente accaduta, ndr) di maledire e far disseccare l’albero di fico; l’immagine che vien impiegata nella parabola era già stata impiegata sette secoli prima e per lo stesso scopo dal profeta Isaia, cosicché Gesù ricollegava ancora una volta la sua propria missione con quella degli antichi profeti e nello stesso tempo rendeva facilissima l’interpretazione della sua parabola. Isaia (5, 1 segg.) nel suo celebre carme aveva descritto una vigna nella quale il padrone aveva riversato le più amorevoli cure, scegliendone il sito in un terreno ubertoso, ripulendolo da pietre, piantandovi magliuoli sceltissimi, costruendovi tutt’attorno un recinto di protezione e al di dentro una torre di guardia col suo pressoio in basso; nonostante tutto ciò quella vigna si era ostinata a produrre acri lambrusche invece di dolci uve. La spiegazione soggiunta all’allegoria aveva ricordato che l’ingrata vigna era la nazione d’Israele e il suo padrone era il Dio Jahvè Sebaoth; il quale però, esacerbato dalla sterilità della vigna, ne avrebbe abbattuto il recinto abbandonandola a devastazione e lasciandovi crescere rovi e spine. Questa immagine fondamentale, ripresa da Gesù, fu da lui ampliata e precisata con ciò ch’era avvenuto nei sette secoli trascorsi da Isaia fino a lui. «C’era un uomo, padrone di casa, il quale piantò una vigna, e la circondò di siepe, e scavò in essa un pressoio e costruì una torre, e la cedette a vignaiuoli, e partì per l’estero. Quando poi s’avvicinò il tempo dei frutti, inviò i suoi servi ai vignaiuoli a prendere i suoi frutti; e i vignaiuoli, presi i servi di lui, uno (ne) percossero, un altro (ne) uccisero e un altro (ne) lapidarono. Nuovamente inviò altri servi più numerosi dei primi, e (i vignaiuoli) fecero ad essi ugualmente. Alla fine inviò loro il figlio suo dicendo: “Avranno rispetto per il figlio mio!”. Ma i vignaiuoli, veduto il figlio, dissero fra loro: “Questo è l’erede. Su dunque, uccidiamolo ed avremo la sua eredità!”. E presolo, (lo) scacciarono fuori della vigna ed uccisero. Quando dunque venga il padrone della vigna, che cosa farà a quei vignaiuoli?». «Gli dicono: “(Essendo) cattivi, di cattiva fine li farà perire, e cederà la vigna ad altri vignaiuoli i quali gli consegneranno i frutti alle loro stagioni”. Dice loro Gesù: “Non leggeste mai nelle Scritture - Una pietra che scartarono i costruttori: questa divenne testata d’angolo: dal Signore avvenne questa cosa ed è mirabile agli occhi nostri - ?” (Salmo 118, 22-23 ebr.) “Per questo vi dico che sarà tolto a voi il regno d’Iddio e sarà dato a nazione che faccia i frutti di esso”» (Matteo, 21, 33-43). Non era necessaria la perizia dei Farisei nelle sacre Scritture e la loro conoscenza della storia religiosa della propria nazione per comprendere subito che la vigna era Israele, il padrone era Dio, e i servi malmenati o uccisi erano i profeti, le cui morti violente formavano un necrologio ininterrotto lungo le pagine delle Scritture. Ma a questa parte riguardante il passato, Gesù aveva aggiunta, a guisa di conclusione, una parte riguardante il futuro ed era quella ove aveva detto che lo stesso figlio, inviato per ultimo dal padrone della vigna, era stato percosso ed ucciso; evidentemente in questo figlio l’oratore aveva adombrato se stesso, e così si era proclamato implicitamente figlio di Dio ed aveva accusato in anticipo i colpevoli del loro futuro delitto (il deicidio, ndr). Tutto era di una chiarezza e precisione che non lasciava luogo ad equivoci. Ed il risultato di questa perfetta comprensione fu in armonia con lo stato d’animo degli uditori: «avendo udito i sommi sacerdoti e i Farisei le parabole di lui conobbero che di loro (egli) parla; e cercando d’impadronirsene ebbero paura delle folle, poiché (queste) lo ritenevano per profeta».

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, vi ricordiamo che sul sito vengono pubblicate le preghiere al Santo del giorno. Stiamo cercando di completare la raccolta per tutti i giorni dell’anno, integrando con numerose pie devozioni (novene, tridui, giaculatorie, etc...). Si tratta di preghiere cattoliche, rivolte a veri Santi e non contaminate dal germe apostata dell’ecumenismo e del modernismo in generale = «Sintesi di tutte le eresie (...) che distrugge ogni religione (...) che porta all’ateismo» (cfr. Pascendi, Papa San Pio X). Il tag della settimana è il 174. La «Vita di Gesù Cristo» dell’Abate Giuseppe Ricciotti oggi ci parla del fico maledetto.
• § 510. La divisione cronologica di queste ultime giornate di Gesù si trova meglio che in ogni altro Evangelista in San Marco; il quale distingue nettamente la notte fra la domenica e il lunedì (Marco, 11, 11-12), la notte fra il lunedì e il martedì (11, 19-20), il giorno del mercoledì (14, 1), quello del giovedì (14, 12) e la sua sera (14, 17), e infine la mattina del venerdì (15, 1), il suo pomeriggio (15, 25.33) e la sua sera (15, 42), che fu l’ultimo giorno della vita di Gesù. Per i primi giorni gli altri Evangelisti sono più vaghi. San Luca aggiunge la notizia generica, che Gesù in questa settimana «stava durante i giorni nel Tempio insegnando; durante le notti poi, uscito fuori, dimorava nel monte chiamato degli Olivi. E tutto il popolo s’affrettava di buon mattino alla volta di lui nel Tempio per ascoltarlo» (Luca, 21, 37-38). Il ripartire tra questi singoli giorni le cose narrate dai quattro Evangelisti non porta a risultati sicuri. Anche seguendo la distribuzione cronologica di San Marco, i fatti e discorsi di Gesù anteriori all’ultima cena spetterebbero in massima parte al martedì, mentre al lunedì e al mercoledì rimarrebbe ben poco; ora, può darsi che questa assegnazione corrisponda alla serie dei fatti, ma può anche benissimo darsi che sia effetto di ripartizione redazionale: anzi quest’ultimo caso sembra accertato per taluni fatti, quali la cacciata dei mercanti dal Tempio (§ 287, nota prima) che Marco sembra collocare in questo lunedì, e il banchetto di Bethania (§ 501) che appare collocato al mercoledì. Certamente l’operosità di Gesù in questi ultimi giorni fu molto intensa, e a buon diritto possiamo supporre che ci sia stata narrata soltanto in parte. Il favore popolare, prolungatosi ancora per due o tre giorni dopo la domenica trionfale, salvaguardava sufficientemente Gesù dall’odio dei maggiorenti giudei e gli permetteva di trattenersi durante il giorno in Gerusalemme insegnando e disputando pubblicamente nel Tempio, ove il popolo l’attendeva ansiosamente come ci ha detto San Luca; di notte invece, quando il popolo avrebbe potuto far pochissimo e i maggiorenti moltissimo, Gesù si allontanava dalla malfida città e, attraversato il torrente Cedron, si ritirava sull’attiguo monte degli Olivi, il quale comprendeva tanto l’amico villaggio di Bethania, quanto il giardino di Gethsemani, ch’era un luogo anche più vicino e prediletto da Gesù. Dunque l’unico impedimento a che l’odio dei maggiorenti si sfogasse era la benevolenza del popolo; ma quei maggiorenti sapevano perfettamente che tale benevolenza è quanto di più mutevole e incostante si possa immaginare, ed essi attesero il momento propizio per farla mutare d’un colpo senza pubblici sconvolgimenti. In tale attesa consumarono essi questi quattro giorni. Nel primo di essi, il lunedì, Gesù partì da Bethania di buon mattino insieme con gli Apostoli alla volta di Gerusalemme. Prima di partire egli non aveva mangiato, e quindi durante il cammino ebbe fame. Veramente appare strano che egli uscisse dalla casa governata da una solerte massaia come Marta senza prender cibo, tanto più che nel Talmud i rabbini raccomandano il pasto in ora sollecita, e Rabbi Aqiba ammonisce: «Alzati di buon’ora e mangia...; sessanta corrieri potranno correre ma non oltrepassare colui che ha mangiato di buon’ora». Ma questo non è il solo elemento paradossale del presente episodio; anche altri suoi tratti ci inducono a considerarlo alla stregua di una di quelle azioni simboliche compiute frequentemente dagli antichi profeti, e specialmente da Ezechiele: l’azione era vera e reale, ma usciva dal quadro della vita ordinaria, mirando solo a rappresentare in maniera visiva e quasi tangibile un dato insegnamento astratto.
• § 511. Per calmare dunque la fame, Gesù s’avvicinò ad un albero di fico che stava presso la strada ed era lussureggiante di foglie, come se ne trovano comunemente ancora oggi sul monte degli Olivi, e cercò tra il fogliame se c’erano frutti. Ma frutti non ce n’erano e non potevano esserci, per la semplice ragione - come dice Marco (11, 13) - che non era la stagione dei fichi. Si stava infatti ai primi d’aprile e a quella stagione in Palestina, anche nelle zone più solatie, l’albero di fico può bensì aver gettato i primi bocci, i cosiddetti fichi fiori, ma questi non sono allora in nessun modo mangiabili e maturano solo verso i primi di giugno; anche i frutti della gettata seconda, o autunnale, possono conservarsi sull’albero fin verso gli inizi dell’inverno, ma non vi resistono mai fino all’aprile in cui allora si stava. Volendo dunque giudicare quell’albero come se fosse stato una persona morale e responsabile, bisognerebbe dire che esso non era «colpevole» se non aveva frutti in quella stagione: in realtà Gesù cercava ciò che, regolarmente, non poteva trovare. Con tutto ciò egli maledisse quell’albero dicendo: «Mai più in eterno nessuno mangi da te frutto!». Tutte queste considerazioni ci confermano che Gesù volle compiere un’azione che aveva valore simbolico [n.b. l’azione fu compiuta, è un accadimento storico, ndr.], analoga per esempio allo spezzamento della brocca compiuto da Geremia (cap. 19), all’azione compiuta da Ezechiele (cap. 5) di radersi barba e capelli con una spada affilata, e a tante altre azioni paradossali degli antichi profeti, le quali avevano tutte un significato simbolico. In questo caso dell’albero il simbolo prendeva argomento dal contrasto tra l’abbondanza del fogliame inutile e la mancanza dei frutti utili: dal quale contrasto era anche giustificata la maledizione all’albero «colpevole». Chi poi - come gli Apostoli ch’erano presenti - conosceva l’indole del ministero di Gesù ed aveva ascoltato le sue discussioni con i Farisei e le sue invettive contro la loro ipocrisia, poteva comprendere agevolmente a chi si riferisse l’insegnamento simbolico: il vero colpevole era il popolo eletto, Israele, ricchissimo allora di fogliame farisaico ma ostinatamente privo da lungo tempo di frutti morali, e quindi meritevole della maledizione di sterilità eterna. Ché se qualche dubbio su tale riferimento storico poté sussistere da principio nella mente degli Apostoli, esso fu del tutto rimosso dalle parabole della riprovazione (§ 512 segg.) pronunziate da Gesù il giorno appresso e indirizzate appunto contro l’Israele contemporaneo. Quanto avvenne dopo la maledizione di Gesù è riassunto in poche parole da San Matteo (21, 19), il quale dice che l’albero si disseccò subito e riporta immediatamente appresso l’ammonizione fatta su tal proposito da Gesù. Sa Marco invece segue una cronologia più precisa, giacché narra che gli Apostoli riscontrarono il disseccamento dell’albero la mattina appresso - quella del martedì - allorché ritornando con Gesù da Bethania a Gerusalemme ripassarono per lo stesso posto, ed attribuisce a quella mattina l’ammonizione di Gesù. Ripassando pertanto di là, Pietro ebbe l’ingenuità d’esclamare: «Rabbi, guarda! Il fico che maledicesti si è disseccato!» (Marco, 11, 21). Gesù nella risposta non accennò al significato morale del fatto simbolico, e si limitò ad ammonire nuovamente gli Apostoli ad aver fede, con la quale sarebbero riusciti a spostare le montagne (§ 405, nota).

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, il 3 settembre la Santa Romana Chiesa festeggia Papa San Pio X. Nacque a Riese, nella diocesi di Treviso, nell’anno 1835, e fu il secondo di dieci figli. Suo padre era procaccia postale e sua madre era sarta. A 12 anni fece la sua prima Comunione. Intelligente e studioso, percorreva sette chilometri a piedi scalzi, per frequentare il ginnasio di Castelfranco Veneto. A 17 anni entrò nel Seminario di Padova. Dopo sei mesi rimase orfano del padre. Il suo avvenire si presentava nero... Pianse, pregò, sperò... Noi tutti abbiamo il nostro bagaglio di sofferenze; ma il Signore veglia sopra ciascuno. Preghiamo, studiamo ed ubbidiamo: al resto ci penserà Lui... 2. Fu prefetto di camerata e maestro di canto in Seminario. A 23 anni fu Sacerdote: poi cappellano a Tombolo; arciprete a Salzano; Direttore Spirituale nel Seminario di Treviso e Cancelliere di Curia. Nel settembre del 1884 fu eletto Vescovo di Mantova, dove riaprì il Seminario, già chiuso da diversi anni, e tenne personalmente l’ufficio di Rettore, di professore di teologia, di canto e di cerimonie. Nel gennaio del 1892 veniva eletto Cardinale e Patriarca di Venezia. Nell’agosto del 1903 fu eletto Papa, succedendo a Leone XIII. Nell’agosto del 1914 moriva di dolore, per non aver potuto impedire la guerra mondiale. Nel giugno del 1951 fu proclamato beato, e nel maggio del 1954 fu canonizzato. Ecco dove lo ha portato l’amore al dovere!... 3. Fu semplice e rettilineo. Guardò e giudicò tutto alla luce della fede. Compì tutti i suoi doveri con mirabile perfezione. Fu di una umiltà profondissima. Da Sacerdote aveva amato e servito il Parroco come un figlio affettuoso, e le anime con assoluta dedizione. Da Vescovo e Cardinale riceveva a tutti gli orari; avvicinava i piccoli, i poveri, tutti. Servì più volte la Messa a umili suoi Sacerdoti. Per risparmiare in favore dei poveri, si privava di sufficiente personale di servizio; una mattina, servita la Messa al futuro Pio XI, gli preparò anche il caffè. Ammiriamolo e preghiamolo...
• Recitiamo una vecchia preghiera a Papa San Pio X per i seminari e per i seminaristi: + O glorioso san Pio X, che avete fondato i Seminari Regionali per dare alla Chiesa Sacerdoti santi e dotti, quali sono necessari ai tempi moderni, io Vi eleggo a mio speciale protettore di questo mese di settembre, mentre andrò meditando i pericoli che mi circondano e le sofferenze di Gesù e di Maria. Ottenetemi dalla SS. Trinità tutti quei lumi e tutte quelle grazie che mi sono necessarie; affinché, sotto la vostra protezione, e sulle orme dei vostri esempi, mantenendomi fedele alle mie pratiche di pietà, e fuggendo l’ozio e le occasioni pericolose, possa perseverare nello spirito della vocazione e rientrare generosamente in Seminario. Ora che non ho a mia disposizione tutti gli aiuti che avevo in Seminario; ora che sono in balia della mia inesperienza e debolezza, di fronte a tanti pericoli; ora mi è urgente il vostro prezioso patrocinio. Ve lo chiedo per l’amore che portate a Gesù e alla sua Chiesa. Così sia. + (Vita del Santo e preghiera tratte dal libro «Meditatio mea», Can. Muscolo, Marietti, 1962, pagine 282 e 285)
• L’Abate Ricciotti, nella sua preziosa «Vita di Gesù Cristo», oggi ci racconta del desiderio dei Greci di voler essere presentati a Gesù. § 508. Alla fine il corteo trionfale (di ingresso a Gerusalemme) Gesù raggiunse la città ed entrò nel Tempio. Ivi, nell’atrio esterno, continuavano ancora le acclamazioni festanti, e i fanciulli ripetevano le grida che già udimmo. Di quell’aura di tripudio approfittarono subito ciechi e storpi che erano a limosinare in un luogo così opportuno, e si fecero condurre presso al trionfatore taumaturgo implorando la sanità; e Gesù li guarì. Il Tempio era già affollato di pellegrini accorsi per l’imminente Pasqua; e fra costoro erano anche molti non giudei ma benevoli per il giudaismo. Nella Diaspora infatti il giudaismo aveva lavorato intensamente a far seguaci, e coloro che erano stati guadagnati si ripartivano in due classi: la classe inferiore era quella dei “devoti” o “timorati” di Dio, i quali erano obbligati all’osservanza del sabbato, a certe preghiere ed elemosine e ad altre prescrizioni minori, pur rimanendo sempre estranei alla nazione eletta d’Israele; la classe superiore invece era quella dei veri “proseliti”, i quali avevano ricevuto la circoncisione ed erano perciò eguagliati in tutto, o quasi, agli Israeliti, e ne condividevano ogni obbligo. Quando il corteo entrò nel Tempio, erano nell’atrio esterno alcuni di questi “devoti”, di stirpe Greci come li chiama san Giovanni (12, 20, greco), ch’erano venuti a Gerusalemme in occasione della Pasqua per fare adorazione, sebbene ai veri riti pasquali essi non potessero partecipare perché non erano eguagliati agli Israeliti. Rimasti colpiti dallo spettacolo del corteo e soprattutto da ciò che videro e udirono della potenza taumaturgica di Gesù, essi desiderarono esser presentati a lui; per riuscirvi più facilmente tra quella calca, si rivolsero all’apostolo Filippo (§ 314) e gli dissero: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo, alquanto sorpreso dalla richiesta, si consigliò in proposito col suo compaesano Andrea, e finalmente ambedue comunicarono la richiesta a Gesù. Ciò che avvenne appresso è narrato da san Giovanni conforme a quella sua singolare maniera che lumeggia i principii perenni più che gli episodi fugaci: nel suo racconto i Greci che hanno chiesto di esser presentati a Gesù non sono più mentovati, ma in compenso Gesù parla della sua missione e questa è confermata solennemente da una testimonianza divina. Si direbbe che Giovanni nella ricerca di Gesù fatta da questi Greci scorga l’inizio della più ampia ricerca che farà di lui l’umanità, tanto che egli trascura l’episodio occasionale per dilungarsi sul risultato perenne. Alla comunicazione dei due Apostoli Gesù replicò: «È venuta l’ora che sia glorificato il figlio dell’uomo. In verità, in verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muoia, esso rimane solo; se invece muoia, porta molto frutto». Torna dunque l’idea della glorificazione di Gesù Messia, preceduta però dalla prova del dolore supremo; il regno di Dio si dispiegherà in pieno nella maniera riserbatagli nel «secolo» presente, solo dopoché il suo fondatore sia stato disfatto come un chicco di grano nascosto nell’umida terra: da quell’interiore disfacimento si sprigionerà la fruttificazione possente e moltiplicativa. Ed eguale alla sorte di Gesù sarà quella dei suoi seguaci: «Chi ama la vita sua la perde, e chi odia la vita sua in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se alcuno mi serva, mi segua; e dove sono io, ivi sarà anche il mio servitore. Se alcuno mi serva, il Padre l’onorerà». Quindi Gesù ritorna su se stesso, e ripensa alla prova suprema che dovrà precedere la sua glorificazione: «Adesso l’anima mia è turbata. E che devo dire? “Padre, salvami da quest’ora”? Al contrario, per questo venni in quest’ora! Padre, glorifica il nome tuo». Appena è apparsa la possibilità di una titubanza davanti alla prova suprema, è respinta; più tardi nel Gethsemani la titubanza riapparirà in circostanze ben diverse e con risultato differente (§ 555).
• § 509. L’invocazione finale al Padre celeste fu esaudita. Come già era accaduto al battesimo di Gesù ed alla sua trasfigurazione (§§ 270, 403) venne una voce dal cielo che disse: «E glorificai, e di nuovo glorificherò». L’oggetto di questa glorificazione non è espresso, ma è chiaramente il nome dell’invocato Padre, il quale sarà glorificato dalla missione del suo Figlio Gesù e soprattutto dalla conclusione di quella missione. La folla astante percepì il suono, ma non capì distintamente le parole; perciò alcuni credettero che fosse scoppiato un tuono, chiamato spesso dagli Ebrei «la voce di Dio» (cfr. II Samuele, 22, 14; Salmo 29, 3.9 ebr.; Giobbe, 37, 5; ecc.), mentre altri supposero che un angelo avesse parlato a Gesù. Egli allora spiegò: «Non per me è stata questa voce, ma per voi. Adesso è (il) giudizio di questo mondo: adesso il principe di questo mondo sarà scacciato fuori. E io, se sia innalzato dalla terra, attirerò tutti a me stesso». In altre parole, Dio stava per compiere il giudizio di condanna sul mondo presente e su Satana, principe di esso; segno materiale che quel giudizio cominciava era la voce testé udita, la quale ricordava le voci divine del Sinai allorché era stata stabilita l’antica alleanza; la chiusura ed il coronamento di quel giudizio si sarebbero avuti quando Gesù fosse stato innalzato dalla terra, poiché avrebbe attirato a sé tutti gli uomini liberandoli dalla sudditanza a Satana. Appena menzionato l’«innalzamento» di Gesù, l’Evangelista si affretta ad aggiungere: «Ciò poi diceva, significando di qual morte stava per morire.» Non sappiamo però con sicurezza in qual maniera gli ascoltatori di Gesù interpretassero il suo annunziato «innalzamento»; dalle loro parole sembra che pensassero ad una specie di «assunzione» di Gesù, analoga all’assunzione di Henoch. Gli rispose pertanto la folla: «Noi udimmo dalla Legge che il Cristo (Messia) permane in eterno, e come tu dici che dev’essere innalzato il figlio dell’uomo? Chi e questo figlio dell’uomo?». Dalle sacre Scritture (Legge) risultava infatti che il regno del Messia sarebbe stato eterno; Gesù invece diceva che egli sarebbe stato innalzato ossia, come interpretavano essi, «assunto» in cielo: dunque il suo regno, qui su questa terra, non sarebbe durato in eterno. Inoltre, quel titolo di «figlio dell’uomo» non era chiaro per quegli ascoltatori, i quali forse conoscevano poco o nulla il libro di Daniele (§ 81); essi quindi si sentivano dubbiosi e aspettavano luce da Gesù. Gesù invece questa volta non si estese in spiegazioni, o almeno esse non ci sono tramandate; ci viene trasmesso soltanto ciò che sembra una sua generica esortazione conclusiva. Disse pertanto ad essi Gesù: «Ancora (per) piccolo tempo la luce è in voi. Camminate mentre avete la luce, affinché tenebra non vi sorprenda; e chi cammina nella tenebra non sa dove va. Mentre avete la luce credete nella luce, affinché diveniate figli di luce». Mentre Gesù pronunziava queste parole, calavano le prime ombre del vespero, dicendoci espressamente san Marco (11, 11) che «tarda era già l’ora»; perciò le parole, mentre convenivano spontaneamente con le circostanze della giornata solare, si riferivano in realtà alla giornata della vita di Gesù e alla sua luce spirituale che era vicina al tramonto. Quando l’ultimo chiarore di quella giornata trionfale fu spento, Gesù con gli Apostoli fece il cammino inverso da Gerusalemme a Bethania, ove passò la notte (Marco, ivi; Matteo, 21, 17; cfr. Giovanni, 12, 36).

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, nel lungo mese di agosto abbiamo preferito pubblicare sul sito numerose preghiere al Santo del giorno, infine molti opuscoli e libretti di fine 1800 e della prima metà del 1900. Si tratta di esili letture di fede e morale, sempre attuali, caratterizzate da chiarezza e praticità, che gli editori cattolici usavano pubblicare e diffondere in maniera capillare prima del funesto Vaticano Secondo e, dunque, prima della progressiva eliminazione della buona stampa. Segue l’indice alfabetico delle devozioni e degli articoli pubblicati (leggibili visitando la pagina Tag numero 172): 1) Altra preghiera a San Rocco, Confessore (16.8); 2) Breve saggio su denatalità, darwinismo e malthusianesimo; 3) Il latino: lingua viva nella Chiesa (del Card. Antonio Bacci); 4) Il Sillabario del buon Chierichetto (Imprimatur 1957); 5) L’alcool, ecco il nemico! 6) L’uso del latino per preservare e trasmettere la fede; 7) La bestemmia (per l’Abate Isidoro Mullois); 8) La moda femminile. La tua vita quale fine ha?; 9) Novena alla B. V. Maria Assunta in Cielo (dal 6 al 14 agosto); 10) Orazione a San Bernardo da Chiaravalle (20.8); 11) Orazione ai Santi Ippolito e Cassiano, Martiri (13.8); 12) Orazione ai Santi Tiburzio e Susanna, Martiri (11.8); 13) Orazione alla Madonna della neve (5.8) - Breve storia; 14) Orazione per la Trasfigurazione di Nostro Signore (6.8); 15) Orazioni a San Donato, Vescovo e Martire (7.8); 16) Preghiera a San Filippo Benizzi, Confessore (23.8); 17) Preghiera a San Giacinto, Confessore (17.8); 18) Preghiera a San Rocco, Confessore (16.8); 19) Preghiera a Santa Giovanna Francesca Frémiot de Chantal, Vedova (21.8); 20) Preghiera a Santo Stefano Protomartire (3.8); 21) Preghiera ai Santi Abdon e Sennen, Martiri (30.7); 22) Preghiera ai Santi Martiri Ciriaco, Largo e Smaragdo (8.8); 23) Preghiera del buon soldato a Sant’Ignazio di Loyola (31.7); 24) Un Cattolico può farsi protestante? (di Mons. de Ségur); 25) Vademecum del giovane per ben passare le vacanze.
• San Giovanni Bosco, per far comprendere ai suoi giovani i pericoli delle vacanze, soleva dir loro che esse sono come la vendemmia del demonio. E Sant’Agostino narra di se stesso nel libro delle Confessioni, che appunto durante le vacanze ebbe principio la sua vita peccaminosa. Sextodecimo aetatis anno, ubi interposito otio, cum parentibus esse coepi, excesserunt caput meum vepres libidinum - «Quando però nel corso di quel sedicesimo anno tornai presso i miei genitori e dalle strettezze della famiglia fui ridotto all’ozio, senza alcun impegno scolastico, i rovi della libidine crebbero oltre il mio capo senza che fosse là una mano a sradicarli» (Confessioni, lib. II, cap. 3, ndr). Le vacanze sono occasione di ozio e vendemmia del demonio. Camminiamo dunque a testa bassa, vestiamoci dignitosamente e prestiamo attenzione all’igiene, mangiamo poco e conserviamoci sobri, possibilmente fuggiamo le occasioni mondane, preghiamo più del solito, teniamoci impegnati con letture di buona stampa e lavori domestici, andiamo a Messa, non perdiamo i contatti con il Sacerdote.
• Argomento di studio del giorno è L’ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme, secondo i preziosi studi dell’Abate Giuseppe Ricciotti. § 503. A Gerusalemme si riseppe subito che Gesù era giunto a Bethania; il suo arrivo colà poté essere comunicato tanto da pellegrini, i quali nel venerdì avessero fatto il viaggio da Gerico a Bethania insieme con lui (§ 501), quanto da spie del Sinedrio le quali ottemperassero all’ordine emanato da quel consesso di segnalare ove si trovasse Gesù (§ 495). La notizia fece impressione in città. Forse anche prima che il riposo sabbatico cominciasse, e certamente appena esso fu terminato, molti curiosi corsero da Gerusalemme a Bethania, spinti dal doppio motivo di vedere sia Gesù che Lazaro, l’uno vicino all’altro, tanto più che il primo non s’era più lasciato vedere in città dopo la resurrezione del secondo. «Riseppe pertanto la gran folla dei Giudei che (Gesù) è lì, e vennero non per Gesù solo ma anche per vedere Lazaro, che (egli) aveva risuscitato dai morti». Durante questa affluenza si ripeté più ampiamente quel che era avvenuto subito dopo la resurrezione di Lazaro, cioè che molti si arresero all’evidenza del miracolo e credettero in Gesù. Anche questo risultato fu subito risaputo in Gerusalemme; e allora i sommi sacerdoti, confermandosi nel proposito di mettere a morte Gesù, «per giunta deliberarono di uccidere anche Lazaro» (Giovanni, 12, 10), inviando così di nuovo all’altro mondo quel testimonio che ne era tornato per scandalizzare l’ortodossia giudaica. Certamente il rimedio era, o sembrava, decisivo: uccisi Gesù e Lazaro, la commozione suscitata tra il popolo dal predicatore Galileo si sarebbe senz’altro calmata. Ma l’esecuzione del progetto era resa difficile, oltreché dall’affluenza dei pellegrini pasquali, anche dalla commozione popolare, da cui potevano sorgere reazioni violente e complicazioni con l’autorità romana che si volevano evitare ad ogni costo. Comincia perciò da questo momento un periodo di vigile attesa in cui le autorità del Tempio tengono continuamente d’occhio Gesù, finché si presenti una circostanza favorevole per eseguire il loro progetto senza fastidiose conseguenze; dal canto suo Gesù prosegue nella linea di condotta tracciatasi indipendentemente dalle circostanze esteriori, e come non paventa le mene del Sinedrio, così non cura il favore delle folle, sebbene da queste egli sia momentaneamente protetto. Durante questa attesa, la prima mossa è fatta da Gesù che, recandosi direttamente verso il pericolo, parte da Bethania alla volta di Gerusalemme.
• § 504. Era la mattina della domenica. A Bethania in quel mattino e nella sera precedente s’erano radunati attorno a Gesù molti fervorosi, sia conterranei della Galilea giunti in pellegrinaggio pasquale, sia cittadini di Gerusalemme testé convinti dal miracolo di Lazzaro: ed era una folla vibrante, che non poteva trattenersi da qualche manifestazione solenne in onore di Gesù. Anche le circostanze si presentavano propizie, giacché era abitudine che i cittadini uscissero incontro ai gruppi di pellegrini più numerosi o importanti, e tutti uniti entrassero in città fra canti e manifestazioni di gioia; quando dunque il maestro avesse manifestato l’intenzione di riprendere il cammino per Gerusalemme, era più che giusto preparargli un solenne ingresso nella città: anche se egli si fosse mostrato riluttante come nel passato, la manifestazione solenne era necessaria questa volta dopo i fatti di Bethania e di Gerusalemme, ed il maestro avrebbe dovuto tollerarla suo malgrado. E invece, contro ogni previsione, Gesù questa volta non si mostrò riluttante. Manifestata l’intenzione di recarsi a Gerusalemme quella mattina stessa, egli scelse la strada più breve e frequentata la quale da Bethania risaliva sul monte degli Olivi, ne discendeva lungo il versante occidentale, e infine si congiungeva con la città presso l’angolo nord-orientale del Tempio dopo un percorso di circa 2.800 metri (§ 490); lungo questo percorso si passava vicino all’antico villaggio chiamato Bethphage, «casa dei fichi [immaturi]», ch’è considerato dal Talmud già come sobborgo di Gerusalemme, e stava certamente vicino al luogo ch’è ritenuto oggi come Bethphage ed è situato a meno di un chilometro a nord-ovest di Bethania. Partita da Bethania la comitiva risaliva festosa verso la sommità del monte degli Olivi ed era già in vista di Bethphage, quando Gesù dette un ordine che colmò di gioia tutti i presenti; chiamati due dei suoi discepoli, disse loro: «Andate al villaggio che vi sta dirimpetto e subito entrativi troverete un asinello legato sul quale nessun uomo sedette giammai; scioglietelo e conducete(lo). E se alcuno vi dica: “Perché fate questo?” dite: “Il Signore ne ha bisogno, e subito lo manda di nuovo qui”». L’asino era in Palestina la cavalcatura delle persone autorevoli fin dai tempi di Balaam (Numeri, 22, 21 segg.), e Gesù, ricercando in questa occasione tale cavalcatura, mostrò di voler assecondare i festosi desideri della comitiva, che ne fu felicissima. Ma la mira di Gesù era anche più lontana; San Matteo, nella sua speciale cura di rilevare l’avveramento delle profezie messianiche, fa notare che allora s’adempì la predizione dell’antico profeta Zacharia (9, 9), secondo cui il re di Sion sarebbe venuto a lei mansueto cavalcando un’asina e un asinello - [Doppia menzione presente nel testo ebraico di Zaccaria che non allude a due animali differenti, ma ad uno solo: essa è un semplice effetto della ripetizione voluta dal parallelismo, suprema legge del verso ebraico - nota 1 pag. 605]: perciò anche il solo Matteo ricorda che là, a Bethphage, nel luogo indicato da Gesù stavano legati l’asinello e sua madre e che ambedue furono recati a Gesù, mentre gli altri Evangelisti menzionano soltanto l’asinello sul quale effettivamente cavalcò Gesù. I due discepoli eseguirono l’ordine; mentre scioglievano i due animali, i padroni ne richiesero la ragione e, udito che servivano a Gesù, non replicarono: probabilmente erano persone amiche della famiglia di Lazaro, e quindi benevole verso Gesù. All’arrivo dei due animali la comitiva non si contenne più. Con quella cavalcatura si poteva compiere un vero ingresso trionfale nella città; se l’asinello non aveva ancora servito da cavalcatura a nessuno, tanto più era indicato a trasportare per la prima volta una persona sacra come Gesù, giacché agli antichi sembrava che un animale già adibito a servizi profani fosse meno atto ad usi religiosi. Il corteo fu subito composto. Alcuni gettarono i loro mantelli sull’asinello a guisa di sella e di gualdrappa, e poi vi fecero salire Gesù; altri, correndo un poco sul davanti, stendevano di tratto in tratto i mantelli sul suolo affinché il cavalcatore vi passasse sopra come su tappeti; moltissimi altri accorrevano lungo la strada man mano che il corteo si avvicinava alla città, gettavano frasche verdi lungo il percorso e agitavano festosi rami di palme staccati dagli alberi dei dintorni: tutti poi gridavano alla rinfusa: «Osanna! Benedetto il Veniente in nome del Signore! Benedetto il veniente regno del nostro padre David! Osanna negli eccelsi» (Marco, 11, 9-1 0).
• § 505. La focosità orientale divampava pienamente in queste grida: ma vi divampava anche la spasmodica attesa che quegli osannanti avevano conservata e repressa nei loro cuori per tanto tempo, l’attesa del regno messianico. I termini impiegati sono tipici: «il Veniente in nome del Signore è il Messia» (§ 339), e «il veniente regno di David è il regno messianico che è inaugurato dal Messia figlio di David». Le insegne di questo inizio di regno erano certamente modestissime, un asinello e quattro rami di palma; ma in ciò non trovavano scandalo quegli entusiasti, i quali erano fermamente sicuri che da un giorno all’altro l’asinello sarebbe stato sostituito da falangi di superbi destrieri e le palme da una selva di ben polite lance [Polito = da una naturale levigatezza o da una rifinitura ottenuta con industria scrupolosa, ndr]. Il padre David dal suo sepolcro e il Dio Jahvè dal cielo avrebbero compiuto questo miracolo in favore del loro Messia. Precisamente questo è il punto ove s’incontrarono, in maniera fugace e quasi fortuita, il messianismo delle plebi e quello di Gesù. Per le plebi quell’ingresso trionfale in Gerusalemme doveva essere la prima favilla d’un immenso incendio futuro: per Gesù era la sola ed unica pompa ufficiale della sua regalità messianica. Quella regalità, da lui nascosta con tanta cura e confidata con tante precauzioni e rettifiche solo ai suoi più intimi, doveva pure essere manifestata ufficialmente almeno una volta, adesso che il tempo stringeva e che l’erronea interpretazione politica aveva scarse probabilità d’attecchire; ebbene, questa appunto valeva come manifestazione ufficiale e solenne e in corrispondenza dell’antica profezia di Zacharia, ma tutto sarebbe finito lì, in quell’asinello contornato da qualche centinaio di osannanti: subito dopo, tutto sarebbe rientrato in ciò che gli uomini chiamavano ombra, ma che per il regno di Dio era notte d’operosità recondita (§ 369). Gesù, insomma, finiva dove le plebi credevano di cominciare. Un quarantennio più tardi un Giudeo rinnegato, Flavio Giuseppe, impiegherà lunghe pagine per descrivere un altro ingresso trionfale a cui aveva assistito egli stesso (Guerra giud., VII, 120-162), come gli Evangelisti a quello di Gesù; senonché le due narrazioni sembrano scritte apposta per contrapporsi l’una all’altra. Quella del Giudeo rinnegato descrive il trionfo di chi ha distrutto poco prima Gerusalemme, ed entra nella Roma pagana fra un apparato d’incredibile splendore e potenza; la narrazione degli Evangelisti descrive il trionfo di chi sarà il distruttore della Roma pagana, e adesso entra in Gerusalemme fra un apparato umilissimo e piangendo sulla prossima distruzione di questa città. Il trionfatore di Roma conclude la sua pompa uccidendo ai piedi del Campidoglio il condottiero dei nemici, trascinato in catene dietro al corteo: il trionfatore di Gerusalemme finisce con l’essere ucciso lui stesso, dopo il suo trionfo d’un giorno. A Roma, dopo i festeggiamenti, si gettano le fondamenta di un nuovo tempio idolatrico dedicato alla Pace romana; a Gerusalemme si annunzia che il Tempio manufatto del Dio vivente sarà ridotto a un cumulo di macerie, e si gettano invece le fondamenta di un Tempio non manufatto (Marco, 14, 58) ove si adorerà il Dio vivente in spirito e verità (§ 295). Esiste tuttavia un punto importantissimo in cui le due narrazioni, così discordi, concordano, ed è nell’affermare che il rispettivo trionfatote è il Messia: per gli Evangelisti il Messia è Gesù, il carpentiere di Nazareth; per il Giudeo rinnegato il Messia è Tito Flavio Vespasiano, agricoltore nato a Falacrine presso Rieti l’anno 9 dopo Cristo (§ 83). Confrontando oggi ciò che rimane dei due trionfi bisogna concludere che il Giudeo, mal consigliato dalla sua apostasia, è caduto in un grave errore.
• § 506. Sebbene umilissimo, il trionfo di Gerusalemme fu cordiale, certamente più di quello di Roma. Giovanni (12, 16 segg.) c’informa che la cordialità fu grande anche da parte di quei cittadini di Gerusalemme i quali erano stati testimoni della resurrezione di Lazzaro o ne avevano udito il racconto dai testimoni; la cordialità dei discepoli senza dubbio era egualmente grande, tuttavia era animata da motivi superficiali e ignara delle ragioni profonde di ciò che avveniva, perché a detta dello stesso Evangelista «queste cose i suoi discepoli non conobbero dapprima; ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e queste cose (essi) fecero a lui». Insomma, l’entusiasmo dei discepoli era troppo sotto l’influenza dell’entusiasmo delle folle per assurgere a considerazioni più alte e più spirituali circa quel brevissimo trionfo umano del loro maestro. Ma il carattere trionfale della manifestazione fu difeso fermamente da Gesù stesso. Poiché i Farisei rimanevano sempre Farisei anche in mezzo all’entusiasmo generale, e d’altra parte vedevano bene che sarebbe stato troppo pericoloso dar sulla voce a quella folla infervorata, alcuni di essi pensarono di ricorrere a Gesù stesso e gli dissero: «Maestro, sgrida i tuoi discepoli!», quasicché gli artefici più numerosi di quella manifestazione fossero i discepoli e non piuttosto i Giudei testimoni della resurrezione di Lazaro. Ma Gesù risponde: «Vi dico, se questi taceranno, le pietre grideranno» (Luca, 19, 40). La protesta fu rinnovata di lì a poco quando, entrato Gesù nel Tempio, frotte di fanciulli accorsi tra la calca si dettero a gridare: «Osanna al figlio di David!» sotto il naso dei sommi sacerdoti e degli Scribi. Queste degnissime persone, irritate dalle grida di quei mocciosi, protestarono verso Gesù: «Senti che dicono costoro?». Questa volta Gesù rispose: «Si. Non leggeste mai (quel passo) “Da bocca di bambini e di lattanti esprimesti laude”?» (Matteo, 21, 16). Il passo citato (Salmo 8, 3) era opportunissimo, perché ivi il poeta contrappone l’ingenua laude innalzata a Dio da bambini e da lattanti al silenzio forzato dei suoi nemici: se dunque i fanciulli del Tempio erano gli esprimenti laude a Dio, i sacerdoti e gli Scribi potevano facilmente riconoscersi nei nemici di Dio ridotti al silenzio. Queste risposte di Gesù e il suo incontrastato trionfo dovettero far perdere il lume degli occhi ai Farisei. Fatto un bilancio di quanto avevano ottenuto con tutte le loro deliberazioni d’impadronirsi di Gesù, di farlo denunziare dalle spie, di metterlo a morte insieme con Lazaro, essi si ritrovarono in pieno fallimento: Gesù circolava a piede libero e in Gerusalemme stessa, la sua vita e quella di Lazaro erano salvaguardate dal fervore popolare, egli faceva sempre più seguaci e ardiva perfino entrare trionfalmente nella città santa. Gli stessi Farisei riconobbero questo loro fallimento e si dissero gli uni agli altri: «Vedete che non ricavate alcuni profitto? Ecco, il mondo andò appresso a lui!» (Giovanni, 12, 19). Tuttavia questa confessione non fu una capitolazione, anzi fu una conferma d’ostilità implacabile, in attesa che si presentasse l’occasione propizia per agire. Frattanto il corteo trionfale di Gesù aveva valicato la sommità del monte degli Olivi e discendeva lungo la china occidentale dirigendosi al sottostante Tempio. Da quella china si contemplava il panorama dell’intera città: era la città uscita un trentennio prima dalle mani di quell’infaticabile ricostruttore ch’era stato Erode il Grande, meno gravata di memorie e meno solenne della città odierna ma incomparabilmente più decorosa e più adorna. Ai piedi del monte, subito oltre il torrente Cedron, s’ergeva la mole grandiosa del Tempio sfavillante di ori e abbagliante di candidi marmi. Ricongiunto a settentrione con esso s’alzava il possente quadrilatero della torre Antonia, allora stazione della guarnigione romana e quasi dimora di falco che vigilasse sulla preda (§ 49). Al lato opposto, verso occidente, troneggiava la reggia di Erode, difesa a settentrione da quelle tre torri che l’esperto Tito un quarantennio dopo avrebbe giudicato inespugnabili. Due recinti di mura proteggevano a settentrione la città, e di là dal recinto più esterno si estendeva il sobborgo del Bezetha (§ 384) che un decennio più tardi Agrippa I comincerà a recingere con un «terzo muro». Qua e là, fra la distesa di case antiche, spiccavano parecchie suntuose costruzioni recenti, mentre il quartiere più negletto appariva quello che occupava la parte sud-orientale della città, immediatamente più in giù del Tempio, ove era stata la Gerusalemme primitiva dei Jebusei, di David e di Salomone. Al contemplare questo panorama, Gesù pianse.
• § 507. Quel pianto, fra tante grida festose e davanti a uno spettacolo così solenne era davvero inaspettato. I discepoli ne dovettero rimanere sconcertati, e forse si domandarono in cuor loro se anche quel pianto voleva essere uno dei soliti correttivi messianici già applicati dal maestro (§ § 400, 475, 495). La ragione fu comunicata dal piangente stesso, che rivolgendosi alla città contemplata esclamò: «Oh! avessi conosciuto in questo giorno anche tu le cose (necessarie) alla pace! Adesso invece stanno nascoste agli occhi tuoi! Poiché verranno su te giorni quando i tuoi nemici ti ricingeranno di vallo, e ti accerchieranno all’intorno, e ti stringeranno da ogni parte, e abbatteranno te e i tuoi figli dentro te, e non lasceranno pietra sopra pietra in te, perché non conoscesti il tempo (propizio) della visita (fatta) a te» (Luca, 19, 42-44). Il pianto dunque si riferiva non al presente ma ad un futuro più o meno remoto. Tutti sanno che queste parole si riferiscono al terribile assedio che Tito mise nel 70 a Gerusalemme. Il «vallo» qui accennato è il muro di circonvallazione lungo 39 stadi (chilometri 7,215) costruito dalle legioni romane in soli tre giorni attorno alla città per prenderla con la fame: esso si trova minutamente descritto da Flavio Giuseppe (Guerra giud., V, 502-511) e se ne sono rinvenute recentemente alcune probabili tracce; è anche da notare che il vallo, nella sua parte ad oriente della città, saliva dal torrente Cedron verso il monte degli Olivi (ivi, 504), dove appunto si trovava Gesù quando pianse. È superfluo dire che una predizione cosi precisa è giudicata assurda dai razionalisti, i quali perciò affermano che queste parole non furono mai pronunziate da Gesù ma sarebbero un’invenzione dell’Evangelista il quale avrebbe scritto dopo la catastrofe del 70; in attesa che questa affermazione sia suffragata da prove storiche, le quali non siano la monotona “impossibilità” del miracolo, si può passare ad un altro riavvicinamento offertoci egualmente da Flavio Giuseppe - [Ricciotti, come d’abitudine, sarcasticamente deride questi razionalisti (e modernisti) ciarlatani, ndr]. Racconta egli (ivi, VII, 112-113) che Tito, alcuni mesi dopo aver distrutto Gerusalemme, da Antiochia passò in Egitto, e che, «strada facendo, si recò a Gerusalemme; confrontando egli allora la mesta solitudine che scorgeva con la passata magnificenza della città, e richiamando alla mente sia la grandezza degli edifici ruinati sia l’antica bellezza, deplorò la distruzione della città, non già vantandosi, come altri (avrebbe fatto), d’averla espugnata pur essendo sì grande e sì forte, bensì maledicendo spesso i colpevoli che avevano iniziato la rivolta e attirato sulla città quella punizione». Cosicché, Gesù e Tito concordano nel far ricadere la responsabilità della distruzione su determinati uomini e nell’affermare che la distruzione non sarebbe avvenuta se la condotta di quegli uomini fosse stata diversa: ma Gesù, giudeo e adoratore del Dio Jahvè, versa anche brucianti lacrime sulla distruzione della sua città e del suo Tempio, mentre Tito, romano e cultore del Giove Capitolino, deplora la perdita di sontuosi edifici e di belle opere d’arte; l’uno piange sulla rovina spirituale, l’altro rimpiange la rovina materiale; ma soprattutto l’uno piange sulla città che lo ucciderà fra pochi giorni, l’altro rimpiange la sorte della città che egli stesso ha distrutto e dove è stato proclamato imperatore mentre il Tempio era tuttora in fiamme.

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, il motto del nostro settimanale è «Chi prega si salva, chi non prega si danna», massima che abbiamo attinto dagli insegnamenti di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Le nostre naturali forze non sono sufficienti poiché il nemico non è di sangue e carne (Ef. VI, 12), dunque dobbiamo pregare e molto: secondo le prudenti direttive del confessore. Sul sito stiamo quotidianamente aggiornando la sezione «Preghiere» (cliccare qui), dove è possibile reperire l’orazione al Santo del giorno e numerose altre pie devozioni. Si tratta di una raccolta assolutamente cattolica, quindi non troverete testi ecumenici, preghiere con errori dottrinali e falsi santi. Vi esortiamo a consultare spesso il sito internet e soprattutto questa sua sezione dedicata alla preghiera.
• L’Abate Ricciotti - riposi in pace! - oggi ci parla di Gesù al convito di Bethania. § 501. Risalendo da Gerico verso Gerusalemme, Gesù doveva passare necessariamente per Bethania, da cui si era allontanato poche settimane prima. Ivi egli giunse sei giorni prima della Pasqua (Giovanni, 12, 1), cioè in un sabbato; poiché il tragitto da Gerico a Bethania (§§ 438, 489 segg.) era così lungo che non sarebbe stato permesso in un giorno di sabbato, Gesù probabilmente viaggiò nel venerdì precedente per giungere a Bethania sul tramonto, quando cominciava ufficialmente il sabbato. Anche qui l’indicazione di Giovanni vuole precisare ciò che i precedenti Sinottici hanno lasciato nel vago: attenendosi infatti a Matteo (26, 6 segg.) e a Marco (14, 3 segg.) sembrerebbe che questa visita a Bethania fosse avvenuta più tardi, il mercoledì successivo: ma questo ritardo della narrazione presso di loro è dovuto alla mira di far risaltare la relazione tra le parole pronunziate a Bethania da Giuda e il suo successivo tradimento. Con la venuta a Bethania sembrava che Gesù si offrisse da se stesso al pericolo: i suoi nemici, che poco prima avevano deciso la sua morte e ordinato il suo arresto (§ § 494, 495), erano là ad una passeggiata da Bethania e potevano essere informati subito ed agire. Il pericolo indubbiamente esisteva, tuttavia era meno immediato di quanto apparisse: in primo luogo dopo l’ordine di arresto Gesù era scomparso, e quindi i primi bollori si erano alquanto raffreddati, salvo a riaccendersi se Gesù fosse ricomparso; inoltre, oramai si era in piena preparazione pasquale, a Gerusalemme giungevano ad ogni ora folle di Giudei di tutte le regioni e quindi anche di conterranei e ammiratori di Gesù, e non era opportuno provocare un tumulto procedendo contro di lui con la città così affollata. Ad ogni modo i Sinedristi ed i Farisei, non dimentichi affatto della loro decisione, si sarebbero regolati con prudenza a seconda delle circostanze; frattanto i comuni Giudei della capitale, incuriositi, aspettavano di vedere come si sarebbe svolta la lotta e se sarebbe prevalso il Sinedrio oppure Gesù. A Bethania Gesù dovette trovare accoglienze trionfali, provocate certamente dal ricordo della recente resurrezione di Lazaro. La sera di quel sabbato fu tenuto un convito in suo onore in casa di un certo Simone soprannominato il Lebbroso, ch’era senza dubbio uno dei più facoltosi della borgata, e doveva il suo soprannome alla malattia da cui era guarito, forse per intervento di Gesù. Fra gli invitati non poteva mancare, e difatti non mancò, Lazaro; sua sorella, la massaia Marta, dirigeva il servizio; l’altra sorella Maria, meno esperta di faccende domestiche, provvide da se stessa a portare un contributo d’onore al convito. Come i convitati erano sdraiati su divani con il busto verso la tavola comune e i piedi all’in fuori nella maniera che già dicemmo (§ 341), Maria ad un certo punto del convito entrò recando uno di quei vasi d’alabastro dal collo allungato, in cui gli antichi usavano conservare essenze odorose di gran pregio: la ragione è data da Plinio quando dice che l’alabastro cavant ad vasa unguentaria, quoniam optime servare incorrupta dicitur (Natur. hist., XXXVI, 12). Il vaso recato da Maria conteneva una libbra, cioè 327 grammi, di «nardo autentico di gran valore». L’aggettivo «autentico», come dice il greco «di fiducia», è opportuno, perché il citato naturalista romano ricorda che l’unguento di nardo si adulterava facilmente, adulteratur et pseudonardo herba quae ubique nascitur (ivi, XII, 26). E come genuino, il nardo di Maria era «di gran valore»: Giuda, che doveva intendersi di prezzi, lo valutò «a più di 300 denari», cioè a più di 320 lire in oro; Plinio (ivi) dice che in Italia il nardo costava 100 denari la libbra, e altre specie meno pregiate anche meno: tuttavia egli stesso ricorda altrove (ivi, XIII, 2) unguenti che costavano da 25 a 300 denari la libbra. Maria pertanto, giunta al divano di Gesù, invece di sciogliere il sigillo apposto sull’orifizio del vaso ne spezzò il collo allungato, in segno di maggiore dedizione, e ne effuse abbondantemente l’essenza profumata dapprima sul capo di lui e poi il rimanente sui suoi piedi: egualmente in segno di particolare omaggio, asciugò ella con i propri capelli i piedi profumati del maestro, imitando in parte l’antica peccatrice innominata (§ 341). E la casa fu piena del profumo dell’unguento.
• § 502. L’atto compiuto da Maria non era insolito: ad ospiti insigni invitati a banchetto si offrivano, dopo la lavanda di mani e piedi, squisiti profumi di cui cospargersi. E tanto più questa finezza era naturale in Maria in quanto la usava verso colui che aveva risuscitato il fratello, anche se per compierla ella impiegava una quantità di essenza veramente straordinaria; ma l’esuberanza della materia testimoniava l’esuberanza del sentimento interno. Questa prodigalità sorprese taluni discepoli, e più di tutti il loro amministratore comune che era Giuda l’Iscariota (§ 313); costui, come avverte in maniera distinta San Giovanni (mentre gli altri Evangelisti parlano di discepoli in genere), protestò apertamente pur sotto la parvenza di beneficenza: «Perché si è fatto questo scempio d’unguento? Si poteva infatti vendere questo unguento per più di 300 denari, e dare ai poveri!» (Marco, 14, 4-5). Ma alla protesta di Giuda l’Evangelista Giovanni, non meno pratico che spirituale, fa seguire una sua riflessione: «Disse però questo, non perché gl’importava dei poveri, ma perché era ladro, e avendo (egli) la cassetta asportava le cose messevi (dentro)» (Giovanni, 12, 6). Da questa notizia apprendiamo che il gruppetto dei seguaci abituali di Gesù faceva vita comune, senza dubbio insieme col maestro, e tutti mettevano i personali proventi in comune depositandoli in una cassetta; questa era affidata a Giuda, il quale fungeva da amministratore e certamente sarà stato coadiuvato occasionalmente da quelle pie donne che, di tempo in tempo secondo le loro possibilità, seguivano il gruppo di Gesù incaricandosi dell’assistenza materiale (§ 343). Ma «Giuda era ladro, e sottraeva il denaro dalla cassetta». Ora, questo furto continuato difficilmente poteva essere riscontrato dagli altri Apostoli, i quali erano totalmente occupati nel ministero spirituale e per le cose materiali si rimettevano in tutto a Giuda; invece appunto le pie donne avevano ogni facilità di riscontrare il furto perché, occupandosi delle spese e fornendo esse stesse buona parte del denaro, potevano seguire a un dipresso le entrate e le uscite della «cassetta» ed avvedersi delle sottrazioni più notevoli. Forse di tali sottrazioni avevano esse informato gli altri Apostoli e Gesù stesso; e da allora l’amministratore infedele fu guardato con occhio d’accorata pietà, ma silenziosamente fu lasciato ancora nel suo ufficio per la speranza che egli, non svergognato, rinsavisse. Qui invece Giuda si mostra incancrenito: «più di 300 denari» era una somma cospicua, quasi un anno intero di salario d’un operaio (§ 488), e il ladro al vedersi sfumare questa bella entrata scatta allegando il pretesto dei poveri. Il seguace di Mammona vuol conservare ancora la divisa esteriore di seguace di Dio (§ 485). [Oggigiorno non credo si faccia fatica a fare la stessa riflessione su quei farisei ereticoni dei modernisti, usurpatori e ladri dei beni della Chiesa, dietro pretesto di “carità” e pur non avendo assolutamente la fede cattolica: predicano difatti ecumenismo e liberalismo, che sono insieme apostasia e negazione del dogma cattolico, ndR]. Alla protesta di Giuda, Gesù rispose: «Lasciala (fare)! Che lo serbi (= che valga come riserbato) per il giorno del mio seppellimento! I poveri infatti sempre avete con voi, me invece non avete sempre» (Giov., 12, 7-8; cfr. Matteo, 26, 10-13; Marco, 14, 6-9). Per Gesù, dunque, l’unzione da lui testé ricevuta valeva come un’anticipazione del suo imminente seppellimento, giacché le salme si deponevano nella tomba cosparse di aromi e di essenze profumate. Ma anche da questo nuovo annunzio pare che gli Apostoli non si convincessero dell’imminente morte di Gesù: tranne forse Giuda che, da buon finanziere umano, previde la bancarotta altrui e dovette da allora pensare direttamente ai casi propri.

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, abbiamo in giacenza ancora alcune copie dei libri «Racconti miracolosi» (del P. Giacinto da Belmonte) e «L’inferno» (di Mons. Gaston de Ségur). Si tratta di due libri formativi scritti da autori di provata fede e di cristallina dottrina: Che Dio li abbia in gloria! Vogliate cortesemente contribuire al sostentamento della nostra piccola Associazione acquistando - secondo le Vostre possibilità e con donazione spontanea - una o più copie. Come di consueto, oltre al libro verranno inseriti nel plico GLS anche l’antico santino per seguire la Santa Messa ed alcune copie di Sursum Corda. Il ricavato sarà utilizzato soprattutto per finanziare la stampa delle prossime novità editoriali. È possibile usare la sezione «Sostienici» del sito, in questo momento attiva e funzionante per la nostra sporadica raccolta fondi.
• Veniamo all’abituale spiegazione della Sacra Scrittura secondo le istruzioni dell’Abate Giuseppe Ricciotti. § 499. Probabilmente l’ammenda di Zaccheo e la risposta di Gesù avvennero durante un banchetto offerto dal capo pubblicano al suo ospite. Vi avranno partecipato, oltre ai discepoli di Gesù, anche altri suoi ammiratori che s’aspettavano da lui grandi cose: e un fremito ansioso doveva passare a ondate in quella sala, ove a mezza voce si sentiva parlare di regno di Dio, di Messia glorioso, di travolgenti vittorie, di tribunali giudicanti, di fulgidi troni e di cortigiani gloriosi e beati; se ne parlava, tuttavia, con qualche prudenziale riserbo per non dispiacere al maestro, giacché tutti sapevano ch’egli - chissà per quali sue recondite ragioni - disapprovava quei ragionamenti e sostituiva a quelle prospettive così rosee altre prospettive altrettanto lugubri (ne abbiamo parlato a proposito delle «Rettificazioni messianiche», ndR). Eppure, senza alcun dubbio, oramai si era alla vigilia di fatti decisivi; tutto induceva a credere che da un giorno all’altro la potenza taumaturgica del maestro si sarebbe dispiegata in pieno, lo stato delle cose sarebbe stato totalmente mutato e il regno di Dio palesemente inaugurato. Da alcune finestre della sala si scorgeva forse la suntuosa reggia ricostruita da Archelao: e taluni di quegli infervorati dovettero ripensare all’effimero ed oscuro principato di quel tetrarca (§ 14), contrapponendogli in cuor loro lo stabile e glorioso regno che il Messia Gesù avrebbe inaugurato di lì a pochi giorni. Gesù in parte udì le sommesse parole, e per il resto comprese da sé lo stato d’animo dei presenti; perciò «disse una parabola, perché egli era vicino a Gerusalemme e quelli credevano che il regno d’Iddio stava per apparire subito» (Luca, 19, 11). La parabola fu la seguente. Un uomo nobile partì per una regione lontana, onde ricevere l’investitura di un regno e poi ritornare quale re effettivo del luogo di partenza. Per non lasciare inoperoso il proprio denaro durante la sua assenza, consegnò una mina - cioè un po’ più di 100 lire in oro - a ciascuno dei dieci suoi servi con l’incarico che la commerciassero fino al suo ritorno. Senonché i suoi cittadini lo odiavano, e mandarono dietro a lui una loro propria ambasceria che dicesse a colui che doveva concedere l’investitura: «Non vogliamo che costui regni su di noi!». Tuttavia l’investitura fu concessa, e l’uomo nobile tornò quale re effettivo. Questa “premessa” della parabola è cavata dalla realtà storica; già notammo che essa corrisponde esattamente al viaggio che un trenta anni prima Archelao aveva fatto a Roma per ricevere da Augusto l’investitura dei suoi dominii, e inoltre anche alla delegazione di cinquanta Giudei che fu inviata da Gerusalemme dietro a lui e contro di lui (§13). Si abbia anche presente che, mentre Gesù parlava e gli altri l’ascoltavano, gli occhi di tutti potevano benissimo posarsi sulla reggia dello stesso Archelao rimasta vuota a Gerico. Tornato il nuovo re, domandò i conti ai servi a cui aveva affidato le mine. Si presentò per primo un servo che con la mina consegnatagli ne aveva guadagnate altre dieci; il re lo lodò perché era stato fedele nel pochissimo, e lo ricompensò dandogli il governo di dieci città. Si presentò un secondo che aveva guadagnato altre cinque mine, e costui fu ricompensato col governo di cinque città. Venne poi un terzo che disse: «Signore, rieccoti la tua mina che io ho tenuta riposta in un fazzoletto; ho avuto infatti paura di te che sei severo, ritiri ciò che non hai depositato e mieti dove non hai seminato!». Evidentemente questo servo non aveva acconsentito all’ambasceria ostile inviata dietro al pretendente al regno, ma neppure aveva fatto alcunché in favore di lui; conoscendolo per altro come molto esigente, aveva conservato tale quale la somma affidatagli, cosicché il futuro re non avrebbe potuto accusarlo d’infedeltà e di furto. Ma il re gli rispose: «Dalla tua bocca ti giudico, servo malvagio! Sapevi che io sono uomo austero, che tolgo ciò che non ho depositato e mieto ciò che non ho seminato? E perché non consegnasti il mio argento alla banca, ché io ritornato l’avrei riscosso con interesse?». Voltosi poi agli astanti comandò: «Toglietegli la mina, e datela a quello che ne ha dieci!». - Gli fu fatto osservare: «Ma, signore, quello ha già dieci mine!». - Però il re replicò: «Eppure è cosi; a chi ha già, sarà ancora dato, mentre a chi non ha, sarà tolto anche ciò che ha! Inoltre, quei tali miei nemici che non volevano ch’io regnassi su loro siano condotti qui ed uccisi in mia presenza!»
• § 500. L’ansiosa aspettativa che quegli uditori avevano del regno messianico non poté rimanere soddisfatta della parabola. In essa l’insegnamento è, in primo luogo, che il palese trionfo del regno di Dio sarà o uno ricompensa o un castigo a seconda del contegno dei singoli individui: in secondo luogo, che quel trionfo avverrà dopo una partenza e un’assenza del pretendente al regno, il quale comparirà ed agirà da re soltanto alla sua futura venuta. Applicando la parabola, troviamo che il pretendente al regno è Gesù stesso; il quale è già nel pieno possesso dei suoi diritti regali, ma ancora non è partito per andare a ricevere l’investitura pubblica e solenne dal suo Padre celeste assentandosi dai suoi sudditi, alcuni dei quali gli sono apertamente ostili e vorrebbero che egli non regnasse; questa sua assenza non è breve, giacché il pretendente parte per una regione lontana e affida ai suoi servi traffici che richiedono molto tempo (difatti Matteo, 25, 19, dirà che il padrone della parabola ritorna «dopo molto tempo»); quando Gesù sarà di ritorno dal suo Padre celeste, allora avverrà l’inaugurazione manifesta e solenne del suo regno con il premio dei sudditi fedeli e il castigo dei negligenti e ribelli. Non stiano dunque in ansiosa trepidazione i discepoli, aspettandosi da un giorno all’altro il trionfo solenne del regno di Dio. Prima di quel trionfo Gesù dovrà partire per una regione lontana e rimanere assente da loro fino alla sua nuova parusia, ossia presenza. Durante questa sua indefinita assenza, i nemici del lontano re brigheranno accanitamente affinché non regni: anzi, quando sarà proposto loro di riconoscere ufficialmente la sua regalità di Messia ebraico, risponderanno di riconoscere soltanto la regalità del Cesare pagano (Giovanni, 19, 15). Perciò questa sua assenza sarà un periodo di dure prove per i sudditi fedeli rimasti soli, e superando tali prove essi meriteranno di partecipare al trionfo finale della parusia. Se però il trionfo definitivo era riservato alla parusia, Gesù stesso aveva già promesso una grande manifestazione di possanza del regno di Dio che poteva ben valere come parziale anticipazione del trionfo finale (§ 401); inoltre aveva promesso particolari soccorsi appunto durante quelle dure prove (§ 486). La parabola delle mine, propria a San Luca, è narrata anche da San Matteo (25, 14-30) ma in altro contesto e con talune divergenze. Matteo la fa recitare da Gesù durante il grande discorso escatologico, pronunziato a Gerusalemme nel martedì della settimana di passione (§ 523); inoltre, colui che parte non è un pretendente al regno che va a riceverne l’investitura ma è un uomo facoltoso, e non distribuisce ai suoi servi una mina a ciascuno ma o cinque o due o un solo talento, il quale valeva sessanta mine: alla fine, poi, non si parla del castigo dei nemici che avevano brigato contro l’assente. - La collocazione che Luca dà alla parabola è senza dubbio migliore di quella di Matteo, perché corrisponde in maniera sorprendente al momento storico e alle circostanze della recita; lo stesso si dica della qualità di pretendente al trono e del conseguente castigo dei nemici, che non si ritrovano in Matteo. Per il resto le due parabole corrispondono quanto alla sostanza: quella di Matteo può essere un raccorciamento di quella di Luca, ma può anche darsi che il dippiù che si ritrova in Luca (specialmente il castigo finale dei nemici) provenga da una parabola diversa.

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, in questo periodo ci siamo dedicati al noioso adeguamento della nostra struttura associativa alle nuove leggi che regolamenteranno il Terzo Settore. Siamo, fra le altre novità rilevanti, diventati O.d.V., Organizzazione di Volontariato, ed abbiamo rimosso l’acronimo di Onlus, categoria che il Legislatore ha deciso di eliminare. Quando entrerà in vigore il nuovo Registro Unico del Terzo Settore, assumeremo anche l’acronimo di E.T.S. (Ente del Terzo Settore). Nella pratica nulla è cambiato quanto ai programmi dell’Associazione, alle nostre intenzioni ed alle attività in essere. Vi terremo aggiornati. Il tema di oggi è «Gesù ad Efraim e a Gerico» da «Vita di Gesù Cristo», Abate Giuseppe Ricciotti.
• § 494. I maggiorenti Giudei di Gerusalemme presero molto sul serio la denunzia fatta dai testimoni della resurrezione di Lazaro. I Farisei, impensieriti, si rivolsero ai sommi sacerdoti che dovevano decidere in proposito, e fu adunata un’assemblea, alla quale certamente presero parte molti membri del Sinedrio. Fu proposta la questione: «Che facciamo? Giacché quest’uomo fa molti portenti! Se lo lasciamo (agire) così, tutti crederanno in lui; e (allora) verranno i Romani e distruggeranno sia il luogo (santo) sia la nazione nostra». I partecipanti all’assemblea non discutono affatto la realtà dei miracoli di Gesù e specialmente dell’ultimo; ma già da tempo comparivano taumaturghi presentandosi quali inviati da Dio e predicando rivoluzioni fra il popolo (§ 433), che Gesù è considerato come uno di essi: anzi egli ha l’aggravante di compiere portenti più numerosi e strepitosi, e quindi tali da attirare anche più l’attenzione dei Romani. Costoro in realtà erano già padroni della Palestina, sebbene non s’immischiassero nelle questioni del luogo (santo), ossia del Tempio, e avessero lasciato alla nazione una certa autonomia interna (§ 22); tuttavia cominciavano già ad essere seccati da quella processione interminabile di taumaturghi rivoluzionari, e forse appunto questo galileo di Gesù li avrebbe indotti a reagire con severità estrema troncando una volta per sempre la fastidiosa processione. Gli eventi immediati si potevano prevedere facilmente: Gesù avrebbe continuato ad operare i suoi sbalorditivi miracoli; le folle sarebbero accorse in massa a lui; tutti d’accordo lo avrebbero proclamato re d’Israele in contrapposto al procuratore di Gerusalemme e all’imperatore di Roma; contro i sediziosi sarebbero accorse le coorti romane di stanza in Palestina ed eventualmente anche le legioni di Siria; sarebbe successa prima una strage di Giudei e poi anche la distruzione del luogo (santo) e della nazione intera. Il pericolo era grave ed imminente: bisognava provvedere subito. All’assemblea partecipava il sommo sacerdote allora in carica, Caifa (§ 52), il quale dopo aver ascoltato per qualche tempo le proposte che venivano fatte, espresse il suo parere con l’imperiosità permessagli dal proprio ufficio: «Voi non sapete nulla! Né riflettete che per voi è conveniente che muoia un solo uomo per il popolo, e non perisca l’intera nazione». Caifa non aveva nominato alcuno, ma tutti capirono: il solo uomo che doveva morire per il popolo era Gesù. È vero che Gesù non era uno sconvolgitore di popolo e non si era mai occupato di politica; è vero che egli era innocente, come probabilmente avevano fatto notare poco prima anche alcuni dell’assemblea stessa: ma che importava tutto ciò? Se egli moriva, l’intera nazione sarebbe scampata alla rovina, e ciò era ragione sufficiente perché egli morisse. Dicendo questo, Caifa aveva parlato soltanto come uomo politico e nell’interesse della sua casta sacerdotale sadducea, interesse che qui concordava pienamente con quello dei Farisei. Tuttavia l’Evangelista scorge nelle sue parole un senso ben più alto, e lo esprime con questa osservazione: «Ora ciò non disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote di quell’anno profetò che Gesù doveva morire per la nazione, e non per la nazione soltanto, ma affinché anche i figli d’Iddio dispersi radunasse (egli) in unità». La frase «essendo sommo sacerdote di quell’anno» ha dato occasione ad accusare l’Evangelista di non sapere che l’ufficio del sommo sacerdote non era annuale. Veramente non si trattava di una notizia peregrina, poiché qualunque lettore dell’Antico Testamento sapeva che quell’ufficio era a vita, sebbene ai tempi di Gesù - come già rilevammo (§ 50) - assai raramente i sommi sacerdoti morissero in carica; perciò San Giovanni, avendo presente questo abuso invalso ai suoi tempi, vuole soltanto dire che in quell’anno solenne in cui morì Gesù era Caifa il sommo sacerdote legittimo, e come tale pronunziò quelle parole che a sua insaputa avevano un significato ben più alto di quello da lui inteso. Agli occhi di San Giovanni quell’ultimo sommo sacerdote dell’antica Legge decade in quell’anno stesso, in cui è stabilita la nuova Legge per mezzo del Messia Gesù; ma prima di decadere, in forza del suo legittimo ufficio, egli rende omaggio ufficiale all’istitutore della nuova Legge, proclamandolo inconsciamente vittima di salvezza per la nazione d’Israele e per tutte le altre della terra. La decisione presa dall’assemblea fu conforme al suggerimento dato da Caifa: Da quel giorno, pertanto, deliberarono di ucciderlo. Questa deliberazione fu probabilmente comunicata, o agli Apostoli o a Gesù stesso, da qualche persona benevola che l’aveva risaputa. Gesù allora non si mostrò più in pubblico, e allontanandosi dalla zona di Gerusalemme si ritirò con i suoi discepoli in una città detta Efraim, che, riconosciuta già nel secolo IV (cfr. Eusebio, Onomasticon, 90), corrisponde quasi certamente all’odierna Taijibeh, circa 25 chilometri a settentrione di Gerusalemme sui margini del deserto. Era abitudine di Gesù ritirarsi in luoghi solitari alla vigilia di avvenimenti importanti per la sua missione.
• § 495. Ad Efraim Gesù rimane non molti giorni. La Pasqua s’avvicinava, e già cominciavano a passare le prime comitive avviate a Gerusalemme. Nella città santa si aspettava da un momento all’altro l’arrivo anche di lui. Ad ogni modo, per far si che la deliberazione dell’assemblea non rimanesse un vano desiderio, i sommi sacerdoti e i Farisei avevano dato comandi affinché, «se alcuno conoscesse dov’era, (lo) indicasse, cosicché lo catturassero» (Giovanni, 11, 57). Nonostante questi ordini, uno dei primi giorni del mese Nisan dell’anno 30, Gesù abbandonò il suo ritiro di Efraim e si mise in viaggio verso Gerusalemme seguendo la strada più lunga che a fianco al Giordano passava per Gerico. I discepoli fiutavano nell’aria sentore di tragedia, e ciò li faceva camminare riluttanti sebbene fossero preceduti da chi non mostrava riluttanza: «erano nella strada per salire a Gerusalemme, e Gesù andava avanti a loro, ed (essi ne) stupivano; coloro poi che seguivano, avevano paura» (Marco, 10, 32). La carovana era formata come da due gruppi: il primo era degli Apostoli con qualche altro discepolo più antico ed affezionato, e questo gruppo era preceduto da Gesù che camminava distaccato in avanti tutto solo, tanto che essi ne stupivano; il secondo gruppo, di quelli che seguivano a qualche distanza, era formato da altri discepoli più recenti, mescolatisi forse con pellegrini pasquali che già conoscevano Gesù e s’interessavano di lui: soprattutto i componenti di questo secondo gruppo avevano paura. Lontano, verso destra, si profilavano le colline di Gerusalemme. A un certo punto Gesù, fattisi venire dappresso con un gesto i dodici Apostoli, cominciò a dir loro le cose che stavano per accadergli: «Ecco, saliamo a Gerusalemme, e il figlio dell’uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli Scribi, e lo condanneranno a morte, e lo consegneranno ai pagani, e lo beffeggeranno e lo sputacchieranno e lo flagelleranno e uccideranno, e dopo tre giorni risorgerà». L’annunzio non era nuovo (§ § 400, 475), ma in quelle circostanze era opportunamente rinnovato: essendo imminente il tempo in cui Gesù avrebbe palesato universalmente la sua qualità di Messia, era opportuno richiamare alla memoria le precedenti rettificazioni messianiche. Ma anche quella volta esse giovarono ben poco. San Luca (18, 34) pazientemente ci fa sapere che i dodici «non capirono nulla di queste cose, ed era questa sentenza nascosta per essi; e non conoscevano le cose che erano dette». Quanto fosse grossolana e massiccia questa incomprensione apparve in una scenetta avvenuta subito appresso.
• § 496. Fra i convocati da Gesù che non capirono nulla del suo annunzio, erano i due fratelli Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, mentre nel secondo gruppo che seguiva Gesù si trovava la loro madre, ch’era forse una di quelle buone massaie che provvedevano alle necessità materiali dei cooperatori di Gesù (§ 343). L’annunzio di Gesù dovette essere comunicato dai figli alla madre e ampiamente commentato da tutti e tre nella maniera più rosea e più falsa: si dovette parlare di Messia dominatore, di vittorie, di gloria, di trono, di corte e cortigiani, e degli altri sogni cari al messianismo politico: e giacché il tempo stringeva, i tre interlocutori giudicarono opportuno fare qualcosa per assicurarsi buone posizioni. Ecco perciò che, poco dopo, la madre accompagnata dai due figli si presenta umile e riverente a Gesù per rivolgergli una domanda; trattandosi di cosa assai importante, parlarono tutti e tre insieme interrompendosi tra loro, cosicché mentre San Matteo (20, 20 segg.) attribuisce l’interrogazione alla madre, San Marco (10, 35 segg.) l’attribuisce ai figli. - «Che vuoi? Che volete?» - dice Gesù. E allora la donna, aiutata dai figli, espone la domanda. Adesso che Gesù fonderà il suo regno a Gerusalemme, non dovrà trascurare quei due bravi giovanotti; essi gli sono stati sempre affezionati, e per amor suo hanno perfino abbandonato la casa e le barche del loro padre; dunque Gesù si mostri riconoscente, e nell’assegnare ai suoi seguaci i posti nella corte messianica collochi l’uno alla destra e l’altro alla sinistra del proprio trono; e per se stessa la madre non chiede niente, ma spera che prima di morire non le sia negata questa giusta consolazione di vedere i suoi due giovanotti nei migliori posti a fianco del Messia glorioso. La donna, rincalzata dai figli, ha finito di parlare. Gesù guarda a lungo tutti e tre, e poi con infinita pazienza dice ai giovani: «Non sapete quel che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati del battesimo onde io sono battezzato?». La gloria del Messia verrà, sì, ma prima egli deve bere un calice e ricevere una «immersione» che corrispondono appunto al tragico annunzio da lui dato testé agli Apostoli: prima della vita gloriosa, vi sarà la morte ignominiosa, e potranno essi affrontarla? I due giovani, con la baldanza dei fiduciosi, rispondono: «Possiamo!». Gesù inaspettatamente dà loro ragione, ma nello stesso tempo respinge la loro richiesta: Si, si, berrete il mio calice e riceverete il mio battesimo, ma non è in poter mio farvi sedere a destra o a sinistra: i posti saranno occupati da coloro per cui sono stati preparati dal Padre celeste. - L’annunzio del calice e del battesimo allude alle future prove dei due Apostoli (§ 156, nota): il restante della risposta distingue ciò che gli interroganti avevano confuso insieme, cioè il regno del Messia sulla terra e quello glorioso nei cieli. Il primo è nel “secolo” presente e sarà pieno di travagli e di persecuzioni (§ 486); il secondo si inaugurerà alla rigenerazione, e sarà prodotto dalla pazienza mostrata nei travagli e nelle persecuzioni del “secolo” presente: allora «il figlio dell’uomo sederà sul suo trono di gloria», ma gli altri seggi ai lati di quel trono saranno assegnati dal Padre celeste. Il dialoghetto ebbe un seguito. Gli altri Apostoli riseppero della cupida richiesta fatta a Gesù, e nella loro gelosia s’indignarono contro i richiedenti, mostrando così di condividerne le ambizioni. Gesù, radunati nuovamente attorno a sé i contendenti, li ammonì mostrandosi anche su questo punto il moralista capovolgitore (§ 318): fra le nazioni pagane i governanti spadroneggiano sugli altri e fanno sentire su loro il peso della propria autorità, ma fra i seguaci di Gesù chi vuol essere maggiore degli altri diventi minore e chi vuol primeggiare diventi lo schiavo di tutti, a imitazione appunto di Gesù che «non venne ad esser servito ma a servire, e a dar la sua vita a riscatto (da schiavitù) in favore di molti» (Matteo, 20, 25-28). Gesù si era già presentato come buon pastore che serve tutta la giornata il suo numeroso gregge e dà la propria vita per esso (§ 434); qui egli riprende quest’ultima idea ed afferma che dà la sua vita a riscatto della schiavitù in favore dei molti suoi seguaci. È la dottrina su cui particolarmente insisterà più tardi San Paolo.
• § 497. Seguendo la strada suddetta, Gesù giunse a Gerico. L’aristocratica città contemporanea era un vero luogo di delizie specialmente d’inverno, perché vi aveva ampiamente esercitato la sua passione di grande costruttore ellenistico Erode il Grande, e dopo di lui in minor parte anche suo figlio Archelao: vi si ammiravano un anfiteatro, un ippodromo, una reggia sontuosa totalmente ricostruita da Archelao, e ampie piscine ove confluivano le acque dei dintorni. Ma il posto di questa città non era quello dell’antica, la vecchia Gerico cananea, le cui rovine si trovavano a circa due chilometri più a settentrione, presso la fontana di Eliseo: le esecrate rovine della città distrutta da Giosuè erano rimaste lungo tempo disabitate, ma la vicinanza della preziosa fonte vi aveva poi richiamato gente e provocato il sorgere d’un certo numero d’abitazioni che ai tempi di Gesù valevano come sobborgo della Gerico contemporanea (cfr. Guerra giud., IV, 459 segg.). Chi dunque scendeva dal settentrione, come qui Gesù, passava prima attraverso questo sobborgo formatosi presso la Gerico antica, e dopo appena una mezz’ora di cammino entrava nella città erodiana, situata davanti all’imbocco della stretta valle (wadi el-Qelt) ove s’immetteva la strada per Gerusalemme. Durante questo passaggio di Gesù avvenne un fatto narrato con interessanti divergenze dai tre Sinottici (Matteo, 20, 20 segg.; Marco, 10, 46 segg.; Luca, 18, 35 segg.). Secondo San Matteo e San Marco il fatto avvenne quando Gesù era uscito da Gerico; secondo San Luca, quando egli vi si avvicinava. Inoltre, il fatto consiste secondo San Marco e San Luca nella guarigione di un cieco, che in San Marco è chiamato Bartimeo, «figlio di Timeo»; al contrario, secondo San Matteo, furono guariti due ciechi. La questione è antica, e ne furono proposte varie soluzioni, anche poco o nulla fondate; una di queste ultime è che i ciechi sarebbero stati tre, uno all’entrata in Gerico e due all’uscita. La soluzione migliore sembra esser quella che tiene conto della doppia Gerico, l’antica e l’erodiana: di un viandante che faceva il breve tragitto dall’una all’altra si poteva ben dire tanto che era uscito da Gerico (antica) quanto che si avvicinava a Gerico (erodiana). Quanto al numero dei ciechi guariti, se uno o due, la divergenza non è nuova, perché già la trovammo a proposito dell’energumeno di Gerasa che secondo il solo San Matteo aveva un compagno (§ 347); anche qui il solo Matteo enumera due ciechi innominati. Trasferendosi mentalmente a quei tempi, la divergenza si comprende: già notammo che in Palestina i ciechi spesso si uniscono a coppia per mutuo aiuto (§ 351), e il cieco più intraprendente della coppia ne è quasi la personificazione comune, mentre l’altro rimane come nascosto all’ombra di lui; qui si aveva la personificazione rappresentata da Bartimeo, ma l’accurato Matteo ricorda che questa personificazione comune era composta da due individui. Bartimeo dunque, assistito dal compagno minore, stava a limosinare lungo la strada. Sentendo dal calpestio che passava un folto gruppo di gente, domandò chi fossero; gli fu risposto che passava Gesù il Nazareno, certamente a lui già noto per la fama dei suoi miracoli. Ambedue i ciechi allora si dettero a gridare: «Signore, abbi pietà di noi, figlio di David!». Quelli della comitiva dettero loro sulla voce affinché tacessero, ma i due tanto più alzavano le loro grida insistendo nell’implorazione. A un tratto Gesù si fermò e dette ordine che gli fossero condotti vicino. I circostanti andarono da Bartimeo con una parola piena di speranza: «Coraggio! Alzati! Ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, saltò su e seguito dal compagno minore andò da Gesù. Gesù chiese loro: «Che volete che vi faccia?» - Che può desiderare un cieco? Bartimeo rispose: «Rabboni, che ci veda! E tutti e due, più e più volte insieme: Signore, che si aprano gli occhi nostri!». Gesù allora disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato!». Era la stessa risposta, in sostanza, già data ai due ciechi di Cafarnao (§ 351). Toccati i loro occhi, ambedue furono guariti all’istante, e subito si unirono con la comitiva che seguiva Gesù.
• § 498. Gesù allora entrò in Gerico, naturalmente fra grande entusiasmo: si correva da tutte le parti per vedere il famoso Rabbi cercato a morte dai Farisei, colui che aveva guarito lì per lì su due piedi la notissima coppia di Bartimeo; il fervore popolare era accresciuto dai due ciechi stessi, che mostravano i propri occhi guariti a quanti volevano esaminarli. Tra gli accorsi fu un certo Zaccheo, ch’era capo dei pubblicani: città di confine e centro commerciale importante, Gerico doveva albergare molti agenti d’imposte, e uno dei loro capi era appunto questo Zaccheo. Il suo nome ebraico, Zakkai, dimostra ch’egli era giudeo; se ciò nonostante faceva quell’odiato mestiere, come l’aveva fatto anche Levi Matteo (§ 306), la colpa non era sua ma dei lauti guadagni che il mestiere procurava. Era infatti ricco; ma in lui, egualmente come in Levi Matteo, le ricchezze non avevano soffocato ogni senso di spiritualità, ché anzi quella sazietà materiale gli faceva provare una certa nausea e sentire talvolta più acuto il desiderio di ricchezze superiori all’oro e all’argento. In questo stato d’animo si trovava Zaccheo quel giorno in cui Gesù entrava a Gerico, e desiderava ardentemente di avvicinarlo e parlargli, o almeno di vederlo. Recatosi lungo il passaggio, capì subito che l’impresa era assai difficile; Gesù era attorniato da folla fittissima, in mezzo a cui sarebbe stato impossibile aprirsi un varco; d’altra parte il povero Zaccheo (non Gesù, come ha sognato l’Eisler; § 189) era basso di statura, cosicché dal piano terra non riusciva a scorgere neppure i capelli di Gesù. Rinunziare all’idea? Neppur per sogno. Il bravo Zaccheo fece una corsa sul davanti della folla che avanzava lentamente, e adocchiato un bel sicomoro ci si arrampicò sopra: era uno di quei bassi alberi, come se ne vedono ancor oggi a Gerico stessa, che hanno lunghe radici risalenti verso il tronco, in modo da sembrare circondati da tante funi; arrampicarsi là sopra, con quella bella comodità delle funi, fu cosa da nulla. La scena però dette sull’occhio. Se si fosse trattato di un contadino o un popolano qualunque, nessuno ci avrebbe badato; ma quell’omettino lassù era un capo pubblicano, cioè un capo di quelle sanguisughe che succhiavano il sangue del popolo. Forse più d’uno dei passanti pensò che quella sarebbe stata una buona occasione per fargli fare un volo dall’albero, o almeno per accendergli un bel falò sotto: tutti ad ogni modo se lo additavano tra loro con beffe e sghignazzamenti. Finalmente passa Gesù presso il sicomoro. Guardando in su tutti, guarda anche Gesù. Quei di Gerico che lo accompagnano gli spiegano chi sia l’omiciattolo appollaiato sull’albero: è un niente di buono, un uomo peccatore, anzi un capo peccatore e capo sanguisuga, che per atroce sarcasmo si chiama Zakkai (“puro”) mentre dovrebbe chiamarsi a ragione con ben altri nomi; non sarebbe quindi decoroso per il maestro rivolgergli la parola, e nemmeno fermarsi a guardarlo. Gesù invece, non solo sì è fermato e lo guarda, ma non sembra affatto persuaso delle informazioni che sta ricevendo; quando poi gli informatori hanno finito di parlare, si rivolge all’omettino sull’albero e gli dice nientemeno così: «Zakkai, presto, vieni giù! Oggi infatti in casa tua devo far sosta». Fu uno scandalo generale. Frettoloso e gioioso Zaccheo si ruzzolò giù dall’albero, e il maestro senz’altro s’avviò con lui a casa sua; «ma, vedendo (ciò), tutti mormoravano che presso un uomo peccatore entrò ad albergare». Trattandosi della casa impura di un peccatore, i fedeli alle norme farisaiche naturalmente rimasero fuori; e invece quella casa diventava più pura di tante altre appartenenti a Farisei. Zaccheo infatti, che sentiva non poche coserelle gravanti sulla sua coscienza, quando fu dentro casa volle onorare l’ospite facendo ampia ammenda del proprio passato; disse perciò a Gesù: «Ecco, la metà delle mie sostanze, Signore, do ai poveri, e se frodai taluno in qualche cosa restituisco al quadruplo». L’ospite, pienamente soddisfatto dell’ammenda, rispose al capo sanguisuga: «Oggi si è fatta salvezza in questa casa, perché anche questo è un figlio di Abramo; venne infatti il figlio dell’uomo a cercare e salvare ciò che era perduto». In maniera analoga aveva risposto Gesù nel difendere l’altro pubblicano, Levi Matteo, divenuto poi suo seguace. La guarigione di Bartimeo era stata un miracolo che aveva meravigliato le folle; l’ammenda di Zaccheo probabilmente non meravigliò nessuno, e forse vi fu gente che vi malignò sopra. Eppure, nel pensiero di Gesù, l’ammenda era un miracolo diverso ma non minore della guarigione: se nel caso di Bartimeo un cieco aveva veduto, nel caso di Zaccheo un cammello era passato attraverso una cruna d’ago, mentre tale passaggio era presso gli uomini impossibile, ma non presso Dio (§ 485).

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, i modernisti (verosimilmente i fautori e divulgatori del “Vaticano Secondo” e della nuova anticristica “religione ecumenica”) non hanno mai realmente creduto alla divinità di Cristo, dunque hanno sempre tentato, apertamente o dietro sofismi, in cumuli di velenosi documenti, di osteggiare questa verità. Benché mascherati da sapienti, nei loro vuoti commenti critici ai Vangeli, nelle loro false esegesi, nei loro eversivi studi biblici, in tutti i loro incomprensibili “dubbi”, in realtà i modernisti hanno tentato maldestramente di epurare o adulterare tutti quegli elementi e quegli episodi storici che attestano ineluttabilmente ed inconfutabilmente la divinità di Nostro Signore Gesù Cristo. Grazie a Dio, non ci siamo fatti sedurre e non siamo interessati alle loro lusinghe. La resurrezione di Lazzaro è un episodio fra i più clamorosi, odiato mortalmente da giudei e modernisti, dunque impariamo ad apprezzarlo dalle parole del sapiente Abate Giuseppe Ricciotti (Riposi in pace!).
• § 489. Dalla Festa della Dedicazione erano passati circa un paio di mesi, e si doveva essere sulla fine di febbraio o sui primi di marzo dell’anno 30 (§§ 460, 462). Gesù nella sua peregrinazione scendendo dai confini della Galilea (§ 414) si doveva essere avvicinato al Giordano e aveva seguito per un certo tratto la strada che, fiancheggiando il fiume, portava verso Gerusalemme; pare che ad un certo punto egli, traversato il fiume, entrasse e rimanesse qualche tempo in Transgiordania, forse nello stesso posto prediletto ove si era ritirato subito dopo la Dedicazione (§ 462). Mentre era ivi, lo raggiunse una triste notizia da Bethania, il villaggio di Marta e Maria: il loro fratello Lazaro, che forse era già malato al tempo dell’ultima visita di Gesù a quella famiglia amica (§ 441), si era aggravato assai e stava in imminente pericolo di vita. Le due sorelle, pur rimanendo in casa ad assistere l’infermo, erano informate in maniera approssimativa dei viaggi e delle soste di Gesù, e, saputolo in Transgiordania a circa una giornata di cammino da Bethania, gl’inviarono un messaggio per comunicargli le condizioni del loro fratello: confidate nell’affetto particolare che egli portava a tutte e tre della famiglia, esse sperarono che Gesù sarebbe accorso e con la sua presenza avrebbe impedito la morte. Ecco come San Giovanni (11, 3 segg.) narra il messaggio delle sorelle e il successivo contegno di Gesù: «Inviarono dunque le sorelle a lui dicendo: “Signore, guarda che quello che tu ami è malato”. Ma, avendo udito, Gesù disse: “Questa malattia non è per morte ma per gloria d’Iddio, affinché sia glorificato il figlio d’Iddio per mezzo di essa”. Amava invero Gesù Marta e la sorella di lei e Lazaro». Ci aspetteremmo che questo amore, espressamente rilevato dall’Evangelista, avesse spinto Gesù a partire immediatamente alla volta della famiglia amica che per varie ragioni l’attendeva; e invece la narrazione continua dicendo che quando Gesù «udì ch’era malato rimase per allora, nel posto dove era, due giorni; in seguito, dopo ciò, dice ai suoi discepoli: “Rechiamoci nella Giudea di nuovo”». Recarsi nella Giudea dal posto dove Gesù stava, significava recarsi a Gerusalemme o nei suoi dintorni, cioè proprio nel covo dei nemici di lui. I discepoli pensarono subito al pericolo e glielo fecero osservare: «Rabbi, testé cercavano i Giudei di lapidarti (§ 461), e di nuovo vai là?». Nella seguente risposta di Gesù ritroviamo i temi ricercati e raccolti con particolare cura da San Giovanni. «Rispose Gesù: “Non sono dodici le ore del giorno? Se alcuno cammini nel giorno non inciampa, perché scorge la luce di questo mondo; se però alcuno cammini nella notte inciampa, perché la luce non è in lui”». Le dodici ore della giornata mortale di Gesù non erano ancora trascorse tutte, sebbene già incombesse la sera; egli, luce di questo mondo (cfr. Giov., 1, 9; 3, 19; 8, 12), doveva compiere tutto il suo cammino fino all’ultima ora, né i suoi nemici potevano recargli alcun male, perché ancora non era giunta la loro ora: l’ora del loro predominio sarebbe stata l’ora di tenebra. Detto ciò, soggiunse: «Lazaro, l’amico nostro, si è addormentato; ma andrò a risvegliarlo». Queste parole confermarono nei discepoli l’erronea convinzione che essi già si erano fatta sia della risposta di Gesù al messaggio delle sorelle (questa malattia non è per morte), sia dall’indugiarsi di Gesù per altri due giorni nel luogo ove stava; risposero perciò fiduciosi: «Signore, se si è addormentato, si salverà». Un sonno profondo era, infatti, considerato dalla medicina contemporanea come un sintomo che l’organismo stava reagendo contro la malattia e cominciava a liberarsene; e quindi, anche per questa ragione, non era opportuno andare in Giudea da Lazaro per disturbarlo. Allora però Gesù disse loro apertamente: «Lazaro morì. E godo per causa vostra - affinché crediate - che io non ero colà. Ma rechiamoci da lui». I discepoli rimasero colpiti da quell’annuncio di morte, né sospettarono affatto l’intenzione vera di Gesù. Giacché dunque la disgrazia era avvenuta e non c’era più nulla da fare, perché recarsi in Giudea presso il covo dei Farisei e dei sommi sacerdoti? Ai discepoli non sorrideva affatto l’idea di questo viaggio e, presi in mezzo fra la paura dei Farisei e la deferenza per Gesù, essi tentennavano. D’altra parte il maestro appariva irremovibile nell’idea del viaggio: bisognava perciò seguirlo anche a costo di non tornare più addietro e di lasciare la vita laggiù fra quegli astiosi nemici, che essi andavano a provocare. L’Apostolo Tommaso fece opera di persuasione tra i suoi colleghi, mettendo però in mostra la sua sfiducia sull’esito finale del viaggio: «Rechiamoci anche noi a morire insieme con lui!». Tutti quindi si misero in cammino verso Bethania, arrivandovi in una giornata; e qui la narrazione di San Giovanni non può essere sostituita. Cito: «Venuto pertanto Gesù, trovò lui (Lazaro) già da quattro giorni nella tomba. Era poi Bethania presso Gerusalemme circa quindici stadi. Ora, molti dei Giudei erano venuti a Marta e Maria per consolarle del fratello. Marta dunque, come udì che Gesù viene, gli andò incontro: Maria invece sedeva in casa. Disse pertanto Marta a Gesù: “Signore, se eri qui, non sarebbe morto il fratello mio. E(ppure) adesso so che quante cose (tu) chiedessi a iddio, te (le) darà Iddio!”. Le dice Gesù: ”Risorgerà il fratello tuo”. Gli dice Marta: “So che risorgerà nella resurrezione nell’estremo giorno”. Le dice Gesù: “Io sono la resurrezione e la vita; chi crede in me, quand’anche fosse morto, vivrà, e chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi ciò?”. Gli dice: “Si, Signore; io ho creduto che tu sei il Cristo, il figlio d’Iddio, il Veniente (§§ 339, 505) nel mondo”. E detto ciò se ne andò a chiamare Maria, la sorella sua, segretamente dicendo: “C’è il maestro, e ti chiama”. Or quella, come udì, si leva prestamente e veniva verso lui, poiché non era ancora giunto Gesù nel villaggio, bensì era ancora al posto dove gli andò incontro Marta. I Giudei pertanto che erano con lei nella casa e la consolavano, vedendo che Maria era sorta ed uscita in fretta la seguivano, credendo che andasse alla tomba per piangere colà. Maria pertanto, come venne dove era Gesù, vedutolo cadde ai piedi di lui dicendogli: “Signore, se eri qui, non sarebbe morto il fratello mio!”. Gesù dunque, come vide lei piangere e i Giudei venuti insieme con lei piangere, fremette nel (suo) spirito e turbò se stesso».

• § 490. Queste parole invitano a sospendere un momento la lettura, per farvi sopra alcune considerazioni. Se la narrazione finisse qui, nessuno al mondo vi troverebbe difficoltà di sorta. Il racconto è piano, trasparente, senza ombra di sottintesi; è inoltre di tale aderenza agli altri dati storici in nostro possesso, da trovar conferme ad ogni linea. Ne rileviamo solo alcune. L’antica Bethania stava veramente, seguendo l’antica strada, presso Gerusalemme circa quindici stadi, che sarebbero 2.775 metri (oggi invece il villaggio tende ad allontanarsene, propagandosi verso oriente): data questa vicinanza da Gerusalemme, molti Giudei erano venuti dalla città a condolersi con la distinta famiglia del morto, come volevano le regole d’urbanità. Presso i Giudei il morto era sepolto di solito il giorno stesso del decesso, come appunto avvenne per Lazaro (§ 491). Si stimava comunemente che l’anima del defunto si aggirasse per tre giorni attorno alla salma, sperando di penetrarvi di nuovo, ma al quarto giorno, cominciando la decomposizione, essa se ne allontanava per sempre. Le visite di condoglianza si prolungavano per sette giorni, ma erano più numerose nei primi tre. I visitatori esprimevano il loro cordoglio dapprima con la solita rumorosità orientale, alzando grida e lamenti, piangendo, strappandosi le vesti, e infine rimanevano per un certo tempo seduti a terra in cupo silenzio. Quando Gesù arrivò, Marta e Maria stavano contornate da questi visitatori di condoglianza. I quali sono chiamati da San Giovanni «Giudei», termine con cui egli designa abitualmente gli avversari di Gesù; tali infatti si mostrarono apertamente taluni di essi, come apparirà dal seguito della narrazione. A Gesù andò incontro per prima Marta, che già vedemmo agire come governante in casa (§ 441); in seguito si mosse anche Maria, seguita dai visitatori. Scambiate le poche parole con le sorelle e viste tutte quelle persone piangenti, «Gesù fremette nel (suo) spirito e turbò se stesso», come uomo vivo e vero che ha un’anima umana nel petto e che sente profondamente l’amore e il dolore umani. Si può immaginare una narrazione più ingenua, più esatta, più “verista”? Tale sarebbe giudicata indubbiamente anche dagli studiosi radicalissimi se non avesse per conclusione un miracolo; ma poiché il tutto termina con la resurrezione di un morto, e avvenuta davanti a testimoni così numerosi e così avversi, perciò si è decretato di scoprire nella stessa narrazione o le tracce di una frode preparata in precedenza, o almeno le prove di un mito o un’allegoria. Alla frode o a qualcosa di simile pensarono critici antichi (§ 198), le cui idee però riposano oggi nella tomba senza speranza di resurrezione. Alla allegoria pensano parecchi moderni, per i quali tutta la narrazione non avrebbe nulla di reale, ma sarebbe, in una maniera o in un’altra, l’illustrazione solo apparentemente storica di un’idea astratta. Senonché il lettore imparziale può aver visto da se stesso se la narrazione offra il minimo appiglio a un’interpretazione allegorica; certo è che, se è allegorica questa narrazione, potrà essere considerato allegorico qualunque attestato di morte rilasciato da medici e da giudici davanti ad una salma e alla presenza di testimoni numerosi ed avversi; mentre, se attestati siffatti hanno valore storico, tanto più ne avrà questo attestato della morte di Lazaro. E ciò apparirà anche meglio dal seguito della narrazione, che qui riprendiamo.
• § 491. Gesù, dunque, alla vista dei piangenti uscitigli incontro, «fremette nel (suo) spirito e turbò se stesso, e disse: “Dove l’avete posto?”. Gli dicono: “Signore, vieni e vedi”. Gesù pianse. Dicevano pertanto i Giudei: “Guarda! Come l’amava!”. Ma alcuni di essi dicevano: “Non poteva costui, che aprì gli occhi al cieco (§ 428), fare che anche questo non morisse?”. Gesù pertanto, di nuovo fremendo in se stesso, viene alla tomba. Era (questa) una spelonca, e una pietra era stata posta su di essa. Dice Gesù: “Togliete la pietra”. Gli dice la sorella del morto, Marta: “Signore, già puzza: è infatti quatriduano”. Le dice Gesù: “Non ti dissi che, se (tu) creda, vedrai la gloria d’iddio?”. Tolsero pertanto la pietra. Gesù allora alzò gli occhi in alto e disse: “Padre, ti ringrazio perché mi ascoltasti! Io invero sapevo che sempre mi ascolti; ma per la folla che sta attorno dissi (ciò), affinché credano che tu m’inviasti”. E, detto ciò, a gran voce gridò: “Lazaro, vieni fuori!“. Uscì il morto legato ai piedi e alle mani da bende, e la faccia di lui era avvolta da un sudano. Dice a quelli Gesù: “Scioglietelo e lasciatelo andare!”». Le tombe palestinesi del tempo di Gesù erano situate poco discosto dai luoghi abitati o proprio alla periferia di essi. Le tombe di persone distinte erano di solito scavate nel tufo, o perpendicolarmente a guisa di fossa nei luoghi pianeggianti, ovvero orizzontalmente a guisa di spelonca nei luoghi collinosi; consistevano essenzialmente in una camera funeraria con uno o più loculi per le salme, e spesso con un piccolo atrio davanti la camera: atrio e camera comunicavano tra loro mediante uno stretto uscio che rimaneva sempre aperto, mentre l’atrio comunicava con l’esterno mediante una porta che veniva sbarrata con una grossa pietra (§ 618). La salma, dopo essere stata lavata, cosparsa di aromi, fasciata di bende e avvolta di lenzuolo, era semplicemente deposta nel suo loculo nella camera funeraria, rimanendo perciò a contatto quasi immediato dell’aria interna: è facile quindi immaginare che, al terzo o quarto giorno dalla deposizione, nonostante gli aromi tutto l’interno della tomba era ammorbato dalle esalazioni del cadavere. Di ciò si preoccupa nel caso nostra Marta, quando Gesù ordina di togliere la pietra che chiude la porta esterna. La salma di Lazaro è là da quattro giorni: retrocedendo infatti in ordine di tempo, troviamo che un giorno, l’ultimo, è stato impiegato da Gesù per venire dalla Transgiordania a Bethania risalendo per la strada da Gerico a Gerusalemme (§ 438); due giorni, il penultimo e il terz’ultimo, sono stati consumati dal suo deliberato indugio dopo aver ricevuto l’annunzio che Lazaro era gravissimo; il quart’ultimo giorno, dunque, è insieme quello in cui le sorelle del malato hanno inviato l’annunzio a Gesù e in cui Lazaro è morto ed è stato sepolto. Egli dunque morì poche ore dopo che le sue sorelle avevano spedito il messo a Gesù.
• § 492. Oggi, sul posto dell’antica Bethania, si mostra una tomba che una tradizione attestata fin dal IV secolo identifica con quella di Lazaro. Trattasi certamente di un sepolcro del solito tipo palestinese, ma oggi è difficile farsi un’idea esatta del rapporto tra il sepolcro e il primitivo territorio circostante, a causa delle ripetute modificazioni che tutto il luogo ha ricevuto lungo i secoli. L’antica porta esterna fu murata dai musulmani nel secolo XVI, quando vi fu edificata la moschea sovrastante: poco dopo vi fu adattato per altra parte l’accesso odierno, che discende per 24 gradini. Questo accesso immette nell’antico atrio della tomba, il quale è un quadrilatero di circa tre metri per lato; scendendo ancora tre gradini si penetra attraverso una stretta apertura nella camera funeraria, che è di dimensioni alquanto minori e contiene oggi i loculi per tre salme. Checché sia dell’identità di questa tomba con quella di Lazaro, l’aderenza della narrazione ai costumi funebri e ai dati archeologici palestinesi è esattissima, e anche per questa ragione si scorge nel narratore un testimonio oculare. Né è minore la corrispondenza della narrazione allo stato psicologico dei Giudei durante il fatto e subito dopo. Durante il fatto, alcuni Giudei contestano a Gesù, non senza una punta di beffa, di non aver impedito la morte di Lazaro dopo aver donato la vista al cieco di Gerusalemme. Dopo il fatto, fra i Giudei stessi avviene una scissione così narrata dal testimonio oculare: «Molti pertanto dei Giudei, che erano venuti a Maria ed avevano contemplato ciò che (egli) fece, credettero in lui; altri di essi, invece, se ne andarono ai Farisei e dissero loro le cose che fece Gesù». L’effetto di questo zelante messaggio fu, come si vedrà, la decisione presa dai Farisei che l’operatore di miracoli così grandiosi e così pubblici doveva essere tolto di mezzo; ma qui è importante rilevare come la scissione prodottasi tra i Giudei testimoni del miracolo abbia un fondamento psicologico storicamente perfetto. Fra quegli avversari di Gesù, coloro che non hanno dimenticato di essere uomini, si arrendono al miracolo e credono in chi l’ha operato; coloro invece che hanno subordinato il loro cervello e cuore di uomini alla propria qualità di membri d’un partito, non si preoccupano che del trionfo del partito e corrono a denunziare Gesù. La storia umana è piena di esempi di paradossale tenacia partigianesca, ma nessuna tenacia è stata più massiccia di quella dei Farisei. Crolli il mondo, ma rimanga a qualunque costo il fariseismo (§ 431). Difatti il mondo crollò e il fariseismo rimase, ma quale testimonio inconfutabile della propria disfatta.
• § 493. I critici radicali odierni [fra cui i modernisti] (seguaci dei metodi dell’antico fariseismo più che non sembri), per dimostrare che la narrazione della resurrezione di Lazaro è tutta allegorica e non ha alcun fondamento storico, portano una ragione che dovrebbe essere perentoria: la ragione è che il fatto è narrato dal solo Giovanni e non dai Sinottici, mentre se si trattasse di un avvenimento reale, i Sinottici nel loro stesso interesse apologetico non avrebbero potuto tralasciare un avvenimento così adatto a conciliare la fede nel Messia Gesù. La ragione è certamente perentoria, ma solo per mostrare la povertà d’argomenti dei critici radicali. In primo luogo si può ricordare loro ad personam che la resurrezione di Gesù è narrata concordemente dai Sinottici e da Giovanni, ma ciò non è per essi un motivo sufficiente per accettarla come fatto storico. Inoltre, la ragione addotta è un argomento a silentio; il quale, se è debolissimo sempre, è assolutamente nullo nel caso nostro. Noi sappiamo infatti che San Giovanni ha voluto appunto supplire e integrare, in piccola parte, quanto era già stato narrato dai precedenti Sinottici (§163 segg.), e questo di Lazaro è precisamente uno di tali casi. D’altra parte i Sinottici, non soltanto sono lontanissimi dalla pretesa di raccontare tutti i fatti o miracoli di Gesù, ma essi stessi ci offrono la prova di averne tralasciati moltissimi: già vedemmo, infatti, come i Sinottici riportino le parole di Gesù secondo cui egli aveva operato molti portenti anche a Chorozain, ma neppure uno di questi fatti di Chorozain è narrato dai Sinottici o da Giovanni (§ 412). Quanto alla ragione per cui i Sinottici omisero questa narrazione, è aperto il campo alle congetture: una molto verosimile è che non volessero esporre Lazaro e le sorelle alle rappresaglie degli ostili Giudei tuttora spadroneggianti a Gerusalemme, dal momento che il Sinedrio aveva già pensato di uccidere Lazaro come testimonio incomodo (§ 503); più tardi invece, quando scrisse San Giovanni, questo silenzio prudenziale non aveva più ragione di essere, perché Gerusalemme era ridotta a un cumulo di rovine. D’una serenità olimpica è la spiegazione che il Renan fornì della resurrezione di Lazzaro. Veramente questa è la seconda spiegazione, giacché la prima che supponeva una sincope passeggera di Lazaro e un trucco accordato tra lui e le sorelle (§ 207) non lo aveva lasciato pienamente soddisfatto; e allora, senza abbandonarla del tutto, di rincalzo egli vi aggiunge questa spiegazione definitiva. Un bel giorno i discepoli chiedono a Gesù che compia un miracolo per convincere i cittadini di Gerusalemme; Gesù risponde sfiduciato che quelli non crederebbero neppure se Lazaro risuscitasse, intendendo il Lazaro già nominato nella parabola del ricco epulone (§ 472). Bastò questa risposta, perché più tardi i discepoli parlassero senz’altro di una vera e reale resurrezione di Lazaro. E così il miracolo è bell’e fatto. Ora, certamente tutti quanti, dotti e indotti, ammetteranno che siffatta spiegazione è opportunissima per procurare un minuto di ilarità cordiale; ma tutti anche, dopo le risate, si domanderanno se una biografia di Gesù era il luogo più adatto per tirare fuori simile pulcinellate.

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, vi ringraziamo per le numerose condivisioni ed interazioni con le nostre pagine Facebook (Sursum Corda - Sant'Alfonso - San Francesco di Sales), azioni di lodevole proselitismo che la scorsa settimana sono notevolmente aumentate. Dice il Signore: «Quod in aure auditis, praedicate super tecta» - Quello che ascoltate all’orecchio predicatelo sui tetti. Facciamo in modo che i contenuti pubblicati sul nostro piccolo sito - uno fra miliardi, una voce sussurrata all'orecchio - raggiungano dunque il maggior numero di anime, tuttavia non dimentichiamo mai i doveri propri del nostro stato (siamo laici e NON predicatori), non eccediamo, siamo prudenti nel pensare e nell’agire e moderati nel parlare (oggi è più appropriato dire “nel postare”), sforziamoci sempre di conservare, grazie a Dio, quel contegno e quella dignità caratteristici del buon cristiano. Facciamo in modo che la nostra libertà non diventi occasione di scandalo e di caduta per i deboli, diceva l'Apostolo. Ed ancora, non diamo occasione al diavolo!
Veniamo alla consueta infarinatura di Sacra Scrittura ricorrendo al prezioso aiuto dell’Abate Giuseppe Ricciotti. § 488. Queste ricompense promesse da Gesù secondo quale criterio saranno distribuite ai suoi seguaci? Questo punto fu esposto da Gesù mediante una nuova parabola, presa anche questa dai costumi agricoli del paese. In Palestina, ai primi accenni della primavera, le vigne dànno molto da fare e i vari lavori di potatura, sarchiatura e altro, devono finirsi presto: prima che le viti si risveglino e comincino a gettare. Sono alcune settimane di lavoro intenso, nelle quali tutti i proprietari cercano braccia. Ora, il regno dei cieli è simile a un padrone di vigna, che al tempo di questi lavori uscì di buon mattino in cerca di braccianti. Recatosi sulla piazza del paese, ne trovò alcuni e, accordatosi con loro sulla paga, che sarebbe stata di un denaro d’argento al giorno (poco più d’una lira in oro), li inviò senz’altro alla sua vigna. Di nuovo verso l’ora terza di sole, cioè verso le nostre nove antimeridiane, quel padrone uscì sulla piazza e trovò altri braccianti inoperosi; disse perciò loro: «Andate anche voi nella mia vigna, e vi darò quello ch’è giusto». Uscì ancora verso l’ora sesta e l’ora nona, cioè verso mezzogiorno e le tre pomeridiane, e trovando altri braccianti inoperosi inviò anche questi promettendo il giusto. All’undicesima ora, cioè un’ora prima del tramonto, uscì nuovamente e, trovando ancora gente inoperosa, disse loro: «Ma perché state qui tutta la giornata oziosi?». E quelli: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Allora il padrone: «Ebbene, andate anche voi alla mia vigna». Calato il sole, il padrone disse al suo fattore: «Chiama i braccianti e pàgali, cominciando dagli ultimi arrivati per finire ai primi». Il fattore chiamò gli ultimi e consegnò loro un denaro d’argento a ciascuno; gli altri braccianti, che tenevano d’occhio il pagatore, vedendo che gli ultimi erano ricompensati così lautamente, speravano che la stessa lautezza sarebbe stata impiegata con loro: e invece, man mano che vennero quelli dell’ora nona e della sesta e della terza, ricevettero tutti lo stesso; perfino quelli impegnati al primo mattino ricevettero egualmente un denaro d’argento. Questi allora, nella loro delusione, cominciarono a brontolare contro il padrone dicendo: «Come? Gli ultimi venuti hanno lavorato appena un’ora e al fresco, e tu li hai trattati alla pari con noi che abbiamo sopportato tutto il peso della giornata e il caldo?». Ma il padrone rispose a uno dei brontolanti: «Amico, io non ti faccio torto. Non ci siamo messi d’accordo per un denaro al giorno? Te l’ho dato, e quindi va’ per i fatti tuoi. Se io voglio dare al bracciante giunto per ultimo quanto ho dato a te, non mi è forse lecito di fare della roba mia quel che mi pare? Oppure non mi è lecito mostrarmi liberale con i tuoi compagni, se l’occhio tuo diventa invidioso della mia liberalità?». Gesù infine chiuse la parabola dicendo: «Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi». Gli scritti rabbinici ci hanno trasmesso vari paragoni che mostrano notevoli analogie con questa parabola di Gesù [Si veda tutto lo Zwanzingter Exkursus di Strack e Billerberck, Op. cit., vol. IV, parte prima, pagine 484-500]; ma, oltre ad essere posteriori in ordine di tempo, mirano anche a insegnamenti diversi. L’insegnamento generico di questa parabola è che la liberalità di Dio si riversa su chi vuole e nella misura che vuole, e che la ricompensa finale per i seguaci di Gesù sarà nella sua parte essenziale eguale per tutti. I braccianti della vigna non adombrano, a rigore, i ricompensati del regno dei cieli, i quali certamente non brontolano né accusano di parzialità chi li ha ricompensati, né sentono invidia per altri: adombrano, invece, storicamente quei seguaci di Gesù che in vista del regno dei cieli si ritenevano per qualsiasi ragione più adorni di meriti che altri, e specialmente quei Giudei di spirito onesto ma di mentalità strettamente giudaica che si ritenevano tuttora più accetti a Dio per la loro appartenenza alla nazione eletta. Per costoro i pubblicani, le meretrici, e anche i pagani, potevano bensì essere ammessi nel regno dei cieli quando si fossero convertiti, tuttavia in quel regno sarebbero stati di gran lunga addietro ai fedeli e genuini Israeliti, pieni di millenari meriti al cospetto di Dio. Gesù invece insegna che siffatti primati scompariranno, e che la liberalità del Re dei cieli potrà far passare gli ultimi ai primi posti, cosicché coloro che già erano primi diverranno ultimi.

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, per un approfondimento su alcune recenti iniziative dell’Associazione rimandiamo al breve comunicato «Due raccolte per i poveri, giugno 2019» pubblicato qui accanto. Siamo tenuti a rendere pubbliche queste iniziative non per propaganda e né per vanagloria (cf. Proverbi, XXI, 14), ma solamente per documentare la nostra attività di O.d.V. (ce lo chiede la legge) e nell’intenzione di eccitare i Lettori alla pratica delle opere di misericordia. Dice infatti la Scrittura: «Chi chiude l’orecchio al grido del povero, griderà anch’egli, e non gli sarà risposto» (Ivi., 13). L’Abate Giuseppe Ricciotti - sia pace alla sua bellissima anima! - oggi ci racconta la vicenda del ricco che si presenta a Gesù; segue una lunga considerazione sulla ricchezza.
• § 484. Quando Gesù stava per allontanarsi dal luogo ove gli erano stati presentati i bambini, si presentò frettoloso un giovane che, inginocchiatosi davanti, gli domandò: «Maestro buono, che cosa farò perché (io) possa ereditare (la) vita eterna?». Ma Gesù gli disse: «Perché mi dici buono? Nessuno (è) buono se non uno, Iddio» (Marco, 10, 17-18). Già rilevammo (§121, nota) come i termini di questo dialogo, confermati da San Luca, appaiono in maniera diversa presso San Matteo: si temette, infatti, che i termini, com’erano impiegati da San Marco e San Luca, offrissero appiglio a scandalo potendo essere interpretati come negazione della bontà di Gesù e della sua divinità; e quindi il traduttore greco del Matteo aramaico, pur conservando materialmente i termini, li impiegò in maniera diversa per togliere ai suoi lettori ogni occasione di malinteso. Ma, appunto perché più difficile (§ 480), il testo di Marco e Luca ha in suo favore ogni probabilità di essere il più antico e il più esatto nel riportare le parole di Gesù: il testo di Matteo, più facile, rispecchia meglio l’impiego che del dialogo faceva la catechesi cristiana posteriormente alla pubblicazione dei vangeli di San Marco e di San Luca. Riportandosi alle circostanze storiche, i termini del dialogo si spiegano agevolmente. L’appellativo Maestro buono (Rabbi tābā) non era mai usato parlando a rabbini, neppure ai più autorevoli, poiché sembrava esagerata adulazione: un rabbino si riteneva sufficientemente onorato dal termine Maestro, mentre colui al quale spettava l’appellativo di buono era a rigore soltanto Dio. Qui il giovane, che ha visto Gesù abbracciare e accarezzare i bambini, lo chiama buono più nel senso umano e familiare che in quello accademico e filosofico. Gesù ne prende occasione per offrire al giovane la maniera di approfondire la conoscenza del Maestro a cui si rivolge; scendendo sullo stesso piano di lui (come aveva già fatto con la Samaritana; Giovanni, 4, 22), egli dice in sostanza al giovane: «Tu mi chiami maestro come qualunque altro dottore della Legge, e per di più mi chiami buono. Perché mi dai questo appellativo? Non sai che, secondo l’uso comune, esso è riservato a Dio?». Il giovane avrebbe potuto giustificare l’uso dell’appellativo rispondendo: «Ma appunto tu sei il figlio di Dio!». E invece non rispose. Si aspettava veramente Gesù questa risposta da quel giovane, forse ignaro; oppure egli aveva cercato di provocarla affinché in cuor loro rispondessero i discepoli, non ignari (§ 396), ch’erano presenti? Poiché il giovane non dette risposta, Gesù continuò per soddisfare alla richiesta di lui: «Se poi vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Il giovane chiese: «Quali?». Gesù allora, confermando ancora una volta la Legge ebraica, gli recitò il Decalogo: «Non ucciderai; non commetterai adulterio; ecc.». Il giovane, meravigliato, replicò: «Ma tutto ciò io l’ho osservato fin dalla mia prima giovinezza! Vorrei sapere se mi manca ancora qualche altra cosa». Dopo questa fiduciosa e volenterosa risposta Gesù, a detta di Marco (10, 21), «riguardatolo lo amò», ossia lo fissò con chiara espressione di benevolenza, e poi gli disse: «Ti manca una cosa. Se vuoi essere perfetto, va’, vendi tutti i tuoi beni, distribuisci ai poveri il ricavato, ché avrai un tesoro nei cieli; e poi seguimi!». A tale invito, quale risulta in complesso da tutti e tre i Sinottici, avvenne un cambiamento di scena: il giovane già cosi ardente e volenteroso diventò a un tratto gelido e «afflittissimo» (Luca, 18, 23) perché possedeva molti beni ed era assai ricco. E così ottenebrato, si allontanò. L’amara proposta di alienare tutti i propri beni era stata addolcita dalla promessa di un tesoro nei cieli, conforme alla sanzione universale della dottrina di Gesù (§ 319), ma il palato del giovane sentì poco o nulla il dolce e moltissimo l’amaro; a lui il futuro tesoro nei cieli parve troppo lontano per poterlo preferire alle sue grosse anfore ripiene di lucenti sicli e custodite gelosamente dentro qualche occulto ripostiglio. Buon giovane, senza dubbio, ma d’una bontà comune e terra terra, mentre Gesù aveva ammonito che ai suoi seguaci poteva chiedere ad ogni momento di essere giganti di eroismo (§ 464). Quel giovane sarebbe stato certamente un ottimo magistrato dell’Impero romano, mentre al primo scrutinio per essere assunto quale alto magistrato del regno dei cieli risultò deficiente: per questo regno egli non aveva l’animo tanto nobile quanto quell’ignobile pubblicano di Levi, che aveva posseduto forse meno sicli ma più generosità (§ 306).
• § 485. Partito il giovane, sul contegno di lui Gesù fece alcune considerazioni con i discepoli. «Quanto difficilmente - esclamò egli - quelli che hanno ricchezze entreranno nel regno d’Iddio!». Senonché i discepoli rimanevano stupiti delle parole di lui. Gesù però, di nuovo rispondendo, dice loro: «Figli, quant’è difficile entrare nel regno d’Iddio! È più agevole per un cammello passare attraverso la cruna dell’ago, che per un ricco entrare nel regno d’Iddio». Quelli allora rimanevano sempre più stupefatti, dicendo tra loro: «E chi può salvarsi?». Riguardatili, Gesù dice: «Presso gli uomini (è) impossibile, ma non presso Dio» (Marco, 10, 23-27). L’immagine del cammello è perfettamente orientale. Sono infondate le interpretazioni che il nome greco di cammello sia stato scambiato col nome somigliante di una grossa fune, oppure che con l’appellativo cruna dell’ago si designasse una ignota porticina delle mura di Gerusalemme stretta ed aguzza. Gesù parla di un vero cammello e di una vera cruna d’ago, come più tardi nel Talmud si parlerà di rabbini che a forza di sottigliezze facevano passare un elefante attraverso una cruna d’ago (cf. Strack e Billerbeck, Op. cit. negli altri articoli, vol. I, pag. 828). Neppure è il caso di attenuare la forza di questo paragone; Gesù se ne serve per adombrare, non una grande difficoltà, ma una vera impossibilità. Il ricco non può entrare nel regno di Dio per la stessa ragione per cui un uomo non può servire a Dio e a Mammona (§ 331): questi due monarchi nella loro lotta implacabile non si dànno quartiere, e l’uno non permette ai sudditi dell’altro di entrare sotto nessun pretesto nel proprio regno. E allora nessun ricco potrà in questo caso entrare nel regno di Dio? No, vi potrà entrare, purché prima svesta la divisa di suddito di Mammona, diventando povero di fatto o equivalente povero in ispirito (§ 321, nota). Ma sarà possibile questa diserzione dei sudditi di Mammona, che diventino sudditi di Dio? No, questa diserzione così paradossale è umanamente impossibile, perché gli uomini preferiranno sempre il palpabile oro terrestre all’impalpabile tesoro celeste: tuttavia essa presso gli uomini (è) impossibile, ma non presso Dio, e Dio opererà questo miracolo di fare che un ricco preferisca il tesoro lontano all’oro vicino. Queste idee in sostanza non erano nuove, essendo già state espresse da Gesù sia nel Discorso della montagna, sia nella sua recente disputa con i Farisei a proposito delle ricchezze (§ 471). Un elemento nuovo qui introdotto è l’affermazione che l’abbandono delle ricchezze per entrare nel regno di Dio non sarebbe stato effetto d’industria umana ma della potenza di Dio.
• § 486. Ascoltate le parole di Gesù e applicatele a se stessi, gli Apostoli riscontrarono che essi si trovavano avvantaggiati sugli altri uomini. Dei loro sentimenti si fece interprete il solito Pietro, che disse a Gesù: «Ecco, noi lasciammo tutto e ti seguimmo»; cosicché erano diventati volenterosi poveri per Gesù e per il regno dei cieli, e stavano in regola con le condizioni testé dettate dal maestro. Seguì per ciò una domanda, riportata da un solo Sinottico: «Che cosa dunque avremo?» (Matteo, 19, 27). Gesù rispose riferendosi sia agli Apostoli suoi particolari seguaci e collaboratori, sia a tutti gli altri seguaci presenti e futuri che non avevano il grado di Apostoli. La parte della risposta che si riferisce agli Apostoli è riportata qui dal solo Matteo (19, 28), mentre da Marco è taciuta e da Luca (22, 28-30) è riportata fra i discorsi dell’ultima cena; la parte relativa agli altri seguaci di Gesù è riportata da tutti e tre i Sinottici, ma presso Marco e Luca con una particolare distinzione cronologica. Agli Apostoli Gesù disse: «In verità vi dico che voi che mi seguiste, nella rigenerazione, quando segga il figlio dell’uomo sul suo trono di gloria, sederete anche voi su dodici troni giudicando le dodici tribù d’Israele». Ciò dunque avverrà alla rigenerazione o palingenesi, la quale rinnoverà ab imis [dalle più profonde fondamenta o totalmente, ndR] il «secolo» presente: allora, su quel trono di gloria che i rabbini riserbavano a Dio, si sederà il Figlio dell’uomo come sul suo proprio trono, e avendo ai suoi lati i dodici Apostoli seduti su troni minori giudicherà insieme con essi quelle dodici tribù d’Israele alle quali esclusivamente egli ha indirizzato la sua personale missione (§ 389). Con questa solenne assemblea giudiziale si chiuderà il «secolo» presente e s’inizierà il « secolo» futuro (§ 525 segg.). [Dalla nota 1 alla pagina 575: «Secondo i rabbini erano state create prima del mondo (più esattamente 2000 anni prima) sette cose, le quali enumerate in maniere diverse erano: la Tōrāh, la penitenza, il giardino di Eden, la Gehenna, il Trono della gloria, il santuario (celeste) e il nome del Messia; la Tōrāh, o Legge, stava deposta sulle ginocchia di Dio, il quale era assiso sul Trono della gloria: cfr. Strack e Billerbeck, Op. cit., vol. I pag. 974-975»]. Ciò che Gesù promise agli altri suoi seguaci, non Apostoli, suona così presso Marco (10, 29-31): «In verità vi dico, non v’e nessuno che lasciò casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a cagione di me e a cagione della buona novella, il quale non riceva centuplicati adesso in questo tempo case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme con persecuzioni, e nel secolo venturo (la) vita eterna». Qui la ricompensa non è messa in relazione col solenne giudizio delle dodici tribù, ma è nettamente divisa in due tempi: la seconda parte si avrà nel secolo venturo, e consisterà nella vita eterna; la prima parte si avrà adesso in questo tempo, che perciò è il «secolo» presente. Nella ricompensa del «secolo» presente si promette ai seguaci di Gesù il centuplo di tutto ciò che hanno lasciato. Ora, questo centuplo è di beni solamente spirituali, ovvero anche materiali?
• § 487. È noto che, come gli scritti apocalittico-messianici del tardivo giudaismo si sbizzarrirono nel descrivere i beni materiali che il futuro Messia avrebbe apparecchiati nel suo regno, così alcuni scrittori cristiani dei primi due secoli presero argomento da queste parole di Gesù per descrivere anch’essi il futuro Regno del Messia Gesù quasi come un paese di Bengodi: in quel regno ogni vite avrà 10.000 tralci, ogni tralcio 10.000 rami, ogni ramo 10.000 viticci, ogni viticcio 10.000 grappoli, ogni grappolo 10.000 acini, e da ogni acino si pigeranno 25 misure di vino, e altrettanto avverrà per il grano e gli altri prodotti del suolo; quel regno poi durerà mille anni (cfr. Apocalisse, 20, 3 segg.). Uguale concezione materiale ne aveva, dal di fuori, Giuliano l’Apostata, il quale domandava beffardamente ai Cristiani se il loro Gesù avesse restituito al centuplo anche le mogli lasciate da essi per seguirlo [San Luca, fra le cose lasciate per seguire Gesù, nomina anche la moglie]. Ma a questo millenarismo materiale inferse gravi colpi già Origene nel secolo III, e più tardi San Gerolamo ripeterà: «In occasione di questo passo (della ricompensa centuplicata) alcuni introducono mille anni dopo la resurrezione, dicendo che allora ci sarà concesso il centuplo di tutte le cose che lasciammo e la vita eterna; non comprendendo però che, se nelle altre cose la promessa è degna, nelle mogli appare una sconcezza, giacché chi ne ha lasciata una per il Signore, ne riceverà cento in futuro. Il senso dunque è questo: Chi, per il Salvatore, abbia lasciato cose carnali, riceverà cose spirituali, le quali in confronto e per valore intrinseco saranno come se si confronta il cento con un numero piccolo». Cosicché per San Girolamo, come pure per altri Padri, il centuplo ha un valore spirituale. La spiegazione è sostanzialmente giusta, ma, dal punto di vista storico, non appare completa e dovrà essere integrata attribuendo al centuplo promesso pure un subordinato valore materiale. Anche sotto questo aspetto, infatti, la promessa di Gesù si riscontra immediatamente avverata fra i primissimi cristiani, i quali costituivano una famiglia in cui si ritrovavano moltiplicati i beni materiali e gli affetti naturali lasciati per amore del Cristo. Narrano gli Atti (2, 44-45) che «tutti i credenti (erano) insieme (e) avevano tutte le cose in comune, e vendevano le possessioni e sostanze e le spartivano fra tutti secondo che alcuno aveva bisogno»; e poco appresso (4, 32) confermano che «la moltitudine dei credenti aveva un cuore e un’anima sola, e nessuno diceva esser cosa sua propria alcunché di ciò ch’egli aveva, bensì tutte le cose in comune essi avevano». Così pure dagli Atti e dalle varie Lettere apprendiamo che i cristiani, di comunità anche lontane, si consideravano legati da vincoli di carità tanto forti da sentirsi, pure nel campo affettivo, largamente ricompensati di vincoli naturali forse spezzati per seguire il Cristo. Se dunque i primi cristiani avevano lasciato una casa ed un cuore, trovavano veramente cento case e cento cuori in compenso. Giustamente quindi in questi benefizi materiali, offerti dalla fratellanza religiosa, gli studiosi moderni delle varie tendenze vedono il centuplo promesso da Gesù adesso in questo tempo, come del resto gli storici delle epoche successive della Chiesa scorgevano l’avveramento della stessa promessa in quelle molte associazioni i cui membri, per avvicinarsi allo spirito di Cristo, vissero e vivono di beni messi in comune, in maniera da poter affermare con San Paolo di essere come nulla aventi ed ogni cosa possidenti (II Corinti, 6, 10). [N.B. Nulla a che vedere con il Socialismo o con il Comunismo, cf. Divini Redemptoris, Pio XI, ndR]. Si noti bene, però, che questo centuplo materiale è promesso da Gesù insieme con persecuzioni. I seguaci del Messia assassinato (§ 400) dovevano infatti in qualche maniera assomigliarsi a lui, e seguirlo - come dice egualmente San Paolo (ivi, 6, 4... 10) - in molta pazienza, in tribolazioni, in necessità, in angustie, in piaghe, in carceri, in tumulti, in travagli, in veglie, in digiuni; ma pur fra queste vicende essi potevano affermare, insieme col nomenclatore delle medesime, di essere come castigati e non messi a morte, come attristati ma sempre gaudenti.

Da Vita di Gesù Cristo, imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
L’Associazione Sursum Corda Onlus, secondo quanto previsto dallo Statuto associativo, ha recentemente effettuato due raccolte per i poveri. Le consegne dei beni - recapitati alla Caritas di Potenza - sono avvenute in data 20 e 21 giugno 2019 a beneficio dei cristiani in difficoltà. Segue l’elenco dei capi d’abbigliamento - molti dei quali di prestigiosi marchi (es. Lacoste, Fred Perry, Jeckerson, Ralph Laurent, Brooksfield) - destinati alla beneficenza: n° 17 maglioni da uomo; n° 2 felpe da uomo; n° 21 polo da uomo, manica lunga e manica corta; n° 14 magliette da uomo, manica corta; n° 1 giubbino da uomo in renna; n° 10 pantaloni di tipo militare assortiti; n° 1 giacca di tipo militare; n° 7 camicie da uomo, manica lunga; n° 3 capi di biancheria da bagno; n° 1 cappotto in piuma d’oca; n° 1 maglione da donna; n° 25 capi d’abbigliamento per bambino; infine dell’intimo vario. Il nostro auspicio è che questi beni possano essere utilizzati dai cristiani appartenenti a categorie disagiate od a rischio emarginazione. Ci auguriamo, a Dio piacendo e sotto il patrocinio di San Giovanni di Dio, di poter proseguire con queste piccole iniziative e di accrescere costantemente il nostro impegno nelle opere di misericordia spirituale e corporale.
Gli Associati ed i Sostenitori che intendono contribuire possono inviare prodotti non rovinati e puliti, o possibilmente nuovi di negozio, da destinare alla beneficenza all'indirizzo dell'Associazione. Si consiglia di avvisare telefonicamente o via mail prima di effettuare spedizioni.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, il naturale e ciclico caldo di stagione è finalmente giunto. Le nostre città sono sempre più torride ed il clima è sfiancante. Raccomandiamo, dunque, nervi saldi, temperanza, igiene del corpo e modestia nel vestire: il buon cristiano si riconosce anche da questo. La morale cristiana - recita il Roberti-Palazzini (Teologia morale, imprimatur 1957, pag. 1531) - permette ed esige una cura ragionevole, moderata del vestire, ordinata al suo giusto fine, entro determinati limiti (differenti secondo la condizione sociale della persona), senza esagerazione o negligenza, e conforme alle prescrizioni dell’igiene e della modestia. Il disordine nel vestire, dunque, proviene dall’offendere o dal non soddisfare al suo fine, o dall’oltrepassare i giusti limiti. In pratica un vestito può essere illecito a causa: 1) o del fine disordinato (immoderato gusto di piacere o di attirare gli sguardi, seduzione ecc.); 2) o dell’effetto anche se preterintenzionalmente provocato (danni economici, fisici e specialmente morali). Ci torneremo nell’articolo che segue.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, il naturale e ciclico caldo di stagione è finalmente giunto. Le nostre città sono sempre più torride ed il clima è sfiancante. Raccomandiamo, dunque, nervi saldi, temperanza, igiene del corpo e modestia nel vestire: il buon cristiano si riconosce anche da questo. La morale cristiana - recita il Roberti-Palazzini (Teologia morale, imprimatur 1957, pag. 1531) - permette ed esige una cura ragionevole, moderata del vestire, ordinata al suo giusto fine, entro determinati limiti (differenti secondo la condizione sociale della persona), senza esagerazione o negligenza, e conforme alle prescrizioni dell’igiene e della modestia. Il disordine nel vestire, dunque, proviene dall’offendere o dal non soddisfare al suo fine, o dall’oltrepassare i giusti limiti. In pratica un vestito può essere illecito a causa: 1) o del fine disordinato (immoderato gusto di piacere o di attirare gli sguardi, seduzione ecc.); 2) o dell’effetto anche se preterintenzionalmente provocato (danni economici, fisici e specialmente morali). Ci torneremo nell’articolo che segue.
• Veniamo, adesso, al nostro abituale studio della Sacra Scrittura e, più precisamente, della «Vita di Gesù Cristo» secondo gli insegnamenti dell’Abate Ricciotti. § 479. A questo punto, nella serie dei fatti, Luca cede il passo a Matteo e Marco per la questione del divorzio; di tale questione Luca (16, 18) dà soltanto la sentenza conclusiva di Gesù, senza alcun accenno alle circostanze e senza collegamento nel contesto immediato: invece Matteo e Marco comunicano le circostanze della questione. D’altra parte, Luca concorda con gli altri due Sinottici nel riferire l’accoglienza fatta da Gesù ai fanciulli, la quale dai due è posta immediatamente dopo la questione del divorzio; è dunque spontaneo concludere che tale questione - omessa da Luca perché forse la ritenne inutile per i suoi lettori pagani - avvenisse immediatamente prima dell’accoglienza fatta ai fanciulli. Si avvicinarono pertanto i Farisei e proposero a Gesù la seguente questione: «Se è lecito rimandare la propria moglie per qualsiasi causa?» (Matteo, 19, 3). L’Evangelista ha avvertito che i Farisei facevano questa domanda per tentare Gesù. Era infatti una questione vecchia, già trattata nelle scuole rabbiniche prima di Gesù e prolungatasi anche dopo. Nella Legge di Mosè il divorzio era stato concesso, solo ad iniziativa del marito, con queste parole: «Quando un uomo prende moglie e ne diventa marito, e avvenga che ella non trovi grazia negli occhi di lui, bensì egli trovi in lei alcunché di turpe, egli scriverà per lei il libello di ripudio e lo consegnerà in mano a lei, e la rimanderà da casa sua» (Deuteronomio, 24, 1); il libello di ripudio permetteva alla divorziata di contrarre nuovo matrimonio, ma dopo questo matrimonio - cessato che fosse per morte del nuovo coniuge o per nuovo divorzio - il primo marito non poteva più riprendere con sé la donna divorziata (ivi, 24, 2-4). I rabbini erano fieri di questa facoltà di divorzio e la ritenevano una prerogativa concessa da Dio al solo popolo d’Israele ma non ai pagani; la divergenza nasceva tra loro quando si trattava di definire la ragione sufficiente per ammettere il divorzio, ragione accennata dalla Legge con le parole «alcunché di turpe» trovato dal marito nella moglie. Stando a quanto riferisce la Mishna (Ghittīn, IX; 10), le scuole dei due grandi maestri pre-cristiani Shammai e Hillel prendevano qui, come in altri casi, posizione contraria: gli Shammaiti interpretavano la ragione addotta dalla Legge in senso morale, cosicché secondo essi «alcunché di turpe» alludeva all’adulterio, che era il caso autorizzante il divorzio; gli Hilleliani la interpretavano in senso molto più largo, come riferita a tutto ciò che fosse sconveniente nella vita familiare o civile, e portavano l’esempio di una moglie che lasciasse bruciare una pietanza meritandosi perciò il divorzio. Più tardi Rabbi Aqiba andrà anche più in là, affermando che ragione sufficiente per il divorzio era se il marito trovava una donna più bella della propria moglie. È difficile dire se i Farisei che proposero la questione a Gesù fossero Shammaiti o Hilleliani. Le loro parole «è lecito rimandare (...) per qualsiasi causa?» alludono certamente alla dottrina lassista degli Hilleliani: ma questa allusione vuol essere un invito ad accettare la stessa dottrina, ovvero un ammonimento per respingerla? In altre parole, sono i lassisti Hilleliani che sperano trarre Gesù dalla loro parte, ovvero sono i rigoristi Shammaiti che sperano udire da Gesù una condanna della dottrina lassista? Gesù, come in altri casi, passa sopra ad Hilleliani e Shammaiti e si riporta alle origini della questione. Egli rispondendo disse: «Non leggeste che chi creò dapprincipio “maschio e femmina li fece”, e disse: “A causa di ciò abbandonerà l’uomo il padre e la madre e s’attaccherà alla propria moglie, e saranno i due in una sola carne”?» (Genesi, 1, 27; 2, 24). Cosicché non sono più due, ma una sola carne. Ciò dunque che Iddio congiunse, uomo non separi» (Matteo, 19, 4-7). Con questa risposta, e specialmente con il suo periodo conclusivo, l’istituzione del matrimonio è investigata nelle sue stesse origini, anteriori a qualsiasi disputa umana ed anche alla Legislazione di Mosè: con la doppia citazione del Genesi è chiamato in causa Iddio stesso, creatore del genere umano ed istitutore del matrimonio, e la conclusione è che ciò che Iddio congiunse, uomo non separi.
• § 480. La replica dei Farisei era prevedibile. Risposero infatti: «Perché, dunque, Mosè comandò di “dare un libello di ripudio e rimandare”» (Deuter., 24, 1)? Non era il divorzio un privilegio degli Israeliti? Non era stato contemplato e regolato nella stessa Legge di Mosè? Se valeva la norma di Gesù «uomo non separi», bisognava rinunziare al privilegio del divorzio: il che, per quei Farisei, era un assurdo. Alla difficoltà legale oppostagli, Gesù rispose rettificando; non si trattava di un privilegio, bensì di una tolleranza, carpita dalle condizioni personali dei destinatari e concessa per timore di peggio. Disse loro: «Mosè, a cagione della vostra durezza di cuore, vi concesse di rimandare le vostre mogli: ma da principio non fu cosi». Con quest’ultimo appello, la questione era riportata ancora una volta alle sue origini. Al rinnovato appello segue in Matteo un periodo sostanzialmente parallelo a quello da lui riportato nel Discorso della montagna (§ 325). Matteo (19, 9): «Ma io vi dico che chiunque rimandi la sua moglie, non per fornicazione, e sposi un’altra commette adulterio». Discorso della Montagna: «Ma io vi dico che chiunque rimandi la sua moglie, eccettuato (il) caso di fornicazione, fa ch’ella sia resa adultera, e chi sposi una (donna) rimandata commette adulterio». La stessa sentenza di Gesù si ritrova negli altri due Sinottici, presso i quali, tuttavia, manca il comma restrittivo «non per fornicazione», ovvero «eccettuato (il) caso di fornicazione». Marco (10, 11-12): «Chi rimandi la sua moglie e sposi un’altra, commette adulterio contro di lei; se ella, rimandato suo marito, sposi un altro, commette adulterio». Luca (16, 18): «Chiunque rimanda la sua moglie e sposa un’altra, commette adulterio; e chi sposa una rimandata dal marito, commette adulterio». A questi due Sinottici si deve aggiungere San Paolo, come testimonio anche anteriore (§ 102) della primitiva catechesi cristiana, il quale scrive: «Agli sposati comando, non io ma il Signore, che la donna non si separi dall’uomo - che se poi si è separata, rimanga senza sposare, oppure si riconcilii con l’uomo - e che (l’) uomo non rimandi (la) donna» (I Corinti, 7, 10-11). Nel qual passo San Paolo distingue chiaramente la «separazione» dei due coniugi dal «rimando» della donna o divorzio; egli ammette la possibilità del primo caso, purché la donna non passi a nuove nozze; nega invece semplicemente la liceità del divorzio. La primitiva catechesi, dunque, è per noi rappresentata da due gruppi di testimonianze. Uno è quello di Matteo, che si ripete due volte (5, 32; 19, 9); l’altro è costituito dalle testimonianze di Marco, Luca e Paolo. Il primo gruppo ha il comma restrittivo; il secondo non ha questo comma. In che relazione stanno tra loro questi due gruppi? Esiste contraddizione tra loro? Parecchi critici radicali vi hanno scorto una contraddizione. Essi riconoscono che la primitiva catechesi non ammetteva il divorzio neppure nel caso d’adulterio, secondo le concordi testimonianze di Marco, Luca e Paolo; ma poiché in Matteo si trova il comma restrittivo che sembra ammettere il divorzio in tale caso, hanno risolto la difficoltà col solito metodo di dichiarare quel comma un’interpolazione: «esso - dicono i radicali - sarebbe stato aggiunto nel testo di Matteo alle parole di Gesù per andare incontro alle esigenze di Giudei fattisi Cristiani, i quali non sarebbero stati disposti a rinunziare al divorzio in caso di infedeltà della moglie». Metodo certamente assai agevole, e che per giunta in questo caso sarebbe comodissimo ai Cattolici; ma anche metodo arbitrario, se non è suffragato - come non è nel presente caso - da nessun documento, e che inoltre va contro alla norma secondo cui il testo più difficile è di solito da preferirsi, come migliore di quello più facile. Qui, appunto, il testo di Matteo, con la sua particolare difficoltà, ha tutte le apparenze di aver conservato meglio l’insieme delle parole di Gesù. Ma qual è il vero senso del comma in questione?
• § 481. Si noti che i Farisei hanno domandato a Gesù «se è lecito rimandare la propria moglie per qualsiasi causa», intendendo senza dubbio il divorzio ebraico; Gesù, in risposta, ha dichiarato lecito tale rimando nel solo caso di fornicazione (adulterio) della donna. Con tale dichiarazione Gesù si è staccato doppiamente dalla Legislazione ebraica: in primo luogo perché in quella Legislazione alla donna adultera era comminata la morte (§ 426) e non il divorzio: in secondo luogo, perché egli non permette al marito che ha rimandato la moglie per adulterio di sposare altra donna, e ciò in perfetta armonia col principio da lui testé enunziato secondo cui «ciò che Iddio con giunse, uomo non separi». Dunque, anche se gli interroganti intendevano riferirsi al vero divorzio ebraico, Gesù non ha concesso tale divorzio neppure nel caso di adulterio, perché il marito in questione non può sposare altra donna, ossia non ha divorziato. Gesù, dunque, ha concesso non il «divorzio» bensì la «separazione». Ma i Giudei sapevano distinguere tra «divorzio» e «separazione»? Qualunque fossero in proposito i loro concetti puramente giuridici (dei quali non siamo sicuramente informati), è certo che in pratica si conosceva e si eseguiva la «separazione» di due coniugi rimanendo essi tali. Il citato passo di San Paolo (§ 480) è decisivo in proposito La stessa Sacra Scrittura narrava un esempio, sebbene antico, in cui la stizzosa moglie di un Levita dopo un litigio si era separata da lui per quattro mesi rifugiandosi presso il proprio padre, dopo di che il marito era andato a rappacificarla inducendola a ritornare presso di lui [Il celebre episodio del Levita di Efraim, Giudici, 19, 1 segg.]. Più forti ancora di queste ragioni sono in primo luogo la circostanza che Marco e Luca non riportano affatto il comma restrittivo [caso di adulterio], appunto perché la primitiva catechesi stimò che esso non era di alcun valore contro l’indissolubilità del matrimonio e in favore del divorzio ebraico: in secondo luogo l’altra circostanza che i discepoli di Gesù, nella loro mentalità ebraica, valutarono appieno l’intransigenza della norma da lui esposta.
• § 482. Terminata infatti la lezione ai Farisei, i discepoli tornarono sulla questione dolorosa della moglie (qualcuno di essi, come Pietro, era ammogliato) interrogandone Gesù privatamente in casa (Marco, 10, 10). Un’esclamazione sommamente spontanea venne allora su dal profondo del loro cuore: «Se in tal modo è la condizione dell’uomo con la moglie, non mette conto sposare!». L’intransigenza era stata capita benissimo dai discepoli; adesso, secondo Gesù, un marito non solo non poteva più far divorzio dalla moglie dopo la bruciatura di una pietanza, come permetteva Hillel, ma doveva ritenersi irrimediabilmente legato ad essa perfino dopo l’adulterio di lei. Le menti giudaiche dei discepoli ne rimasero perturbate: Gesù avrà avuto certamente ragione ed Hillel [aveva torto], ma in tal caso essi stimavano che era preferibile non legarsi a nessuna donna e non sposare affatto. Gesù, dal canto suo, lungi dal temperare la sua precedente intransigenza, giudicò troppo generica l’esclamazione degli sconcertati discepoli, dichiarandola adatta per alcuni e disadatta per altri. I singoli individui del genere umano non sono, per Gesù, tutti egualmente disposti di fronte a tale questione: essi si raggruppano in più categorie, alle quali non si può imporre [un unico e comune stato di vita]. Alcuni potranno ripetere con libera e piena adesione di coscienza l’esclamazione dei discepoli, e questi sono i privilegiati; altri la ripetono per una necessità buona o cattiva imposta dalla natura o dalla società umana, e questi sono i forzati; altri non la ripetono affatto, e questi prendono moglie. Di questi ultimi non si occupa qui Gesù, che vuole mostrare ai discepoli i pregi del celibato scelto liberamente e per uno scopo religioso [non per evitare di tenere in moglie un’adultera]. Egli però disse loro: «Non tutti capiscono questa parola, ma (solo) coloro ai quali è dato (capirla). Vi sono infatti eunuchi che dal seno della madre furono generati così; e vi sono eunuchi che furono resi eunuchi dagli uomini; e vi sono eunuchi che si resero eunuchi da se stessi per il regno dei cieli. Chi può capire capisca». Non si tratta dunque di una legge [quella del celibato] data a tutti; si tratta di una proposta vantaggiosa per il regno dei cieli offerta a chi può capirla, e che possono capire (solo) coloro ai quali è dato (capirla). Gli altri agiscano liberamente, e prendano pur moglie: a patto però che «ciò che Iddio congiunse, uomo non separi». Riassumendo, si trova che Gesù non ha affatto condannato il matrimonio, bensì lo ha riportato alla sua ragione e norma primitiva, pur avendolo posposto al celibato liberamente scelto per il regno di Dio. Una riprova se ne può vedere nel fatto che, subito dopo la disputa sul matrimonio, Matteo e Marco narrano l’accoglienza fatta da Gesù ai bambini (Luca ha l’accoglienza, ma non la disputa). I bambini sono i frutti dell’albero matrimoniale; e Gesù, che ha testé potato l’albero dai rami secchi e da vegetazioni parassitarie, fa festa a quei frutti riserbando a quei piccoli innocenti una predilezione somigliantissima, sebbene d’altro genere, a quella riserbata alle meretrici e ai pubblicani.
• § 483. «E recavano a lui dei fanciullini affinché li toccasse; ma i discepoli sgridavano quelli (che li recavano). Visto però (questo), Gesù si sdegnò e disse loro: “Lasciate che i fanciullini vengano a me [battezzate i bambini, ndR], non li impedite, perché di tali è il regno d’Iddio. In verità, vi dico, chi non accolga il regno d’Iddio come un fanciullino, non entrerà in esso” (cfr. § 408). E abbracciatili li benediceva, ponendo le mani su di essi» (Marco, 10,13-16). Fra questi fanciullini c’erano senza dubbio sia maschi che femmine, e Gesù li abbracciava tutti con eguale affetto. Ora, un trentennio prima di questa scena, e precisamente nell’anno I avanti Cristo, un contadino egiziano che si era allontanato da casa sua per ragioni di lavoro, aveva scritto a sua moglie, lasciata da lui gravida, una lettera conservataci fra i papiri recentemente recuperati; la lettera finisce con questo comando dato alla futura madre: «Quando avrai partorito il bambino, se è maschio, allevalo; se è femmina, ammazzala» (Oxyrhyncus Papyri, IV, n. 744). Né quel contadino agiva diversamente da tanti altri padri di quei tempi [e prima della Cristianità], in Egitto e fuori.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, abbiamo caricato sul nostro canale Youtube il prezioso video: «Abate Giuseppe Ricciotti sull’eutanasia: il suicidio commissionato». Segue la trascrizione dell’intervento: «Suicida è il malato che, essendo disperato della sua salute, vuole morire. Omicida è il medico che accetta quasi la commissione del malato disperato e acconsente di ucciderlo. Abbiamo, cioè, un suicidio commissionato. Questo è lecito? Questo è accettabile da una morale seria? No, perché la vita è un deposito che noi abbiamo e che non abbiamo creato da noi stessi. La vita, in altre parole, è un posto di battaglia che noi riceviamo da un alto Capitano e non possiamo in nessuna maniera abbandonare questo posto di battaglia, anche se è doloroso, anche se è faticoso».
Stimati Associati e gentili Sostenitori, abbiamo caricato sul nostro canale Youtube il prezioso video: «Abate Giuseppe Ricciotti sull’eutanasia: il suicidio commissionato». Segue la trascrizione dell’intervento: «Suicida è il malato che, essendo disperato della sua salute, vuole morire. Omicida è il medico che accetta quasi la commissione del malato disperato e acconsente di ucciderlo. Abbiamo, cioè, un suicidio commissionato. Questo è lecito? Questo è accettabile da una morale seria? No, perché la vita è un deposito che noi abbiamo e che non abbiamo creato da noi stessi. La vita, in altre parole, è un posto di battaglia che noi riceviamo da un alto Capitano e non possiamo in nessuna maniera abbandonare questo posto di battaglia, anche se è doloroso, anche se è faticoso».
• Veniamo, adesso, agli odierni argomenti di studio della Sacra Scrittura: «Il giudice iniquo. Il fariseo e il pubblicano». § 477. Il precedente dialogo [sulla Parusia] ebbe uno strascico. Come prospettiva terrena, il dialogo aveva pronunziato parole di colore oscuro, che avevano lasciato prevedere, oltre alla sofferenza suprema ed alla riprovazione del maestro, anche quei giorni di distretta e di calamità in cui i discepoli avrebbero desiderato invano di vedere uno solo dei giorni trionfali del figlio dell’uomo. Ma, se in quei giorni di prova i discepoli avessero pregato, non sarebbero stati esauditi? La prova non sarebbe stata abbreviata? Iddio non avrebbe reso giustizia ai suoi eletti, facendo un piccolo anticipo al trionfo finale del figlio dell’uomo? Si, certamente; e Gesù espresse questo insegnamento con una parabola molto simile a quella dell’amico importuno (§ 443) e riportata dal solo San Luca (18, 18) appunto dopo il precedente dialogo: «Diceva poi loro una parabola riguardo alla necessità che essi pregassero sempre e non si stancassero». C’era in una città un giudice che non aveva né timor di Dio né riguardo per uomini. Nella stessa città c’era anche una povera vedova che, come di solito le vedove nell’antichità, riceveva continui soprusi da un tale. La vedova ricorreva ogni tanto dal giudice racccomandandosi: «Rendimi giustizia del mio persecutore!». - Per un pezzo il giudice non se lo dette per intesa, ma alla fine, seccato per l’insistenza della donna, fece tra sé questo ragionamento: «Se pur non temo Iddio né ho riguardo per uomo, tuttavia per il fastidio che mi dà questa donna le renderò giustizia, affinché non venga alla fine a rompermi la testa». - Finita qui la parabola, Gesù soggiunse: «Udiste che cosa dice il giudice iniquo? E Iddio forse non farà giustizia dei suoi eletti che gridano a lui di giorno e di notte ed è lento a loro riguardo? Vi dico che farà giustizia di essi con celerità!. Senonché il figlio dell’uomo, venuto (che sia), troverà la fede sulla terra?». Quest’ultima proposizione non mostra una chiara connessione logica con ciò che precede, e non senza fondamento si è pensato che essa sia un detto staccato di Gesù proveniente da altro discorso. La proposizione sembra aver presenti i tempi in cui i discepoli desidereranno vedere un solo dei giorni del figlio dell’uomo e non lo vedranno (§ 475); quei tempi saranno così duri e calamitosi che scoteranno la fiducia di moltissimi (cfr. Matteo, 24, 12; Marco, 13, 22), tanto che in tono retorico si può ben domandare se «il figlio dell’uomo... troverà la fede sulla terra». Checché sia del senso e riferimento di questa proposizione, è noto che i cristiani delle prime generazioni fecero un particolare assegnamento su queste promesse. Stretti fra persecuzioni incessanti, essi anelarono di vedere il giorno del figlio dell’uomo, in cui il Cristo trionfatore calasse dalle nubi a rendere loro giustizia: e attesero di vedere questa giustizia con celerità e di contemplare la grande rivelazione del figlio dell’uomo da un giorno all’altro. Ma alla loro ansia furono somministrati correttivi già dagli Apostoli, i quali ammonirono di non perturbarsi «quasicché sia imminente il giorno del Signore» (II Tessalonicesi, 2, 2), e di ricordarsi che «un solo giorno (è) presso il Signore come mille anni, e mille anni come un solo giorno; non ritarda il Signore la promessa» (II Pietro, 3, 8-9). Quei primi cristiani inquadravano la promessa di Gesù nel calendario dell’uomo; gli Apostoli, invece, l’inquadravano nel calendario di Dio.
• § 478. La parabola della vedova, esaudita per la sua insistenza nel pregare, porta ad un’altra riguardante l’indole e le disposizioni spirituali della preghiera: è la parabola, particolare anch’essa a San Luca (18, 9-14), in cui sono attori un Fariseo e un pubblicano, cioè i due estremi della scala su cui erano disposti i valori morali nel giudaismo. La parabola fu indirizzata da Gesù «a taluni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri». Un Fariseo e un pubblicano salgono alla stessa ora nel Tempio di Gerusalemme per pregare. Il Fariseo, nella sua confidente sicurezza di essere giusto, agisce e pensa come tale. S’inoltra egli nell’«atrio degli Israeliti» (§ 47), fino al limite più vicino al «santuario» ove dimora il Dio della sua nazione e della sua setta. Quel Dio è un essere potente: ma per lui, uomo giusto e Fariseo rigoroso, quel Dio ha una predilezione singolare, e quindi egli può trattarlo con una certa familiarità; anzi può trattarlo come un monarca, sì, ma a cui il suddito viene ad elencare una quantità di belle cose fatte in favore di lui. Il Fariseo infatti, messosi là in piedi come pregavano ordinariamente gli Ebrei, comincia il suo elenco: «O Dio, ti ringrazio perché io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, o anche come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana (§ 77); pago la decima di quanto posseggo (§ 36)». La parabola non prosegue nell’elenco; ma questo poté benissimo prolungarsi assai ed enumerare altre elette virtù del Fariseo, come le sciacquature di mani e di stoviglie prima di mangiare, l’astenersi dallo spegnere una lampada in giorno di sabbato, la conoscenza a memoria dei 613 precetti della Torah (§ 30), e tante altre egregie doti dell’inappuntabile Fariseo [il Ricciotti sta facendo del sarcasmo]. In conclusione, Dio è stato beneficato dal Fariseo: l’uomo ha fatto consistere la sua preghiera nell’elencare i benefizi elargiti da lui a Dio, ossia nello sciorinare quelle giustizie umane di cui l’antico profeta aveva sentenziato: «Come panno di mestrui (sono) tutte le nostre giustizie» (Isaia, 64, 5 ebr.). Nel frattempo il pubblicano, conscio del disprezzo decretatogli dai benpensanti del giudaismo e sicuro che lo stesso disprezzo è condiviso da Dio, si è fermato appena all’ingresso dell’atrio, come un mendico mal tollerato; là lontano, senza neppure osare di alzare gli occhi verso il «santuario», egli sta a battersi il petto implorando: «O Dio, sii propizio a me peccatore!». Tutta qui è la preghiera di colui che i rabbini definivano «tanghero» (§ 40), perché egli ha coscienza di non poter donare a Dio nulla di quanto sta donandogli il Fariseo: s’affida quindi alla misericordia di Dio confessandosi peccatore in umiltà profonda: «... io mi rendei Piangendo a quei che volentier perdona. Orribil furon li peccati miei; Ma la bontà infinita ha sì gran braccia, Che prende ciò che si rivolge a lei». (Purgatorio, III, 119-123). Il risultato del contrasto tra questi due uomini fu precisamente la smentita delle loro rispettive coscienze. Concluse infatti Gesù: «Vi dico, questo (il pubblicano) discese giustificato a casa sua a differenza di quello: perché chiunque s’innalza sarà abbassato, mentre chi s’abbassa sarà innalzato». Nessuno meglio di Sant’Agostino ha riassunto in poche linee i punti principali della parabola: «Che cosa (il Fariseo) abbia domandato a Dio, cercalo nelle sue parole: non troverai nulla. Salì per pregare; non volle domandare a Dio, ma lodare se stesso. È poco non domandare a Dio e lodare se stesso: per dippiù, anche insultava chi domandava. Il pubblicano stava lontano, egli tuttavia s’avvicinava a Dio... poco che stesse lontano: neppure alzava gli occhi al cielo... C’è dippiù, si batteva il petto... dicendo: “Signore sii propizio a me peccatore!”. Ecco colui che domanda».

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, l’Abate Ricciotti finalmente ci erudisce sugli insegnamenti dogmatico-morali e sulle vicende che caratterizzano la «Vita di Nostro Signore Gesù Cristo» (Opera citata) dall’ultimo viaggio lungo la Giudea e fino alla settimana di Passione.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, l’Abate Ricciotti finalmente ci erudisce sugli insegnamenti dogmatico-morali e sulle vicende che caratterizzano la «Vita di Nostro Signore Gesù Cristo» (Opera citata) dall’ultimo viaggio lungo la Giudea e fino alla settimana di Passione.
• § 473. Le peregrinazioni di Gesù, frattanto, continuavano; trasferitosi dalla Transgiordania nuovamente nella Giudea, egli dovette spingersi fin verso la Galilea, donde scese per il suo ultimo viaggio alla volta di Gerusalemme (§§ 413 segg., 462). All’inizio di questo viaggio, mentre Gesù stava per entrare in un villaggio posto sui confini tra la Samaria e la Galilea (che una tradizione molto tardiva vorrebbe riconoscere in Genin) gli vennero incontro dieci lebbrosi, i quali, tenendosi a distanza per la nota prescrizione (§ 304), si dettero a gridargli che avesse pietà di loro. Gesù rispose che andassero a presentarsi ai sacerdoti, come aveva già ordinato l’altra volta; non era già la guarigione, ma una promessa di guarigione. I lebbrosi interpretarono la risposta in questo senso, e s’incamminarono per obbedire; strada facendo si trovarono guariti. La felicità della guarigione fece dimenticare ad essi i doveri della gratitudine e tutti se ne andarono per i fatti loro, tranne uno, che glorificando Dio tornò addietro a ringraziare Gesù. Ora, costui era proprio un Samaritano. Gesù gradi l’omaggio di quello straniero, rilevò che egli solo aveva sentito il dovere della gratitudine, e gli confermò che era stato salvato dalla sua fede (§ 349 segg.).
• § 474. Dopo l’episodio dei lebbrosi, San Luca introduce i Farisei, e riporta un dialogo di Gesù con essi e poi con i suoi discepoli. Il dialogo, riferito quindi dal solo San Luca, contiene tuttavia vari elementi che si ritrovano nel grande discorso escatologico degli altri Sinottici (§ 523 segg.), di cui questo dialogo sembra un’ anticipazione; ma anche qui Luca è da preferirsi sotto l’aspetto cronologico, perché è assai probabile che l’argomento comune al dialogo e al discorso fosse trattato più di una volta da Gesù, sebbene gli altri Sinottici per ragioni redazionali riuniscano le varie trattazioni in una sola. Questo dialogo è provocato da una interrogazione dei Farisei che domandano a Gesù quando viene il regno d’Iddio (Luca, 17, 20). Era ironica la domanda, ovvero si riferiva seriamente alla venuta clamorosa del regno nazionalistico-messianico? Non si potrebbe dire con certezza, sebbene la risposta di Gesù faccia propendere per il secondo senso. Gesù rispose agli interroganti in maniera sbrigativa, come a gente non disposta a lasciarsi convincere: «Il regno d’Iddio non viene con avvertenza, né si dirà “Ecco (è) qui” ovvero “(È)lì”. Ecco, infatti, il regno d’Iddio è dentro voi». Questa indicazione dentro voi si riferiva alla collettività (in mezzo a voi) non ai singoli (nell’interno di ciascuno di voi), perché Gesù vuol far rilevare che il regno di Dio si propaga, non in maniera spettacolosa come l’attendevano i Farisei, ma senza avvertenza: tanto è vero che esso è già in mezzo a loro. E altro Gesù non disse a quegli interroganti maldisposti.
• § 475. Tuttavia, data l’importanza dell’argomento, vi tornò sopra rivolgendosi nell’intimità ai suoi discepoli; ai quali disse: «Verranno giorni quando desidererete vedere uno solo dei giorni del figlio dell’uomo, e non vedrete (tal giorno)». I giorni qui annunziati sono di distretta e di calamità: in quelle circostanze i discepoli di Gesù desidereranno di vedere uno solo dei giorni in cui il figlio dell’uomo viene in possanza (§ 401), cioè dispiegando quella sua forza che gli assicurerà il trionfo finale: eppure quel sospirato giorno, di manifesta ripresa e palese sopravvento contro le calamità imperversanti, non verrà. Si avranno piuttosto annunzi fallaci, contro i quali Gesù mette in guardia i suoi discepoli: «E vi si dirà “Ecco (è) qui”, “Ecco (è) là”» il sospirato figlio dell’uomo che torna da trionfatore; ma voi non prestate fede, «non vi muovete, né andate appresso» a tali indicazioni. «Come infatti la folgore folgoreggiando da un punto all’altro del cielo lampeggia, così sarà il figlio dell’uomo nel giorno suo». Dunque il figlio dell’uomo verrà indubbiamente da trionfatore a compiere la consumazione del regno messianico, ma quel suo giorno sarà subitaneo e improvviso come la folgore del cielo né alcuno potrà prevederlo; oltre a ciò, quel suo trionfo dovrà essere preceduto dalla sua sofferenza (§ 400): «Prima però è necessario che egli soffra molto, e che sia riprovato da questa generazione» (Luca, 17, 25). Stante questa sicurezza del fatto unita con l’incertezza del tempo, i discepoli dovranno stare sempre pronti e non abbandonarsi alla negligenza a cui si abbandoneranno gli altri uomini. «E come avvenne nei giorni di Noè, così sarà anche nei giorni del figlio dell’uomo: mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno che Noè entrò nell’arca e venne il diluvio e distrusse tutti. Similmente, come avvenne nei giorni di Lot: mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano, ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e distrusse tutti; conforme a ciò sarà nel giorno in il figlio dell’uomo si rivela». Cosicché molti, moltissimi, saranno coloro che nel giorno del figlio dell’uomo penseranno a tutt’altro che a lui e al suo trionfo; questi moltissimi staranno tenacemente attaccati al mondo che tuttora li avvolge, e non si accorgeranno del mondo nuovo che sopravviene: come appunto la moglie di Lot al tempo del cataclisma era ancora attaccata col desiderio alla sua casa di Sodoma, e fu uccisa da questo suo attaccamento che la fece rivolgere indietro. «In quel giorno chi starà sul tetto e i suoi oggetti (staranno) dentro la casa, non scenda a prenderli; e chi (starà) nel campo, egualmente non si rivolga addietro. Ricordatevi della moglie di Lot! Chi cerchi di porre in salvo la sua vita la perderà, e chi la perderà la farà vivere». Perciò l’avvento glorioso del figlio dell’uomo, essendo subitaneo ed imprevisto, esige che tutti siano staccati da tutto, perfino dalla propria vita, onde seguire immediatamente il trionfatore apparso. Questo distacco sarà il criterio di discriminazione per selezionare coloro che seguiranno il trionfatore. «Vi dico: in quella notte saranno due in un solo letto; l’uno sarà preso e l’altro sarà lasciato. Saranno due (donne) macinanti alla stessa (mola); e l’una sarà presa e l’altra sarà lasciata». Ma, fatta la discriminazione, coloro che saranno presi dove andranno? Evidentemente presso il trionfatore apparso. I discepoli ne interrogano Gesù dicendogli: «Dove, Signore?». Forse, più che la risposta, intendevano il luogo. A quest’ultimo punto non rispose Gesù, che si limitò a far rilevare come i prescelti si raccoglieranno spontaneamente da tutto il mondo attorno al trionfatore, con la stessa rapidità sicura con cui le aquile si raccolgono attorno al carname: «Dove (sta) il corpo, là pure sopra s’accoglieranno le aquile».
• § 476. Riassumendo in poche parole l’intero dialogo, troviamo che Gesù ha parlato del regno di Dio ai Farisei e ai discepoli. Ai Farisei egli ha confermato che quel regno è un fatto, non fragoroso o folgoreggiante, ma pure realissimo, tanto che è già in mezzo ad essi: è dunque la predicazione stessa di Gesù, simboleggiata nella stessa maniera per mezzo delle parabole (§ 365 segg.). Ai discepoli Gesù ha parlato di una nuova venuta del figlio dell’uomo, destinata al trionfo palese di lui ed alla consumazione del regno messianico: essa sarà subitanea ed imprevista, e poiché deciderà circa la sorte degli eletti e dei riprovati, tutti devono tenersi pronti col distacco assoluto da ogni bene presente. È dunque la parusia del Cristo glorioso, che instaurerà il regno di palese ed universale giustizia e che costituisce l’ultimo risultato della predicazione di Gesù, presentata poco prima ai Farisei egualmente come regno di Dio. Di questa parusia parlerà nuovamente Gesù (§ 525 segg.).

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, Vi siamo davvero grati per la numerosa, devota e fervorosa partecipazione allo scorso «Pellegrinaggio della Tradizione», processione di 22 km da Osimo a Loreto in onore della Virgo Lauretana. Un appuntamento di vera amicizia, di amici della Chiesa, amici del Papato, amici del Clero, amici dei Santi e dei Martiri, amici di Nostro Signore Gesù Cristo e della Beata Vergine Maria. Cogliamo l’occasione per segnalare la relazione sulla vera amicizia, tratta soprattutto dagli studi di Cornelio ALapide, pubblicata sul nostro canale Youtube. Veniamo al consueto studio della Sacra Scrittura usando la preziosa «Vita di Gesù Cristo» dell’Abate Ricciotti, che oggi ci parla del fattore infedele e del ricco epulone.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, Vi siamo davvero grati per la numerosa, devota e fervorosa partecipazione allo scorso «Pellegrinaggio della Tradizione», processione di 22 km da Osimo a Loreto in onore della Virgo Lauretana. Un appuntamento di vera amicizia, di amici della Chiesa, amici del Papato, amici del Clero, amici dei Santi e dei Martiri, amici di Nostro Signore Gesù Cristo e della Beata Vergine Maria. Cogliamo l’occasione per segnalare la relazione sulla vera amicizia, tratta soprattutto dagli studi di Cornelio ALapide, pubblicata sul nostro canale Youtube. Veniamo al consueto studio della Sacra Scrittura usando la preziosa «Vita di Gesù Cristo» dell’Abate Ricciotti, che oggi ci parla del fattore infedele e del ricco epulone.
• § 470. Oltre ad essere lo scriba della misericordia, San Luca è anche l’Evangelista della povertà (§145): ecco quindi che nella collana di parabole che stiamo esaminando, alle perle sulla misericordia divina seguono altre sulla povertà umana, anche queste conservate dal solo forziere di Luca. Che il rinunziare alla ricchezza fosse un atto di accortezza da parte del seguace di Gesù, fu da lui mostrato con la seguente parabola. Ci fu un uomo ricco che aveva un fattore, e costui fu accusato presso il padrone di dissiparne i beni; perciò fu chiamato dal padrone, che gli disse seccamente: «Mi sono giunte all’orecchio cattive voci sul conto tuo; presentami al più presto i conti della tua amministrazione!». - Uscito di là, il fattore pensò ai casi suoi, e si vide perduto se non avesse trovato qualche ripiego per campare la vita nella sua vecchiaia. Cominciò quindi a ragionare: «Adesso che mi sarà tolta l’amministrazione, come potrò mantenermi? A lavorare nei campi non sono più capace; a domandare l’elemosina mi vergogno». Dopo averci ripensato su lungamente, decise di far ricadere sul padrone il peso del suo sostentamento per mezzo di un’astuta truffa. Si trattava di diminuire falsamente il debito che ciascun colono aveva col padrone, affinché poi quei debitori fraudolentemente beneficiati si mostrassero grati col fattore ricompensandolo. Chiamato perciò un colono gli domandò: «Quanto devi al mio padrone?» - Quello rispose: «Cento barili d’olio». - Il fattore allora: «No, prendi qua la ricevuta e scrivi cinquanta!». - Cosicché a questo primo debitore era rimessa la metà del debito. Chiamato poi un altro, gli fece la stessa domanda; e quello rispose: «Devo cento misure di grano». - E il fattore: «No, prendi qua la ricevuta, e scrivi ottanta!». - Naturalmente con questo metodo egli trattò tutti gli altri coloni del padrone, i quali gli furono ben grati nel presente e anche nel futuro. E in tal modo il fattore esonerato provvide alla sua vecchiaia. Un furto, senza dubbio. Ma un furto furbo, ben congegnato, che mostra l’accortezza e la previdenza di quel fattore, riluttante a finire nella miseria. Qui appunto sta la forza della parabola, la quale - astraendo dalla disonestà del furto che non entra in considerazione - converge tutta su quella accortezza e quella previdenza. La parabola, infatti, prosegue dicendo che quel padrone, parlando della frode di cui era stato vittima, lodò il suo fattore truffaldino perché prudentemente aveva agito. Era un uomo di spirito quel padrone, e sapeva prendere da gran signore i dispiaceri della vita mettendone in luce gli aspetti interessanti! La parabola, quindi, termina ammonendo che i figli di questo secolo sono più prudenti dei figli della luce fra (quelli della) loro generazione, cioè confrontati con i membri della rispettiva categoria. Ma a spiegare meglio il funzionamento di questa prudenza, Gesù aggiunse: «E io vi dico: “Fatevi degli amici per mezzo dell’iniquo Mammona (§ 331), affinché quando (esso) venga a mancare vi accolgano negli eterni tabernacoli”». Con queste parole il funzionamento della prudenza è chiaro, e la parabola, trasportata ad un’atmosfera superiore, è applicata con precisione. Le ricchezze terrene siano spese tutte per acquistare, non già beni terreni che sono egualmente transitori e fallaci, bensì beni perenni e sicuri. E in qual modo? Impiegando quelle ricchezze nel beneficare i poveri. Questa beneficenza è un frutto imperituro delle ricchezze, perché i beneficati diventano gli amici del beneficante e al crollo di questo secolo lo ricompenseranno accogliendolo negli eterni tabernacoli. Con ciò riappare evidentissima la sanzione ultraterrena che è alla base di tutta la dottrina di Gesù (§ 319): erogare le proprie ricchezze in vista e in attesa della vita futura. In quella suprema attesa (§ 450 segg.) la povertà è somma prudenza.
• § 471. I Farisei, che udirono l’esposizione di questi principii ma non partecipavano alla suprema attesa, trovarono che tutto ciò era sciocco. Udivano tutte queste cose i Farisei, che erano amatori del denaro, e lo beffeggiavano. E che modo di parlare era quello? Buttare via il proprio denaro per rimaner poi nudi come un lumacone senza guscio? Queste erano, non soltanto pazzie da mentecatto, ma anche bestemmie da eretico! La legge ebraica parlava ben chiaro: la prosperità materiale era una benedizione di Dio e un premio per chi osserva le norme della morale religiosa (cfr. Levitico, 26, 3 segg.), mentre la povertà e la miseria erano il retaggio degli empi secondo l’antica tradizione ebraica (cfr. Giobbe, 8, 8 segg.; 20, 4 segg.; 27, 13 segg.). Se dunque Gesù era povero, peggio per lui: era segno che Dio non gli concedeva il premio dei giusti perché non lo meritava; ma cessasse di sconvolgere la Legge e la tradizione ebraica (Questo ragionamento non è riportato da San Luca, ma si può ragionevolmente ricostruire in maniera approssimativa sulla base della risposta di Gesù in Luca, 16 15-16). Gesù, riferendosi al vero motivo che faceva parlare i Farisei in difesa delle ricchezze, rispose: «Voi siete coloro che si dimostrano giusti davanti agli uomini (in quanto cioè si spacciavano per giusti perché ricchi), ma iddio conosce i vostri cuori; perché ciò che è eccelso tra gli uomini è abominio davanti a Iddio». Quanto alla Legge e alla tradizione, questo delle ricchezze era uno dei casi in cui l’antica Legge doveva essere compiuta e perfezionata (§ 322): infatti «la Legge e i Profeti, fino a Giovanni (il Battista); da allora, del regno d’Iddio si dà la buona novella e ognuno fa violenza verso di esso» (Luca, 16, 15-16). La Legge allettava i suoi seguaci anche con la promessa delle ricchezze; ma dopo Giovanni il Battista la [vecchia] Legge [ebraica] è stata sostituita dal regno di Dio, che non promette più beni materiali ed esige anzi la violenza morale di distaccarsi da essi. Del resto lo stesso spirito intimo della Legge antica non induceva ad attaccarsi alle ricchezze ma a superarle, perché esse erano proposte come mezzo e non come fine: chi si fermava a questo mezzo allettativo, tradiva lo spirito della Legge. Questo è l’insegnamento che Gesù illustrò con una nuova parabola strettamente aderente a vari concetti del giudaismo, tanto da apparire sotto un certo aspetto la più giudaica delle parabole di Gesù.
• § 472. C’erano due Giudei, uno ricchissimo, l’altro poverissimo. Il ricco portava vesti fatte di porpora di Tiro e di bisso d’Egitto, e ogni giorno teneva conviti interminabili. Il povero, che aveva il comunissimo nome di Lazaro, giaceva ricoperto di piaghe sulla strada presso l’atrio del ricco; di là egli sentiva il lontano frastuono dei conviti del ricco e suo sogno supremo sarebbe stato saziarsi di ciò che cadeva da quelle mense, ma nessuno badava a lui: anzi, pur in quella sua povertà così nera, sembra che egli recasse qualche utilità al ricco, giacché i cani (forse di costui) ogni tanto al passargli davanti si fermavano a leccare il marciume delle piaghe che gli ricoprivano il corpo. Ma, come Dio volle, morirono ambedue [il ricco epulone ed il povero Lazzaro], e allora le parti si invertirono. Morto prima Lazaro, vennero gli angeli e lo trasportarono di peso su in alto nel luogo di felicità eterna deponendolo nel Seno di Abramo [o Limbo dei Padri, luogo che ospitava le anime dei giusti prima della «discesa agli inferi» di Nostro Signore - Approfondimenti sul Limbo], fra le braccia del privilegiato «amico di Dio» capostipite degli Ebrei. Morto poi il ricco, fu sepolto con gran pompa; la quale però fu anche l’ultima, giacché dalla sua splendida tomba egli rotolò giù nella Sheol [§ 79 - nell’Inferno], ove si trovò immerso in atroci tormenti. Capovoltasi in tal modo la situazione, il già ricco alzando gli occhi dalla Sheol vide su in alto Abramo che sorreggeva dolcemente in seno il già povero Lazaro. Alzò allora anche la voce gridando: «Padre Abramo! Abbi pietà di me, e invia Lazaro affinché bagni d’acqua la punta del suo dito e refrigeri la mia lingua, perché spasimo in questa fiamma!». Ma Abramo disse: «Figlio! Ricordati che ricevesti i tuoi beni nella vita tua e Lazaro egualmente i mali; adesso però qui (egli) è consolato, tu invece spasimi». Il giusto Abramo fa rilevare la giustizia della doppia sorte: poiché il ricco è stato «dimostrato giusto davanti agli uomini» (Luca, 16, 15) dalle sue ricchezze e la sua religione è consistita tutta in questo, egli è già stato ricompensato sufficientemente; poiché d’altra parte «ciò ch’è eccelso fra gli uomini [fra i mondani] è abominio davanti a Iddio», adesso davanti a Dio le sue passate ricchezze [usate male] diventino per lui ragione di sofferenza. Precisamente il contrario, per la ragione inversa, avvenga a Lazaro. Del resto le nuove sorti sono assolutamente immutabili, e Abramo non può far niente anche per uno della sua razza che non stia lassù vicino a lui: «E oltre a tutto questo, tra noi e voi è stato stabilito un abisso grande, affinché quei che volessero passare di qui verso di voi non possano né di costà si attraversi verso di noi». Anche qui si trova la sorte perfettamente invertita: come prima della morte il ricco non faceva nulla in pro di Lazaro, così adesso Lazaro non fa nulla in pro del ricco; l’abisso morale che separava i due è diventato adesso un abisso cosmologico. Tuttavia il ricco, anche rotolato nella Sheol, ripensa ai suoi parenti e desidera - [ma non ber bontà di animo, giacché è impossibile per un dannato] - che almeno essi sfuggano in futuro alla sorte presente di lui. A tale scopo torna a pregare Abramo: «Ti chiedo perciò, padre, che invii lui (Lazaro) a casa di mio padre - ho infatti cinque fratelli - affinché faccia testimonianza ad essi, affinché non vengano anch’essi in questo luogo del tormento». Ma neppure questa domanda è accolta da Abramo, il quale secco secco risponde: «Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino quelli!», cioè regolino la loro condotta conforme alle norme di Mosè e dei Profeti consegnate nella Sacra Scrittura, e ciò basterà ad evitare il luogo del tormento. Ma il ricco non è di questa opinione, e perciò insiste: «No, padre Abramo! Ma se alcuno da(lla regione dei) morti vada a loro, cambieranno di mente». La ragione è respinta risolutamente da Abramo, che chiude la disputa sentenziando: «Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neppure se alcuno sia risorto dai morti saranno persuasi». In conclusione, la Legge ebraica non solo non è abolita, ma è dichiarata più efficace della rivelazione privata fatta da un morto risuscitato. [Lo stesso ragionamento è certissimo oggi, nell’epoca del materialismo più radicale. Difatti il cristiano che vuol salvarsideve osservare il Catechismo e obbedire ai Precetti della Chiesa, non in altra maniera può salvarsi, poiché ha quanto basta per avere, grazie a Dio, la vita eterna. E se si rifiuta di osservare Catechismo e Precetti che vengono dalla Chiesa, dal Papa, insomma dalla legittima Autorità di Dio, peggio ancora vivrà nell’inganno al seguito di una privata rivelazione]. Inoltre, lo spirito di quella legge invita a servirsi delle ricchezze come di una scala per salire a Dio, ma non già a fermarsi sulla scala; il regno di Dio, poi, respinge senz’altro la scala [della mondanità].

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, segnaliamo il nostro canale Youtube. Vi ricordiamo che è possibile destinare il 5x1000 alla nostra piccola Associazione. È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi (o in allegato ad altri modelli) il nostro codice fiscale - 01944030764 - nell’apposita casellina: «Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale ...». Qui maggiori informazioni. Grazie, Dio Vi benedica!
Stimati Associati e gentili Sostenitori, segnaliamo il nostro canale Youtube. Vi ricordiamo che è possibile destinare il 5x1000 alla nostra piccola Associazione. È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi (o in allegato ad altri modelli) il nostro codice fiscale - 01944030764 - nell’apposita casellina: «Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale ...». Qui maggiori informazioni. Grazie, Dio Vi benedica!
• Il venerando Abate Ricciotti oggi ci parla del Figliuol prodigo. § 466. Le due parabole precedenti (la pecorella smarrita e ritrovata, la dramma perduta e ritrovata, ndR) hanno mostrato quale sarà il contegno di Dio riguardo al peccatore che si penta e torni a lui; ma quale dovrà essere il contegno dell’uomo non peccatore riguardo al peccatore pentito? A questa nuova domanda risponde, dopo aver confermato il contegno di Dio, la parabola del figliuol prodigo. Letterariamente parlando, questa parabola non può essere definita che come un miracolo. Questo racconto, che nel campo morale è il massimo argomento di speranza per ogni figlio dell’uomo, nel campo letterario sarà sempre il massimo argomento di disperazione per ogni cultore dell’umana parola, come hanno riconosciuto da gran tempo studiosi di ogni tendenza. Nessuno scrittore al mondo ha raggiunto tanta potenza di commozione, in un racconto così breve, così vero, così privo di qualsiasi artificio letterario. La sua semplicità è somma, il disegno è appena lineare: eppure la sua efficacia è maggiore di quella d’altre narrazioni giustamente celebrate per sapienza di costruzione e limpidezza d’eloquio. Ripetere questa parabola con altre parole equivale indubbiamente ad offuscarne la bellezza; tuttavia, per ragioni di chiarezza storica, siamo costretti a questo deturpamento. Un uomo aveva due figli, con i quali viveva agiatamente in campagna curando i suoi vasti terreni e governando la numerosa servitù. Dei figli il maggiore era una vera perla: giovane serio e posato, non badava che alla fattoria, era il braccio destro di suo padre nel dirigere i lavori dei campi, non si prendeva uno svago con i pochi ed assennati amici che aveva. Il figlio minore era tutt’altro: pieno di fumi nel cervello, si sentiva soffocare in quella vita così puntuale e metodica; i lavori dei campi lo annoiavano, il gregge e l’armento lo infastidivano col loro tanfo, la fattoria gli sembrava un carcere dove i carcerieri erano i garzoni sempre pronti a fare la spia d’ogni sua azione al padre. Dai molti e scapati (persone senza senno, ndR) amici che aveva nei dintorni aveva sentito raccontare cose mirabili di grandi città lontane, dove si tenevano banchetti, danze, musiche, feste sbalorditive, dove si incontravano ad ogni passo donne profumate e piacevolissimi amici, invece delle puzzolenti pecoraie e dei lerci bifolchi di suo padre [Segnalazione. La vera e la falsa amicizia (Dottrina cattolica), ndR] . Là era la vera vita! Là lontano egli ripensava accorato nelle sere estive, quando dopo un’oziosa giornata se ne stava sdraiato sul prato della fattoria rassegnandosi a sentir cantare i grilli, e riflettendo con melanconia che i mesi e gli anni volavano via irrimediabilmente e che la sua gioventù sfumava nel vuoto e nella noia. Ma un giorno il giovane non ne poté più e prese la sua risoluzione, conforme a ciò che qualche tempo prima gli era stata suggerito da un amico. Si presentò egli al padre e gli disse senz’altro: «Padre, dammi la parte del patrimonio che (mi) spetta». La richiesta non era irregolare: secondo la Legge ebraica (Deuteronomio, 21, 17), il figlio primogenito aveva diritto a una parte doppia; in questo caso, essendo due figli, al minore spettava un terzo dell’asse ereditario. A quella richiesta, il padre dovette guardare lungamente negli occhi il giovane, ma non disse parola, come il giovane non ardì aggiungere parola a quella della richiesta; l’uno s’allontanò dall’altro in silenzio. In questo scambievole silenzio, che durò più giorni, la spartizione fu fatta; i beni immobili da cedersi furono convertiti in denaro, e non molti giorni dopo, radunata ogni cosa, il figlio più giovane emigrò in una regione lontana. Finalmente cominciava la vera vita! La regione era assai lontana, ignara affatto dei pregiudizi di morale ebraica e anzi seguace di costumanze aborrite dall’ebraismo; il giovane vi entrava provvisto di gran denaro, equivalente alla terza parte di un asse molto considerevole; poteva dunque fare il piacer suo. I suoi antichi sogni cominciavano a diventare realtà, e quell’assetato di godimenti vi si immerse a corpo morto. Il testo dice che egli si dette a vivere sfrenatamente o dissolutamente, sia anche prodigalmente o da scialacquatore; le due maniere, del resto, sono necessariamente congiunte tra loro. I giorni passavano presto e bene, in quella vita; ma vennero anche le conseguenze. Dopo un certo tempo, insieme col tempo, era passato anche il denaro, unica fonte di quei piaceri, giacché per quanto ricolma fosse stata da principio la borsa del giovane, non era poi senza fondo. Ma la febbre del piacere l’aveva subito pervaso ed accecato a tal punto, da non lasciargli vedere che la borsa andava sempre più scemando. Un giorno, poi, rimase affatto vuota. La vita “beata” era finita; ne cominciava un’altra ben diversa.
• § 467. Avendo dunque egli speso tutto, avvenne gran fame in quella regione, ed egli cominciò ad aver bisogno. Il gaudente di ieri è adesso assalito da due parti, all’interno e all’esterno; non solo la sua borsa è vuota, ma nel paese è giunta a un tratto la carestia, una di quelle carestie che mettono in ristrettezze anche chi in tempo ordinario vive senza stenti, ed è superfluo dire che gli amici adulatori di ieri sono scomparsi insieme col denaro dell’adulato e adesso badano soltanto ai casi propri. In tali frangenti e in paese straniero il giovane non ha da sofisticare: o morir di fame, o mettersi a lavorare come capita, anche nel lavoro più umiliante e schifoso. Egli allora andò e s’attaccò a uno dei cittadini di quella regione; e (costui) lo mandò nei suoi campi a pascere i porci. Era dunque una regione non giudaica, altrimenti non vi si sarebbero allevati i porci; questo animale, impuro secondo la Legge ebraica, era così abominato dai Giudei, che evitavano perfino di nominarlo, e un dottore del Talmud poteva sentenziare: «Maledetto l’uomo che alleva porci, e maledetto chi insegna a suo figlio la sapienza greca» (Baba qamma, 82 b Bar.). E così il gaudente di ieri è divenuto porcaio: ma se con ciò ha evitato la morte, non ha evitato la fame che gli rode continuamente le viscere. C’è penuria di tutto; i porci, grufolanti tutta la giornata per i campi sotto la sua sorveglianza, trovano poco o niente, ma almeno la sera, tornati al porcile, ricevono la loro razione di carrube, e bene o male si saziano. Lui no; per lui non c’è nemmeno una sola carruba: il porcaio vale assai meno d’un porco. Ed è un Giudeo! E bramava riempire il suo ventre delle carrube che i porci mangiavano e nessuno glie(le) dava. In queste spaventose condizioni passa parecchio tempo. Durante le soste canicolari (sotto il sole torrido, ndR), quando i porci famelici ed estenuati si sdraiano all’ombra di un albero, anche l’emaciato porcaio si sdraia a fianco loro fra la polvere e il letame; ma il pensiero gli vola ostinatamente alle lontane serate estive, quando sdraiato sul prato della fattoria paterna sentiva cantare i grilli vagando con la mente dietro ai sogni del futuro. Quei rosei sogni si sono adesso pienamente avverati; egli li sente attorno a sé nei porci che grugniscono, addosso a sé nei luridi e fetenti stracci di cui è coperto, dentro di sé nella fame che gli torce le budella. Tornato pertanto in se stesso disse: «Quanti mercenari di mio padre abbondano di pani, e io invece qui muoio di fame!». E che fare? Tornare dal padre? Ma come averne il coraggio, dopo quello che è accaduto? Ebbene, si può tornare a lui non come a padre ma come a padrone; sarà sempre un guadagno immenso vivere a mercede nella fattoria paterna come un garzone qualunque, piuttosto che continuare in quella vita nefanda ch’è una lenta morte. Certo sarà una gran degnazione da parte del padre se dimenticherà l’ingiuria ricevuta e se vorrà accoglierlo - non già come figlio, beninteso - ma solo come umile garzone; ma quell’uomo è così buono che forse acconsentirà a riceverlo! «Sorto, me n’andrò da mio padre e gli dirò: Padre, peccai contro il cielo (= Dio) e innanzi a te! Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio! Fammi come uno dei tuoi mercenari!».
• § 468. Sorretto da questa speranza e raccolte le ultime sue energie, il giovane si mette in viaggio verso la fattoria paterna. Durante il cammino, più volte il cencioso viandante, stremato di forze, dispera di poter giungere alla beata mèta, più volte sopraffatto dal ricordo della sua partenza dispera di esservi accolto almeno come un cane randagio. Ma non c’è altro per lui: il mondo intero adesso si racchiude per lui in quella fattoria. Ed egli, strascinandosi per la strada come meglio può, finalmente vi giunge. È un chiaro pomeriggio. Suo padre sta nei campi a sorvegliare i lavori; ma il suo occhio solerte, che scorre da aratro ad aratro e da garzone a garzone, non ha più la limpidezza di una volta; è velato, mostra le stigmate di una pena antica ma non invecchiata, e di tanto in tanto si fissa là verso l’estremo Orizzonte restando immobile a riguardare chissà quali fantasmi. Mentre però egli stava ancora assai distante, suo padre lo vide e (ne) fu intenerito; e correndo gli cadde sul collo e lo baciò. Un bacio? Anzi molti e molti baci su quel collo pidocchioso e su quella barba inzaccherata? Certo il padre l’ha riconosciuto pur ridotto in quello stato; ma appunto perché l’ha riconosciuto come mai lo bacia? Come mai non chiama invece i garzoni per farlo menar via? Non è egli il figlio che ha rinnegato suo padre? È necessario attirare su ciò l’attenzione del vecchio. Gli disse allora il figlio: «Padre, peccai contro il cielo e innanzi a te! Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio!». È il discorsetto già preparato a memoria, che qui però è accorciato mancando l’implorazione finale: «Fammi come uno dei tuoi mercenari!». Non ha il coraggio il figlio di implorare il posto di servo davanti a quell’effusione di bontà paterna, oppure l’implorazione è impedita da altri baci? Ma a che cosa serve quell’implorazione? Sono parole vane, supremamente inutili; il padre non le avverte nemmeno. Tutto concitato, il vecchio si rivolge ai garzoni accorsi, e: «Presto! Tirate fuori la veste migliore e rivestitelo, e mettetegli un anello alla mano e sandali ai piedi!». E come no? Non è forse il padroncino che rientra? Deve forse un solo istante di più comparire così sfigurato e deturpato, il padroncino? Quando poi egli è rivestito e rimesso a nuovo, bisogna che tutti facciano festa insieme; si abbandonino aratri e zappe, e si prepari un gran banchetto: «E portate il vitello ingrassato, ammazzate(lo), e banchettando facciamo festa! Perché questo figlio mio era morto e tornò in vita, era perduto e fu ritrovato!».
• § 469. A questi fatti non fu presente il figlio maggiore; quella perla di giovane, come al solito, stava al lavoro, e in quel pomeriggio si era recato nei campi più lontani dal casale per certe faccende a cui doveva badare. Ritornò quindi assai tardi, quando il banchetto era inoltrato e quando le copiose libazioni avevano rafforzato le ugole al canto e i piedi alla danza. A sentire tutto quel frastuono, il giovane posato cadde dalle nuvole. Allora, chiamato uno dei garzoni, domandava che cosa fosse ciò. E quello gli disse: «È arrivato tuo fratello, e tuo padre ammazzò il vitello ingrassato perché lo riebbe sano e salvo». Ma naturalmente il garzone non si fermò qui, e cominciò ad informare l’interrogante su tutto il resto, descrivendo cioè come il fratello fosse arrivato in uno stato tale che l’ultimo cane rognoso della fattoria a petto a lui sembrava il sommo sacerdote di Gerusalemme. Il figlio maggiore ne rimase accorato. Dunque, per quel giovinastro che era il danno e la vergogna della famiglia, il padre faceva tanta baldoria? Ma era impazzito anche il padre? Se però il vecchio era rimbecillito, il suo unico degno figlio, che era stato sempre con la testa a posto, non aveva nessuna intenzione di imitarlo. Si adirò allora e non voleva entrare. Ma suo padre, uscito fuori, si raccomandava a lui. Quello però rispondendo, disse al padre: «Ecco! Da tanti anni ti faccio da servo, e giammai trasgredii un tuo comando, e a me giammai desti un capretto affinché con gli amici miei facessi festa! Quando invece venne cotesto tuo figlio, che ha divorato le tue sostanze con le prostitute, ammazzasti per lui il vitello ingrassato!». Il (padre) allora gli disse: «Figlio! Tu sempre stai con me, e tutte le cose mie sono tue. Ma far festa e rallegrarsi bisognava, perché cotesto tuo fratello era morto e (ri)visse, ed era perduto e fu ritrovato!». Si osservi come il figlio maggiore, parlando del minore al padre, lo chiami cotesto tuo figlio; il padre, invece, parlando dello stesso al figlio maggiore, lo chiama cotesto tuo fratello. Il maggiore ha quasi paura di imbrattarsi la bocca chiamando quello scapestrato suo fratello, e vorrebbe rinnegarlo come tale; il padre gli ricorda che lo scapestrato è suo fratello, e quindi egli lo deve trattare come tale, nella stessa guisa che egli padre lo ha già trattato come figlio. L’insegnamento morale di questa seconda parte della parabola è tutto qui: come il padre è sempre padre, così il fratello sia sempre fratello. È dunque falsa la conclusione decretata da pochi critici, per i quali la seconda parte della parabola - cioè l’episodio del fratello maggiore - sarebbe un’aggiunta fatta tardivamente. Al contrario, la mira generale di tutta la parabola include anche l’insegnamento contenuto in quella seconda parte. Nella prima parte la parabola ha insegnato la misericordia per il peccatore pentito, elargitagli da Dio ch’è suo padre, ma questo insegnamento non è nuovo perché è già stato proposto nelle precedenti parabole della pecora e della dramma perdute; nella seconda parte poi insegna la necessità della misericordia per il peccatore pentito elargitagli anche dall’uomo ch’è suo fratello, e precisamente come conseguenza del perdono del padre e in riconnessione con quel perdono. Questa seconda parte della parabola è dunque veramente la cupola di tutto l’edificio e il suo coronamento supremo. Non si può dire che il fratello maggiore, sdegnato della bontà paterna, simboleggia storicamente i Farisei, sdegnati della bontà di Gesù per i pubblicani e i peccatori. Il simbolo invece ha valore più ampio, e include qualunque figlio del Padre celeste che sia geloso della misericordia di quel Padre verso un altro figlio rinsavito dopo un traviamento.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Comunicato numero 160. Le necessarie condizioni per seguire Gesù
- Comunicato numero 159. Gesù all’ultima Festa della Dedicazione
- Comunicato numero 158. La donna rattrappita e l’uomo idropico
- Comunicato numero 157. Urgenza del cambiamento di mente
- Comunicato numero 156. Questioni finanziarie. La suprema aspettativa
- Comunicato numero 155. Gesù va a pranzo da un Fariseo
- Comunicato numero 154. Guarigione di un indemoniato
- Comunicato numero 153. Il Pater Noster e la preghiera
- Comunicato numero 152. La parabola del buon Samaritano
- Comunicato numero 151. Espansione del Regno di Dio in Giudea










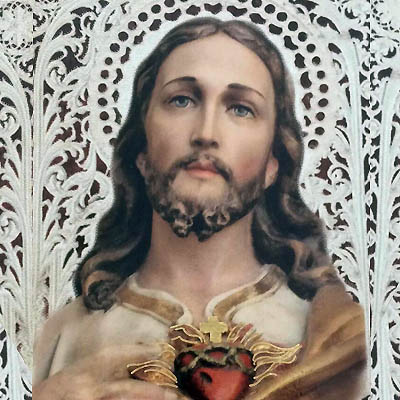














































![[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1](/images/stories/virtuemart/product/resized/[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1_0x130.jpg)