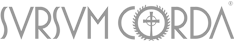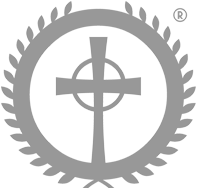Comunicati e Note
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, sul nostro canale Youtube abbiamo caricato il video «Complotto contro la Chiesa e la società civile - La Massoneria e l’Alta Vendita Suprema» (Cliccare qui), tratto dalla preziosa Corrispondenza de «La Civiltà Cattolica» anno 1875: quando la Rivista della Compagnia di Gesù pubblicava scritti cattolici ed era gestita da Cattolici. Vi ricordiamo che è possibile destinare il 5x1000 alla nostra piccola Associazione. È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi (o in allegato ad altri modelli) il nostro codice fiscale - 01944030764 - nell’apposita casellina: «Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale ...». Grazie, Dio Vi benedica!
Stimati Associati e gentili Sostenitori, sul nostro canale Youtube abbiamo caricato il video «Complotto contro la Chiesa e la società civile - La Massoneria e l’Alta Vendita Suprema» (Cliccare qui), tratto dalla preziosa Corrispondenza de «La Civiltà Cattolica» anno 1875: quando la Rivista della Compagnia di Gesù pubblicava scritti cattolici ed era gestita da Cattolici. Vi ricordiamo che è possibile destinare il 5x1000 alla nostra piccola Associazione. È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi (o in allegato ad altri modelli) il nostro codice fiscale - 01944030764 - nell’apposita casellina: «Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale ...». Grazie, Dio Vi benedica!
• Con l’Abate Ricciotti oggi tratteremo vari argomenti, iniziando a scrivere di Gesù nella Transgiordania. § 462. Poco dopo la Festa della Dedicazione, ossia nei primi giorni dell’anno 30, Gesù si recò in Transgiordania (Perea), precisamente nella zona ove Giovanni il Battista aveva amministrato il suo battesimo (§ 269) e vi si trattenne qualche tempo (Giovanni, 10, 40; cfr. Matteo, 19,1; Marco, 10, 1; Luca, 13, 31 segg.); di là tuttavia egli dovette in seguito irradiarsi per varie escursioni missionarie nelle parti settentrionali della Giudea, attraversando anche la Samaria e raggiungendo la Galilea, dalla cui direzione lo fa scendere San Luca (17, 11) nel suo ultimo e definitivo viaggio verso Gerusalemme (§ 414). Perciò anche per questo periodo continua l’imprecisione di cronologia e di topografia che già rilevammo, e la narrazione di San Luca prosegue ad essere aneddotica (§ 415). Un tale una volta l’interroga: «Signore, saranno pochi coloro che si salvano?» - Gesù risponde impiegando idee che già abbiamo udite nel Discorso della montagna secondo San Matteo (§ 333): «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, giacché molti cercheranno invano di entrare quando il padrone, visto che gli invitati sono tutti giunti, si è levato da sedere ed è andato a chiudere l’uscio; allora sarà troppo tardi, e a quelli che busseranno per entrare sarà risposto: “Non so donde siete!”». L’interrogazione fatta a Gesù risentiva dell’opinione diffusa a quei tempi nel giudaismo, che gli eletti fossero in numero molto minore dei reprobi. Gesù non respinge né approva tale opinione, ma solo invita a sforzarsi per entrare nella sala del convito non essendo facile l’ingresso. È vero che l’interrogante è giudeo, membro del popolo eletto e connazionale di Gesù: ma tale qualità non serve a nulla per avere un ingresso di favore. Prosegue infatti Gesù: «Quando vi vedrete così esclusi, insisterete dicendo “Ma come? Abbiamo mangiato e bevuto insieme con te, e tu hai insegnato nelle nostre piazze!“, eppure vi sarà ancora risposto “Non so donde siete; lungi da me voi tutti operatori di iniquità” (§ 333). Voi rimarrete là ove è pianto e stridore di denti, pur vedendo i vostri antenati Abramo, Isacco e Giacobbe, nel regno di Dio. Né i posti lasciati vuoti da voi a quel convito rimarranno vuoti, giacché giungeranno altri invitati non giudei da Oriente ed Occidente, da Settentrione e Mezzodì, e s’assideranno a mensa nel regno di Dio!».
• § 463 Si avvicinarono poi a Gesù alcuni Farisei e gli dissero in tono confidenziale: «Va’ fuori, allontanati di qua, perché Erode vuole ucciderti» (Luca, 13, 31). Questo Erode è Antipa, l’assassino di Giovanni il Battista; trovandosi allora Gesù nella Transgiordania, era appunto sul territorio di lui: di qui il consiglio datogli da quei Farisei. Ma come stavano in realtà le cose? Aveva Antipa vera intenzione di mettere a morte Gesù? Molto probabilmente no, ché se l’avesse avuta, l’avrebbe eseguita con segretezza e facilità. Egli piuttosto cominciava ad essere seccato di quel Rabbi galileo, ricomparso adesso nel suo territorio a commuovere turbe e sovvertire istituzioni e che nella sua fisionomia morale rassomigliava tanto al Giovanni da lui ucciso; questa sua vittima doveva stargli sempre fissa davanti agli occhi, quasi per continuare con più potenza il suo ufficio di censore, e il tetrarca non aveva alcun desiderio di disturbare ancor più le sue notti adulterine facendo una vittima anche di Gesù. Si allontanasse costui spontaneamente dal suo territorio, senza costringerlo a ricorrere alla forza. Ma come indurlo a questa partenza? C’erano i Farisei pronti a questo servizio; se - com’è probabile (§ 292) - appunto essi si erano prestati come mediatori per attirare Giovanni il Battista sul territorio di Antipa e farlo catturare da lui, adesso in compenso facessero la mediazione inversa inducendo Gesù ad allontanarsi con lo spauracchio della morte: e i Farisei si sarebbero prestati volentieri a questo servizio perché, attirato che avessero Gesù nella zona di Gerusalemme, più facilmente avrebbero fatto di lui ciò che volevano. Una fine astuzia da volpe. Gesù infatti, sapendo benissimo come stavano le cose, rispose a quei premurosi Farisei: «Andate a dire a questa volpe: “Ecco, scaccio demonii e compio guarigioni oggi e domani, e al terzo (giorno) son consumato; senonché è necessario che oggi e domani e il dì seguente io cammini, perché non è conveniente che un profeta perisca fuori di Gerusalemme”». La risposta da portare alla volpe, ossia ad Antipa, lo esortava a non preoccuparsi: Gesù avrebbe continuato la sua operosità taumaturgica, nel territorio del tetrarca o altrove, ancora due giorni e al terzo giorno l’avrebbe cessata ed egli stesso sarebbe stato consumato; ma questa consumazione della sua vita non sarebbe avvenuta nel territorio di Antipa bensì a Gerusalemme, tanto per rispettare il tragico privilegio di questa città di essere l’assassina dei Profeti. Ancora una volta, dunque, Gesù si appella nettamente alle sue opere taumaturgiche come alle prove della sua missione; inoltre afferma che questa missione durerà ancora un giorno, un secondo giorno, e parte di un terzo. È questa indicazione di tempo soltanto vaga e generica (come, riferendosi al passato, si direbbe “ieri, l’altro ieri e tre giorni fa”), oppure vuole essere una delimitazione ben precisa? Il primo caso è certamente possibile, ma il secondo sembra più probabile; se Gesù pronunziava queste parole nel gennaio dell’anno 30 (§ 462), circa due mesi e mezzo lo separavano dalla sua morte, e questi sarebbero i due giorni e mezzo qui accennati. • Condizioni per seguire Gesù. § 464. San Luca continua nella sua raccolta di aneddoti. All’avvertimento da parte di Antipa, egli soggiunge il convito presso il Fariseo e le successive discussioni di cui già trattammo (§ 456 segg.); appresso ancora egli colloca una serie di condizioni per seguire Gesù, il quale le elenca un giorno ch’è seguito da numerose folle, mentre alcune di queste condizioni sono collocate altrove da San Matteo. Esse si raggruppano in tre capi principali: l’amore per Gesù deve prevalere nel suo seguace sull’amore per il proprio sangue e per tutte le persone che ne partecipano; deve prevalere sull’amore per la sua propria persona morale e fisica; deve prevalere sull’amore per i beni materiali. «Se alcuno viene a me, e non odia il padre suo e la madre e la moglie e i figli e i fratelli e le sorelle e anche la sua propria vita non può essere mio discepolo. Chiunque non porta la sua croce e viene dietro a me (§ 400) - non può essere mio discepolo. Ognuno di voi che non rinunzia a tutte le sue sostanze - non può essere mio discepolo». Il Semita, per dire che egli amava meno Tizio che Caio, diceva che odiava Tizio in confronto di Caio (cfr. Genesi, 29, 30-33: Deuteronomio, 21, 15-17); in tal senso qui Gesù, nella prima condizione, dice che il suo seguace deve odiare le persone del suo proprio sangue. Probabilmente per effetto del lavoro redazionale la terza condizione (Luca, 14, 33) è staccata dalle altre due (14, 26-27), ed è preceduta da una doppia parabola che le illumina tutte e tre. Queste condizioni sono essenzialissime per entrare nella sequela di Gesù: ognuno dunque, avanti d’incamminarsi per seguirlo, faccia bene i suoi calcoli e ponderi se è disposto ad osservarle, altrimenti non s’incammini. E infatti, chi è che voglia costruire una torre, e non faccia prima il computo delle spese per vedere se potrà sostenerle? Se invece comincerà senz’altro a costruire, gli potrà succedere che, gettate le fondamenta, non abbia più denari per sovredificare; e allora la fabbrica rimasta a mezzo diventerà la favola del paese, e tutti si befferanno del presuntuoso costruttore. Oppure qual è quel re che voglia muovere guerra con 10.000 armati a un altro re che ne ha 20.000, e non faccia prima i calcoli strategici per vedere se l’inferiorità numerica delle proprie forze può essere compensata dalla loro valentia o da altre circostanze propizie? Se poi vede che non può essere compensata, non attacca battaglia, ma piuttosto entra in negoziati di pace. Nella stessa guisa, chi vuol seguire Gesù, deve amar lui prima di tutto e sopra ogni altra cosa. Può darsi benissimo il caso che l’amor per lui si accordi con altri amori; ma quando questi altri amori contrastino con quello supremo, dovranno cedere il campo ad esso e lasciarlo dominare da padrone assoluto. Altrimenti non si può essere in alcun modo vero seguace di Gesù. Queste condizioni, franche fino alla rudezza, furono presentate da Gesù alle molte folle che accorrevano a lui (Luca, 14, 25). Il loro significato storico è chiaro. Fra gli accorrenti molti, anzi moltissimi, si sentivano attirati dalla superiorità spirituale di Gesù, dalla potenza dei suoi miracoli, da vaghe speranze di trionfi e di gloria, da aspettative di condominio con lui nel suo regno messianico, ma costoro alle prime difficoltà si sarebbero ritirati precipitosamente addietro; Gesù previene queste difficoltà, e presenta le rudi condizioni per seguirlo come altrettante disillusioni di cotesti loro sogni beati. Non si prendano le cose alla leggiera. Al seguace di Gesù si può chiedere ad ogni momento di essere un gigante di eroismo: l’edificio che questo seguace comincia a costruire è una torre basata sulla terra, ma la cui cima dovrà toccare il cielo; il volo che egli spicca, affidato unicamente a «l’ale sue», congiunge due «liti sì lontani» quali la terra e il cielo. Chi non si sente la forza di far ciò rinunziando a tutti «gli argomenti umani», potrà mettersi alla sequela di qualche insigne maestro fariseo, non già di Gesù: «Vedi che sdegna gli argomenti umani, Si che remo non vuol né altro velo Che l’ale sue tra liti si lontani». (Purgatorio, II, 31-33).
• La pecora e la dramma perdute. § 465. Qui San Luca fa seguire una collana di parabole: le prime perle di questa collana, da lui conservateci, si possono ben chiamare i gioielli della misericordia divina, e confermano al gioielliere il titolo decretatogli da Dante di scriba mansuedinis Christi (§138). Una breve introduzione serve da cornice a queste parabole della misericordia: «Stavano a lui vicini tutti i pubblicani ed i peccatori per udirlo; e (quindi) mormoravano sia i Farisei che gli Scribi dicendo: “Costui accoglie i peccatori e mangia insieme con essi!”». Brontolamenti di questo genere erano già noti a Gesù, che aveva risposto in proposito molto tempo prima (§ 306). Questa volta rispose nuovamente ricorrendo alle predilette parabole, le quali potevano giovare sia ai tracotanti condannatori sia ai poveri condannati. Il primo paragone fu preso dai costumi pastorali (§ 432 segg.). Un pastore ha 100 pecore e la mattina, fattele uscire dall’ovile, si mette in giro con esse per la steppa a farle pascolare. A una certa ora della giornata si avvede che una pecora manca; guarda e riguarda, non la vede. Non c’è dubbio: s’è perduta. Si sarà staccata dal gruppo, attirata da qualche valloncello più verde e ubertoso, e mentre il resto del gregge si allontana sarà rimasta là solitaria, ingannata dalla momentanea abbondanza ma esposta al lupo notturno. Presto! Bisogna far di tutto per ritrovarla, prima che calino le rapide ombre del vespero palestinese. Il sollecito pastore affida allora le altre 99 pecore ai garzoni, e corre alla ricerca della smarrita... Cala in valloncelli, sale su collinette, scruta su distese aperte, sempre col cuore angosciato; spia il roteare dei falchi, chiama, tende l’orecchio, non si dà pace, finché in un momento di gaudio ode un belato. È la pecora perduta! Le corre dappresso. Per lei non ha una voce di rimprovero, non un gesto di minaccia; anzi l’alza di peso e se la mette sulle spalle, estendendo a lei il privilegio riserbato agli agnellini da latte che non possono ancora camminare: trovandosi solitaria, quella povera bestiola avrà tanto penato, non meno del suo pastore, e merita bene quel privilegio! Né il pastore avverte sulle sue spalle quel carico non leggiero: il gaudio di sentire addosso a sé la bestiola perduta gliene fa sembrare piacevole il peso. La sera poi, giunto a casa, il pastore non si occupa affatto delle altre 99 pecore che egli sa al sicuro, bensì chiama amici e compagni volendo condividere con essi il suo nuovo gaudio: «Allegri! È andata bene! Eccola là, la pecora perduta! L’ho ritrovata!» - Gesù concluse: «Vi dico che così sarà gaudio nel cielo per un solo peccatore che si penta, più che per 99 giusti i quali non hanno bisogno di penitenza». Il secondo paragone è tolto dalle usanze domestiche, ma simboleggia l’identico insegnamento morale del primo. Una buona donna di casa, accorta ed economica, si è costituita un gruzzoletto a forza di piccole industrie e di risparmiucci. Sono dieci dramme, dieci lampanti monete del valore complessivo di poco più che 10 lire in oro. La donna le tiene ben raggruppate dentro una pezzuola; la pezzuola è accuratamente ravvolta e legata a nodo; il prezioso involto sta gelosamente nascosto in un angoletto oscuro della casa, dove di tanto in tanto la donna va a far delle visitine per vedere che tutto sia in ordine e per rallegrarsi la vista a quel luccichio. Senonché un brutto giorno la visitatrice, slegato l’involto, trova che le dramme non sono più dieci, ma nove. Che amara sorpresa! Dove mai sarà andata a finire la dramma mancante? Quando sarà scomparsa? Tutta affannata la donna ripensa alle ultime volte che ha maneggiato il gruzzolo: forse è rotolata via il giorno tale, quando fece in fretta e furia quel pagamento; forse quell’altro giorno, quando sconvolse tutta la casa per far pulizia. E allora l’ansiosa donna si arma di lucerna e di scopa; scruta gli angoletti più oscuri, spazza una per una le fessure dell’impiantito, spia in tutti i bucherelli e in tutte le screpolature, fino a che scorge rimpiattata fra due assi la dramma mancante. Allora esplode la sua gioia rumorosa; la donna fa crocchio con amiche e comari per raccontare a tutte il suo gaudio, come aveva fatto il pastore per la pecora ritrovata. E Gesù conclude: «Così, vi dico, è gaudio al cospetto degli angeli d’Iddio per un solo peccatore che si penta». In conclusione, conversione di uomini in terra significa in cielo gaudio di angeli.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, sul nostro canale Youtube abbiamo caricato alcuni video, fra i quali una relazione sulla vera umiltà secondo i preziosi studi dell’intramontabile Cornelio ALapide (link per l’ascolto). Se possibile, vi chiediamo altresì di destinare il 5x1000 alla nostra piccola Associazione. È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi (o in allegato ad altri modelli) il nostro codice fiscale - 01944030764 - nell’apposita casellina: «Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale ...». Grazie, Dio Vi benedica! Con questo editoriale diamo inizio allo studio di un altro periodo della vita di Nostro Signore: «Dall’ultima Festa della Dedicazione fino all’ultimo viaggio lungo la Giudea». Il venerando Abate Giuseppe Ricciotti - riposi in pace! - oggi ci parla dell’ultima Festa della Dedicazione.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, sul nostro canale Youtube abbiamo caricato alcuni video, fra i quali una relazione sulla vera umiltà secondo i preziosi studi dell’intramontabile Cornelio ALapide (link per l’ascolto). Se possibile, vi chiediamo altresì di destinare il 5x1000 alla nostra piccola Associazione. È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi (o in allegato ad altri modelli) il nostro codice fiscale - 01944030764 - nell’apposita casellina: «Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale ...». Grazie, Dio Vi benedica! Con questo editoriale diamo inizio allo studio di un altro periodo della vita di Nostro Signore: «Dall’ultima Festa della Dedicazione fino all’ultimo viaggio lungo la Giudea». Il venerando Abate Giuseppe Ricciotti - riposi in pace! - oggi ci parla dell’ultima Festa della Dedicazione.
• § 460. Nella precedente operosità di Gesù furono consumati circa due mesi e mezzo, cioè l’intervallo di tempo che separava la Festa dei Tabernacoli (§ 416) da quella delle Encenie, ossia della Dedicazione del Tempio (§ 77). Poiché San Giovanni (10, 22) dice esplicitamente che a quest’ultima festa Gesù intervenne, viene spontaneo identificare questo intervento con uno dei viaggi minori appena accennati da San Luca (§ 415). Era dunque la fine di dicembre dell’anno 29; interrompendo la sua vaga peregrinazione lungo la Giudea, Gesù si recò nella capitale per continuare ivi il suo ministero durante quella nazionalistica «festa dei lumi». La sua presenza in città fu subito notata le recenti discussioni sulla sua missione e il suo aggirarsi nella circostante Giudea avevano reso il Rabbi galileo oggetto di particolare attenzione e sorveglianza da parte delle supreme autorità del giudaismo. Difatti un giorno dell’ottava festiva, mentre Gesù si intratteneva nel Tempio e insegnava passeggiando nel «portico di Salomone» (§ 48) forse a causa della pioggia - il minuzioso San Giovanni ricorda appunto che era inverno - gli vennero attorno i soliti avversari Giudei e gli dissero: «Fino a quando tieni sospeso l’animo nostro? Se tu sei il Cristo (Messia), diccelo francamente!». La forma di questa dichiarazione è non solo amichevole, ma quasi di raccomandazione e di preghiera: si direbbe che quegli interroganti aspettassero soltanto la franca dichiarazione che Gesù era l’aspettato Messia per darsi anima e corpo a lui. La sostanza dell’interrogazione è invece un’insidia: gli avversari aspettano quella franca dichiarazione soltanto per ritorcerla in accusa contro Gesù e rovinarlo, come mostreranno poi i fatti. Il carattere subdolo dell’interrogazione è rivelato da Gesù, il quale risponde fornendo la sostanza della dichiarazione attesa, ma non nella forma desiderata, giacché dichiara chi egli sia, senza però offrire appiglio all’insidia: «Ve (lo) dissi e non credete: le opere che io faccio nel nome del Padre mio, queste attestano circa me; ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore odono la voce mia, e io le conosco e mi seguono; e io do ad esse vita eterna, e non periranno in eterno e non le rapirà alcuno dalla mia mano. Ciò che il Padre mio mi ha dato è maggiore di tutte le cose, e nessuno può rapir(lo) dalla mano del Padre. (Ora), io e il Padre siamo una sola cosa» (Giovanni, 10, 25-30). Gli interroganti avevano sperato che Gesù rispondesse esplicitamente «io sono il Messia»; Gesù invece ha risposto in sostanza «Che io sia il Messia argomentatelo dalle opere che io faccio», evitando una dichiarazione precisa e netta, come già aveva fatto con gli stessi avversari alla Festa dei Tabernacoli (§ 422). Anche il motivo di questa maniera indiretta di rispondere è il medesimo; considerando serenamente i miracoli di Gesù, tutti potevano concludere che era giunto... il regno d’iddio (§ 444) e che egli era il Messia, mentre questo appello ai miracoli non offriva appiglio a denunzie politiche e a violenze; se invece Gesù si fosse con termini espliciti dichiarato Messia davanti a quegli avversari, avrebbe fornito loro occasione di accusano presso le autorità romane come agitatore politico, o anche di trascendere ad atti di violenza immediata contro di lui.
• § 461. Infatti, appena udite le ultime parole di Gesù, i Giudei presero di nuovo le pietre per lapidarlo; l’Evangelista con l’avverbio «di nuovo» vuol ricordare l’analogo tentativo fatto ai Tabernacoli pochi mesi prima. In quell’occasione Gesù si era proclamato anteriore ad Abramo (§ 423), si era descritto come buon pastore di affezionate pecore (§ 432 segg.), ed aveva anche risaputo del tentativo fatto dai Farisei di «rapire dalla sua mano» una di quelle pecore, cioè il cieco nato scacciato dagli inquisitori, ed espulso conseguentemente dalla sinagoga (§ 430). Qui Gesù va assai più oltre: in linea preliminare afferma che gli avversari non credono in lui perché non sono del numero delle sue pecore, e che queste non possono essere rapite via dalla mano di lui come neppure dalla mano del Padre; infine, rivela la ragione fondamentale di tutto ciò, la quale è che Gesù e il Padre sono una sola cosa. Dunque Gesù, pur non proclamandosi esplicitamente Messia, si proclama addirittura Dio? Così interpretarono le sue parole i Giudei con logica inappuntabile, e lo dichiararono apertamente. Vedendoli infatti raccogliere le pietre, Gesù domandò loro: «Molte opere buone vi mostrai (fatte per autorità ricevuta) dal Padre; per quale opera fra esse mi lapidate?». Gli risposero i Giudei: «Per opera buona non ti lapidiamo, ma per bestemmia, e perché, essendo tu uomo, fai te stesso Dio!». Il furore per la lapidazione è momentaneamente calmato: in Oriente sui mercati e nei fondachi, nei luoghi pubblici e nei privati, gli animi si accendono ad un tratto per un nonnulla: si grida, si gesticola, teatralmente, senza conseguenze tragiche. Così avvenne quella volta, e i minacciosi ascoltarono le spiegazioni di Gesù, che disse: «Eppure nella vostra Legge sta scritto quel passo: “Io dissi - Siete Dei -” (cfr. Salmo 82, 6 ebr.). Se dunque Dio stesso, rivolgendosi agli uomini li chiama Dei, e fa ciò nella sacra Scrittura la cui testimonianza è irrefragabile; perché accusate di bestemmia me per aver detto che sono figlio di Dio, se il Padre stesso mi ha santificato e inviato nel mondo? Ad ogni modo, guardate le mie opere: se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete; ma se le faccio, lasciatevi convincere da esse, e allora conoscerete che in me (è) il Padre e io (sono) nel Padre» (Giovanni, 10, 34-38). Nel passo della Scrittura addotto a prova, il termine «Dei» è usato in senso improprio, perché si riferisce ai giudici umani, che rappresentano l’autorità di Dio nei tribunali. La prova tuttavia era efficace come argomento ad hominem, per ridurre al silenzio gli avversari di Gesù rispettosi della sacra Scrittura: se la Scrittura stessa chiamava «Dei» gli uomini, i Giudei non potevano accusarlo di bestemmia avendo egli maggior ragione per attribuirsi quel termine. Anche qui Gesù non scese a particolari, che avrebbero gettato altra esca sul fuoco; tuttavia, riferendosi alla frase incriminata secondo cui egli e il Padre erano una cosa sola, precisò dichiarando «In me (è) il Padre e io (sono) nel Padre». Lungi dall’essere un’attenuazione, questa spiegazione era una conferma della frase. Anche questa volta i Giudei capirono perfettamente, e il fuoco che era appena sopito divampò nuovamente: Cercavano pertanto di nuovo di afferrarlo; ma (egli) uscì fuori dalle loro mani. Quei Giudei erano molto intelligenti: capirono subito e perfettamente ciò che gli Ariani, tre secoli più tardi, non vollero capire, cioè che dalle parole di Gesù risulta indubbiamente che egli si è dichiarato eguale in tutto al Padre. I critici radicali odierni sono intelligenti quanto quegli antichi Giudei, e forse anche più: capiscono anch’essi perfettamente che dalle parole di Gesù risulta una dichiarazione di eguaglianza al Padre, ma parecchi di essi - tanto per non essere da meno degli antichi Ariani - assicurano che Gesù non pronunziò mai quelle parole, le quali sarebbero un’esposizione teorica del dogma cristiano dovuta all’autore del IV Vangelo. [L’Abate Ricciotti si riferisce ad una delle tante e deliranti elucubrazioni dei modernisti in campo biblico ed esegetico. D’altronde riconoscendo la divinità di Nostro Signore, non solo ipocritamente a parole ma ragionevolmente e nei fatti, sarebbe impossibile professare la turpe apostasia dell’ecumenismo: insieme di eresie, infedeltà e menzogne che, al contrario, i modernisti spacciano per cattolicesimo - Qui è possibile ascoltare una relazione dettagliata sull’ecumenismo, ndR] Le prove “storiche” di questa spiegazione sono tutte nell’assicurazione di chi la propone, e nella solita “impossibilità” che Gesù abbia pronunziato quelle parole. Ritorna insomma l’identico procedimento già seguito a proposito dell’episodio di Cesarea di Filippo (§ 398): giacché in sostanza quella critica demolitrice, se è povera e nuda di argomenti storici, è anche monotona e uniforme nei suoi procedimenti dialettici.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, vogliate, anche quest’anno, destinare il 5x1000 alla nostra piccola Associazione. È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi (o in allegato ad altri modelli) il nostro codice fiscale - 01944030764 - nell’apposita casellina: «Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale ...». Grazie, Dio Vi benedica! Veniamo all’Abate Ricciotti ed alla sua «Vita di Gesù Cristo», da cui oggi studieremo il capitolo: «La donna rattrappita e l’uomo idropico. Questioni conviviali».
Stimati Associati e gentili Sostenitori, vogliate, anche quest’anno, destinare il 5x1000 alla nostra piccola Associazione. È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi (o in allegato ad altri modelli) il nostro codice fiscale - 01944030764 - nell’apposita casellina: «Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale ...». Grazie, Dio Vi benedica! Veniamo all’Abate Ricciotti ed alla sua «Vita di Gesù Cristo», da cui oggi studieremo il capitolo: «La donna rattrappita e l’uomo idropico. Questioni conviviali».
• § 455. Fecero effetto queste minacce? [«In quest’ultima dilazione concessa all’albero, o esso darà frutti, ovvero finirà sotto i colpi d’accetta», cf. Sursum Corda n° 157]. Divampava l’incendio acceso da quel fuoco che Gesù era venuto a gettare sulla terra? In altre parole, si stava attuando il «cambiamento di mente» che ripudiava il vecchiume formalistico e ricercava lo spirito nuovo? A queste domande San Luca non dà una risposta esplicita, ma sembra bene che ne dia una implicita mediante un aneddoto ch’egli soggiunge alle narrazioni precedenti, e che mostra come il formalismo rabbinico gravasse quale cappa di piombo sugli spiriti e non fosse stato neppure scalfito dalle minacce di Gesù. L’aneddoto è quello della donna rattrappita guarita di sabbato (Luca, 13, 10-17); senonché lo stesso Evangelista, indulgendo alla sua predilezione per i quadretti abbinati, poco dopo questo aneddoto fa seguire l’altro somigliantissimo dell’uomo idropico guarito egualmente di sabbato (14, 1-6). I due quadretti si richiamano logicamente l’un l’altro, come una ripetuta e sfiduciata risposta alle precedenti domande sull’efficacia della predicazione di Gesù, ed è quindi opportuno presentarli affiancati; tuttavia, egualmente dai dati di San Luca confrontato con gli altri Evangelisti, appare che i due fatti sono cronologicamente staccati, e che la donna fu guarita poco prima della festa della Dedicazione e nella Giudea, l’uomo invece poco dopo quella festa e probabilmente nella Transgiordania. Gesù dunque, durante la sua peregrinazione nella Giudea, si recò di sabbato in una sinagoga e si mise a predicare. Tra i presenti vi era una donna malata da diciotto anni - forse di artrite o anche di paralisi - e così rattrappita che non poteva in nessun modo alzare la testa e guardare in alto. Vistala, Gesù la chiamò e le disse: «Donna, sei disciolta dalla tua malattia»; e le impose le mani. Quella, raddrizzatasi all’istante, si dette a ringraziare e glorificare Dio. L’archisinagogo che presiedeva all’adunanza (§ 64) s’indignò per quella guarigione fatta di sabbato; non osando però abbordare direttamente Gesù, se la prese con la folla arringandola stizzito: «Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare: in essi dunque venite a farvi curare, e non nel giorno del sabbato!». Per quello zelante archisinagogo la guarigione miracolosa non significava nulla, il sabbato invece - che del resto non era stato violato - significava tutto. Gesù allora rispose a lui e agli altri della mentalità di lui: «Ipocriti! ognuno di voi di sabbato non scioglie forse il suo bove o l’asino dalla mangiatoia, e (lo) conduce ad abbeverare?». Infatti, sciogliere o stringere un nodo di fune era compreso in quei 39 gruppi di azioni ch’erano proibite di sabbato (§ 70); ma nella pratica, trattandosi delle bestie domestiche, si provvedeva in una maniera o un altra al loro sostentamento. Messo ciò in chiaro, Gesù argomenta a fortiori concludendo: «E costei ch’è figlia di Abramo, e che il Satana legò or è diciotto anni, non bisognava che fosse sciolta da questo legame nel giorno di sabbato?». Al Satana erano fatte risalire comunemente malattie di ogni genere (§ 78). Se dunque c’era un giorno più opportuno di tutti per dimostrare la vittoria di Dio sul Satana, cioè del Bene sul Male, era appunto il sabbato, il giorno consacrato a Dio: quindi Gesù, meglio d’ogni altro, era penetrato nello spirito del sabbato, operando appunto in esso quella vittoria di Dio sul Satana.
• § 456. Al ragionamento di Gesù la folla assenti cordialmente; quanto ai suoi avversari, San Luca dice che rimasero confusi, ma ciò non significa che assentissero al ragionamento. Già vedemmo che l’osservanza rabbinica del sabbato era uno dei piloni su cui troneggiavano i Farisei e che non doveva mai crollare (§ 431). Anche se i fatti miracolosi smentivano quell’osservanza, ciò non significava nulla: si trascurassero i fatti e si bestemmiasse lo Spirito santo (§ § 444, 446), purché rimanesse il sabbato farisaico. Il quadretto corrispondente si svolge, non in sinagoga, ma in casa di un insigne Fariseo che ha invitato Gesù a prender cibo da lui. È di sabbato, e i Farisei stanno spiando. Ecco che un uomo idropico si presenta a Gesù, attirato forse dalla sua fama di taumaturgo e sperando d’esser guarito. Gesù allora si rivolge ai legisti e ai Farisei dicendo: «È lecito di sabbato curare o no?». Quelli rimasero in silenzio, sebbene per molti casi la questione fosse già stata trattata e decisa dai dottori della Legge (§ 71). Continuando il silenzio, Gesù tira per mano a sé l’idropico, lo guarisce e lo licenzia; quindi dice ai silenziosi: «Chi di voi avendo il figlio o il bove che cada in un pozzo, non lo ritira su subito in giorno di sabbato?» [Si tratta di azioni che, anche oggi, il cristiano può compiere lecitamente di domenica, senza per questo venire meno all’ordine di Dio di santificare la festa, ndR]. - Ma anche questa domanda rimane, secondo San Luca, senza risposta. Appare a prima lettura che i due aneddoti sono somigliantissimi; solo che in quello dell’idropico gli avversari di Gesù non si mostrano acrimoniosi e si limitano a tacere. Poiché questo fatto sembra avvenuto in Transgiordania, bisognerebbe concludere che i Farisei e i legisti di quella zona, più remota da Gerusalemme, fossero un po’ meno fanatici e gretti di quelli della Giudea, i quali stavano sotto l’immediata influenza della capitale.
• § 457. La mancanza d’acrimonia in questi Farisei d’oltre Giordano appare anche dalla circostanza che il convito si protrasse a lungo e vi furono trattate senza astio varie questioni, cominciando da quella dei primi posti. Quei bravi Farisei non sarebbero stati Farisei se non fossero venuti a diverbio per occupare a mensa i posti più vicini al padrone di casa e più onorifici: Quel divano spetta a me! - Spetta invece a me, che sono più degno! - Più degno tu? Chi credi di essere? - Io sono più anziano e più dotto di te; cedimi il posto! - E così di seguito. Per gente che viveva soprattutto di esteriorità, siffatte questioni di etichetta erano capitali. Gesù intervenne commentando il diverbio, e volle confondere i litiganti mostrando come la loro vanità non fosse neppure abbastanza sagace nello scegliere i mezzi per trionfare. Disse egli: «Quando (tu) sia invitato da alcuno a nozze, non ti adagiare sul primo divano, affinché non (avvenga) per caso che uno più degno di te sia invitato da lui, e venuto colui che invitò te e lui ti dica: “Da’ posto a costui!” e allora (tu) cominci ad occupare con vergogna l’ultimo posto. Quando invece (tu) sia invitato, va’ ad adagiarti all’ultimo posto, affinché quando venga chi ti ha invitato ti dica: “Amico, sali più in alto!”. Allora avrai gloria al cospetto di tutti i tuoi commensali: poiché chiunque s’innalza sarà abbassato, e chi s’abbassa sarà innalzato». Confusa in tal modo la vanità degli invitati con la considerazione della loro propria imperizia, restava da mettere a posto l’atteggiamento dell’invitante, e in genere di tutti gli invitanti che troppo spesso agivano per vanagloria congiunta col tornaconto materiale; inoltre, agli invitati e agli invitanti, la lezione sul convito materiale poteva giovare per una sfera più alta, ricordando loro le norme e i vantaggi di un certo convito spirituale. Perciò Gesù, rivolgendosi all’invitante, proseguì: «Quando (tu) faccia un pranzo o una cena, non chiamare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né ricchi vicini, affinché non (avvenga) per caso che pure essi ti invitino alla loro volta, e tu abbia il contraccambio. Ma quando (tu) faccia un ricevimento, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e beato sarai, perché non hanno da contraccambiarti! Il contraccambio infatti ti sarà dato nella resurrezione dei giusti». Strettamente affine a questa norma è quella contenuta nel logion ignoto ai quattro Vangeli ma attribuito a Gesù da San Paolo: «È cosa più beata dare che ricevere» (§ 98). La base comune a tutte queste norme è sempre quella del Discorso della montagna, cioè una sanzione non terrena ma ultraterrena (§ 319): qui essa è chiamata «resurrezione dei giusti», altrove «regno dei cieli» oppure «venuta del figlio dell’uomo», ma è in sostanza la stessa base che sorregge tutto l’edificio della dottrina di Gesù, mentre tolta questa base l’edificio crolla e la dottrina non ha più senso. Erano perfettamente logici e conseguenziari gli antichi pagani di cui parla San Paolo, i quali, dal momento che negavano questa base ultraterrena alla dottrina di Gesù (cfr. Atti, 17, 32), trovavano che la stessa dottrina era una stoltezza (I Corinti, 1, 23). Ancora oggi, le posizioni dialettiche non sono affatto mutate, e la dottrina di Gesù è ancora definita o stolta o divina, a seconda che si respinge o si accetta quella sua base.
• § 458. Con l’idea della ricompensa ultraterrena quegli invitati erano stati sollevati - come appunto voleva Gesù - al pensiero di un convito spirituale. Allora uno di essi esclamò: «Beato chi mangerà cibo nel regno d’iddio!». Gesù prese occasione per presentare il regno di Dio quale un convito servendosi di una parabola, la quale è riportata sia da Luca (14, 16-24) sia da Matteo (22, 2-14). Le due recensioni sono differenti fra loro in parecchi accessori, ma soprattutto perché quella di Matteo ha per aggiunta uno sviluppo abbastanza lungo (22, 11-14) che non trova corrispondenza nella recensione di Luca. Recitò Gesù una sola volta la parabola nella forma più ampia di Matteo, che poi fu accorciata da Luca? Oppure la recitò nella forma più corta di Luca, che poi fu ampliata da Matteo con un frammento di altra parabola affine? Oppure la recitò più volte in forme diverse? Si è molto discusso su queste domande; la risposta più probabile sembra essere che Gesù abbia impiegato più volte nelle sue parabole questo tema generico del convito - come del resto facevano anche i rabbini - pur con mire alquanto diverse secondo le circostanze. La recensione pertanto di Matteo risulterebbe dalla fusione di due parabole conviviali di Gesù: la prima (22, 2-10) corrisponde sostanzialmente a quella di Luca; la seconda (22, 11-14) sarebbe soltanto la parte conclusiva di un’altra parabola, il cui antefatto manca perché nella redazione odierna si giudicò che la somigliante parabola di Luca lo sostituisse bastevolmente. Nella recensione lucana la parabola è la seguente.
• § 459. Un uomo fece una gran cena e invitò molti. All’ora opportuna spedì il suo servo agli invitati pregandoli di venire perché ogni cosa era pronta; senonché tutti cominciarono ad addurre pretesti per non venire. Uno disse: «Ho comprato un campo, e devo andare ad esaminarlo; scusami!» - Un altro disse: «Ho comprato cinque paia di buoi, e vado a provarli; scusami!» - Un terzo si sbrigò con poche parole: «Ho preso moglie, e quindi non ne parliamo nemmeno!» - Ottenute tali risposte, il servo le riportò al padrone. Costui allora si adirò, e dette ordine al servo: «Va’ per le piazze e le strade della città, e fa’ entrare al banchetto poveri, storpi, ciechi e zoppi!» - L’ordine fu eseguito, e il servo ne informò il padrone aggiungendo: «Quei disgraziati sono entrati, ma ci sono ancora posti vuoti.» - Il padrone allora replicò: «Esci ancora per la campagna, e fai entrare quanti troverai lungo i sentieri e le siepi; perché la mia casa dovrà essere gremita di quei disgraziati, mentre nessuno degli invitati di prima gusterà la mia cena!». Evidentemente il convito simboleggia il regno di Dio, gl’invitati riluttanti sono i Giudei, e i poveri che li sostituiscono sono i Gentili: ciò che appare anche meglio dalla recensione di Matteo. Luca termina qui; ma in Matteo la scena ha il seguito già accennato. Riempita la sala di quei miserabili, l’invitante (il quale in Matteo è un re che fa il convito di nozze a suo figlio) viene in persona nella sala a vedere i commensali. Ad un tratto scorge fra essi un tale che non ha indossato la prescritta veste nuziale (della quale, tuttavia, non è stato fatto cenno in precedenza). Il re perciò gli dice: «Amico, come mai sei entrato qui senza avere la veste nuziale?» - Quello tace confuso. Allora il re ordina agli inservienti: «Legategli mani e piedi, e gettatelo nella tenebra esteriore: ivi sarà pianto e stridor di denti!» - Gesù infine concluse dicendo: «Molti infatti sono chiamati, pochi tuttavia eletti». La parte finale di questo tratto singolare esce già dalla sfera simbolica e si riferisce direttamente all’oggetto vero della parabola (“pianto e stridor di denti”). Inoltre esso aggiunge un elemento nuovo alla parabola comune a Luca e Matteo, ed è che non tutti i nuovi invitati sono degni del convito, ma solo quelli che hanno la veste nuziale: fuori di allegoria, non tutti i Gentili che hanno sostituito i Giudei nel regno del Messia sono degni del regno, ma solo quelli che hanno le opportune disposizioni spirituali. Gesù, infatti, già aveva ammonito Nicodemo che se alcuno non sia nato da acqua e (da) Spirito, non può entrare nel regno d’Iddio (§ 288); questa rinascita interna era la condizione essenziale per entrare legittimamente nel convito messianico. L’esclamazione del commensale di Gesù: «Beato chi mangerà cibo nel regno d’Iddio!» era stata anche un’interrogazione, cercando in qualche maniera di sapere chi avrebbe goduto di quella beatitudine. Gesù ha risposto all’interrogazione mostrando chi avrebbe respinto e chi accettato l’invito al convito messianico, e fra quelli che l’avrebbero accettato chi se ne sarebbe mostrato degno e chi indegno.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, auguriamo a tutti Voi ed alle vostre famiglie una Santa Pasqua. Qual propizia occasione per “rinascere”, per amare Dio odiando il peccato, per dedicarci al prossimo fuggendo ogni male e iniquità, per attuare quel necessario «cambiamento di mente» predicato instancabilmente da Nostro Signore Gesù Cristo, e di cui il venerando Ricciotti a breve ci parlerà. Meditiamo con attenzione le parole del Sommo Pontefice Leone XII (Qui pacem, Omelia della Domenica di Pasqua, 26 marzo 1826): «Voi desiderate soltanto la pace, voi cercate insistentemente la pace, ma non trovate pace: perché dunque? Perché la cercate dove non è e non può essere. Sulle loro vie vi sono l’afflizione e l’infelicità, e non conobbero la via della pace; è questa, e Dio stesso lo afferma, la condizione di coloro che sperano di trovare la quiete e la tranquillità nel peccato. Sperano la quiete, e finiscono nella tempesta; si ripromettono la gioia, e non trovano infine se non tedio, e affanno, e terrori: anzi sentono principalmente crescere dentro (di loro) una tetra amarezza, proprio là dove, ingannati da una falsa immagine di bene, si erano ripromessi la massima felicità». Nell’articolo che segue riporteremo l’Omelia per intero, ma adesso veniamo alla consueta lezione tratta dalla preziosa «Vita di Gesù Cristo» dell’Abate Giuseppe Ricciotti: sia pace alla sua bellissima anima!
Stimati Associati e gentili Sostenitori, auguriamo a tutti Voi ed alle vostre famiglie una Santa Pasqua. Qual propizia occasione per “rinascere”, per amare Dio odiando il peccato, per dedicarci al prossimo fuggendo ogni male e iniquità, per attuare quel necessario «cambiamento di mente» predicato instancabilmente da Nostro Signore Gesù Cristo, e di cui il venerando Ricciotti a breve ci parlerà. Meditiamo con attenzione le parole del Sommo Pontefice Leone XII (Qui pacem, Omelia della Domenica di Pasqua, 26 marzo 1826): «Voi desiderate soltanto la pace, voi cercate insistentemente la pace, ma non trovate pace: perché dunque? Perché la cercate dove non è e non può essere. Sulle loro vie vi sono l’afflizione e l’infelicità, e non conobbero la via della pace; è questa, e Dio stesso lo afferma, la condizione di coloro che sperano di trovare la quiete e la tranquillità nel peccato. Sperano la quiete, e finiscono nella tempesta; si ripromettono la gioia, e non trovano infine se non tedio, e affanno, e terrori: anzi sentono principalmente crescere dentro (di loro) una tetra amarezza, proprio là dove, ingannati da una falsa immagine di bene, si erano ripromessi la massima felicità». Nell’articolo che segue riporteremo l’Omelia per intero, ma adesso veniamo alla consueta lezione tratta dalla preziosa «Vita di Gesù Cristo» dell’Abate Giuseppe Ricciotti: sia pace alla sua bellissima anima!
• § 453. Insegnamenti [escatologici] di questo genere [leggere l’editoriale sul numero 156 di Sursum Corda] rovesciano la stratificazione dei pensieri umani. Non erano le elucubrazioni dei casuisti Farisei sull’uovo fatto dalla gallina di sabbato (§ 251) e sulle sciacquature di mani e di stoviglie prima di mangiare: era un incendio che metteva tutto a soqquadro in quel mondo concettuale giudaico, e che più tardi propagherà le sue fiamme anche in altri mondi. Lo riconobbe Gesù stesso, proclamando dopo le precedenti dichiarazioni: «Un fuoco venni a gettare sulla terra, e che voglio se è già acceso?». Se è un fuoco, sarà una prova attraverso cui passeranno i seguaci di Gesù. Vi passerà anzi, per primo, Gesù stesso: «Ma d’un battesimo ho da esser battezzato, e come sono angustiato fino a che sia compiuto!». Il metaforico «battesimo» di Gesù segnerà il divampare palese del fuoco; ma battesimo e fuoco sono ambedue una prova, il primo per Gesù, l’altro per tutta la terra. La prova della terra apporterà su essa, non già pace e concordia, ma guerra e discordia. Continua infatti Gesù descrivendo gli effetti della sua dottrina sulla terra: avverranno scissioni e lotte in una famiglia di cinque persone, e tre si schiereranno contro due, e due contro tre; il padre si metterà contro il figlio e viceversa, la madre contro la figlia e viceversa, la suocera contro la nuora e viceversa. Prima, tutti erano d’accordo; ma penetrato che sia in quelle cinque persone il messaggio di Gesù, è penetrata fra esse la discordia, perché alcuni lo benedicono e altri lo maledicono (Luca, 12, 49-53). Già il vecchio del Tempio, più di trenta anni prima, aveva contemplato Gesù quale «segno contraddetto» (§ 250): la persona di Gesù e la sua dottrina saranno il segno di contraddizione per tutto il genere umano. Anche qui lo storico odierno può facilmente riscontrare se queste idee espresse venti secoli fa abbiano reale riscontro nei fatti storici di allora e dei secoli seguenti fino ad oggi. Intanto Farisei e Sadducei, mescolati con le turbe, seguivano passo passo Gesù mirando al loro scopo di raccogliere prove contro di lui. Gesù ne trasse occasione per rivolgere esortazioni in comune ad essi ed alle turbe. I giorni passano, gli eventi precipitano, e costoro invece di provvedere ai loro supremi interessi si arrovellano per ostacolare il regno di Dio. Ma non vedono essi ciò che accade attorno a loro? Non riconoscono i segni dei nuovi tempi morali? I segni dei tempi materiali essi sanno ben riconoscere quando di sera scorgono una nuvola che viene su da ponente, dicono subito che verrà la pioggia; quando invece soffia vento da mezzogiorno, dicono che farà caldo; così infatti avviene. E dai segni morali manifestatisi da Giovanni il Battista in poi non scorgono essi, ipocriti, che è venuto il tempo di rinnovamento spirituale e di «cambiamento di mente» (§ 266)? Il vecchiume sarà inesorabilmente abolito; e vi sono ancora dei ciechi che non scorgono la novità che si attua, e pretendono rimanere attaccati al vecchiume? Aprano gli occhi, vedano, e giudichino essi stessi ciò ch’è necessario prima che sia troppo tardi (Luca, 12, 54-57).
• § 454. Un paio di fatti di cronaca offrirono di lì a poco occasione per tornare sullo stesso argomento. A Gesù, galileo, fu riferita in quei giorni la strage che il procuratore romano Pilato aveva fatta di certi Galilei mentre offrivano sacrifizi nel Tempio (§ 26). Gesù allora, riferendosi alla vecchia opinione ebraica secondo cui il male materiale era sempre punizione di un male morale (§ 428), rispose: E credete voi forse che quei Galilei rimasti uccisi fossero peccatori più di tutti gli altri Galilei, essendo capitata loro questa sorte? Tutt’altro; vi dico infatti che se non «cambierete di mente», tutti nella stessa guisa perirete. Col fatto recentissimo ne ricollegò poi Gesù un altro, avvenuto poco prima egualmente a Gerusalemme; ivi nel quartiere del Sibe (§ 428), cioè alla periferia dell’abitato, era crollata improvvisamente una torre che faceva parte del sistema difensivo della città, del quale scavi recenti hanno rimesso in luce varie tracce: crollando, la torre aveva travolto ed ucciso diciotto persone. Ebbene - soggiunse Gesù - credete voi che quei diciotto infelici fossero più colpevoli di tutti gli altri abitanti? Tutt’altro; vi dico infatti che se non abbiate «cambiato di mente», tutti egualmente perirete (Luca, 13, 1-5). Qual è la fine qui minacciata agli impenitenti. Si osservi come ambedue i fatti citati quali esempi contengano una fine violenta, perché le vittime di Pilato muoiono di spada e le vittime della torre muoiono schiacciate: erano le morti ordinarie nelle guerre e negli assedi di allora, e basta leggere la Guerra giudaica di Flavio Giuseppe per trovare ad ogni pagina morti di spada o di schiacciamento (oltreché di fame) durante tutto l’assedio di Gerusalemme. Qui dunque si minaccia una fine tra violenze abitualmente guerresche, alle quali invece non era stato fatto alcun cenno nelle precedenti parabole dei servi che aspettano la venuta del padrone. Là infatti si trattava di un fatto assolutamente inevitabile, sebbene da attuarsi in un tempo ignoto, cioè della [seconda] «venuta del Figlio dell’uomo» il quale fisserà a ciascuno la propria [eterna] sorte; qui invece la fine violenta è senz’altro evitabile, bastando a tale scopo ricorrere al «cambiamento di mente». Le parole di Gesù sono nettissime nel loro dilemma O non cambierete di mente, e allora tutti perirete come nei due esempi; oppure cambierete di mente, e allora vi sottrarrete alla fine violenta degli esempi. Senza alcun dubbio il «cambiamento di mente» rappresenta qui lo scopo della missione di Gesù; questa missione è presentata come un’ultima dilazione offerta da Dio al prediletto popolo giudaico affinché si converta; in caso negativo, le minacce si eseguiranno. Tutto ciò è chiaramente confermato nella breve parabola soggiunta subito da Gesù. C’era un uomo il quale aveva nella sua vigna un albero di fichi che non faceva frutto. Disse pertanto al vignaiuolo: «Son già tre anni che vengo a cercar frutti da quest’albero e non ne trovo; perciò taglialo via, giacché non dà frutto e isterilisce anche il terreno attorno!». Ma il vignaiuolo intercedette: «Padrone, lascialo stare ancora quest’anno. Io zapperò torno torno alle radici, ci metterò letame, e poi vedremo: se darà frutto, bene; altrimenti, dopo quest’ultima prova, lo taglierai via!» (Luca, 13, 6-8). Il simbolismo è trasparente. Già rilevammo che i tre anni di sterilità dell’albero sembrano alludere alla durata della vita pubblica di Gesù (§ 178), della quale allora correva appunto il terzo anno; ma checché sia di ciò, è chiaro che l’albero rappresenta il giudaismo, il padrone della vigna Dio, il vignaiuolo Gesù stesso. Ritorna quindi la minaccia di prima: in quest’ultima dilazione concessa all’albero, o esso darà frutti, ovvero finirà sotto i colpi d’accetta.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, le recenti dichiarazioni del preteso “papa emerito” (Link), Giuseppe Ratzinger, non ci lasciano affatto stupiti. Il collasso morale nel cosiddetto clero moderno - egli sostiene - sarebbe conseguenza del ’68 e del pensiero sessantottino. Non ci stupiamo affatto: il modernismo, difatti, produce anche queste tipologie di aberrazioni e gravi scandali. Lo stesso “papa pensionato”, tuttavia, omette di denunciare che il ’68 non è altro che la promanazione, in ambito profano e sociale, del pensiero modernista (e rivoluzionario in generale) che ha animato, ed anima ininterrottamente, il “Vaticano Secondo”, almeno nelle sue conclusioni più drammatiche. Ratzinger, non dobbiamo dimenticarlo, fu proprio, ed è, un sofista promotore, divulgatore e difensore di questa ribellione contro il sacro inviolabile ordine di Dio. Se consideriamo che il “Vaticano Secondo” conclude la sua funesta ultima sessione nel ’65, mentre il ’68 arriva tre anni dopo, per retto ragionamento deduciamo chi è vera causa e chi è vera conseguenza del male contemporaneo. Bastarono soli tre anni alla “primavera conciliare” per sradicare massivamente la fede dai Popoli e per avviarli, anche a causa delle contingenze storico-sociali, alla dissoluzione morale più completa. Il resto lo lasciamo raccontare all’evidenza storica. Ciò detto per amore della verità, veniamo al Ricciotti ed alla sua consueta lezione sulla «Vita di Gesù Cristo».
Stimati Associati e gentili Sostenitori, le recenti dichiarazioni del preteso “papa emerito” (Link), Giuseppe Ratzinger, non ci lasciano affatto stupiti. Il collasso morale nel cosiddetto clero moderno - egli sostiene - sarebbe conseguenza del ’68 e del pensiero sessantottino. Non ci stupiamo affatto: il modernismo, difatti, produce anche queste tipologie di aberrazioni e gravi scandali. Lo stesso “papa pensionato”, tuttavia, omette di denunciare che il ’68 non è altro che la promanazione, in ambito profano e sociale, del pensiero modernista (e rivoluzionario in generale) che ha animato, ed anima ininterrottamente, il “Vaticano Secondo”, almeno nelle sue conclusioni più drammatiche. Ratzinger, non dobbiamo dimenticarlo, fu proprio, ed è, un sofista promotore, divulgatore e difensore di questa ribellione contro il sacro inviolabile ordine di Dio. Se consideriamo che il “Vaticano Secondo” conclude la sua funesta ultima sessione nel ’65, mentre il ’68 arriva tre anni dopo, per retto ragionamento deduciamo chi è vera causa e chi è vera conseguenza del male contemporaneo. Bastarono soli tre anni alla “primavera conciliare” per sradicare massivamente la fede dai Popoli e per avviarli, anche a causa delle contingenze storico-sociali, alla dissoluzione morale più completa. Il resto lo lasciamo raccontare all’evidenza storica. Ciò detto per amore della verità, veniamo al Ricciotti ed alla sua consueta lezione sulla «Vita di Gesù Cristo».
• § 450. Un giorno, durante questo vago peregrinare di Gesù, un tale si presentò a lui pregandolo che interponesse la sua autorità in una questione finanziaria: «Maestro, dì a mio fratello di spartire con me l’eredità» (Luca, 12, 13). Assai imprudentemente siffatto invito era rivolto a colui che nel Discorso della montagna aveva contrapposto nettamente Dio e Mammona (§ 331); la risposta adeguata non poteva essere che una esortazione di lasciare l’intero Mammona a chi lo deteneva e di passar totalmente alla parte di Dio. Gesù invece dette una risposta inadeguata, non entrando neppure nell’argomento dell’invito: «O uomo, chi mi costituì giudice o spartitore a vostro riguardo?». Si direbbe quasi che il denaro per se stesso faccia ribrezzo a Gesù [N.B. Gesù non era affatto un pauperista, ndR], e che egli tema imbrattarsi le mani anche maneggiandolo in servizio. Non vuol saperne nulla. All’invito respinto seguirono considerazioni sulla fallacia dei beni materiali, illustrate da una parabola. C’era un uomo ricco, a cui un’annata i campi fruttarono in misura abbondantissima. Su tutto quel raccolto egli si concentrò col pensiero, cercando modo di allogarlo e conservarlo per bene. E cominciò a dire: «Butterò giù i miei granai e ne costruirò di maggiori, e là disporrò convenientemente questa gran raccolta!». - Tutto contento per questa sistemazione, passò a rallegrarsi con se stesso: «Allegro, che hai l’abbondanza assicurata per molti anni! Sta’ tranquillo, mangia, bevi e divertiti!». - Ma ecco che improvvisamente interviene come nuovo attore di scena Dio stesso, il quale dice a quel ricco beato: «Stolto, questa notte tu dovrai morire, e tutti quei tuoi beni di chi saranno?». - Tale è la sorte, concluse Gesù, di chi tesoreggia per se stesso, e non è ricco in Dio. Soggiunse poi, riannodandosi ai concetti del Discorso della montagna: «Non temere, o piccolo gregge! Poiché si compiacque il vostro Padre di dare a voi il regno. Vendete le vostre sostanze e date elemosina; fatevi borse che non s’invecchiano, tesoro non manchevole nei cieli! (...)» (§ 330) (Luca, 12, 32-33). È comunismo tutto ciò? È assai più che comunismo, perché è altruismo della carità; è precisamente quell’altruismo totale ed assoluto, che per un principio sovrumano provvede materialmente agli altri fino a trascurare se stesso: «Vendete le vostre sostanze e date elemosina». D’altra parte il comunismo odierno, nella sua intima essenza, non ha neppur l’ombra della dottrina di Gesù, perché non conosce affatto le «borse che non s’invecchiano» e il «tesoro non manchevole nei cieli»: gli manca cioè la suprema aspettativa.
• § 451. Su questa aspettativa, infatti, tornò di lì a poco Gesù, come sulla più profonda base di tutti i suoi insegnamenti. Perché rinunziare alle ricchezze? Perché confidare solo nel tesoro dei cieli? Perché considerare tutto il mondo presente come un’ombra fugace? A queste domande rispose Gesù ammonendo: «Siano i vostri fianchi recinti e le lucerne accese (tale era la tenuta notturna dei famigli pronti a servire), e voi (siate) simili ad uomini aspettanti il loro signore quando torni dalle nozze, affinché venuto che sia e bussato che abbia subito gli aprano». Il padrone era partito avvertendo la servitù che sarebbe andato ad una festa di nozze, e perciò il suo ritorno non poteva essere che a notte assai inoltrata (§ 281); ma i premurosi servi vogliono ch’egli non attenda alla porta neppure un istante, ed essi passano le ore notturne vegliando con i fianchi recinti e le lucerne accese e con l’orecchio teso all’arrivo di lui. «Beati quei servi che il signore venuto troverà veglianti!». Commosso da tanta cura, quel buon padrone si cingerà egli stesso i fianchi, li farà adagiare a mensa e li servirà: egli infatti ha già cenato alle nozze, ma quei bravi servi non hanno avuto tempo di prepararsi un po’ di cibo per l’ansia di tenersi pronti mentre passavano in sollecita attesa la seconda e la terza vigilia della notte (§ 376). Nella stessa guisa un solerte padrone di casa fa sorvegliare tutta la notte, perché non sa in quale ora il ladro possa venire a scassinare la casa: volendo il padrone esser sicuro, diffida di qualunque ora e durante l’intera notte mantiene la sorveglianza. Onde Gesù concluse: «Anche voi siate preparati, perché in quell’ora che non credete il figlio dell’uomo viene». Qual è questa “venuta” del figlio dell’uomo? È quella che mostrerà palesemente il risultato perenne e immutabile degli insegnamenti di Gesù. Aveva egli parlato della rinunzia alle ricchezze, contrapponendo ad esse il tesoro nei cieli. Ma perché rinunziare alle ricchezze? Perché considerare il mondo presente come un’ombra fugace? Appunto perché si effettuerà questa “venuta” del figlio dell’uomo; la quale dissiperà l’ombra fugace e disvelerà la realtà perenne, farà sfumare le ricchezze terrene accumulate e distribuirà l’invisibile tesoro celeste, adempirà le speranze di coloro che hanno sperato in quella “venuta” e fisserà in eterno la loro sorte beata. «Beati quei servi che il signore venuto troverà veglianti!»
• § 452. Pietro domandò spiegazioni a Gesù: «Signore, a noi dici questa parabola, o anche a tutti?». Egli era rimasto colpito dell’annunzio che il padrone dei premurosi servi si metterà egli stesso a servire i servi per premiarli della loro premura, e voleva sapere se questa era la sorte di alcuni privilegiati soltanto, ovvero di tutti. Gesù rispose introducendo un elemento nuovo, cioè i servi eventualmente trascurati e infingardi, e stabilendo una graduazione fra i doveri e le responsabilità dei servi in genere. C’è un servo zelante ch’è stato destinato, durante l’assenza del padrone, a dispensare i viveri agli altri servi; se egli eseguirà fedelmente questa incombenza, il padrone al suo ritorno lo premierà eleggendolo amministratore di tutti i suoi averi. Se invece quel dispensiere, approfittando della prolungata assenza del padrone, si darà a spadroneggiare egli stesso, a battere garzoni e ancelle, e a far orge ed ubriacarsi, il padrone al suo improvviso ritorno lo punirà di castigo severissimo, mentre con castighi minori punirà anche gli altri servi che abbiano mancato in misure minori; rimane infatti il principio generico che a chiunque fu dato molto, molto sarà ricercato a lui; e a chi fu affidato molto, maggiormente si domanderà a lui (Luca, 12, 35-48). Dunque, la “venuta” del figlio dell’uomo apporterà come elemento comune a tutti la stabilità immutabile della propria sorte, ma in questo elemento comune vi saranno differenze e graduazioni; soprattutto, poi, il tempo preciso della “venuta” è ignoto.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, oggi l’Abate Ricciotti - pace all’anima sua! - ci descriverà il «Pranzo di Gesù da un fariseo: invettive e ammonizioni», dalla pagina 526 alla pagina 530 della sua preziosa «Vita di Gesù Cristo», Rizzoli, 1941.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, oggi l’Abate Ricciotti - pace all’anima sua! - ci descriverà il «Pranzo di Gesù da un fariseo: invettive e ammonizioni», dalla pagina 526 alla pagina 530 della sua preziosa «Vita di Gesù Cristo», Rizzoli, 1941.
• § 447. Evidentemente il dissidio tra i Farisei e Gesù diventava sempre più grave e profondo. I primi non perdonavano a Gesù la sua indipendenza dal formalismo legale, la quale egli in mille occasioni proclamava con le parole e dimostrava con i miracoli. Gesù, dal canto suo, non cessava dal redarguire con le parole più severe la vacuità spirituale ricoperta dal formalismo farisaico, l’ostinazione pervicace di quegli uomini della Legge e la loro orgogliosa tracotanza: egli inoltre mostrava di aver sentito intimamente l’ingiuria da essi rivoltagli, allorché lo avevano designato come amico e ministro di Beelzebul. Tuttavia, poco dopo i fatti precedenti, un Fariseo invitò Gesù a pranzo: non sappiamo se facesse ciò mosso da una certa simpatia per il discusso Rabbi oppure dal desiderio d’implicarlo in questioni insidiose, ad ogni modo nessuno più di un Fariseo era abile nel salvare le apparenze e nel distinguere la teoria dalla pratica. Gesù accettò l’invito, ed entrato nella camera da pranzo si adagiò senz’altro sul suo divano in attesa delle vivande. Questa maniera di comportarsi era una mancanza farisaicamente assai grave: Gesù veniva dalla strada e dal contatto con la folla, e osava prender cibo senza prima aver praticato le accurate lavande di prescrizione? Il Fariseo ospitante ne rimase disgustato; in cuor suo egli pensò che il suo ospite, invece d’un autorevole Rabbi, non era che uno di quei «tangheri» a cui Giuda il Santo non avrebbe dato un tozzo di pane neppure se l’avesse visto morir di fame (§ 40): e invece il Fariseo ospitante aveva commesso la dabbenaggine d’invitarlo a pranzo. I sentimenti interni del Fariseo gli si leggevano sul viso: Gesù li lesse, e ne seguì una serrata disputa. Disse Gesù: «Voi dunque, Farisei, mondate l’esterno della coppa e del piatto, ma il Vostro interno è ripieno di rapina e malvagità! Stolti! Forseché chi fece l’esterno non fece anche l’interno? Piuttosto date in elemosina le cose contenute (in quei recipienti), ed ecco che tutto diventerà per voi puro! - Ma guai a voi, Farisei, perché pagate la decima della menta e della ruta e d’ogni legume, e trasgredite l’(equità nel) giudizio e l’amore di Dio! Invece, queste cose bisognava fare e quelle non tralasciare. - Guai a voi, Farisei, perché amate il primo seggio nelle sinagoghe (§ 63) e i saluti nelle piazze! - Guai a voi, perché siete come i sepolcri invisibili, e gli uomini che (ci) camminano sopra non (li) sanno!». È ben lecito supporre che, alle prime note di questa musica, il pranzo finisse lì e che le invettive sostituissero le vivande. Il Fariseo ospitante e i suoi soci di «colleganza» (§ 39) avranno risposto come meglio potevano; ma assistevano a quel pranzo anche taluni maestri di Legge (§ 41), i quali si sentirono chiamati in causa almeno implicitamente, tanto che uno di essi replicò risentito: «Maestro, dicendo ciò insulti anche noi!». Ma anche egli e i suoi colleghi ebbero la loro parte, giacché l’indomabile Rabbi riprese: «E anche a voi legisti, guai! Perché caricate gli uomini di carichi mal sopportabili, e voi con un solo dei vostri diti non toccate quei carichi! - Guai a voi, perché costruite i sepolcri dei profeti, mentre i vostri padri li hanno uccisi! Dunque siete testimoni e consentite alle opere dei vostri padri, perché essi li hanno uccisi e voi costruite. (...) Guai a voi, legisti, perché toglieste la chiave della scienza, (ma) voi non entraste ed impediste coloro ch’entravano!» (Luca, 11, 39-52).
• § 448. In queste invettive Gesù ha di mira la pratica e non la teoria, la generalità e non i singoli. In teoria i rabbini, almeno dopo l’Era Volgare, insegnarono più d’una volta che la dottrina doveva esser congiunta con l’esempio personale, e che era cosa riprovevole esser più severo con gli altri che con se stesso ; quanto alla pratica, lo storico prudente non ha che da rimettersi al giudizio degli stessi interessati, cioè al riportato passo del Talmud che descrive i sette tipi diversi di Farisei (§ 38). Non tutti e singoli i Farisei e gli Scribi meritavano queste invettive, senza dubbio; ma Gesù s’indirizza, non ai singoli, ma alla generalità, e questa le meritava senza dubbio. Se poi Gesù rinfaccia loro di costruire i sepolcri ai profeti, non è per rimproverarli dell’opera in sé pia: è piuttosto perché la pietà si limitava all’opera materiale, mentre spiritualmente quei che costruivano sepolcri ai profeti continuavano con la loro condotta morale l’opera dei padri loro che avevano ucciso gli stessi profeti: i figli, mentre confessavano d’aver nelle loro vene il sangue dei padri, mostravano con i fatti di averne ereditato anche lo spirito (cfr. Matteo, 23, 29 segg.). In particolare i legisti e gli Scribi si erano arrogati il monopolio della Legge mosaica, e di questa torre d’avorio pretendevano di possedere essi soli la chiave: ma era una chiave monca e rugginosa, che poteva aprire a mala pena gli accessi esterni di quella torre i quali si chiamavano «lettera morta», mentre né ai possessori della chiave né ad altri essa permetteva d’inoltrarsi fino ai penetrali interni i quali si chiamavano «carità viva» [La carità è il vincolo di perfezione. La carità non ha finzioni: fugge il male e si attacca la bene. La carità è fare integralmente la volontà di Dio. La carità è amare Dio secondo i Suoi ordini, quindi è amare il prossimo, ndR]. Il risultato di quel battagliero pranzo fu quale ci potevamo facilmente attendere. «Uscito egli (Gesù) di là, gli Scribi e i Farisei cominciarono ad essere terribilmente indignati (contro di lui) e ad assillarlo di questioni su molti punti, tramandogli insidie per cogliere alcunché dalla sua bocca». L’antica lotta, dunque, diveniva sempre più serrata, e tutto lasciava prevedere una conclusione prossima.
• § 449. Da quanto era avvenuto Gesù trasse argomento per impartire avvisi ai suoi seguaci. La folla, in questa congiuntura di tempo, si era moltiplicata al punto da esserne in pericolo l’incolumità personale degli accorsi (Luca, 12, 1): e qui San Luca fa pronunziare a Gesù un discorso i cui elementi si ritrovano quasi tutti in Matteo ma sparpagliati. - Si guardino i suoi discepoli dal fermento dei Farisei, ch’è ipocrisia (§ 393). Nessun discepolo è dappiù del proprio maestro; se dunque Gesù è stato chiamato Beelzebul (§ 444), i suoi discepoli non dovranno aspettarsi un trattamento migliore (Matteo, 10, 25). Essi tuttavia parlino con tutta apertura e franchezza: non v’è nulla di occulto che non debba esser rivelato, e ciò ch’essi hanno udito in segreto lo palesino dall’alto dei tetti. Non temano essi di coloro che possono soltanto uccidere il corpo ma non l’anima; temano invece di colui che può mandare in rovina corpo e anima nella Geenna. Non si preoccupino della propria esistenza, ma si affidino alle predisposizioni del Padre celeste che sorveglia su ogni cosa; i passeri dei campi valgono un’inezia, perché se ne comprano cinque per due assi (13 centesimi), eppure nessuna di quelle bestiole è dimenticata da Dio: stiano dunque tranquilli i discepoli perché essi valgono assai più di molti passeri messi insieme, e perché tutti i capelli delle loro teste sono contati. Chiunque pertanto confesserà davanti agli uomini il figlio dell’uomo, costui lo confesserà davanti al Padre celeste e agli angeli di Dio, ma chiunque lo rinnegherà sarà da lui rinnegato. Né si preoccupino i discepoli della propria difesa oratoria quando saranno citati al giudizio delle sinagoghe e dei vari tribunali, perché lo Spirito santo insegnerà loro in quel momento ciò che dovranno dire per difendersi.
• Anche in quest’ultima norma Gesù si mostra capovolgitore (§ 318). Preoccupazioni di difesa oratoria non aveva avute neppure Socrate, quando si presentò al tribunale per uscirne condannato a morte: «Le cose infatti stanno così. Io adesso per la prima volta sono salito in tribunale, all’età di settanta anni; sono quindi imperito e straniero al parlare di qui» (Apologia di Socrate, I). Il filosofo ateniese parlò con sincerità perfetta, con franchezza assoluta; m il suo discorso -almeno nella forma pervenutaci - è disposto secondo tutte le norme classiche dell’oratoria forense, con esordio, proposizione, confutazione delle accuse, perorazione e controproposta di pena. Né egli parlò in virtù di altri, ma in virtù sua propria ... (§ 194). Quel suo arcano genio ispiratore, mentre in altre occasioni gli si era opposto internamente affinché non operasse alcunché di inopportuno, in quella mattina del giudizio non intervenne in nessuna maniera: «A me infatti, o uomini giudici, - e chiamandovi giudici intendo chiamarvi esattamente - è accaduto alcunché di meraviglioso. Infatti l’ispirazione a me abituale (...) era sempre assai frequente in tutto il tempo passato e si opponeva anche in cose assai minute, se io fossi stato per operare alcunché non rettamente. Adesso invece (...) il segno del Dio non mi si oppose né all’uscire stamane di casa, né quando salivo qui in tribunale, né in alcun punto del discorso quando stavo per dire alcunché; eppure in altri discorsi mi trattenne a mezzo in molti punti mentre parlavo: adesso invece non mi si è opposto giammai in tutto ciò che ho fatto o detto in questo negozio» (Apologia, XXXI). Nei seguaci di Gesù avverrà un fenomeno ben più importante di quello di Socrate. In essi lo Spirito non agirà solo negativamente, come il socratico che impediva il non retto ma non suggeriva il retto; invece lo Spirito stesso suggerirà le parole di difesa e porrà un’efficace apologia in bocca ai calunniati. I quali perciò potranno e dovranno trascurare l’oratoria forense.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, non è nostra abitudine occuparci di attualità, tuttavia consentiteci una breve riflessione su quanto sta accadendo in questi giorni in Italia. Un numeroso gruppo di intellettuali ed attivisti “pro life” - come si fanno chiamare - è riunito in un consesso laicista (qui le condanne della Chiesa) ed ecumenico (qui le condanne della Chiesa) a Verona per discutere di famiglia, matrimonio, prole ed altre tematiche cardine della società. Ebbene, in conseguenza di ciò, gli abituali paladini (ad intermittenza) della “libertà di espressione” e (sempre ad intermittenza) acerrimi nemici della censura - fra i quali volti noti della tv e della moderna politica - hanno iniziato quella consueta campagna d’odio, di censura e di boicottaggio ai danni dei partecipanti al suddetto evento e di chi con loro coopera (es. albergatori, ristoratori, ecc...). Da che parte stare? Con nessuna delle due.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, non è nostra abitudine occuparci di attualità, tuttavia consentiteci una breve riflessione su quanto sta accadendo in questi giorni in Italia. Un numeroso gruppo di intellettuali ed attivisti “pro life” - come si fanno chiamare - è riunito in un consesso laicista (qui le condanne della Chiesa) ed ecumenico (qui le condanne della Chiesa) a Verona per discutere di famiglia, matrimonio, prole ed altre tematiche cardine della società. Ebbene, in conseguenza di ciò, gli abituali paladini (ad intermittenza) della “libertà di espressione” e (sempre ad intermittenza) acerrimi nemici della censura - fra i quali volti noti della tv e della moderna politica - hanno iniziato quella consueta campagna d’odio, di censura e di boicottaggio ai danni dei partecipanti al suddetto evento e di chi con loro coopera (es. albergatori, ristoratori, ecc...). Da che parte stare? Con nessuna delle due.
Il “Congresso di Verona”, difatti, ostenta la laicità, il compromesso ed il pensiero ecumenico; mentre i paladini della “democrazia” e della “libertà di espressione” - i cosiddetti “progressisti” - presentano le solite istanze intrinsecamente incompatibili con l’ordine di Dio, con la fede cristiana e, dunque, con la natura stessa. Per approfondimenti dogmatico-morali e per eventuali chiarimenti rimandiamo alla nostra corposa sezione dedicata alla Teologia politica. È evidente, perciò, che ambo gli schieramenti si palesano «mandatari, più o meno consapevoli, di quell’insidiosissimo nemico, che sempre si adopera a seminare zizzania in mezzo al frumento» (La Casti Connubii di Papa Pio XI condanna esplicitamente gli uni e gli altri con la seguente sentenza: «(Taluni lo fanno integralmente ed apertamente), poi vi sono taluni che, sforzandosi di arrestarsi come a mezzo della china, vorrebbero far qualche concessione ai tempi nostri, solamente su alcuni precetti della legge divina e naturale. Ma questi non sono altro che mandatari, consapevoli più o meno, di quell’insidiosissimo nemico che sempre si adopera a soprasseminare zizzania in mezzo al frumento. Noi pertanto, che il Padre di famiglia ha posto a custodia del proprio campo, e perciò siamo tenuti dall’obbligo sacrosanto a vigilare che il buon seme non sia soffocato dalle male erbe, stimiamo a Noi rivolte dallo Spirito Santo quelle gravissime parole, con le quali l’Apostolo Paolo esortava il suo diletto Timoteo: Ma tu, veglia, adempi il tuo ministero … predica la parola, insisti a tempo, fuori di tempo: riprendi, supplica, esorta con ogni pazienza e dottrina»).
Per chi simpatizzare? Umanamente è probabile per i primi, mai per i secondi. Ciò premesso, assodato; 1) che in questa sede nessuno pretende di dettare il programma a casa di altri, né ha velleità politiche o mediatiche; 2) che «(le Leggi di Dio) non possono andar soggette ad alcun giudizio umano e ad alcuna contraria convenzione» (ivi.); 3) ben sapendo che non può esistere alcun compromesso con «i fautori di queste nuove (funeste) massime (che) giungono a tutte le ultime conseguenze della sfrenata libidine» (ivi.); adesso spendiamo due parole sull’aborto. Alcuni partecipanti al “forum di Verona” si sono dichiarati - «personalmente, ma non è tema del forum», sic! - favorevoli all’abolizione della “legge 194”, odiosa misura che pretende legalizzare l’aborto in Italia. Le ire dei liberali e dei progressisti (due facce della stessa medaglia) non sono tardate: «Si tratta di un ritorno al Medioevo ... i diritti delle donne non si toccano ... sarebbe un imperdonabile ritorno all’oscuro passato ... è una misura illiberale ... le donne sono in pericolo ... eccetera». Ma che cos’è l’aborto? È possibile essere cattolici e, nel contempo, non essere disposti ad usare qualsiasi mezzo lecito pur di abrogare la “legge 194”? Si tratta di una misura iniqua, contro la vita, che mina l’ordine sociale, che va abrogata ad ogni costo. Come vanno abrogate altre misure parimenti inique - «(contrarie) alla Sacra Scrittura, (al)la costante ed universale tradizione della Chiesa; (al)la solenne definizione del Concilio Tridentino ... eccetera ...» (ivi.) - quali le cosiddette “unioni civili”, il “divorzio”, e tutte quelle pretese leggi contro la Legge naturale, eterna ed il Diritto divino positivo. Allora, quale pragmatico compromesso, «(quali) concessioni quanto (ai) precetti della Legge divina e naturale»? Nessun compromesso e nessuna concessione: questo ci comanda Dio, questa è la fede dei Martiri.
• L’aborto è l’uccisione del nascituro. È l’espulsione del prodotto del concepimento nel periodo in cui esso non può vivere fuori dell’utero materno. L’aborto si distingue dalle altre odiose pratiche chiamate “anticoncezionali”, poiché queste ultime tendono ad impedire la fecondazione e non ad uccidere il concepito. L’aborto diretto, ossia voluto e realizzato mediante l’uso di mezzi per se stessi tendenti a procurarlo, è sempre omicidio, poiché sopprime una vera persona umana innocente, la quale, essendo valore-fine (= assoluto), non può essere subordinata a nessun altro scopo, anche per se stesso ottimo. La Chiesa ha sempre condannato l’aborto come vero omicidio (v. Denzinger, aborto - cfr. Dizionario del Cristianesimo, E. Zoffoli, 1992, pag. 3-4). Facciamo presente che, dove diciamo «la Chiesa ...», non intendiamo assolutamente i modernisti che massicciamente occupano la Chiesa da più di mezzo secolo (qui approfondimenti). Più avanti, nel prossimo articolo, Papa Pio XII ci fornirà un corposo approfondimento dogmatico, morale e pratico (useremo il suo Discorso alle ostetriche del 1951).
• Conclude Papa Pio XI nella preziosa Casti Connubii - Enciclica dogmatico-morale sulla vita e sul matrimonio cristiano: «A coloro (...) che tengono il supremo governo delle Nazioni, e ne sono legislatori, non è lecito dimenticare che è dovere dell’autorità pubblica di difendere con opportune leggi e con la sanzione di pene la vita degli innocenti; e ciò tanto maggiormente, quanto meno valgono a difendersi coloro la cui vita è in pericolo, e alla quale si attenta; e fra essi, certo, sono da annoverare anzitutto i bambini nascosti ancora nel seno materno. Se i pubblici governanti non solo non prendono la difesa di quelle creature, ma anzi con leggi e con pubblici decreti le lasciano, o piuttosto le mettono in mano dei medici o d’altri, perché le uccidano, si rammentino che Dio è giudice e vindice del sangue innocente, il quale dalla terra grida verso il cielo». Piaccia o non piaccia, questa è la nostra fede, questo è l’ordine di Dio, questa è la regola della nostra vita: indifferenti a qualsiasi rispetto umano, limpidamente la esponiamo, la rivendichiamo e la difendiamo, contro ogni assalto diretto o indiretto, aggressivo o mitigato!
• Veniamo, adesso, all’abituale docenza dell’Abate Ricciotti sulla «Vita di Gesù Cristo» e sulla Sacra Scrittura: «Guarigione di un indemoniato e calunnie dei Farisei. Più beati della Madre di Gesù. Il segno di Giona». § 444. Alle istruzioni sulla preghiera San Luca fa seguire la guarigione di un indemoniato muto (Luca, 11, 14 segg.). La stessa narrazione si ritrova in San Matteo (12, 22 segg.), ove però l’indemoniato è anche cieco oltreché muto (cfr. S. Agostino, De cons. evangelist., II 37 - lo citiamo «Matteo prosegue: Allora gli fu presentato un ossesso, cieco e muto; ed egli lo guarì sì che poteva parlare e vedere. Questo episodio lo riferisce anche Luca, non però nello stesso ordine ma dopo molti altri avvenimenti e affermando che egli era muto, non però cieco. Non mi sembra - dice Sant’Agostino - tuttavia logico ritenere che egli, sebbene passi sotto silenzio alcuni particolari, parli di un altro individuo. Nel riferire infatti gli avvenimenti successivi si ricollega a quanto narrato anche da Matteo»); inoltre la discussione con i Farisei, che seguì alla guarigione, si ritrova in Marco (3, 22 segg.), ov’è collocata in mezzo alla visita dei parenti di Gesù (§ 345). La collocazione di Luca, che mette guarigione e discussione durante questa permanenza nella Giudea è da preferirsi a quella degli altri due Sinottici che l’anticipano. Gesù dunque, a cui era stato presentato un indemoniato muto (oltreché cieco), lo guarì pubblicamente. Al fatto si trovarono presenti alcuni Scribi giunti da Gerusalemme e alcuni Farisei, i quali non negarono la guarigione ma la spiegarono affermando che Gesù comandava ai demonii perché egli stesso se la intendeva col principe dei demonii Beelzebul, e con l’autorità di costui agiva. Il nome di questo principe era stato anticamente Ba῾al zebūb, “Baal (dio) delle mosche”, e aveva designato una divinità filistea di Accaron (cfr. II[IV] Re, 1, 2 segg.); più tardi, invece, designò l’oggetto dell’idolatria in genere, e allora il nome con leggiera mutazione fu cambiato in Ba῾al zebūl, “Baal del letame”, per allusione dispregiativa agli idoli ed alloro culto. Gesù, pertanto, sarebbe stato in amichevoli relazioni con questo principe. All’ingiuria degli Scribi e dei Farisei Gesù rispose nella maniera meno gradita ad essi, cioè invitandoli ad un sereno ragionamento. Riferendosi pertanto all’angelologia del giudaismo contemporaneo (§ 78), Gesù fece osservare che il regno di Satana era un regno gerarchicamente costituito e ben compatto, mentre se fosse stato diviso in se stesso sarebbe caduto in rovina. «Come dunque voi, Scribi e Farisei, potete affermare che io scaccio Satana nel nome di Satana? In tal caso il suo regno sarebbe diviso e cadrebbe in rovina. Del resto anche voi, Scribi e Farisei, avete i vostri esorcisti; ebbene, domandate ad essi se è possibile scacciare Satana in nome di Satana, ed essi vi giudicheranno nella vostra calunnia contro di me. Se poi scaccio i demonii nel nome di Dio, e li scaccio io personalmente con tanta facilità e li fo anche scacciare dai miei discepoli, tutto ciò dimostra che qualcosa di straordinario si compie in mezzo a voi, cioè che è giunto su voi il regno d’Iddio. Ma voi non vedete tutto ciò perché non volete vedere, e davanti al fulgore della luce chiudete ostinatamente gli occhi; il che significa peccare direttamente contro lo Spirito santo fonte di luce per voi, significa sbarrare le strade di salvezza appianatevi da Dio e frustrare i suoi disegni. Badate però che ogni peccato e bestemmia sarà rimessa agli uomini, ma la bestemmia dello Spirito non sarà rimessa; e chi dica parola contro il figlio dell’uomo gli sarà rimessa, ma chi (la) dica contro lo Spirito santo non gli sarà rimessa né in questo secolo né in quello venturo». Rimane in oscurità eterna chi non vuole disserrare gli occhi dell’anima alla luce dello Spirito; e non basta disserrarli momentaneamente ma è necessario tenerli sempre aperti, perché Satana espulso una volta torna all’assalto del suo antico dominio.
• § 445. A questa discussione erano presenti anche persone favorevoli a Gesù; ed ecco d’in mezzo ad esse levarsi una voce di donna che grida a Gesù: «Beato il ventre che ti portò, e le mammelle che succhiasti!». La felicitazione, squisitamente femminile, è riportata dal solo Luca (§ 144). Gesù accolse la felicitazione, ma nello stesso tempo la sublimò rispondendo: «Ancor più beati quelli che ascoltano la parola d’Iddio e (la) custodiscono». Una risposta sostanzialmente eguale Gesù aveva già data a coloro che gli annunziavano esser giunti i suoi parenti e sua madre per parlargli (§ 345).
• § 446 E la discussione, dopo il grido della donna, riprese. Alcuni Scribi e Farisei, mostrando quasi una certa condiscendenza, si dichiararono disposti a riconoscere la missione di Gesù: ma naturalmente ci volevano le prove, i «segni», e questi non potevano essere i miracoli operati fino allora da Gesù; ci voleva invece un «segno» di tipo rabbinico, di quelli fatti a tempo e luogo prestabiliti, quasi a tocco di bacchetta magica, e meglio ancora se fosse stato un «segno» meteorologico calato dal cielo. Era in sostanza la richiesta fatta poco prima a Gesù da altri Farisei (§ 392). Anche questa volta la richiesta è respinta da Gesù, il quale però aggiunge talune dichiarazioni: «Una generazione perversa e adultera ricerca un segno, e un segno non le sarà dato se non il segno di Giova il profeta. Poiché, come Giona era nel ventre del cetaceo tre giorni e tre notti, cosi sarà il figlio dell’uomo nel cuor della terra tre giorni e tre notti». L’espressione «giorno e notte» designava nell’uso rabbinico il complesso di 24 ore, fosse questo complesso intero o soltanto frazionario; perciò qui Gesù annunzia che il figlio dell’uomo sarà nel cuor della terra durante tre complessi di 24 ore, interi o frazionari; e poi ne risalirà fuori come Giona dal suo cetaceo. Dal momento che i Farisei respingono gli altri segni e ne richiedono uno con particolari condizioni, accolgano questo segno di Giona che risponde in gran parte alle loro condizioni: esso infatti avverrà a tempo prestabilito, cioè alla morte del figlio dell’uomo; se non calerà dal cielo aperto ove dimorano gli angeli potenti, sorgerà in compenso dall’abisso chiuso ove dimorano i morti impotenti (§ 79); infine, non rappresenterà un puntiglio di potenza personale perché il figlio dell’uomo avrà cessato allora le sue presenti contese e si troverà nel cuor della terra, ma in compenso il segno rappresenterà il trionfo di un’idea come il fatto di Giona rappresentò il trionfo della «penitenza» presso gli abitanti di Ninive. «Uomini Niniviti sorgeranno nel (giorno del) giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché fecero penitenza alla predicazione di Giona: ed ecco, più che Giona è qui». Lo stesso farà in quel giorno la regina di Saba, venuta dalle estremità della terra ad ammirare la sapienza di Salomone (I [III] Re, 10, 1 segg.): «ed ecco, più che Salomone è qui». L’allusione al triplice «giorno e notte» da passare nel cuore della terra fu capita bene dai Farisei. Appena morto Gesù, essi correranno da Pilato raccomandandosi che provveda in tempo, giacché essi in quell’occasione si ricordano che quell’imbroglione (cioè Gesù) disse, essendo ancora vivo: «Dopo tre giorni risorgo» (§ 619). Cosicché anche il segno di Giona, rispondente in gran parte alle condizioni da loro poste, verrà da loro respinto: essi si raccomanderanno a Pilato per paura che il nuovo Giona risalga dal cuor della terra, per paura che la loro cecità sia illuminata, e per paura che essi non possano ancora bestemmiare lo Spirito santo.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, oggi affronteremo tre vicende o argomenti: Marta e Maria; il «Pater noster»; le parabole sulla preghiera.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, oggi affronteremo tre vicende o argomenti: Marta e Maria; il «Pater noster»; le parabole sulla preghiera.
• § 441. Durante la sua peregrinazione, Gesù giunse alle immediate vicinanze di Gerusalemme; entrato in un villaggio, che San Luca non nomina, fu ospitato da due sorelle di nome Marta e Maria. Sono le sorelle di Lazaro, delle quali parla anche San Giovanni (IV Vangelo, 11, 1 seguenti), e perciò l’innominato villaggio deve essere Bethania; con l’insieme della narrazione concorda anche la situazione di Bethania che è sulla strada pericolosa da Gerusalemme a Gerico, e quindi, se la parabola del buon Samaritano fu recitata poco prima dell’arrivo a Bethania, occasione alla parabola fu fornita dai luoghi stessi ove Gesù era di passaggio. Nella casa ospitale, certamente già nota a Gesù, chi appare governante è Marta, probabilmente la più anziana delle due sorelle ch’erano forse orfane: e non per nulla si chiama Marta (in aramaico «signora»), giacché ella provvede a tutto, dispone tutto, per fare degna accoglienza all’ospite e amico venerato. Il fratello Lazaro non figura affatto in questo episodio e non è neppur nominato; era egli forse appartato e già in preda a quella malattia che pochi mesi più tardi l’avrebbe condotto alla sua quatriduana dimora nella tomba (§ 489)? Non è impossibile, ma non sappiamo nulla di preciso. Quanto a Maria, ella sfrutta l’incessante operosità di sua sorella per starsene tranquillamente vicino a Gesù; dal momento che la brava Marta bada a tutto, la sorella minore ha agio d’ascoltare dalla bocca di Gesù quelle parole che trascinano folle e tramutano cuori. Marta va e viene affaccendata, passando per la stanza dei due, e cerca di raccogliere anch’essa talune delle parole di Gesù: ma la spigolatura è scarsa, perché sono molte le faccende domestiche; cosicché ad un certo punto un’amorevole invidiuzza - o meglio emulazione - verso la sorella, nonché una certa dimestichezza con l’amico di casa Gesù, la rendono ardita ad accenti di confidenza; fattasi dappresso disse: «Signore, non t’importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che s’unisca ad aiutarmi!». In altre parole Marta, solerte massaia e devota ammiratrice di Gesù, fa notare che, sbrigando più presto in due le faccende domestiche, le sorelle unite insieme potranno più tranquillamente godere della parola del maestro. Senonché Gesù, con confidenza eguale ma animata da un’idea ben più alta, le risponde: «Marta, Marta! Ti preoccupi ed agiti per molte cose, mentre di poche c’è bisogno o d’una sola. Maria, in realtà, si scelse la porzione buona, la quale non le sarà tolta». Erano infatti molte le cose materiali a cui badava la buona Marta, ma queste molte si potevano ridurre a poche, data la frugalità di Gesù e dei suoi discepoli presenti; e anche queste poche cose materiali erano trascurabili davanti a quell’una sola, ma spirituale, a cui convergeva tutta l’operosità di Gesù. Non aveva egli ammonito, nel Discorso della montagna, di cercare in primo luogo il regno di Dio con la certezza che esso avrebbe portato con sé per soprappiù tutto il resto? Quella era la porzione buona che Maria si era scelta. [N.B. Non si tratta di un’esortazione a trascurare i doveri del proprio stato, per le donne ordinariamente la cura del focolare domestico. Assolutamente no! Gesù intende esplicitare alla donna quella priorità necessaria alla salvezza, ndR]
• § 442. Subito dopo l’episodio di Bethania, San Luca colloca l’insegnamento del Pater noster, che San Matteo, invece, ha già riportato nel Discorso della montagna. La collocazione di Luca, come già rilevammo (§ 371), sembra più a suo posto storicamente, perché ha la seguente introduzione che dà ragione dell’insegnamento. «E avvenne che, mentre egli era in un certo luogo pregando, appena terminò, uno dei suoi discepoli gli disse: “Signore, insegnaci a pregare, come pure Giovanni (il Battista) insegnò ai discepoli suoi”. Disse quindi loro: “Quando preghiate, dite: Padre noster, ecc.”». Ma fu questa veramente la prima volta che Gesù insegnò a pregare ai suoi discepoli? Se si risponde in maniera affermativa resta da spiegare come mai Gesù, dopo tante norme di formazione spirituale impartite a quei suoi prediletti, non avesse mai toccato questo punto così importante relegandolo agli ultimi mesi di sua vita. Ovvero questa volta Gesù tornò sopra ad un argomento già trattato, spiegandolo e confermandolo sempre meglio? Ciò sembra più verosimile; e allora le collocazioni sia di Luca che di Matteo avrebbero ciascuna la sua parte di ragione. Se, pertanto, questo rinnovato insegnamento del Pater noster avvenne poco dopo l’episodio di Bethania, è anche naturale che avvenisse nei pressi di Bethania. Nel secolo IV si additava il vicino monte degli Olivi come luogo ove Gesù ammaestrò i discepoli, ma solo verso il secolo IX si hanno le prime affermazioni che ivi fosse insegnato il Pater noster. Nell’anno 1345 Nicolò da Poggibonsi scriveva: «(...) Vai a monte Uliveto; e a parte destra, sopra la via, si è un muro, insu una chiesa, ma ora si è guasta, che non c’è se non l’amattonato. Di sotto si c’è una cisterna, e al ponente, in sul muro, si c’è una grande pietra, nella quale si vedea scritto tutto il Paternostro. E ivi il nobile Jesù Cristo fece il Paternostro, e diello agli Apostoli (Libro d’Oltramare, I, pag. 165). Oggi, nella rinnovata chiesa dell’Eleona, presso la vetta del monte degli Olivi, la prima preghiera cristiana è parimente scolpita in lingue d’ogni stirpe umana.
• § 443. Insegnata la formula, Gesù continuò l’insegnamento sulla preghiera illustrandone particolarmente le principali qualità, che erano la tenacia e la fiducia. La preghiera, secondo Gesù, doveva essere tanto insistente e tenace, da sembrare quasi petulante: la norma infatti viene illustrata con una breve parabola, che è un bell’esempio di petulanza palestinese. In un villaggio qualsiasi vi sono due amici, uno dei quali a notte inoltrata riceve la visita d’un suo conoscente che è in viaggio e desidera alloggiare quella notte presso di lui. Un giaciglio si fa presto a prepararglielo; ma il viandante ha pure fame, e come si fa a servirlo se tutto il pane disponibile in casa è stato consumato nella cena di quella sera? Non resta che andare a chiederne in prestito; ma dove andare, che l’ora è tarda e tutti dormono? Non c’è da tentare che presso l’amico; è già mezzanotte, ma avrà pazienza e farà questo favore. Difatti l’amico ospitante va all’uscio dell’altro e comincia a bussare a distesa: «Ehi! Ehi! Prestami tre pani. È capitato da me un conoscente in viaggio, e non ho che mettergli davanti?» - Quello di dentro, risvegliato bruscamente, pensa ch’è un’indiscrezione bell’e buona: «Non mi dar seccature! La porta è già inchiavata, e i miei figlioli stanno con me a letto! Non posso alzarmi! (...)». Ma se quello di fuori non si lascerà disanimare dalla prima ripulsa, e seguirà invece a bussare e strepitare, quello di dentro alla fine cederà, se non in forza dell’amicizia, certo in forza della seccatura. E Gesù concluse: «Anch’io dico a voi: “Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto. Ognuno infatti che chiede riceve, e che cerca trova, e che bussa gli sarà aperto”». Ciò valeva per la tenacia della preghiera. Ma da quale considerazione morale doveva essere alimentata quella tenacia? Donde proveniva la fiducia d’essere esauditi? Anche questo punto fu illustrato da Gesù con brevi esempi pratici. «A chi di voi, essendo padre, il figlio domanderà un pane, gli darà forse un sasso? Oppure anche un pesce, forse invece d’un pesce gli darà un serpente? Oppure chiederà un uovo, gli darà uno scorpione?» (Luca, 11, 11-12). (Infatti i grossi scorpioni palestinesi hanno il ventre ovale e biancastro, cosicché, visti rovesciati, dànno l’impressione d’un uovo). In questo modo, dunque, si comportano i padri terreni; ciò offre il terminus a minori alla comparazione che fa Gesù, il quale prosegue: «Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare doni buoni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, quello nei cieli, darà cose buone a quei che lo pregano?» (Matteo, 7, 11).

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, (§ 438) durante questo peregrinare nella Giudea, probabilmente poco dopo il ritorno dei settantadue discepoli, Gesù fu avvicinato da un dottore della Legge che voleva farsi un’idea chiara del pensiero di Gesù su alcuni punti fondamentali: se ne dicevano tante sul conto di quel Rabbi galileo, che il dottore volle rendersi conto della realtà e metterlo alla prova. Lo interrogò, quindi, con semplicità: «Maestro, che cosa devo fare per ottenere la vita eterna?». Gesù gradì l’interrogazione, e volle con opportune sollecitazioni far rispondere allo stesso interrogante, come già aveva usato far Socrate. Gli chiese quindi: «Nella Legge che cosa sta scritto? Come (vi) leggi?». Quello rispose che vi stava scritto d’amare Iddio con tutte le proprie forze e il prossimo come se stesso. L’amor di Dio era appunto il primo e più solenne precetto che ogni fedele Israelita ricordava a se stesso recitando quotidianamente lo Shěma (§ 66), e Gesù, da fedele israelita, approvò pienamente la risposta: «Rispondesti rettamente. Fa’ ciò, e vivrai!». Senonché in nessun passo della Legge si trovano uniti insieme i due precetti dell’amore di Dio e del prossimo, e sembra che anche i rabbini di quel tempo non usassero unirli insieme; ad ogni modo restava l’incertezza del termine «prossimo», che non si sapeva bene a chi doveva riferirsi, se ai soli parenti o amici, oppure anche a tutti i connazionali e correligionari, ovvero nella più esorbitante delle ipotesi perfino ai nemici, agli alienigeni, agli incirconcisi, agli idolatri (§ 327, nota seconda). Di tutta questa gente chi era il vero «prossimo» per un Israelita? Possibile che fosse un «prossimo» ognuno di essi senza discriminazione? Il dottore volle mostrare di non aver parlato alla leggiera, giacché aveva mirato appunto all’ultima questione; perciò egli, volendo giustificare se stesso, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». Gesù gli rispose con una parabola. «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico; e s’imbatté in ladroni i quali spogliatolo e carica to(lo) di percosse se n’andarono, lasciandolo mezzo morto». L’odierna strada da Gerusalemme a Gerico è di 37 chilometri, ma anticamente era un poco più breve perché l’ultimo suo tratto oggi è stato allungato per comodità del traffico; quell’uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, perché la strada è quasi tutta in discesa essendovi fra le due città un dislivello di circa 1000 metri. Circa dall’8° chilometro fin quasi alle porte di Gerico la strada si svolge in luoghi assolutamente deserti, montagnosi, e spesso impervii; perciò in tutti i tempi è stata infestata da ladroni, essendo praticamente impossibile snidarli dai rifugi segreti disseminati ai fianchi della strada ed avendo essi ogni comodità di allontanarsi e scomparire dopo qualche misfatto. Oggi sono stati moltiplicati lungo la strada i corpi di guardia della polizia; ai tempi dei Bizantini e dei Crociati serviva da corpo di guardia il Khān Hathrūr, massiccia costruzione situata al 19° chilometro, che mentre proteggeva da rapine i viandanti poteva offrir loro anche un ricovero per la notte. La strada infatti, benché così malsicura, era frequentatissima, essendo l’unica che metteva la capitale Gerusalemme e buona parte della Giudea in comunicazione con l’ubertosa e popolosa pianura di Gerico e più in là ancora con la Transgiordania.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, (§ 438) durante questo peregrinare nella Giudea, probabilmente poco dopo il ritorno dei settantadue discepoli, Gesù fu avvicinato da un dottore della Legge che voleva farsi un’idea chiara del pensiero di Gesù su alcuni punti fondamentali: se ne dicevano tante sul conto di quel Rabbi galileo, che il dottore volle rendersi conto della realtà e metterlo alla prova. Lo interrogò, quindi, con semplicità: «Maestro, che cosa devo fare per ottenere la vita eterna?». Gesù gradì l’interrogazione, e volle con opportune sollecitazioni far rispondere allo stesso interrogante, come già aveva usato far Socrate. Gli chiese quindi: «Nella Legge che cosa sta scritto? Come (vi) leggi?». Quello rispose che vi stava scritto d’amare Iddio con tutte le proprie forze e il prossimo come se stesso. L’amor di Dio era appunto il primo e più solenne precetto che ogni fedele Israelita ricordava a se stesso recitando quotidianamente lo Shěma (§ 66), e Gesù, da fedele israelita, approvò pienamente la risposta: «Rispondesti rettamente. Fa’ ciò, e vivrai!». Senonché in nessun passo della Legge si trovano uniti insieme i due precetti dell’amore di Dio e del prossimo, e sembra che anche i rabbini di quel tempo non usassero unirli insieme; ad ogni modo restava l’incertezza del termine «prossimo», che non si sapeva bene a chi doveva riferirsi, se ai soli parenti o amici, oppure anche a tutti i connazionali e correligionari, ovvero nella più esorbitante delle ipotesi perfino ai nemici, agli alienigeni, agli incirconcisi, agli idolatri (§ 327, nota seconda). Di tutta questa gente chi era il vero «prossimo» per un Israelita? Possibile che fosse un «prossimo» ognuno di essi senza discriminazione? Il dottore volle mostrare di non aver parlato alla leggiera, giacché aveva mirato appunto all’ultima questione; perciò egli, volendo giustificare se stesso, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». Gesù gli rispose con una parabola. «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico; e s’imbatté in ladroni i quali spogliatolo e carica to(lo) di percosse se n’andarono, lasciandolo mezzo morto». L’odierna strada da Gerusalemme a Gerico è di 37 chilometri, ma anticamente era un poco più breve perché l’ultimo suo tratto oggi è stato allungato per comodità del traffico; quell’uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, perché la strada è quasi tutta in discesa essendovi fra le due città un dislivello di circa 1000 metri. Circa dall’8° chilometro fin quasi alle porte di Gerico la strada si svolge in luoghi assolutamente deserti, montagnosi, e spesso impervii; perciò in tutti i tempi è stata infestata da ladroni, essendo praticamente impossibile snidarli dai rifugi segreti disseminati ai fianchi della strada ed avendo essi ogni comodità di allontanarsi e scomparire dopo qualche misfatto. Oggi sono stati moltiplicati lungo la strada i corpi di guardia della polizia; ai tempi dei Bizantini e dei Crociati serviva da corpo di guardia il Khān Hathrūr, massiccia costruzione situata al 19° chilometro, che mentre proteggeva da rapine i viandanti poteva offrir loro anche un ricovero per la notte. La strada infatti, benché così malsicura, era frequentatissima, essendo l’unica che metteva la capitale Gerusalemme e buona parte della Giudea in comunicazione con l’ubertosa e popolosa pianura di Gerico e più in là ancora con la Transgiordania.
• § 439. Il malcapitato, dunque, giace sulla strada ammaccato di percosse, stordito, e non può in nessun modo tirarsi fuori da quelle condizioni se qualche pietoso non viene in suo soccorso. «Ora per caso un sacerdote scendeva per quella strada, e veduto quello passò di lungo. Similmente poi anche un Levita, venuto sul posto e veduto (quello), passò di lungo». La parabola evidentemente suppone che ambedue, il sacerdote ed il Levita, avessero terminato la loro muta di servizio al Tempio (§ 54), e quindi tornassero alle loro case situate a Gerico o giù di lì. Dopo questi due, passa un terzo viandante. «Ma un Samaritano, essendo in viaggio, venne presso di quello, e veduto(lo) si commosse; e avvicinatosi fasciò le ferite di lui versandovi sopra olio e vino; fattolo poi salire sul giumento (suo) proprio, lo condusse alla locanda ed ebbe cura di lui. E la dimane, messi fuori due denari, (li) dette al locandiere e disse: “Abbi cura di lui, e ciò che (tu) abbia speso in più io al mio ritorno ti renderò”». Il Samaritano era forse un mercante che andava per acquisti nel distretto di Gerico, e di li a poco sarebbe ritornato facendo il cammino inverso; era anche benestante, perché viaggiava su un giumento suo proprio. La pietà ch’egli sentì subito per l’infelice l’indusse a curarlo come meglio poteva in quella solitudine: applicò quindi alle ferite i medicinali del tempo, ossia l’olio emolliente e il vino disinfettante, e le fasciò con bende improvvisate; caricò poi di peso sul giumento quell’uomo inerte e imbambolato, e sostenendolo di fianco come meglio poteva lungo il tragitto lo portò fino alla locanda. Questo ricovero era certamente il caravanserraglio (§ 242) di quella strada; forse era situato sul posto dell’odierno Khān Hathrūr, che una vecchia denominazione chiama anche «Castel del sangue», dal colore rosso che le rocce ferrigne hanno in quel luogo, ma che spontaneamente fu applicato al sangue abitualmente sparso lungo la strada: di qui anche l’altra denominazione usuale di «Albergo del buon Samaritano». I due denari d’argento, equivalenti a un poco più di due lire in oro, erano una scorta sufficiente per provvedere a vari giorni di cura: del resto, se la scorta non fosse bastata, il Samaritano aveva promesso al locandiere di rimborsarlo del di più.
• § 440. La parabola era finita. Siccome il dottore aveva richiesto di sapere chi fosse il suo prossimo, così Gesù concluse la parabola provocando la risposta dal dottore stesso: «Chi di questi tre ti sembra che sia stato (il) prossimo di colui che s’era imbattuto nei ladroni?». Il dottore naturalmente rispose: «Quello che usò misericordia con lui». E allora Gesù: «Va’, anche tu fa’ lo stesso!». Si noterà l’apparente discrepanza fra la domanda del dottore (chi è il mio prossimo?) e la risposta di Gesù (anche tu fa’ lo stesso!); è una discrepanza di pura forma. Il dottore rimane nel campo delle idee: Gesù scende nel campo dei fatti, perché le più belle idee rimangono parole se non diventano fatti della vita; la vita è il paragone delle parole, e le parole più belle diventano efficaci solo quando siano precedute e seguite da una vita di disinteresse e di sacrificio. E perciò al dottore che vuol sapere chi è il prossimo, Gesù mostra chi agisce da prossimo e aggiunge l’esortazione ad imitare costui. Nel caso della parabola, il prossimo del ferito erano ufficialmente più d’ogni altro il Sacerdote e il Levita: ottima idea, pessimo risultato. In nessun modo era ufficialmente prossimo del ferito il Samaritano: pessima idea, ottimo risultato. I due ministri della religione nazionale non sentono il minimo palpito di pietà per il loro connazionale boccheggiante: lo straniero ed esecrato Samaritano fa per quell’infelice quanto avrebbe fatto per suo padre e sua madre. Dei tre, solo il Samaritano agisce da prossimo, pur non essendo ufficialmente «prossimo»; dunque qualsiasi uomo, di qualsiasi razza e fede, può essere «prossimo» perché può agire da prossimo.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, (§ 435) terminate le ultime discussioni sorte in occasione del Tabernacoli, Gesù si allontanò da Gerusalemme. Nel bimestre abbondante che correva fra i Tabernacoli e la Dedicazione (§ § 76-77), avvennero buona parte dei fatti narrati a proposito del cosiddetto «viaggio» di Luca (§ 413 segg.), che perciò si svolsero in massima parte nella Giudea: questo, infatti, era il nuovo campo di lavoro scelto da Gesù allorché aveva abbandonato la Galilea (§ 411). Come già avvertimmo, questa narrazione particolare a Luca ha mire cronologiche e geografiche soltanto vaghe e generiche, e ciò le imprime un carattere spiccatamente aneddotico; dell’operosità varia spiegata da Gesù in questo tempo per diffondere il regno di Dio nella Giudea abbiamo soltanto elementi isolati, di fatti e di discorsi, ma non una relazione completa ed organica. Il diligente raccoglitore Luca ci fornisce solo le notizie ch’è riuscito a ricuperare, sia nella loro quantità sia nei loro reciproci collegamenti: di ciò ch’egli ignora, fedelmente tace. Occasionalmente ci vengono ricordati, tutti insieme, tre uomini che vogliono seguire Gesù (Luca, 9, 57-62); di questi tre, soltanto due sono mentovati da Matteo (8, 19-22), ed è molto probabile che i tre si presentassero in tempi e luoghi diversi, sebbene poi le loro menzioni fossero riunite insieme per ragioni redazionali.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, (§ 435) terminate le ultime discussioni sorte in occasione del Tabernacoli, Gesù si allontanò da Gerusalemme. Nel bimestre abbondante che correva fra i Tabernacoli e la Dedicazione (§ § 76-77), avvennero buona parte dei fatti narrati a proposito del cosiddetto «viaggio» di Luca (§ 413 segg.), che perciò si svolsero in massima parte nella Giudea: questo, infatti, era il nuovo campo di lavoro scelto da Gesù allorché aveva abbandonato la Galilea (§ 411). Come già avvertimmo, questa narrazione particolare a Luca ha mire cronologiche e geografiche soltanto vaghe e generiche, e ciò le imprime un carattere spiccatamente aneddotico; dell’operosità varia spiegata da Gesù in questo tempo per diffondere il regno di Dio nella Giudea abbiamo soltanto elementi isolati, di fatti e di discorsi, ma non una relazione completa ed organica. Il diligente raccoglitore Luca ci fornisce solo le notizie ch’è riuscito a ricuperare, sia nella loro quantità sia nei loro reciproci collegamenti: di ciò ch’egli ignora, fedelmente tace. Occasionalmente ci vengono ricordati, tutti insieme, tre uomini che vogliono seguire Gesù (Luca, 9, 57-62); di questi tre, soltanto due sono mentovati da Matteo (8, 19-22), ed è molto probabile che i tre si presentassero in tempi e luoghi diversi, sebbene poi le loro menzioni fossero riunite insieme per ragioni redazionali.
• § 436. Un tale, che era scriba secondo Matteo, raggiunge Gesù per strada e gli dice: «Maestro, ti seguirò dovunque tu vada!». - Pensava forse, il buon uomo, che un profeta così autorevole e potente avesse una dimora stabile e decorosa, la quale gli servisse da centro di irradiazione per la sua operosità. Gesù lo disillude con franchezza: «Le volpi hanno tane e i volatili del cielo nidi, ma il figlio dell’uomo non ha dove reclini il capo». [Questo NON significa affatto che per essere buoni cristiani bisogna diventare accattoni o vagabondi, ndR]. In altre parole, il primo a seguire le norme del Discorso della montagna relative alla fiducia nella Provvidenza (§ 331) era appunto l’oratore di quel discorso. A un altro, che già faceva parte dei discepoli secondo Matteo, Gesù stesso rivolse l’invito dicendogli: «Seguimi!». L’invitato era ben disposto, ma prima domandò licenza di andar a seppellire suo padre; Gesù replicò: «Seguimi! E lascia i morti a seppellire i loro morti»; alle quali parole Luca aggiunge le altre: «Tu invece va’, annunzia il regno d’Iddio!». - Molto si è discusso su questo breve dialogo. Taluni hanno pensato che il padre di quel discepolo non fosse veramente morto, altrimenti il figlio secondo i costumi giudaici avrebbe dovuto stare presso la salma e non vicino a Gesù: egli quindi avrebbe domandato in realtà il permesso di andare ad assistere il vecchio padre nei suoi giorni estremi, come ancora oggi per esprimere questa assistenza si usa la frase affettuosa «chiudere gli occhi ai propri vecchi»; tuttavia, pur non essendo assolutamente impossibile, la spiegazione è poco verosimile. Anche meno verosimile è l’ipotesi (del Perles) secondo cui il testo greco risulterebbe da una traduzione difettosa dell’aramaico, il quale avrebbe detto originariamente «lascia i morti al seppellitore dei loro morti». Secondo ogni verosimiglianza, il padre del discepolo era veramente morto; d’altra parte Gesù vuol far risaltare l’imperiosità dell’appello al regno di Dio, che poteva in certi casi passar sopra anche alle costumanze più legittime. Se per ragioni religiose la Legge mosaica proibiva al sommo sacerdote e al «nazireo» di curare il seppellimento dei propri genitori (Levitico, 21, 11; Numeri, 6, 7), a maggior ragione il Messia Gesù esigeva negli annunziatori del regno di Dio almeno la stessa libertà dai legami sociali e una dedizione totale al loro ufficio. I viventi fuor del regno di Dio erano spiritualmente morti, e il tornare anche per breve tempo fra quei morti poteva essere pericoloso per quel discepolo: costui ch’era chiamato al regno di Dio, entrasse risolutamente nel regno della vita senza volgersi addietro a rimirare il cimitero del mondo. Questa è anche, in sostanza, l’esortazione rivolta al terzo postulante. Egli dice a Gesù: «Signore, io ti voglio seguire, ma prima permetti ch’io vada a congedarmi da quei di casa mia». - Gesù risponde: «Nessuno che imponga la mano su aratro e riguardi all’indietro, è adatto al regno d’iddio!». Come il bifolco che governa l’aratro non traccerà solchi diritti se si rivolta addietro, così chi mira al regno di Dio non deve voltarsi a riguardare le cose del mondo lasciate dietro le sue spalle.
• § 437. Trasferitosi in Giudea, Gesù inviò nuovamente in missione particolare i suoi cooperatori, come aveva già fatto in Galilea (§ 352). Essendo cresciuti i cooperatori, questa volta gli inviati furono ben più numerosi: settantadue, o settanta, a seconda dei codici; è ben probabile che fra i nuovi inviati fossero inclusi, tutti o in parte, i dodici già inviati l’altra volta. Le norme e gli scopi della nuova missione furono sostanzialmente gli stessi di quella precedente; la sua zona d’azione dovette essere la Giudea e forse anche la Transgiordania, senza però che ci siano fornite notizie precise in proposito: neppure siamo in grado di dire quanto tempo durasse questo nuovo giro d’evangelizzazione, ma sembra che non si protraesse oltre una ventina di giorni. Al loro ritorno gl’inviati erano giubilanti. Riunitisi appresso a Gesù, gli riferirono con fierezza che perfino i demonii si erano assoggettati a loro nel nome di Lui. Gesù si associò alla loro gioia, asserendo di aver visto Satana caduto dal cielo come folgore, e confermò ad essi per l’avvenire l’impero sulle potenze avverse; ma insieme li ammonì che la loro vera gioia doveva esser causata non dall’impero sugli spiriti del male, ma dal fatto che i loro nomi erano stati scritti nel cielo. Il bel successo ottenuto dai discepoli nel propagare il regno di Dio produce in Gesù una gioia più ampia ed elevata. Innalza egli il pensiero al suo Padre celeste, ne contempla i piani dell’umana salvezza e rileva che nell’attuare quei piani sono impiegati i mezzi umanamente meno opportuni, gli uomini meno pregiati ed appariscenti: il suo spirito erompe allora in un ringraziamento tripudiante al Padre celeste. «In quella stessa ora esultò (egli) nello Spirito santo e disse: “Rendo laude a te, Padre, Signore del cielo e della terra, perché celasti queste cose a sapienti e intelligenti, e le rivelasti a pargoli! Si, Padre, perché così fu beneplacito al tuo cospetto! - Tutte le cose a me furono consegnate dal Padre mio: e nessuno conosce chi è il Figlio se non il Padre, e chi è il Padre se non il Figlio e a chi voglia il Figlio rivelare”». Rivolto infine ai discepoli li proclamò beati perché contemplavano e udivano cose che invano avevano desiderato di contemplare e udire antichi profeti. Questa «esultanza» di Gesù è riferita concordemente da due Sinottici (Luca, 10, 21-22; Matteo, 11, 25-27); eppure, a sentirla leggere senza conoscere la provenienza, si concluderebbe fiduciosamente che essa proviene dal Vangelo di Giovanni, tante sono le sue analogie di pensiero e di espressione col IV Vangelo: il quale invece non contiene nulla di questo tratto. Siffatte analogie sono state sufficienti agli studiosi prevenuti per concludere, ad onta dell’attestazione concorde degli antichi documenti, che il tratto è aggiunto posteriormente o almeno ampiamente interpolato. Gli studiosi non prevenuti, e che si riportano alle origini storiche dei quattro Vangeli, vedranno in questo tratto un documento genuino dell’insegnamento di Gesù, pur rammentandosi che di quell’ampio insegnamento i Sinottici hanno ordinariamente preferito certe parti più accessibili e piane, mentre Giovanni è andato apposta in cerca delle parti più elevate ed ardue tralasciate da quelli (§ § 165, 169); tuttavia l’ordinaria preferenza dei Sinottici riceve un’eccezione appunto qui, ove essi trasmettono ciò che Giovanni tralascerà. Ma rimane sempre fermo che Sinottici e Giovanni si riportano egualmente al Gesù storico [NON ad un Gesù inventato, idealizzato o ad aggiunte postume dei primi cristiani: come sognano i maledetti modernisti, ndR].

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, anche il numero di oggi, grazie a Dio, sarà ricco di dottrina e di insegnamenti morali. Nell’editoriale di apertura ci occuperemo - con il compianto Abate Ricciotti - di Gesù Cristo buon Pastore. Seguiranno due articoli: 1) il primo contro il quietismo e sulla lotta al peccato (dalle docenze di Papa Pio XII); 2) il secondo sulla questione, tanto adulterata dai moderni fallibilisti (per brevità: dai cosiddetti Lefebvriani), riguardante la menzione esplicita del nome del Pontefice regnante nella Messa (dalle docenze di Papa Benedetto XIV).
Stimati Associati e gentili Sostenitori, anche il numero di oggi, grazie a Dio, sarà ricco di dottrina e di insegnamenti morali. Nell’editoriale di apertura ci occuperemo - con il compianto Abate Ricciotti - di Gesù Cristo buon Pastore. Seguiranno due articoli: 1) il primo contro il quietismo e sulla lotta al peccato (dalle docenze di Papa Pio XII); 2) il secondo sulla questione, tanto adulterata dai moderni fallibilisti (per brevità: dai cosiddetti Lefebvriani), riguardante la menzione esplicita del nome del Pontefice regnante nella Messa (dalle docenze di Papa Benedetto XIV).
• § 432. La guarigione del cieco nato e le relative discussioni ebbero ancora degli strascichi, probabilmente vari giorni dopo ma egualmente a Gerusalemme. Gesù ricorre ad una parabola, parzialmente allegorizzata (§ 360) ma ricavata dai comuni usi palestinesi, e paragona la propria operosità a quella d’un buon pastore, e la società da lui fondata ad un ovile. L’ovile in Palestina si riduce oggi (e così più o meno era venti secoli fa) ad un muricciolo di pietre ove si radunano la sera le pecore, di uno o più greggi, che di giorno hanno pascolato nei dintorni. Una porticina bassa e stretta, aperta nel muricciolo, permette alle pecore di entrare e uscire ad una ad una, per essere più facilmente contate ambedue le volte. Di notte un solo pastore fa la guardia all’ovile contro i ladri e le bestie feroci; ma, verso l’alba, quando vengono gli altri pastori a prendersi ciascuno il suo gregge, il pastore di guardia apre regolarmente ad essi la porticina: il nuovo arrivato dà il suo grido particolare, e allora le sue sole pecore si affollano all’uscio, escono ad una ad una e seguono per tutta la giornata il pastore nella steppa. Le altre pecore aspettano finché non odono il grido particolare del proprio pastore, e s’avviano ad uscire soltanto quando sentono quella voce, che poi le guiderà per tutta la giornata. Così, gregge per gregge, le pecore partono tutte attraverso l’unica porticina, dirette dalle rispettive voci; le quali, poi, alle volte pronunziano nomi particolari per le pecore predilette: «Ehi! La Bianca!». «Tu, la mia Bella!». Quella porticina, dunque, è il punto più delicato dell’ovile, ed essa sola ispira fiducia; chiunque non passi attraverso essa ma salga per il muricciolo scavalcandolo, si dimostra con ciò stesso nemico, e non può essere che un ladro o una bestia feroce. Perciò disse Gesù: «In verità, in verità vi dico, chi non entra per la porta nell’ovile delle pecore, bensì salendo da altra parte, colui è ladro e rapinatore. Chi invece entra per la porta è pastore delle pecore: a lui apre il portiere, e le pecore odono la voce di lui, e le proprie pecore chiama (egli) per nome e le conduce fuori; quando tutte le proprie abbia menate fuori, cammina davanti ad esse, e le pecore lo seguono perché sanno la voce di lui. Un estraneo invece non seguiranno, bensì fuggiranno da lui, perché non sanno la voce degli estranei».
• § 433. Senonché l’allusione non fu capita; e allora Gesù vi ritornò sopra: «In verità, in verità vi dico, che io sono la porta delle pecore. Tutti, quanti vennero prima di me, ladri sono e rapinatori; ma le pecore non li udirono. Io sono la porta: se per me alcuno sia entrato, sarà salvato, ed entrerà ed uscirà e troverà pascolo. Il rapinatore non viene se non per rapire, fare strage e distruggere: io venni affinché abbiano vita e abbondantemente (l’)abbiano». Chi fossero questi ladri e rapinatori Gesù non spiegò, ma le condizioni storiche dei suoi tempi erano sufficienti a farli riconoscere; come gli antichi profeti avevano trovato il massimo ostacolo alla loro missione nell’operosità avversaria degli pseudoprofeti «profetizzanti la menzogna e... la fraude del loro cuore» (Geremia, XXIII, 26; si veda tutta la lunga invettiva di questo Profeta - XXIII, 9-40 - contro gli pseudoprofeti, alla quale se ne potrebbero aggiungere altre di altri), così Gesù, parlando qui da Messia, si riferisce all’operosità avversaria degli pseudopredicatori messianici che pullularono prima e dopo di lui. [Questo passo della Scrittura, che è Parola di Dio, ci fa comprendere, ancora una volta, quanto sia radicalmente incompatibile il sistema dell’ecumenismo con la fede cattolica: Gesù unica via di salvezza, la Chiesa unica Istituzione salvifica; non più divinità, non più chiese, non più religioni, ndR - Cliccare qui per approfondimenti]. Flavio Giuseppe, che li conobbe di persona, descrive coloro che predicarono sotto il procuratore Antonio Felice (52-60 dopo Cristo) con queste parole: «Uomini ingannatori e impostori, che sotto apparenza d’ispirazione divina operavano innovazioni e sconvolgimenti; inducevano essi la folla ad atti di fanatismo religioso, e la conducevano fuori nel deserto, come se là Dio avesse mostrato loro i segni della libertà (imminente)» (Guerra giud., II, 259). Riferendosi, poi, al tempo dell’assedio di Gerusalemme, lo stesso testimone oculare afferma: «Molti, del resto, erano allora i profeti che... andavano intimando d’aspettare il soccorso da parte di Dio... Cosicché il misero popolo fu allora illuso da ciarlatani e da quei che parlavano falsamente a nome di Dio» (ivi, VI, 286-288). Ma la cancrena era vecchia, e se scoppiò in pieno ai tempi qui accennati da Flavio Giuseppe, raccogliamo dallo stesso storico che essa covava da molto tempo prima; e che ai tempi di Gesù aveva invaso già largamente la plebe giudaica. Questi sono i «ladri e i rapinatori» biasimati da Gesù, come ai diretti e immediati avversari di lui Messia; se poi afferma che «le pecore non li udirono», si riferisce alla parte buona e sana del popolo, che del resto ai suoi tempi era ancora la parte numericamente maggiore, mentre in seguito andò sempre scemando.
• § 434. Insistendo ancora nel paragone dell’ovile, Gesù continuò: «Io sono il pastore, quello buono. Il pastore, quello buono, rimette la sua vita per le pecore. Il mercenario e che non è pastore, di cui non sono proprie le pecore, vede il lupo che viene, e lascia le pecore e fugge - e il lupo le rapisce e disperde - perché è mercenario e non gl’importa delle pecore. Io sono il pastore, quello buono, e conosco le mie e conoscono me le mie, come conosce me il Padre ed io conosco il Padre: e la mia vita rimetto per le pecore. Ho pure altre pecore, che non sono di questo ovile; anche quelle devo io condurre, e la mia voce udranno, e si farà un solo gregge e un solo pastore». Gesù dunque, da vero pastore e non da mercenario, è pronto a perdere la vita per il bene dei suoi seguaci. Inoltre, egli è pastore non soltanto di questo ovile dell’eletto popolo israelitico, ma anche di altre pecore le quali un giorno udranno la sua voce: si formerà allora un solo gregge di suoi seguaci, tratti indifferentemente dal popolo d’Israele e da altri popoli, e il nuovo gregge collettivo avrà per comune pastore il Messia Gesù. Già gli antichi Profeti, trattando dei tempi del futuro Messia, avevano contemplato questo slargamento del ristretto ovile d’Israele entro cui sarebbero entrate pecore di altri ovili: «Alla fine dei giorni, sarà stabilito il monte della casa di Jahvè sulla cima dei monti e più elevato delle colline, e affluiranno ad esso tutte le genti e accorreranno popoli molti, dicendo: “Venite, ascendiamo al monte di Jahvè, alla casa del Dio di Giacobbe, affinché c’insegni le sue vie e procediamo sui sentieri di lui: perché da Sion uscirà la legge, e la parola di Jahvè da Gerusalemme!”. Terrà egli giudizio fra le genti, e darà sentenza su popoli molti; ed essi foggeranno le loro spade a zappe, e le loro lance a falci: non alzerà gente contro gente la spada, né impareranno più oltre la guerra» (Isaia, II, 2-4; cfr. Michea, IV, 1-3). Gesù infine concluse: «Per questo il Padre mi ama, perché rimetto la mia vita affinché nuovamente (io) la riprenda. Nessuno la tolse a me, bensì io la rimetto da me stesso. Ho potestà di rimetterla, e ho potestà di riprenderla nuovamente. Questo comando ricevetti dal Padre mio». Anche per queste parole ci fu dissenso tra i Giudei. Molti, e forse i più, le commentavano spregiosamente concludendo: «Ha un demonio ed è pazzo; perché state ad ascoltarlo?». - Altri tuttavia replicavano: «Eh, no! Queste parole non sono da indemoniato! Può forse un demonio aprire gli occhi ai ciechi?» (Giov., X, 19-21). Da «Vita di Gesù Cristo» - Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941, dell’Abate Giuseppe Ricciotti - Riposi in pace! Per studiare la dottrina sui miracoli, quindi per comprendere le differenze fra veri e falsi miracoli, consiglio lo studio del libro «Racconti miracolosi» del P. Giacinto da Belmonte, pubblicato nel 2018 dalla nostra piccola casa editrice.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, Dio benedica tutti voi. Oggi ricorderemo la vicenda del cieco nato ed useremo, come d’abitudine, l’ottimo commento dell’Abate Ricciotti. Perché usiamo il defunto Giuseppe Ricciotti e non un qualsiasi moderno commentatore? Perché gli autori contemporanei, in quanto modernisti, non hanno la fede cattolica e, dunque, sono pestilenziali e cripto-atei anche nell’esegesi della Scrittura. Ordinariamente i loro commentari, sebbene presentati con eleganza di stile e con una certa parvenza di sapienza, in realtà nascondono molte insidie. I modernisti, difatti, adottano un sistema intellettualmente disonesto e poggiano le loro elucubrazioni non sulla verità, bensì su conclusioni preconcette. Dunque essi non commentano la Scrittura alla luce dei fatti, ma si concentrano sull’adulterazione di questi fatti in ragione delle loro errate filosofie e credenze. È evidente, per esempio, che un sostenitore dell’ecumenismo non potrà mai veramente credere nella divinità di Cristo, quindi userà una serie di artifizi e sofismi per adeguare a questo delirio personale i passi della Scrittura, pur non dichiarandosimiscredente. Come si può credere nella divinità di Gesù Cristo e, nel contempo, nella divinità degli “dei” delle false religioni, che l’ecumenismo ritiene pari vie di salvezza? Non è possibile, dunque bisogna mentire; ed è proprio quello che fanno i moderni. Chi è il padre della menzogna? Il demonio; ed è proprio il demonio che li ispira. Teniamoli alla larga da noi, dai nostri figli e parenti, mentre teniamoci stretti i compianti Giuseppe Ricciotti, Marco Sales, Salvatore Garofalo, Francesco Spadafora e gli altri venerandi esegeti e biblisti.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, Dio benedica tutti voi. Oggi ricorderemo la vicenda del cieco nato ed useremo, come d’abitudine, l’ottimo commento dell’Abate Ricciotti. Perché usiamo il defunto Giuseppe Ricciotti e non un qualsiasi moderno commentatore? Perché gli autori contemporanei, in quanto modernisti, non hanno la fede cattolica e, dunque, sono pestilenziali e cripto-atei anche nell’esegesi della Scrittura. Ordinariamente i loro commentari, sebbene presentati con eleganza di stile e con una certa parvenza di sapienza, in realtà nascondono molte insidie. I modernisti, difatti, adottano un sistema intellettualmente disonesto e poggiano le loro elucubrazioni non sulla verità, bensì su conclusioni preconcette. Dunque essi non commentano la Scrittura alla luce dei fatti, ma si concentrano sull’adulterazione di questi fatti in ragione delle loro errate filosofie e credenze. È evidente, per esempio, che un sostenitore dell’ecumenismo non potrà mai veramente credere nella divinità di Cristo, quindi userà una serie di artifizi e sofismi per adeguare a questo delirio personale i passi della Scrittura, pur non dichiarandosimiscredente. Come si può credere nella divinità di Gesù Cristo e, nel contempo, nella divinità degli “dei” delle false religioni, che l’ecumenismo ritiene pari vie di salvezza? Non è possibile, dunque bisogna mentire; ed è proprio quello che fanno i moderni. Chi è il padre della menzogna? Il demonio; ed è proprio il demonio che li ispira. Teniamoli alla larga da noi, dai nostri figli e parenti, mentre teniamoci stretti i compianti Giuseppe Ricciotti, Marco Sales, Salvatore Garofalo, Francesco Spadafora e gli altri venerandi esegeti e biblisti.
• § 428. Dopo il discorso sulla luce spirituale, terminato senza effetto e col tentativo di lapidazione, San Giovanni narra immediatamente una diffusione di luce materiale che ottiene il suo effetto, ossia la guarigione del cieco nato: il fatto dovette avvenire un poco più tardi, quando la festa dei Tabernacoli era finita da qualche tempo e il bollore degli animi si era calmato alquanto. Un giorno, di sabbato, Gesù passò vicino a un uomo cieco dalla nascita che chiedeva l’elemosina, forse nei pressi del Tempio. Riflettendo su quell’infelice, i discepoli che accompagnavano Gesù gli domandarono: «Rabbi, chi peccò, costui o i suoi genitori, perché nascesse cieco?». Si scorge in questa domanda la vecchia opinione ebraica, secondo cui il male fisico era sempre conseguenza e punizione del male morale: opinione già dimostrata fallace dal nobilissimo autore del Libro di Giobbe, eppure tenacemente prolungatasi presso dotti e indotti. Gesù respinse l’opinione dicendo che né quell’infelice né i suoi genitori avevano peccato, e che quel caso singolo era stato permesso affinché si manifestassero le opere di Dio: «Fin quando (io) sia nel mondo, luce sono del mondo» (Giov., 9, 5). Detto ciò, Gesù sputò in terra, fece con lo sputo un po’ di fango, mise quel fango sugli occhi del cieco, e poi gli disse: «Va’, lavati nella piscina del Siloam». - Quello andò, si lavò, e tornò che vedeva. L’Evangelista spirituale (San Giovanni, ndR), appena ha scritto il nome di Siloam, vi aggiunge una glossa di sapore mistico, avvertendo che quel nome si traduce in «Inviato». E in realtà il greco Siloam sta per l’ebraico Shiloah: questo era il nome dato originariamente al canale sotterraneo che raccoglieva le acque della fonte di Gihon (§ 384) convogliandole e introducendole dentro la città; in virtù di tale funzione al canale era stato dato il suddetto nome col significato di inviante (il liquido), o anche di (liquido) inviato, e dal canale il nome si era esteso naturalmente anche alla piscina in cui il canale terminava [Canale scavato dal Re Ezechia verso l’anno 701 avanti Cristo]. Era la piscina del Siloe (§ 76). L’Evangelista spirituale, che ha parlato dell’acqua simbolica convogliata sul mondo da Gesù, ripensa volentieri a lui come a soprannaturale liquido inviato; in quel liquido deve lavarsi l’intero genere umano privo di luce, come il cieco nato si lavò nella piscina del Siloe, e in ambedue i casi il risultato sarà il medesimo.
• § 429. Avvenuta la guarigione, seguono le inevitabili discussioni, perché il guarito era un mendicante di mestiere, notissimo a tutta la città e tutti sapevano ch’era nato cieco, mentre adesso vedeva. Perciò alcuni dicevano: «È proprio lui!». - Altri invece: «Macché! È uno che rassomiglia al cieco!». - Il guarito, interpellato, rispondeva: «Ma no, sono proprio io, il mendicante nato cieco!». - Gli altri allora: «E come ti si sono aperti gli occhi?». - E quello, con semplicità: «Eh! Quel tale che si chiama Gesù ha fatto un po’ di fango; me l’ha messo sugli occhi; mi ha detto: “Va’, lavati al Siloam”; ci sono andato; mi sono lavato; ho veduto. Ecco tutto!». - Per approfondire l’indagine bisognava interpellare Gesù stesso. - «Dov’è andato?», domandarono al guarito. Quello rispose che non lo sapeva. Il caso era grave, sia per il fatto in sé, sia perché il tutto era avvenuto di sabbato; perciò il guarito fu condotto ai Farisei. I Farisei ripeterono le stesse domande e ricevettero le stesse risposte. Nessun dubbio era possibile: quell’uomo lì davanti era il cieco nato, e adesso vedeva benissimo. Tuttavia c’era di mezzo il sabbato. Quindi alcuni Farisei sentenziarono: «Quest’uomo non è da Dio, perché non osserva il sabbato!». - E infatti aveva violato il riposo sabbatico, facendo quella ditata di fango che aveva messo sugli occhi del cieco. Ma ci furono altri, un po’ meno farisei, che osservarono: «Ma se fosse un peccatore, come potrebbe fare prodigi di tal genere?». - E i due gruppi dissenzienti cominciarono a discutere fra loro. Si, che il cieco fosse guarito era cosa certa; ma cosa anche più certa era che chi faceva una ditata di fango in giorno di sabbato era un peccatore, un empio, un esecrando, perciò non poteva operare miracoli. [Ricciotti, come sempre, ci espleta le credenze deiFarisei, ndR]. Non c’era via d’uscita. Nell’imbarazzo si volle conoscere, per aver qualche lume, il parere del guarito; gli fu chiesto: «Che pensi tu di quel tale che ti ha aperto gli occhi?». - E quello senz’altro: «Per me, è un profeta!».
• § 430. Male, malissimo. Si stimò necessario fare un passo indietro, e si ritornò sui dubbi, già scartati, riguardo all’identità del guarito. Si mandarono a chiamare i genitori di lui: «Costui è proprio il figlio vostro? È proprio nato cieco? E come va che adesso ci vede?». - I due vecchi, intimoriti da quell’accolta d’illustri dottori, si ripararono dietro alla realtà dei fatti, declinando ogni responsabilità loro personale: «Che questo sia il figlio nostro è certo, ed è pure certo ch’è nato cieco; ma come sia che adesso ci veda, o chi gli abbia aperto gli occhi, noi non ne sappiamo nulla. Interrogate lui stesso! Ha l’età: (egli) è maggiorenne; risponda egli stesso dei casi suoi!». Riferita questa risposta, l’Evangelista avverte: «Ciò dissero i genitori di lui perché avevano paura dei Giudei; già infatti si erano accordati i Giudei che, se alcuno lo riconoscesse (come) Cristo (Messia), fosse espulso dalla sinagoga». I vecchi sagacemente avevano evitato il pericolo, e da essi non si poteva cavare nulla di decisivo. Gl’inquisitori allora tornarono di nuovo alla carica sul figlio. Presero perciò un tono esortativo e confidenziale; commovendosi, il cieco avrebbe forse “cantato”: «Su dunque! Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo benissimo che questo tale è un peccatore. Dicci con schiettezza come sono andate le cose!». - Quello rispose: «Se sia peccatore o no, io non lo so; so unicamente che prima ero cieco, e adesso ci vedo!». - E quegli altri: «Ma che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» - Il guarito, che si serviva la prima volta degli occhi per contemplare quegli inquisitori, mentre forse avrebbe preferito andar fuori ad ammirare visioni più piacevoli, cominciò a perdere la pazienza: «Ma ve l’ho già raccontato! Perché volete sentirlo di nuovo? Volete forse anche voi diventare discepoli di Gesù?». - Apriti cielo! Un diluvio di maledizioni e d’improperi cadde addosso all’impertinente che aveva fatto l’ironica domanda, e fu ritorta su lui l’obbrobriosa insinuazione: «Tu sei discepolo di quel tale; noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Iddio; costui invece non sappiamo donde sia» (§ 419). - Ma l’investito non si lasciò abbattere, e replicò impavido: «Ma appunto qui sta la stranezza, che voi non sapete donde egli sia, e quello invece mi ha aperto gli occhi. È certissimo che Dio ascolta, non già i peccatori, ma i giusti e i pii; come pure, dacché mondo è mondo, nessuno ha mai potuto fare quello che ha fatto!». - Quale irriverenza! Ai più insigni rappresentanti della “tradizione” e della sapienza giudaica pretendeva insegnare quel cialtrone tracotante, generato per di più nella colpa come la sua cecità aveva dimostrato! Gli fu perciò risposto sdegnosamente: «Sei nato tutto intero nel peccato, e vieni a insegnare a noialtri? Fuori di qua!». - E fu messo alla porta. Lo scacciato incontrò poco dopo Gesù, che gli disse: «Credi tu nel figlio dell’uomo (variante: di Dio)»? Il guarito rispose: «E chi è, Signore, affinché io creda in lui?». Gesù soggiunse: «E lo hai visto (alludendo alla guarigione ottenuta), e colui che ti parla è (appunto) esso». Allora il guarito esclamò: «Credo, Signore!», e si prostrò davanti a lui. Gesù soggiunse: «Per una cernita venni io in questo mondo, (ciò) affinché i non vedenti vedano e i vedenti diventino ciechi». Essendosi nel frattempo avvicinati alcuni Farisei, udirono le ultime parole e le interpretarono come allusione a loro stessi; chiesero perciò a Gesù: «Siamo forse ciechi anche noi?». Gesù rispose: «Se foste (soltanto) ciechi, peccato non avreste; ora invece dite “Vediamo!”, (e perciò) il vostro peccato permane». In altre parole, la cecità è generale, ma si può guarire da essa soltanto se si comincia col riconoscere di esserne affetti, mentre non ne guarirà giammai colui che s’illude di vedere; questa illusione è più dannosa della cecità stessa, perché è il suo settemplice sigillo.
• § 431. L’irriducibile tenacia dei Giudei nel non riconoscere la guarigione del cieco nato è di una storicità perfetta, ed è anche un fenomeno storicamente regolarissimo. Questi Farisei troneggiavano su certi loro piloni che non dovevano mai crollare, anche se tutto il resto del mondo fosse crollato: l’osservanza farisaica del sabbato, l’appartenenza all’associazione farisaica, e cose simili, erano i loro piloni, dall’alto dei quali essi giudicavano l’universo intero, approvando ciò che rafforzava i piloni e riprovando ciò che li indeboliva. Citano essi al loro tribunale il cieco guarito e i suoi genitori, investigano sulle testimonianze, almanaccano scappatoie, senza però ottenere la spiegazione desiderata. Non fa niente: si lasci crollare tutto il resto, ma rimangano i piloni. Ebbene, confrontando serenamente i fatti, lo storico odierno trova che dopo tanti secoli una certa parte dell’umanità ha cambiato ben poco nei suoi procedimenti riguardo ai dati della vita di Gesù: ha cambiato soltanto i nomi, ma i procedimenti sono rimasti in sostanza gli stessi. Quei piloni incrollabili che una volta si chiamavano osservanza del sabbato, e simili, oggi si chiamano assurdità del miracolo, impossibilità del soprannaturale, e simili: ma i piloni, agli effetti pratici, sono sempre gli stessi. Si citano al tribunale del razionalismo i vari documenti, s’investigano le testimonianze, si almanaccano teorie, senza però ottenere la spiegazione desiderata, anzi ottenendo un Gesù sempre più soprannaturale (§ 221 segg.). Non fa niente: si lasci crollare tutto il resto - [dicono i moderni] - ma rimangano i piloni. E così rimane la cecità, col suo settemplice sigillo. Da «Vita di Gesù Cristo» - Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941, dell’Abate Giuseppe Ricciotti - Riposi in pace!

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, oggi l’Abate Ricciotti ci erudirà sulla vicenda della «donna adultera», accentuando quegl’insegnamenti dottrinali e morali che dobbiamo fare nostri.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, oggi l’Abate Ricciotti ci erudirà sulla vicenda della «donna adultera», accentuando quegl’insegnamenti dottrinali e morali che dobbiamo fare nostri.
• § 424. Egualmente in occasione della Festa dei Tabernacoli è riportato l’episodio della «donna adultera», che è collocato precisamente dopo il discorso dell’acqua simbolica e prima del discorso della luce simbolica (Giovanni, 8, 3-11). Ma sull’episodio grava la famosa questione della sua trasmissione, che sorge dai fatti seguenti. Il racconto dell’episodio manca nei più antichi codici greci ufficiali (salvo nel dibattuto codice D, del secolo VI) e in molti minuscoli, come pure nelle antiche versioni siriaca, copta, armena, e nei codici più autorevoli della versione latina pre-geronimiana. Fra gli antichi scrittori cristiani tacciono dell’episodio i Greci tutti quanti fino al secolo XI; lo ignorano anche i Latini più antichi, quali Tertulliano, Cipriano e Ilario, mentre sulla fine del secolo IV e nel V lo conoscono Paciano di Barcellona, Ambrogio, Agostino, e in seguito altri sempre più numerosi. Altri codici greci, sia ufficiali sia specialmente minuscoli, o lasciano uno spazio nel luogo ove andrebbe il racconto dell’episodio, oppure riportano il racconto ma notandolo con un asterisco (che segnalava i passi aggiunti posteriormente e controversi). I codici stessi che riportano il racconto contengono una quantità eccezionale di varianti testuali, fenomeno ordinario di passi dibattuti. Si è anche notato che il racconto, mentre contiene espressioni linguistiche estranee allo stile abituale di San Giovanni e affini invece a quello dei Sinottici, interrompe la concatenazione logica fra i due discorsi dell’acqua simbolica e della luce simbolica; e questa brusca interruzione sembra che fosse notata già nell’antichità, giacché un codice greco colloca il racconto non al suo posto solito ma dopo Giov., 7, 36, qualche altro lo relega in fondo al IV Vangelo (dopo 21, 24), e infine quattro particolari codici (gruppo Ferrar) lo trasferiscono ad altro Vangelo collocandolo dopo Luca, 21, 38. Riportano invece il racconto sei ufficiali greci meno antichi (oltre al suddetto D) e molti minuscoli; lo hanno anche parecchi codici della versione latina pre-geronimiana, quelli della Vulgata, dell’etiopica e alcuni recenti di altre versioni. D’altra parte, come risulta con buona probabilità da una notizia di Eusebio (Hist. eccl., III, 39, 17), sembra che l’episodio fosse già noto a Papia (§ 114) cioè già divulgato nel primo ventennio del secolo II.
• § 425. Come risolvere la questione? L’assenza del racconto è dovuta a una soppressione, oppure la sua presenza è dovuta a un’aggiunta? La prima alternativa è scelta da Sant’Agostino (De coniug. adult., II, 7, 6); egli pensa che il racconto sia stato soppresso nei codici da uomini di poca fede, i quali temevano «peccandi impunitatem dari mulieribus suis». Senonché tale ragione, più psicologica che storica, non convince: in primo luogo perché, come osserva lo stesso Sant’Agostino, non fu dato nessun permesso di peccare da quel Gesù «qui dixit: Iam deinceps noli peccare»; inoltre perché storicamente non è verosimile che semplici fedeli, laici e ammogliati, avessero tanta autorità nella Chiesa dei primi secoli da far sopprimere nelle sacre Scritture un passo di tanta ampiezza ed importanza: troppo gelosa era la Chiesa nel preservare intatte le sacre Scritture sia da interpolazioni in più, sia da soppressioni in meno. Del resto, come e quando si sarebbe potuta effettuare una soppressione così radicale, che avrebbe cancellato ogni traccia del racconto da tutti i codici originali fino a mezzo il secolo IV? D’altra parte gli argomenti in favore del racconto hanno il loro innegabile peso; esso è riconosciuto addirittura da critici radicali, che considerano l’episodio come porzione antichissima della tradizione evangelica (es. Loisy), o come perla perduta dell’antica tradizione e casualmente ricuperata (es. Heitmüller). Altrettanto dicono i più autorevoli studiosi cattolici, per i quali naturalmente il racconto è ispirato e fa parte delle sacre Scritture canoniche; fra essi appunto un editore neotestamentario conclude la sua ricerca dicendo che, nel testo del IV Vangelo, il racconto dell’adultera è evidentemente una parte aggiunta ... sebbene la sua alta antichità sia indiscutibile: perciò il racconto dev’essere annoverato fra le più preziose perle della tradizione; ma quale sia la prima origine del passo e come esso abbia trovato la strada per entrare nel Vangelo di San Giovanni, è questione che rimane totalmente insoluta (Vogels). Proviene il racconto dal testo aramaico di San Matteo (§ 114)? Sarebbe forse una noticina solitaria vergata dallo stilo di San Luca? In favore di quest’ultima congettura deporrebbe il carattere del racconto, che è tutto di una misericordia infinita e ben degno dello scriba mansuetudinis Christi (§ 138). Ma dal punto di vista documentario dobbiamo confessare, purtroppo, la nostra ignoranza.
• § 426. Un giorno dunque, forse durante l’ottava dei Tabernacoli, Gesù, dopo aver passato la notte sul prediletto monte degli Olivi, di buon mattino ne scese, attraversò il Cedron, risalì ad occidente ed entrò nel Tempio: ivi il popolo accorse a lui nell’atrio esterno, ed egli sedutosi cominciò ad insegnare. Ad un certo punto irrompe nell’atrio un gruppo di Scribi e Farisei seguiti da un codazzo di gente; guardando essi torno torno nell’atrio, e scorto il cerchio di coloro che ascoltano Gesù vanno direttamente verso quella parte. Giunti, si aprono un varco tra la folla interrompendo la predica; di tra il codazzo che segue Scribi e Farisei si fanno avanti due o tre uomini che trascinano a forza una donna riluttante, e con un ultimo spintone la cacciano nello spazio rimasto vuoto davanti all’oratore; la donna, scarmigliata e coprendosi con le mani il viso per la vergogna, si accascia là a terra come un ciarpame di stracci. Gli Scribi e i Farisei spiegano allora a Gesù di che si tratta. Quella là è una donna sorpresa in flagrante adulterio: il complice, come per lo più succede (Daniele, 13, 39), pare che sia riuscito a fuggire, ma la donna è stata presa; ella non può negare la flagranza del delitto, e quindi dev’esser punita secondo la Legge. Ora, Mosè nella Legge ha comandato che siffatte donne siano lapidate (Deuteronomio, 22, 23 segg.; cfr. Levitico, 20, 10). Che ne pensa, dunque, il maestro? Come bisognerà comportarsi con questa delinquente? Dopo tale scena l’Evangelista avverte: «Dicevano questo per metterlo alla prova [per mettere Gesù alla prova], onde avere (di che) accusarlo». Era quanto potevamo immaginarci, anche indipendentemente dall’avviso dell’Evangelista. L’occasione, senza dubbio, era eccellente per quei Farisei. In primo luogo, quell’andare in giro per la città trascinandosi appresso la donna tremante e piangente permetteva ad essi di fare una magnifica figura, come custodi esattissimi della Legge e guardiani zelanti della moralità. Del delitto doveva giudicare il Sinedrio (§ 59); ma che vantaggio ci sarebbe stato a condurre la donna direttamente al Sinedrio senza tanto strepito e clamore? Se tutto si fosse fatto con modesta riservatezza, nessuno avrebbe potuto apprezzare i meriti di loro: [degli Scribi e dei Farisei]. Inoltre, questo spiegamento di forze offriva un’altra opportunità bellissima. C’era quel Rabbi galileo che, con la sua ostentata indipendenza dai grandi maestri della Legge e con la sua crescente autorità sul popolo, meritava bene una lezione pubblica e solenne, e precisamente su una questione di Legge. Il caso di quella donna sembrava fatto apposta per impartirgli questa lezione. Prima di consegnare la colpevole al Sinedrio bisognava sottoporre il caso a lui, come per averne un parere: si doveva lapidare o no quell’adultera? Se egli avesse risposto di no, si sarebbe svelato da se stesso come un rivoluzionario, sovvertitore dell’ordine pubblico e abolitore della Legge mosaica [e Gesù non era né un becero rivoluzionario, né un sovvertitore dell’ordine]. Se avesse risposto di essere inesorabili ed eseguire la lapidazione, avrebbe perduto quella sua autorità sul popolo, che gli era conciliata specialmente dai suoi precetti di misericordia e di bontà. L’occasione, dunque, era davvero bellissima; i Farisei la colsero, e dettero battaglia a Gesù.
• § 427. La battaglia fu accettata Gesù. Interrotta ormai la predica, ascoltò l’esposizione del caso, rimanendo tranquillamente assiso come stava prima. Quando gli accusatori dell’adultera ebbero finito, egli non rispose parola; soltanto, come persona che non abbia nulla da fare e cerchi d’ingannare il tempo, si curvò verso terra e si dette a tracciare col dito segni di scrittura sul pavimento. Il suo atteggiamento diceva in sostanza ch’egli non aveva alcuna risposta da comunicare, e che stava ingannando il tempo fino a che la questione fosse finita. Gli accusatori aspettarono alquanto: Gesù seguitava a tracciare svolazzi in terra. Quelli ripeterono l’accusa, rinnovarono la domanda, aspettarono ancora; solo dopo altro tempo Gesù lentamente si rialzò sul busto, girò lo sguardo sugli accusatori, sulla folla, sulla donna, poi disse con semplicità: «Chi di voi è senza peccato, lanci per primo su lei (una) pietra». Detto ciò come la cosa più naturale di questo mondo, si curvò di nuovo verso terra e ricominciò a tracciare svolazzi. Tutto era finito, anzi non avrebbe dovuto neppur cominciare: l’interpellato era e si manteneva estraneo a quella questione, proposta da quegli accusatori, in quelle circostanze; egli preferiva tracciare svolazzi, e se aveva dato quella risposta, lo aveva fatto cedendo alle loro insistenze. Agissero loro: purché si conformassero alla norma da lui data. Ahi, ahi! quella norma li toccava intimamente! Non si trattava di giudicare su un elegante caso giuridico, per stabilire quanti colpi di staffile doveva ricevere il dorso altrui o quanto doveva esser alto il palo a cui si doveva impiccare il corpo altrui; [L’Abate Ricciotti, come suo solito, sta giustamente facendo del sarcasmo sugli assurdi “eleganti casi giuridici” di un certo Giudaismo che poi chiameremo Talmudismo]; ma si trattava di un giudizio intimo, di un tribunale invisibile in cui accusatore e giudice erano tutt’uno, il tribunale della propria coscienza. Sarebbe stato in realtà facilissimo rispondere a quel Rabbi: «Io sono senza peccato, e quindi lancerò per primo una pietra!» - Ma con lui non era prudente scherzare; padrone della natura e scrutatore degli spiriti come si era più volte mostrato, quel Rabbi era capace di ripetere e precisare l’apostrofe dell’antico Daniele ai vecchioni di Susanna (Daniele, 13, 57) e di rispondere lì davanti alla folla: «Sei senza peccato tu, che il giorno tale con la tal donna maritata hai fatto questo, e il giorno tal altro con la tal altra hai fatto quest’altro?!...» - No, no: era troppo pericoloso stuzzicare quel vespaio. Perciò avvenne che quelli, quand’ebbero udito, se ne uscirono uno per uno cominciando dai più anziani (fino agli ultimi), e fu lasciato solo Gesù con la donna che stava in mezzo. Rialzatosi poi Gesù disse a lei: «Donna, dove sono? Nessuno ti condannò?». Quella allora disse: «Nessuno, Signore!». Disse allora Gesù: «Nemmeno io ti condanno. Vai, da questo momento non peccare più!». Colui che era venuto non ad abolire la Legge di Mosè ma a compierla (§ 323), non aveva violato quella Legge e per di più ne aveva raggiunto l’intimo spirito; l’intimo spirito di ogni legge onesta non può essere che distogliere dal male e indirizzare al bene. La giustizia era stata sublimata nella misericordia. Da «Vita di Gesù Cristo» dell’Abate Giuseppe Ricciotti.
• Ricorda Mons. Garofalo, che è molto pungente quel «più anziani», ovvero i primi ad andarsene furono proprio quegli «anziani» che avrebbero dovuto condurre una vita moralmente retta e di esempio: invece, interrogata la loro coscienza, scappano via. L’adultera non fugge perché si sente sicura al cospetto di Gesù. Per concludere, l’esortazione al ravvedimento - «Vai, da questo momento non peccare più!» - dimostra palesemente che Gesù non scusa affatto la donna, tuttavia la perdona: mentre sarebbe stato il solo ad avere il diritto di scagliare la prima pietra. Quante volte il Signore ci ha usato misericordia? E quante volte Egli ci ha risparmiato dalle fiamme eterne dell’inferno non facendoci morire in stato di peccato mortale? Grande è la misericordia di Dio, tuttavia, come insegna Sant’Alfonso, «ne manda più all’inferno la misericordia della giustizia (di Dio)». Cosa intende dire il Santo moralista? Non bisogna irridere Dio e farsi gioco della Sua misericordia seguitando a peccare, non bisogna tornare come cani a rotolarsi nel proprio vomito: prima o poi, la giustizia di Dio ci colpirà!

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, segnaliamo con gioia una delle tante lodevoli iniziative del sito spagnolo Propaganda Católica (Sito - Pagina Facebook). Scrive Albert Navarro di Barcellona, ideatore e gestore del portale: «Inauguramos con esta entrada la nueva serie de artículos sobre Teología Política, a cargo del periodista italiano Carlo Di Pietro, que ofrecemos desde ahora en español para nuestros lectores. Unas reflexiones sobre la política contemporánea a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia». I nostri articoli di Teologia politica saranno, dunque, tradotti in spagnolo e pubblicati qui. Dio benedica Albert ed il suo zelo.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, segnaliamo con gioia una delle tante lodevoli iniziative del sito spagnolo Propaganda Católica (Sito - Pagina Facebook). Scrive Albert Navarro di Barcellona, ideatore e gestore del portale: «Inauguramos con esta entrada la nueva serie de artículos sobre Teología Política, a cargo del periodista italiano Carlo Di Pietro, que ofrecemos desde ahora en español para nuestros lectores. Unas reflexiones sobre la política contemporánea a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia». I nostri articoli di Teologia politica saranno, dunque, tradotti in spagnolo e pubblicati qui. Dio benedica Albert ed il suo zelo.
• Con l’aiuto del compianto Abate Giuseppe Ricciotti, «Vita di Gesù Cristo» anno 1941, il nostro approfondimento di oggi è dedicato al ministero di Gesù nel periodo che va dall’ultima Festa dei Tabernacoli, fino all’ultima Festa della Dedicazione. Riserveremo a questo approfondimento vari editoriali.
• La questione cronologica e geografica. § 413. Finora i tre Evangelisti sinottici hanno camminato su strade abbastanza parallele fra loro: solo San Giovanni, secondo la sua abitudine, si è inoltrato in una particolare direzione che non ignora ma neppure fiancheggia quella dei tre suoi predecessori (§ 165). Senonché a questo punto anche fra i tre Sinottici avviene un distacco: San Matteo e San Marco proseguono verso una direzione che è genericamente comune, ma sono abbandonati da San Luca che piega da un altro lato, mentre San Giovanni continua per la sua via che non è nè quella di Matteo e Marco, né quella di Luca. Soltanto in occasione dell’ultima Pasqua della vita di Gesù, Luca si affiancherà nuovamente a Matteo e Marco; dal canto suo anche Giovanni terrà loro dietro, ma come al solito precisando e integrando. Già sappiamo chè Giovanni si preoccupa soprattutto dell’operosità di Gesù in Gerusalemme e fissa nettamente le date: perciò, anche in questo nuovo periodo, egli offre allo storico elementi di sommo pregio per l’integrità della biografia e per il suo quadro cronologico. A sua volta Luca, in questa sua narrazione ove non è fiancheggiato dagli altri due Sinottici, comunica molti fatti e discorsi del tutto nuovi, pur curandosi poco o nulla di fissare tempi e luoghi. Di qui sorge la questione di collocare in tempi e in luoghi convenienti le cose che Luca narra indipendentemente sia da Matteo e Marco sia anche da Giovanni. Molti studiosi moderni designano convenzionalmente questa narrazione propria al terzo Evangelista come il «viaggio» di Gesù secondo Luca, perché l’intera sezione comincia annunziando un viaggio di Gesù alla volta di Gerusalemme (Luca, 9, 51) e termina con l’ingresso effettivo nella città (19, 28 segg.); il quale ingresso, però, è precisamente il punto in cui Luca si ricongiunge con gli altri Evangelisti, perché è l’ingresso dell’ultima Pasqua. Ma si tratta di un vero «viaggio»?
• § 414. Per rispondere bisogna tener conto di alcuni fatti. In primo luogo, questo «viaggio» sarebbe stato di una lentezza eccezionale, giacché s’inizierebbe al principio dell’autunno per raggiungere la meta solo nella primavera successiva: più che un viaggio, dunque, sarebbe una peregrinazione vaga su zone occasionali e senza una meta urgente. Inoltre, nel racconto di questo «viaggio» si ripete una seconda e una terza volta che Gesù è in cammino verso Gerusalemme (Luca, 13, 22; 17, 11), la quale però non è mai raggiunta; solo alla quarta volta, quando si conferma il proposito di raggiungere la meta (18, 31), questa è effettivamente raggiunta (19, 28 segg.). Ora, perché mai questi ripetuti annunzi, che non sono affatto richiesti dalla chiarezza del discorso e non vi aggiungono nulla di nuovo? Non acquisterebbero invece un preciso significato qualora si considerassero come allusioni a differenti viaggi a Gerusalemme, piuttosto che conferme di un solo «viaggio»? Così infatti si è pensato, facendosi rilevare che l’indipendente Giovanni colloca, appunto, in questo periodo il viaggio per la Festa dei Tabernacoli, quello per la Dedicazione, e quello per l’ultima Pasqua. Tuttavia questa presunta corrispondenza fra i viaggi minori di Luca e quegli espliciti e distinti di Giovanni, oltre ad incontrarsi in talune difficoltà topografiche e cronologiche, sembra avere contro di sé le parole stesse con cui Luca annunzia a principio il suo maggiore «viaggio»: «Avvenne poi, nel compiersi i giorni dell’assunzione di lui (di Gesù), che egli decise stabilmente (a parola: confermò il volto) di andare a Gerusalemme» (Luca, 9, 51). Queste parole indicano chiaramente che il viaggio annunziato si dovrà concludere con la morte di Gesù e la sua successiva assunzione nella gloria; ma anche qui nulla c’induce a ritenere che questa conclusione del viaggio sia cronologica piuttosto che logica, ossia che in questo scorcio della vita di Gesù Luca badi più al succedersi dei giorni che all’imminente prova suprema di Gesù e al successivo trionfo di lui. D’altra parte nel maggiore «viaggio» di Luca troviamo inquadrati fatti e discorsi di Gesù che presso Matteo e Marco sono collocati in altro contesto, cioè durante l’operosità di Gesù in Galilea: e in questa divergenza, se Luca il più delle volte sembra da preferirsi quanto alla serie degli avvenimenti, è ben possibile che qualche rara volta siffatta preferenza sia da concedersi a Matteo e Marco.
• § 415. Tutto considerato, non sembra che sia il caso di parlare di un maggiore «viaggio» di Luca sotto l’aspetto cronologico e grafico. Questo «viaggio» non è che una giustapposizione o composizione letteraria: essa è stata formata con elementi di più viaggi compiuti in questo tempo da Gesù, ed è inoltre accresciuta con vari altri elementi raccolti senza preoccupazioni cronologiche e geografiche ma solo concettuali e logiche (cf. § 378). I viaggi minori di Gesù, che hanno fornito il precipuo materiale a questa narrazione complessiva, possono benissimo essere i viaggi distintamente ricordati da Giovanni; tuttavia Luca, nell’utilizzarne il materiale, non ha preteso stenderne la minuta e distinta cronistoria, ma ha solo mirato a presentare la realtà dei fatti in maniera tale che risultasse un’appropriata conclusione e un degno coronamento alla precedente operosità di Gesù: il quale si avvicina con serena consapevolezza alla prova suprema in Gerusalemme, e superata la prova raggiunge la sua assunzione nella gloria. Questo scopo concettuale e logico, ben più che quello cronistorico e annalistico, era nella mira della catechesi primitiva, e specialmente di quella di San Paolo seguita fedelmente da San Luca (§ 135 segg.).
• Alla festa dei Tabernacoli. § 416. Finiva l’estate dell’anno 29, e con l’autunno si avvicinava la gaia e popolare Festa dei Tabernacoli (§ 76). Se Gesù era stato l’ultima volta a Gerusalemme per la festa della Pentecoste (§ 384), erano circa quattro mesi che mancava dalla città santa: in questo tempo la sua operosità in Galilea aveva trovato pessima corrispondenza, ed egli aveva deciso di allontanarsene. Ma dove andare? La meta gli fu zelantemente suggerita da quei suoi «fratelli» che non credevano in lui (§ 264); essi avevano ben notato i meschini risultati ottenuti dal loro parente dopo tanto affaticarsi nella Galilea, e d’altra parte lo avrebbero visto con loro grande soddisfazione a capo di una fiumana di popolo bene inquadrata e diretta baldanzosamente verso Gerusalemme: là bisognava recarsi per sbalordire quegli insigni dottori con le opere se si volevano risultati decisivi, altro che perdere tempo e sprecare miracoli fra quei montanari della Galilea! Gli dissero, pertanto, i suoi fratelli: «Trasferisciti di qua e va’ nella Giudea, affinché anche i tuoi discepoli (di laggiù) vedano le opere tue che fai. Nessuno, invero, fa alcunché in segreto, e cerca d’essere egli stesso in evidenza. Se fai queste cose, mostra te stesso al mondo!». Neppure, infatti, i fratelli di lui credevano in lui! (Giovanni, 7, 3-5). A Gerusalemme aveva già pensato anche Gesù; ma appunto quel suggerimento dei suoi «fratelli», dettato da tutt’altre considerazioni, servì da momentaneo ostacolo all’attuazione dei suoi piani. Essi pensavano che assai opportuna per una altisonante manifestazione di Gesù era appunto la Festa dei Tabernacoli, alla quale affluivano grandi folle anche da fuori la Palestina; Gesù, invece, pensava che precisamente il pericolo di quella rumorosità era un motivo per respingere il loro consiglio. Cosicché i «fratelli», insieme con gli altri pellegrini Galilei, partirono per Gerusalemme, e Gesù invece rimase ancora in Galilea; tuttavia più tardi, quando le carovane parentali (§ 261) erano già partite, si mosse anch’egli alla volta della città santa non manifestamente ma come in segreto (Giov., 7, 10).
• § 417. L’itinerario scelto da Gesù fu il più breve, quello che scendeva lungo il mezzo della Palestina attraversando la Samaria. I Samaritani, nel loro inveterato rancore, coglievano volentieri l’occasione di questi grandi passaggi di pellegrini israeliti per dar loro fastidi di ogni sorta, non escluse ferite e morte; veramente Gesù nel passato aveva trovato buone accoglienze presso i Samaritani, ma soltanto presso quelli di Sychar (§ 294), e del resto il fatto era avvenuto circa un anno e mezzo prima, cosicché non si poteva fare molto assegnamento su quelle antiche disposizioni amichevoli. Quindi, per premunirsi, egli inviò in precedenza alcuni suoi discepoli che preparassero l’alloggio in un villaggio innominato della zona pericolosa; ma quanto egli aveva temuto avvenne, perché i Samaritani di quel villaggio, conoscendo che si trattava di Galilei diretti a Gerusalemme, non vollero concedere ospitalità. A quest’atto disumano i due fratelli Giacomo e Giovanni, infiammati da baldanzoso zelo, si ricordarono di aver ricevuto da Gesù la potestà di far miracoli per la diffusione del regno di Dio; domandarono perciò a Gesù se acconsentiva a che facessero cadere fuoco dal cielo per incenerire quei ribaldi. Egli invece «rivòltosi, li rimproverò. E andarono in un altro villaggio» (Luca, 9, 55-56, greco). Chissà che questo altro villaggio non fosse appunto Sychar?
• § 418. Nel frattempo le prime comitive di Galilei erano giunte a Gerusalemme; i cittadini, memori del fatto del Bezetha avvenuto pochi mesi prima (§ 384), avevano cercato subito se fosse giunto anche Gesù: «Dov’è colui?». E molto bisbiglio era riguardo a lui nelle folle; alcuni dicevano: «È buono»; altri invece dicevano: «Macché! Anzi inganna la folla!». Nessuno, tuttavia, parlava con franchezza a suo riguardo, per paura dei Giudei (Giovanni, 7, 11-13). Questa scena vividamente storica, sebbene dovuta all’Evangelista che si vorrebbe far passare come un astratto allegorista, mostra che la precedente visita di Gesù a Gerusalemme aveva lasciato tracce abbastanza profonde, suscitando consensi e dissensi. Improvvisamente, quando gli otto giorni dei Tabernacoli erano per metà passati, si seppe che Gesù era giunto e si era messo ad insegnare nell’atrio del Tempio (§ 48). Accorsero ammiratori e detrattori; tutti indistintamente riconoscevano l’efficacia del suo parlare. Ma i detrattori cominciarono subito con una questione pregiudiziale. Non poteva esser veramente dotto e sapiente, se non chi aveva frequentato le scuole dei grandi Rabbi e Scribi ed era stato ammaestrato secondo i loro metodi; perciò quei tali si domandavano diffidenti: «Come sa costui di lettere, non essendo stato ammaestrato?». C’era ben da diffidare di quell’autodidatta, che in materia religiosa osava staccarsi dalla «tradizione». Gesù rispose: «La mia dottrina non è mia ma di chi m’inviò. Se alcuno voglia fare la volontà di lui, conoscerà riguardo alla dottrina se è da Dio, oppure (se) io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso, cerca la gloria propria; chi invece cerca la gloria di chi l’inviò, costui è verace e ingiustizia in lui non è. Non vi dette forse Mosè la Legge, e(ppure) nessuno di voi pratica la Legge? Perché cercate d’uccidermi?». Rispose la folla: «Hai un demonio! (§ 340). Chi cerca d’ucciderti?». Rispose Gesù e disse loro: «Un’unica opera feci e tutti ammirate. Per questo Mosè vi dette la circoncisione - non che (essa) sia (istituita) da Mosè; ma dai padri - e in sabbato circoncidete un uomo. Se un uomo riceve la circoncisione in sabbato affinché non sia abolita la Legge di Mosè, vi sdegnate con me perché feci sano un uomo intero in sabbato? Non giudicate secondo apparenza, bensì con giusto giudizio giudicate!» (Giov., 7, 15-24).
• § 419. La discussione si riferiva alla guarigione del Bezetha e alle obiezioni fattele dai Farisei. Gesù, senza tornar sopra alle diatribe rabbiniche né replicare all’ingiuria di avere un demonio, cerca di far penetrare i suoi contraddittori più addentro nel significato vero della Legge mosaica. E la disputa continuò; tanto che alcuni di Gerusalemme, ben sapendo qual vento spirasse in città, si chiedevano: «Non è costui quello che vogliono uccidere?. Eppure, ecco che parla in pubblico e non gli dicono nulla! Avrebbero forse i nostri maggiorenti riconosciuto che egli è proprio il Messia? Ma noi sappiamo donde è costui, mentre quando verrà il Messia nessuno conosce donde sia!». - Era infatti opinione diffusa che il Messia doveva sì essere un discendente di David e nascere a Bethlehem (§ 254), ma anche che sarebbe comparso inaspettatamente dopo essersi trattenuto per lungo tempo in un luogo a tutti sconosciuto: in assoluto ritiro; di Gesù, invece, si sapeva benissimo il luogo abituale di dimora, e perciò egli non poteva essere il Messia. Gesù quindi rispose appellandosi ancora una volta alla sua propria origine preterrena e all’autorità di chi l’aveva inviato. «E me sapete, e donde sono sapete. E(ppure) da me non sono venuto, bensì è vero colui che m’inviò che voi non sapete. Io (invece) so lui, perché da lui sono ed egli inviò me» (Giov., 7, 28-29). Queste parole furono pronunziate da Gesù ad alta voce, come dichiarazione solenne. Come tale fu intesa dai suoi avversari, i quali la interpretarono - e interpretarono giustamente - come una dichiarazione di esistenza preterrena e divina; senonché tale dichiarazione era per essi blasfema, e perciò quegli scandalizzati scattarono e cercarono d’attuare subito l’antico progetto d’impadronirsi di Gesù. «Ma ancora non era venuta l’ora di lui» - osserva l’Evangelista spirituale - cosicché nessuno gli mise le mani addosso. Gli avversari, infatti, erano controbilanciati dagli ammiratori, anzi questi ultimi presero animo, nonostante il vento infido, ed entrando in discussione fecero osservare: «Quando il Messia verrà, opererà forse più miracoli di costui?». Questa risposta era un richiamo alla precisa realtà. L’argomento dei miracoli, ch’era perentorio e perciò bersagliatissimo venti secoli fa non meno di oggi, ottenne buon effetto e molti credettero in lui. Tuttavia gli avversari, che volevano impadronirsi di Gesù, non si rassegnarono, e ricorsero ai magistrati del Tempio affinché procedessero a un regolare arresto; ma l’atteggiamento risoluto degli ammiratori di Gesù dovette sconsigliare di procedere a un’azione così pericolosa, potendo seguirne uno di quei tumulti che troppo spesso sorgevano negli atrii del Tempio. E mentre le guardie ronzavano attorno a Gesù, egli ripeteva ai suoi avversari: «Ancora breve tempo sono con voi, e (poi) vado a colui che m’inviò. Mi cercherete (allora) e non (mi) troverete; e dove sono io, voi non potete venire». Gesù si riferiva ancora alla precedente affermazione della sua origine e provenienza divina; gli avversari, respingendo questa idea, si trovarono davanti ad una allusione imprecisabile e si domandavano fra loro: «Vorrà egli forse recarsi nella Diaspora giudaica all’estero, per ammaestrare là i pagani?».
• § 420. Frattanto, durante l’ottava dei Tabernacoli, si svolgeva ogni giorno la processione che andava ad attingere l’acqua alla fonte di Siloe (§ 76). L’ultimo giorno, ch’era il più solenne, Gesù prese occasione dalla cerimonia e ne fece un’applicazione a sé e alla sua dottrina: «Se alcuno ha sete, (venga) a me e beva!». Di una certa acqua aveva Gesù parlato già alla Samaritana; ma anche nei secoli prima aveva parlato della stessa acqua un profeta, facendo pronunziare a Dio questo lamento: «Due mali ha commesso il popolo mio: abbandonarono me, sorgente d’acqua viva, per scavarsi cisterne screpolate, cisterne che non serbano acqua!» (Geremia, 2, 13) Anche questa volta Gesù aveva parlato ad alta voce in tono di dichiarazione solenne, e la dichiarazione riaccese tra la folla le dispute di pochi giorni prima. Degli ammiratori alcuni affermavano: «Costui è davvero il profeta!». Altri: «È il Messia». - Gli avversari rispondevano: «Macché Messia! Forseché dalla Galilea viene il Messia? Non viene forse da Bethlehem, come discendente di David?». - Le guardie del Tempio tentarono nuovamente d’impadronirsi di Gesù, ma rimasero interdette dalla sua potenza spirituale. Rimproverate dai magistrati e dai Farisei di non averlo arrestato, risposero con semplicità: «Giammai un uomo parlò in tal maniera come parla quest’uomo!» (Giov., 7, 46). I Farisei replicarono sarcastici: «Anche voialtri sareste forse rimasti ingannati da lui? Guardate invece se alcuno dei maggiorenti, o di noi Farisei, ha creduto in lui! Ma questa folla, che non conosce la Legge, è tutta di maledetti!». - I maledetti della folla, che ammiravano Gesù, costituivano l’abominevole «popolo della terra» (§ 40). Alla discussione prese parte anche il cauto Nicodemo, rimasto «fra coloro che sono sospesi» (§ 290). Ebbe egli il coraggio di appellarsi alla legalità osservando: «Forseché la nostra Legge giudica l’uomo, se non l’ha in precedenza ascoltato e non ha conosciuto ciò che fa?». - Ma anche a Nicodemo fu risposto col sarcasmo: «Sei forse pure tu della Galilea? Fa’ ricerche e ti convincerai che dalla Galilea non sorge profeta!». - Lo spirito regionalista dei Giudei faceva da avanguardia allo spirito nazionalista dei Gentili; l’uno e l’altro concorderanno più tardi nel sentenziare che «dalla Galilea non sorge profeta», e pronunzieranno la loro sentenza senza prima ascoltare l’imputato e senza indagare ciò che ha fatto.
• § 421. Un’altra circostanza della festa offrì occasione a Gesù per presentare se stesso e la sua dottrina. Fin dai vespri del primo giorno dei Tabernacoli il popolo accorreva all’atrio esterno del Tempio recando rami di palma, mirto e salice; appena calavano le tenebre, i sacerdoti accendevano grandi lampade appese ad altissimi candelieri, e subito la folla accendeva innumerevoli altri lumi d’ogni genere. Fra questa luminaria si svolgevano festeggiamenti giocondi, in cui tenevano il primo posto danze eseguite nel mezzo dell’atrio, mentre i Leviti, schierati sui gradini dell’atrio interno, cantavano inni sacri: le danze erano eseguite specialmente dai maggiorenti della nazione e dai dottori più famosi, che facevano a gara nel danzare il più a lungo possibile tenendo fiaccole ardenti in mano (Sukkah, V, 1-4; Sukkah babli, 50 a-b, 53 a-b). I bagliori di quella gaia notte rimanevano negli occhi delle folle festanti anche durante l’ottava seguente, e in uno di quei giorni Gesù applicò la cerimonia a se stesso. Qual giorno fosse, non ci viene detto; ma se Giovanni (8, 12-59) colloca questo episodio dopo gli altri della stessa festa, fa ciò probabilmente perché vede in esso un’opportuna preparazione all’episodio successivo del cieco nato, che riceve la luce da Gesù. Un giorno, dunque, trovandosi nell’aula del Tesoro attigua all’«atrio delle donne» (§ 47), Gesù disse ai Giudei: «Io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nella tenebra, bensì avrà la luce della vita». Come prima aveva parlato dell’acqua riferendosi alla cerimonia dei Tabernacoli, così adesso parlava della luce con analogo riferimento. I Farisei gli risposero che nessuno era tenuto a prestargli fede, perché egli rendeva testimonianza a se stesso, e la sua testimonianza non era verace. Ne seguì una disputa in più riprese (cfr. Giov., 8, 20-21 con 8, 30-31), che dovrà essere letta per intero nel testo originale. Le affermazioni fondamentali di Gesù sono le seguenti.
• § 422. La testimonianza di Gesù è garantita dal suo Padre celeste; ma i Giudei non conoscono il Padre, perché non conoscono Gesù. Intanto il tempo stringe: Gesù si allontanerà per sempre dai Giudei, ed essi moriranno ostinati nel peccato di non aver riconosciuto la sua missione. Essi sono dalle cose di giù e del mondo; Gesù è dalle cose di su e non del mondo. A questo punto i Giudei, ironicamente, gli rivolgono la stessa domanda già rivolta a Giovanni il Battista dalla loro ambasceria (§ 277): «Tu chi sei?». Gesù risponde: «In primo luogo, (io sono) ciò che appunto vi sto dicendo»; la frase evita una dichiarazione precisa e netta, la quale invece è aspettata dai Giudei per poter scendere subito a violenze contro Gesù, come di fatto avverrà alla fine della discussione. Eppure - prosegue Gesù - quando i Giudei avranno «innalzato il figlio dell’uomo» allora conosceranno che egli è «il figlio dell’uomo», fedele esecutore della missione ricevuta dal Padre. Questa totale dedizione alla volontà del Padre colpisce molti uditori, i quali credono in lui. Ai nuovi credenti si rivolge poi Gesù, ma subito interloquiscono altri presenti che gli sono rimasti avversi. Accettando gl’insegnamenti di Gesù - dice egli - si ottiene la vera libertà, e questa consiste non già nell’essere discendenti di Abramo bensì nell’affrancamento dal peccato. Chi è vero discendente di Abramo compia le giuste opere di Abramo, e non cerchi di uccidere Gesù inviato dal Padre celeste. Non basta proclamarsi - come fanno gli avversari - figli d’Iddio, bisogna anche amare Gesù ed accettare i suoi insegnamenti, perché egli è «uscito da Iddio» e «inviato da lui»; chi non ascolta le parole di Gesù dimostra d’avere «per padre il diavolo che fu omicida da principio» ed il «padre della menzogna». Se Gesù dice la verità, perché non gli si crede? Chi può convincere lui di peccato? Chi è da Dio, ascolta i detti di Dio; ma per questo gli avversari non ascoltano Gesù, perché non sono da Dio.
• § 423. A questo punto la lotta diviene più serrata. I Giudei risentono dei colpi ricevuti, e reagiscono non con accorgimenti dimostrativi ma con ingiurie. Essi replicarono: «Non diciamo bene noi che tu sei un Samaritano (§§ 4, 417) e hai un demonio?». Gesù rispose: «Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi (invece) mi disonorate. Io al contrario non cerco la mia gloria; v’è chi (la) cerca e (su ciò) giudica. In verità, in verità vi dico, se alcuno abbia custodito la mia parola non vedrà morte in eterno». Gli risposero i Giudei: «Adesso abbiamo conosciuto che hai un demonio! Abramo morì, (così) pure i profeti, e tu dici - Se alcuno abbia custodito la mia parola non gusterà morte in eterno. - Forseché sei tu maggiore del nostro padre Abramo che morì? (Così) pure i profeti morirono. Chi ti fai (da) te stesso?». Gesù rispose: «Se io abbia glorificato me stesso, la mia gloria è niente; v’è il Padre mio che mi glorifica, (quello di) cui voi dite - Dio nostro. - E(ppure) non lo conoscete, mentre io so lui; e qualora (io) dica che non so lui, sarò simile a voi mentitore. Ma (io) so lui, e la parola di lui custodisco. Abramo, il vostro padre, esultò per (desiderio di) vedere il mio giorno, e (lo) vide e (ne) godé». Dissero pertanto i Giudei a lui: «Cinquanta anni ancora non hai, e hai visto Abramo?» (§§ 176,182). Disse loro Gesù: «In verità, in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono». La discussione è finita. Gesù si è proclamato anteriore ad Abramo, e quindi all’intero ebraismo di cui Abramo è il capostipite. O si accetta la sua affermazione, credendo in lui: oppure in contrapposto si proclama che Gesù è posteriore e inferiore all’ebraismo, e quindi sottoposto alle sue leggi. Ora, secondo la Legge ebraica (Levitico, 24, 16), il bestemmiatore deve esser lapidato; perciò i Giudei, secondo i quali Gesù ha bestemmiato proclamandosi preesistente ad Abramo, passano ad applicare la Legge: «Tolsero pertanto delle pietre per lanciar(le) addosso a lui. Ma Gesù si nascose, e uscì dal Tempio».

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Prosegue ... Ultimi giorni in Galilea. § 406. Dopo i precedenti fatti Gesù «s’aggirava per la Galilea, e non voleva che alcuno (lo) sapesse» (Marco, 9, 30); era, dunque, una peregrinazione impiegata soltanto alla formazione spirituale dei discepoli che l’accompagnavano, mentre l’annunzio della buona novella alle turbe non entrava nel suo scopo. Quella formazione richiese ben presto una nuova ammonizione circa la sorte terrena del Messia, per dissipare sempre meglio i sogni di messianismo politico tenacemente albergati in quegli spiriti giudaici: «Il figlio dell’uomo sta per essere consegnato in mano agli uomini, e l’uccideranno, e al terzo giorno risusciterà». Il risultato della nuova ammonizione dimostra quanto fosse necessaria, giacché i discepoli «furono afflitti assai» (Matteo, 17, 22-23), e un altro Evangelista aggiunge che «non capivano questa parola, ed era velata per essi affinché non la percepissero; e temevano d’interrogare lui circa questa parola» (Luca, 9, 45). Più tardi il gruppo s’indirizzò a Cafarnao, e vi giunse mentre i discepoli, un po’ appartati da Gesù, erano tutti infervorati in una seria discussione fra loro (§ 408). Nella borgata l’arrivo fu notato dai gabellieri, i quali s’affrettarono ad accertarsi se Gesù aveva pagato il tributo per il Tempio di Gerusalemme: tutti gli Israeliti adulti erano, infatti, obbligati a pagare annualmente, per la manutenzione del Tempio, mezzo siclo d’argento: ossia due dramme (§ 534). La colletta si faceva ordinariamente prima della Pasqua, ma nelle zone più distanti come la Galilea si protraeva o si suppliva fino a prima della Pentecoste e dei Tabernacoli; essendo stato Gesù assente da Cafarnao da molto tempo, e avvicinandosi la festa dei Tabernacoli, i gabellieri vennero a riscuotere. Si rivolsero essi a Pietro domandandogli: «Il vostro maestro non paga (il) didramma?». E Pietro, con la sua solita foga: Ma certamente: ed entrò nella casa ove stava Gesù per parlargliene. Ma Gesù lo prevenne: «Che te ne pare, Simone? I re della terra da chi percepiscono tasse o censo? Dai loro figli o dagli estranei?». E Pietro rispose: «Dagli estranei». Gesù allora replicò: «Dunque i figli sono esenti!». L’applicazione al caso di Gesù era chiara: Egli era il figlio di Dio, e perciò non era tenuto al tributo per la casa terrena del suo Padre celeste. Tuttavia Gesù continuò: «Ma affinché non li scandalizziamo, andato (tu) al mare getta un amo, e il primo pesce che viene su prendi(lo), e apertagli la bocca troverai uno statere. Prendilo, e dallo ad essi per me e te» (Matteo, 17, 24-27). Lo statere, infatti, equivaleva a un siclo intero, cioè a quattro dramme; così si soddisfaceva ai tributi di Gesù e di Pietro insieme. L’oratore del Discorso della montagna aveva esortato ad imitare gli uccelli del cielo e i gigli del campo, e a non preoccuparsi di cose materiali ma soltanto del regno di Dio e della sua giustizia: là egli aveva predicato a parole, qui commenta con le opere le sue parole dimostrandole sagge, come aveva già fatto nelle due moltiplicazioni dei pani. Forse in quel momento il peculio comune del gruppo degli Apostoli era ridotto a pochi spiccioli; Gesù, senza ricorrere a prestiti, rinvia Simone a quella Provvidenza che fornisce il cibo agli uccelli e il vestito ai gigli, e la Provvidenza avalla l’ipoteca addossata su lei dal Discorso della montagna.
Prosegue ... Ultimi giorni in Galilea. § 406. Dopo i precedenti fatti Gesù «s’aggirava per la Galilea, e non voleva che alcuno (lo) sapesse» (Marco, 9, 30); era, dunque, una peregrinazione impiegata soltanto alla formazione spirituale dei discepoli che l’accompagnavano, mentre l’annunzio della buona novella alle turbe non entrava nel suo scopo. Quella formazione richiese ben presto una nuova ammonizione circa la sorte terrena del Messia, per dissipare sempre meglio i sogni di messianismo politico tenacemente albergati in quegli spiriti giudaici: «Il figlio dell’uomo sta per essere consegnato in mano agli uomini, e l’uccideranno, e al terzo giorno risusciterà». Il risultato della nuova ammonizione dimostra quanto fosse necessaria, giacché i discepoli «furono afflitti assai» (Matteo, 17, 22-23), e un altro Evangelista aggiunge che «non capivano questa parola, ed era velata per essi affinché non la percepissero; e temevano d’interrogare lui circa questa parola» (Luca, 9, 45). Più tardi il gruppo s’indirizzò a Cafarnao, e vi giunse mentre i discepoli, un po’ appartati da Gesù, erano tutti infervorati in una seria discussione fra loro (§ 408). Nella borgata l’arrivo fu notato dai gabellieri, i quali s’affrettarono ad accertarsi se Gesù aveva pagato il tributo per il Tempio di Gerusalemme: tutti gli Israeliti adulti erano, infatti, obbligati a pagare annualmente, per la manutenzione del Tempio, mezzo siclo d’argento: ossia due dramme (§ 534). La colletta si faceva ordinariamente prima della Pasqua, ma nelle zone più distanti come la Galilea si protraeva o si suppliva fino a prima della Pentecoste e dei Tabernacoli; essendo stato Gesù assente da Cafarnao da molto tempo, e avvicinandosi la festa dei Tabernacoli, i gabellieri vennero a riscuotere. Si rivolsero essi a Pietro domandandogli: «Il vostro maestro non paga (il) didramma?». E Pietro, con la sua solita foga: Ma certamente: ed entrò nella casa ove stava Gesù per parlargliene. Ma Gesù lo prevenne: «Che te ne pare, Simone? I re della terra da chi percepiscono tasse o censo? Dai loro figli o dagli estranei?». E Pietro rispose: «Dagli estranei». Gesù allora replicò: «Dunque i figli sono esenti!». L’applicazione al caso di Gesù era chiara: Egli era il figlio di Dio, e perciò non era tenuto al tributo per la casa terrena del suo Padre celeste. Tuttavia Gesù continuò: «Ma affinché non li scandalizziamo, andato (tu) al mare getta un amo, e il primo pesce che viene su prendi(lo), e apertagli la bocca troverai uno statere. Prendilo, e dallo ad essi per me e te» (Matteo, 17, 24-27). Lo statere, infatti, equivaleva a un siclo intero, cioè a quattro dramme; così si soddisfaceva ai tributi di Gesù e di Pietro insieme. L’oratore del Discorso della montagna aveva esortato ad imitare gli uccelli del cielo e i gigli del campo, e a non preoccuparsi di cose materiali ma soltanto del regno di Dio e della sua giustizia: là egli aveva predicato a parole, qui commenta con le opere le sue parole dimostrandole sagge, come aveva già fatto nelle due moltiplicazioni dei pani. Forse in quel momento il peculio comune del gruppo degli Apostoli era ridotto a pochi spiccioli; Gesù, senza ricorrere a prestiti, rinvia Simone a quella Provvidenza che fornisce il cibo agli uccelli e il vestito ai gigli, e la Provvidenza avalla l’ipoteca addossata su lei dal Discorso della montagna.
• § 407. Vivono ancora oggi abbondantissimi nel lago di Tiberiade i pesci del genere dei Chronidi i quali seguono un ciclo d’incubazione singolarissimo, facilmente riscontrabile soprattutto nella specie chiamata Chronis Simonis, volgarmente “pesce di S. Pietro”. La femmina di questo pesce depone fra la vegetazione subacquea le uova, in numero di circa 200; più tardi il maschio raccoglie queste uova fra le sue branchie e specialmente nella sua bocca, conservandole ivi molto tempo, fino a che il ciclo evolutivo sia terminato e i piccoli, raggiunta la lunghezza media di 10 millimetri, possano vivere indipendentemente: questo ufficio d’incubazione ha procurato al maschio anche il nome di Chronis paterfamilias. Nell’ultimo periodo dell’incubazione, quando gli embrioni sono abbastanza sviluppati, la gola del maschio incubatore è divenuta mostruosamente sproporzionata al resto del suo corpo, ed è così rigonfia che assai spesso le mascelle non si rinserrano più. Quando poi è giunto il tempo di mandar via liberi i piccoli, il maschio incubatore ne provoca l’uscita introducendosi nella bocca qualche oggetto che espelle man mano i piccoli e che rimane al loro posto per qualche tempo. Questo oggetto è di solito un ciottolo, ma in sua vece lo stesso servizio potrebbe esser fatto da una moneta, ad esempio da uno statere o siclo antico. Fu questo il caso del pesce pescato da Simone con lo statere in bocca? Non potremmo dirlo; sappiamo soltanto che il moltiplicatore dei pani fece assegnamento sulla Provvidenza anche questa volta, sebbene in altra maniera, e la Provvidenza pagò puntualmente l’ipoteca emessa su di lei dal Discorso della montagna. Dei successivi seguaci di Gesù forse nessuno fece assegnamento sulla banca della Provvidenza più fiduciosamente di San Francesco d’Assisi, e la sua esperienza gli permetteva di dire ch’era una banca puntualissima nei pagamenti. C’è da chiedersi se il figlio di Bernardone non fosse un esegeta più acuto dei moderni critici del Vangelo.
• § 408. L’incarico dato a Pietro si ricollegava in qualche modo con la discussione che i discepoli avevano avuta fra loro quand’erano giunti a Cafarnao; ciò forse apparve dal loro contegno o da qualche frase mozza, cosicché Gesù li interrogò direttamente: «Di che ragionavate per strada?». La domanda li mise in imbarazzo: si vergognavano essi di rispondere, perché oggetto della discussione era stato chi di loro fosse il maggiore nel regno dei cieli. C’era motivo infatti da discutere, non tanto riguardo a Pietro già preferito a Cesarea di Filippo e anche adesso per il pagamento dello statere, quanto riguardo agli altri: ciascuno avrà portato le sue buone ragioni per dimostrare che, quando il maestro si fosse assiso sul suo trono messianico rilucente di ori e tempestato di gemme, il seggio più onorifico e più vicino al trono spettava a sé e non al compagno con cui discuteva. Dopo un breve silenzio di pudore, uno prese coraggio e disse a Gesù di che si era discusso: Chi sarebbe stato il primo? Nell’interpellato parlò nuovamente l’oratore del Discorso della montagna, il capovolgitore. Primo - egli rispose - sarebbe stato l’ultimo di tutti, il servo e lo schiavo di tutti. Proprio in quel momento passa a caso per la stanza un bambino; Gesù lo chiama a sé, lo accarezza, lo mette nel mezzo di quegli uomini maturi, e guardandoli uno per uno in faccia sentenzia: «In verità vi dico, se non vi mutiate e diventiate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli! Chiunque pertanto si abbasserà come questo bambino, costui è il maggiore nel regno dei cieli» (Matteo, 18, 3-4). Proseguendo poi a proposito del bambino preso a modello, Gesù affermò che chi accoglieva nel nome di lui un bambino come quello accoglieva lui stesso, come accogliendo lui si accoglieva il Padre celeste che lo aveva inviato (§ 483). Questa larghezza d’accoglienza non sembrò chiara a Giovanni. Poco prima egli e gli altri Apostoli non avevano accolto, anzi avevano a bella posta ostacolato, un tale che scacciava demonii nel nome di Gesù: poteva certo ammettersi che quel tale si servisse del nome del maestro per esorcizzare, ma in tal caso egli avrebbe dovuto entrare nel gruppo di discepoli e accompagnarsi con loro; siccome però non aveva voluto unirsi, gli Apostoli lo avevano ostacolato. Gesù disapprovò l’agire degli Apostoli; essi non avrebbero dovuto ostacolare quel tale, perché (in quel momento, ndR) chi non era contrario a loro era favorevole a loro (Marco, 9, 38-40).
• § 409. Alla rinfusa, poi, in quei giorni impiegati nella formazione spirituale dei discepoli Gesù impartiva loro altre norme, man mano che se ne presentava l’occasione (Marco, 9, 41 segg., e paralleli): Chi darà un bicchiere d’acqua ai discepoli di Gesù in quanto tali, non rimarrà senza ricompensa. Chi scandalizza uno di coloro, che credendo in Gesù sono ridiventati piccoli come bambini, sarà meglio per lui che legatagli con una corda al collo una mola asinaria sia gettato in mare; a questo servizio si prestava benissimo la mola inferiore (delle due pietre che formavano la macina da grano mossa da asini), la quale pietra era bucata per far scorrere in basso la farina, e attraverso il foro sarebbe passata la corda. Si deve far attenzione a non disprezzare uno dei piccoli in ispirito, perché i loro angeli tutelari contemplano sempre il volto del Padre celeste. Se un fratello ha mancato, sia ripreso in segreto a quattr’occhi: se ascolta, è stato guadagnato un fratello. Se non ascolta, si prendano uno o due testimoni per regolarsi conforme alla prescrizione della Legge mosaica (Deuteronomio, 19, 15-17). Se ancora non ascolta, sia deferito alla Chiesa; e se non ascolta neppure la Chiesa, sia considerato com’è considerato nel giudaismo un pagano e un pubblicano, ossia come un estraneo alla comune vita spirituale. Però quanto gli Apostoli, costituenti la Chiesa, legheranno o scioglieranno sulla terra sarà anche legato o sciolto in cielo (§ 397). Quando due concordino sulla terra a chiedere qualche cosa, sarà loro concessa dal Padre celeste. Poiché dove siano congregati due o tre in nome di Gesù, anche Gesù è in mezzo a loro. La primitiva catechesi, trasmettendoci queste sentenze, mostrò di scorgere in esse le norme che dovevano regolare la vita sociale dei seguaci di Gesù e lo stampo su cui doveva plasmarsi la Chiesa delle prime generazioni. Ma la norma di denunziare il fratello colpevole e pervicace risvegliò nel cervello di Pietro una difficoltà: «Signore, quante volte peccherà contro di me il mio fratello e io gli rimetterò? Fino a sette volte?». Il numero sette era tipico e sacro nel giudaismo, e qui Pietro si mostra ancora magnanimo, giacché nel secolo appresso Rabbi b. Jehuda sentenzierà che Dio perdona fino alla terza volta ma non la quarta (Joma, 86 b, Bar.; allusione ad Amos, 2, 4). Con tutto ciò la magnanimità di Pietro sembra pusillanimità a Gesù, il quale replica: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette!», cifra convenzionale per indicare una quantità illimitata. Secondo Pietro, infatti, il precetto del Discorso della montagna di offrire l’altra guancia a chi dia uno schiaffo doveva valere solo sette volte, e all’ottavo schiaffo il precetto era abolito; invece, secondo l’oratore del Discorso della montagna, l’ottavo schiaffo era sempre il primo e quindi il precetto era sempre valido. E perché mai?
• § 410. Il perché fu spiegato da Gesù con una parabola. C’era un potente re che un bel giorno volle fare il bilancio di cassa, e perciò chiamò alla resa dei conti i suoi ministri. Fra i primi si presentò uno che doveva consegnare ben 10.000 talenti: somma addirittura spaventosa, e specialmente per quei tempi, giacché equivarrebbe a più di 60 milioni di lire in oro (anno 1941, ndR). Il debitore naturalmente non aveva tal somma; e allora il re, per recuperarne almeno una minima parte, ordinò che si vendessero sia il debitore con la moglie e i figli come schiavi, sia tutti i suoi possedimenti. In sostanza, la sentenza era benigna per quei tempi, perché al debitore e ai suoi familiari era lasciata ancora la vita, mentre il re perdeva la massima parte del suo credito. Ma a udire quella decisione il debitore si gettò ai piedi del re, implorando non tanto con la solita teatralità orientale quanto con la sincerità dell’uomo rovinato per sempre: «Sii longanime con me, e ti restituirò ogni cosa!». Il re, ch’era di cuore molto buono, ne ebbe compassione, e senz’altro rimandò libero il debitore rimettendogli l’intero debito. - L’uomo tornava davvero a respirare e ad esser uomo: era scampato dalla schiavitù, e per di più aveva guadagnato ben 10.000 talenti! Senonché, appunto questa fierezza l’accecò. Uscito dalla terribile e fortunata udienza, egli s’imbatté in un suo collega che gli era debitore di cento denari, somma di poco più che 100 lire in oro (ivi.); appena lo vede, gli salta addosso, lo prende per il collo da soffocarlo quasi, e si dà a gridare: «Pagami il tuo debito!». Il povero collega gli si getta ai piedi esclamando: «Sii longanime con me, e ti restituirò!». Ma quello non dette ascolto, e lo fece mettere in prigione fino a che avesse pagato. Il fatto addolorò gli altri impiegati di corte, che lo riferirono al re. Allora il re fece chiamare il debitore graziato e gli disse: «Servo malvagio! Io ti ho rimesso tutto quell’enorme debito perché ti raccomandasti; e non dovevi, dunque, anche tu aver compassione del tuo collega?». E, adiratissimo, il re lo fece consegnare, non già ai soliti carcerieri, ma ai torturatori fino a che non avesse pagato l’intero debito. E Gesù concluse: «Così anche il mio Padre celeste farà con voi, se non rimettiate ciascuno al suo fratello dai vostri cuori». Pare che questa volta gli Apostoli non chiedessero a Gesù la spiegazione della parabola, tanto era chiara. Il re è Dio; la spaventosa somma condonata dal re al ministro sono le mancanze condonate da Dio all’uomo; la trascurabile somma brutalmente richiesta dal collega al collega sono i piccoli torti di uomo ad uomo. Cosicché, ed è questo l’insegnamento conclusivo della parabola, il perdono di Dio all’uomo esige imperiosamente il perdono dell’uomo all’uomo. E quanto Gesù aveva già concluso nel Pater noster: «Rimetti a noi i debiti nostri come anche noi rimettemmo ai nostri debitori».
• § 411. A questo tempo, cominciando dalla Pasqua della prima moltiplicazione dei pani (§ 372), erano trascorsi parecchi mesi e giungeva oramai l’autunno dell’anno 29; dall’inizio del ministero pubblico di Gesù era passato più d’un anno e mezzo, circa una ventina di mesi. Stando ai dati espliciti dei Vangeli, l’operosità di tutti questi mesi era stata impiegata soltanto nella Galilea, salvo il viaggio a Gerusalemme (§ 384) e l’altro viaggio nella Fenicia e a settentrione della Palestina (§ 389). Purtroppo, facendo un bilancio secondo i calcoli umani, risultava un forte deficit nel risultato di quell’operosità. I compaesani di Nazareth avevano decretato l’ostracismo al predicatore della «buona novella» (§ 359). Le borgate presso il lago, che sembravano le preferite da lui, erano accorse attorno al taumaturgo, si, ma per ottener luce ai loro ciechi, udito ai loro sordi, vita ai loro morti, pane ai loro stomachi: quando invece si era trattato di accettare il «cambiamento di mente» e il capovolgimento spirituale richiesti dal taumaturgo, gli accorsi avevano in massima parte rifiutato, e la sementa da lui sparsa era caduta o sui sentieri calpestati o sul pietrame o fra le spine (§ 365). Che cosa era germogliato dalla sua seminatura? Oltre al manipolo dei discepoli - anche questi lontanissimi da una piena maturazione - si potrà ragionevolmente supporre che molto scarsi dovevano essere coloro che in tutta la Galilea aderivano sinceramente alla «buona novella». Umanamente dunque era, o sembrava, un bilancio fallimentare. Gesù lo sentì. Il suo cuore ne fu attristato; tanto più che non c’era tempo per insistere ancora, dovendo egli allontanarsi per tentare altrove. Che cosa avrebbe potuto egli fare nel passato fra quei Galilei, e specialmente fra le borgate prossime al lago, per ottener una messe più abbondante? Nulla. E se la messe era stata scarsissima, il danno non era forse di quelle borgate da lui tanto amate? Cosicché dal suo cuore, uno di quei giorni, eruppe il rimpianto e la deplorazione: «Guai a te Chorozain! Guai a te Bethsaida! Giacché, se in Tiro e Sidone fossero avvenuti i portenti avvenuti in voi, da lungo tempo in sacco e cenere avrebbero fatto penitenza! Sennonché vi dico, per Tiro e Sidone vi sarà più tollerabile (sorte) nel giorno del giudizio che per voi! E tu Cafarnao, forseché fino al cielo sarai innalzata? Fino agli Inferi sarai abbassata! Giacché se in Sodoma fossero avvenuti i portenti avvenuti in te, sussisterebbe fino ad oggi! Senonché vi dico che per la terra di Sodoma vi sarà più tollerabile (sorte) nel giorno del giudizio che per te» (Per questi recenti testimoni increduli ci saranno castighi eterni addirittura peggiori di quelli, già terribili, riservati ai sodomiti, ndR).
• § 412. Delle borgate galilee qui nominate conosciamo bene Bethsaida e Cafarnao; ma Chorozain non appare altrove, ed è ricordata soltanto qui in tutti i Vangeli. Questa inaspettata menzione è altamente istruttiva, perché mostra quanto lacunose siano le informazioni trasmesseci dagli Evangelisti circa i fatti di Gesù; se adesso Gesù nomina Chorozain individualmente per una particolare deplorazione, ciò mostra che nel passato la borgata era stata oggetto di amorevoli cure non meno di Bethsaida e di Cafarnao: eppure di queste cure noi non sappiamo assolutamente nulla. L’Onomastico di Eusebio dice che Chorozain distava due miglia da Cafarnao. Infatti a circa tre chilometri a nord di Cafarnao è il luogo chiamato oggi Keraze (o Kerazie), ove recentemente è stata riportata alla luce l’antica sinagoga costruita di pietra di basalto e con decorazioni analoghe a quelle della sinagoga di Cafarnao (§§ 285, 336): un’iscrizione aramaica conservata ivi nel seggio dell’archisinagogo ricorda per gratitudine un Judan figlio di Ismael, benemerito della costruzione dell’edificio. Oggi, come già ai tempi di Eusebio, tutto il luogo è deserto. In tempi tardivi questa borgata, nominata nei Vangeli soltanto per esser maledetta, attirò la fantasia popolare cristiana la quale, dopo averci riflettuto sopra parecchi secoli, sentenziò che essa sarebbe stata la patria dell’Anticristo.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, mi scuso se non sono riuscito a scrivere, impaginare e pubblicare il nostro periodico per alcune settimane: non era mai accaduto! Posso dedicare all’Associazione solo il sabato e, trattandosi di un’opera di misericordia, anche parte della domenica. Tuttavia il lavoro settimanale è praticamente raddoppiato ed ho avuto bisogno di riposare. Le opere di misericordia, difatti, devono dare frutto anche a chi le compie e non possono assolutamente rappresentare un ostacolo per il regolare e corretto adempimento dei doveri del proprio stato. Grandi Santi ammonivano quei soggetti che trascurano i figli, la casa, la pulizia, il lavoro e gli altri doveri, per dedicarsi esclusivamente alla beneficenza, alle devozioni ed ai pellegrinaggi: mentre il cristiano deve essere, con l’aiuto di Dio e del buon Confessore, una persona responsabile ed equilibrata. La nostra Associazione non si è, però, fermata ed abbiamo realizzato il DVD del «Dizionario di Erudizione Storico-Ecclesiastica» a cura del compianto erudito Cav. Gaetano Moroni. È possibile richiedere questa preziosa raccolta (ben 109 volumi - digitalizzati e riconosciuti in OCR) cliccando qui.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, mi scuso se non sono riuscito a scrivere, impaginare e pubblicare il nostro periodico per alcune settimane: non era mai accaduto! Posso dedicare all’Associazione solo il sabato e, trattandosi di un’opera di misericordia, anche parte della domenica. Tuttavia il lavoro settimanale è praticamente raddoppiato ed ho avuto bisogno di riposare. Le opere di misericordia, difatti, devono dare frutto anche a chi le compie e non possono assolutamente rappresentare un ostacolo per il regolare e corretto adempimento dei doveri del proprio stato. Grandi Santi ammonivano quei soggetti che trascurano i figli, la casa, la pulizia, il lavoro e gli altri doveri, per dedicarsi esclusivamente alla beneficenza, alle devozioni ed ai pellegrinaggi: mentre il cristiano deve essere, con l’aiuto di Dio e del buon Confessore, una persona responsabile ed equilibrata. La nostra Associazione non si è, però, fermata ed abbiamo realizzato il DVD del «Dizionario di Erudizione Storico-Ecclesiastica» a cura del compianto erudito Cav. Gaetano Moroni. È possibile richiedere questa preziosa raccolta (ben 109 volumi - digitalizzati e riconosciuti in OCR) cliccando qui.
Colgo l’occasione per esortare Associati e Sostenitori al rinnovo della quota annuale (cliccare qui), parimenti segnalo il link da usare per inoltrare le nuove richieste di iscrizione all’Associazione (cliccare qui). Sursum Corda è una Onlus che non ha assolutamente scopo di lucro, non fa “falso volontariato”, non distribuisce prebende o stipendi ed usa i fondi raccolti interamente per le attività associative. Il Rendiconto economico annuale è trasparente e consultabile, dagli aventi diritto, in qualsiasi momento nella sezione del sito appositamente realizzata (cliccare qui).
Torniamo ad usare la «Vita di Gesù Cristo» dell’Abate Giuseppe Ricciotti per parlare della Trasfigurazione, dell’indemoniato epilettico e degli ultimi giorni di Gesù in Galilea.
• La Trasfigurazione. § 402. Com’era da aspettarsi, le energiche rettificazioni messianiche depressero l’animo dei discepoli; quei focosi Galilei di pretto sangue giudaico ne rimasero sconcertati e abbattuti. La medicina per rianimarli fu somministrata da Gesù mediante la sua trasfigurazione, avvenuta sei giorni (circa otto giorni, secondo Luca) dopo la manifestazione messianica. La scena è collocata dagli Evangelisti su un monte eccelso, di cui però non ci è trasmesso il nome. Molti studiosi moderni pensano che fosse l’Hermon, la cui cima più elevata raggiunge i 2.759 metri sul Mediterraneo, e che offrirebbe la congruenza di stare immediatamente sopra Cesarea di Filippo dove era avvenuta la manifestazione messianica. Ma, oltreché l’ascesa del monte è faticosa e richiede tra andare e tornare una buona giornata, sta il fatto che si tratta di una congettura del tutto recente: l’antichità, invece, non ha ricollegato la trasfigurazione con l’Hermon, sebbene una provocazione a tale ricollegamento fosse offerta a menti mistiche dal passo del Salmo 89, 13 (ebr.): «Il Tabor e l’Hermon nel nome tuo esulteranno». Al contrario, sul primo di questi due monti si è accentrata una tradizione che risale al secolo IV. Il Tabor non è per noi moderni un monte eccelso, essendo alto 562 metri dal Mediterraneo e 600-620 metri dalle valli circostanti (che sono più basse del Mediterraneo); ma per gli antichi poteva ben passare per un monte assai alto, essendo totalmente isolato e scorgendosi dalla sua cima buona parte della Galilea. Un’altra difficoltà è che la sua cima era forse abitata, e perciò non offriva quella solitudine che sembra richiesta dalla scena della trasfigurazione; ma anche questa difficoltà non è insormontabile: la cima doveva essere abitata in occasioni di torbidi e di guerre, riducendosi facilmente a fortezza come avvenne verso il 218 av. Cr. sotto Antioco III il Grande (cfr. Polibio, V, 70) e al tempo della guerra di Vespasiano quando fu fortificata da Flavio Giuseppe che ne parla a lungo (Guerra giud., IV 54-61); fuor di questi tempi la cima doveva essere in stato d’abbandono, soprattutto perché l’intero monte, oltre ad essere scosceso e sassoso, è assolutamente privo di acqua. Quanto alla distanza del Tabor da Cesarea di Filippo, poteva essere superata senza difficoltà nei 6 (o 8) giorni indicati. - Ovunque poi avvenisse il fatto, esso si svolse in questo modo.
• § 403. Fra i disanimati discepoli Gesù prese con sé i tre prediletti, ossia Pietro e i fratelli Giacomo e Giovanni, e li condusse sul monte. La strada lunga, la salita faticosa, la stagione estiva contribuirono a far si che i viandanti giungessero sul posto assai stanchi: probabilmente giunsero di sera, cosicché i tre discepoli, preparatosi alla meglio un giaciglio, si misero a dormire (Luca, 9, 32): Gesù invece, com’era solito di notte, si mise a pregare (ivi, 29) a breve distanza da loro. A un tratto i visi dei dormienti sono inondati d’una luce vivissima: aprono essi gli occhi, e scorgono Gesù in aspetto tutto diverso dal solito. Stava egli là «trasfigurato davanti a loro, e lampante era il suo viso come il sole, e le sue vesti divenute bianche come la luce» (Matteo, 17, 2). Quando i risvegliati, che erano «aggravati di sonno» (Luca, 9, 32), ebbero adattato alla meglio la vista e l’animo alla folgoreggiante visione, riconobbero presso il trasfigurato anche Mosè ed Elia, i quali parlavano con lui della sua «dipartita, che stava per compiere in Gerusalemme» (Luca, 9, 31). Il discorso fra i tre dura più o meno tempo, e a un certo punto Mosè ed Elia fanno come atto di allontanarsi. Allora il solito Pietro crede opportuno intervenire e dice a Gesù: Rabbi! Noi stiamo bene qui! E possiamo fare tre tende, una a te, una a Mosè e una a Elia!». Il bravo Pietro ripensa forse con rammarico di aver provveduto soltanto al suo proprio giaciglio dopo il faticoso cammino, trascurando quello per Gesù: che adesso si mostra in quell’aspetto e in compagnia di quegli insigni visitatori; ma l’Evangelista interprete di Pietro ha aggiunto subito appresso la vera spiegazione, udita certamente più volte dalla bocca di Pietro: «Non sapeva infatti che cosa dicesse; giacché erano sgomentati» (Marco, 9, 6). Pietro non riceve risposta, perché una luminosa nube li avvolge tutti e nella nube risuona una voce: «Questo è il figlio mio diletto, in cui mi compiaccio qui. Ascoltatelo!». I tre discepoli, ancor più sgomentati, si prosternano con la faccia a terra, ma poco dopo Gesù va verso di loro, li tocca e dice: «Alzatevi, e non temete!». Guardando attorno, essi non vedono più nessuno, salvo Gesù nel suo aspetto abituale. Il giorno appresso, scendendo dal monte, Gesù ordina loro: «Non dite a nessuno la visione, fino a che il figlio dell’uomo sia risuscitato dai morti!».
• § 404. È inutile ricordare che per i razionalisti il racconto della trasfigurazione non ha nulla di storico, ed è o una allucinazione, o una elaborazione mitica, o un simbolo, e simili. Tuttavia un rappresentativo razionalista ne ha esattamente riconosciuto il valore concettuale, affermando che «la trasfigurazione del Cristo si ricollega strettamente, nel quadro sinottico, con l’annunzio della sua passione e della sua resurrezione gloriosa. Essa corregge la prospettiva dei dolori, e prelude al trionfo» (Loisy). È esatto (questa volta il pessimo Loisy non dice solo sciocchezze, ndR), sebbene non del tutto completo: infatti anche la (reale) presenza di Mosè ed Elia, rappresentanti rispettivamente della Legge e dei Profeti, ha un suo particolare valore, volendo dimostrare che la Legge ed i Profeti dell’Antico Testamento hanno per loro ultima mira il Messia Gesù: e ciò corrisponde a quanto Gesù aveva detto nel Discorso della montagna, di non essere venuto «ad abolire la Legge o i Profeti... bensì a compiere» (§ 323). Sotto un certo aspetto, la trasfigurazione di Gesù è anche un contrapposto alla sua tentazione (§ 271 segg.). Più direttamente, è un correttivo all’effetto deprimente che le rettificazioni messianiche avevano prodotto sui discepoli, ma nello stesso tempo è una conferma di quelle rettificazioni. Gesù Messia, anche sfolgorante di luce, parla con Mosè ed Elia della sua dipartita, ossia morte, che sta per occorrergli a Gerusalemme, come se quella morte sia per lui il passaggio necessario onde entrare nella sua gloria manifesta. Quando egli avrà superato quel passaggio e sarà già entrato nella sua gloria, rimprovererà a certi suoi tardi discepoli: «O stolti e lenti di cuore a credere...; non doveva forse patire tali cose il Cristo (Messia), e (così) entrare nella sua gloria?» (§ 630). In tal modo la medicina somministrata fece senza dubbio il suo effetto, rianimando i discepoli, ma insieme moltiplicò in essi talune ansie ed incertezze. Perché quella proibizione di parlare ad altri della visione? E il permesso di parlarne solo dopo che il figlio dell’uomo fosse risuscitato dai morti, a quale avvenimento futuro si riferiva? Si era dunque veramente alla vigilia della palingenesi cosmica e della resurrezione dei morti accennate dalle antiche profezie (Isaia, 26, 19; Ezechiele, 37; Daniele, 12, 1-3)? Ma allora perché Elia non compariva stabilmente - e non fugacemente come nella visione - per disporre i preparativi della grande palingenesi? Con quest’ultima questione cominciarono i discepoli, e chiesero a Gesù: «Perché dunque gli Scribi dicono che Elia deve venire dapprima?» (Matteo, 17, 10). Gesù rispose confermando ma insieme schiarendo: Elia, sì, deve venire a predisporre tutto; ma esso è già venuto, e gli hanno fatto tutto il male che hanno voluto: così anche il figlio dell’uomo dovrà soffrire e ricevere il male da quelli. «Allora i discepoli capirono che di Giovanni il Battista parlò ad essi» (ivi, 13).
• L’indemoniato epilettico. § 405. Scesi alle falde del monte, i quattro raggiunsero ben presto gli altri Apostoli rimasti alla pianura. Trovarono allora che i rimasti, forse in numero di nove, erano circondati da molta gente e da Scribi, con i quali stavano discutendo. Visto Gesù, uno della folla gli si fa innanzi dicendo: Ti ho portato mio figlio, l’unico che io abbia, ch’è posseduto da uno spirito maligno muto; quando se ne impadronisce, lo dilania, ed esso schiuma, digrigna i denti e s’irrigidisce. Ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Questo fallimento aveva forse provocato la discussione con gli Scribi, i quali non avranno mancato di dir la loro parola maligna sui discepoli e anche sul maestro assente. Ma adesso egli è presente, e saputo di che si tratta esclama: «O generazione priva di fede, fino a quando sarò presso di voi? Fino a quando vi sopporterò?». Poi, cercando con lo sguardo il giovanetto: «Portatelo a me! (Marco, 9, 19). La fede era per Gesù condizione essenziale per i miracoli; ed egli ne deplorava la mancanza sia presso gli Scribi e il padre del giovanetto, sia presso gli Apostoli il cui fallimento tradiva in essi una fede fiacca e tentennante. Fino a quando dovrà Gesù sopportare quella mancanza o fiacchezza di fede? Il giovanetto fu portato a Gesù; ma, alla presenza del taumaturgo, fu subito preso da una crisi parossistica, e stramazzò a terra dibattendosi, rantolando e spumando. Durante l’attacco Gesù volle interrogare il padre, non tanto come medico che cerchi di stabilire una diagnosi, quanto per far risaltare agli occhi dei presenti il valore del “segno” che si accingeva a compiere e per indurli a riflettere sulla loro mancanza di fede. «Quanto tempo è che gli successe questo?». Il padre rispose: «Dalla fanciullezza; spesso il maligno spirito lo getta nel fuoco o nell’acqua. Se puoi far qualcosa, vieni in nostro aiuto, avendo pietà di noi!». - Le parole del povero padre tradivano ancora una titubanza di fede, nonostante la deplorazione di Gesù. Perciò Gesù gli disse: «Quanto al “se puoi“, tutto è possibile a chi ha fede!» (Marco, 9, 23, greco). La scena che successe a queste parole, delineata dallo stile di San Marco conforme alle parole di San Pietro, è di una vivezza palpitante. «Subito, gridando, il padre del ragazzetto diceva (con lacrime): “Ho fede! Soccorri alla mia mancanza di fede!”. Vedendo però Gesù che affluisce folla correndo, intimò allo spirito impuro dicendogli: “Spirito muto e sordo, io t’impongo, esci da costui e non entrare mai più in esso!”. E dopo aver gridato e molto sbattuto(lo), (lo spirito) uscì. E (il ragazzetto) diventò come un cadavere, tanto che molti dicevano: “È morto!”. Gesù, invece, prendendogli la mano, lo rialzò e (quello) si levò ritto». L’Evangelista medico ha la finezza di aggiungere che Gesù lo rese a suo padre. Gli Apostoli, già rimasti delusi, non potevano rinunziare a indagare la causa della delusione; avvicinatisi in privato a Gesù gli dissero: «Perché noialtri non potemmo scacciarlo?». E Gesù di rimando: «Per la vostra scarsezza di fede! In verità infatti vi dico, se abbiate fede quanto un chicco di senapa, direte a questo monte “Passa oltre da qua a là!” e passerà oltre, e nulla vi sarà impossibile». Del chicco di senapa Gesù già aveva parlato nella sua parabola (§ 368); questo monte a cui alludeva era forse il Tabor, la cui mole s’ergeva davanti a loro; quanto alla necessità della fede per ottenere miracoli Gesù vi aveva insistito più volte nel passato (§ 349 segg.), ma la sua lezione aveva prodotto scarsi frutti.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, oggi l’Abate Giuseppe Ricciotti - dalla sua «Vita di Gesù Cristo» - ci parlerà delle «Rettificazioni messianiche». Di che si tratta?
Stimati Associati e gentili Sostenitori, oggi l’Abate Giuseppe Ricciotti - dalla sua «Vita di Gesù Cristo» - ci parlerà delle «Rettificazioni messianiche». Di che si tratta?
• § 400. Il decisivo annunzio ormai era stato comunicato (cfr. Sursum Corda n° 143), ma subito appresso vennero quei correttivi (§ 301) che dovevano contenerne il significato nei suoi giusti termini. E in primo luogo l’annunzio era ancora confidenziale, riserbato ai soli discepoli; terminato, infatti, il conferimento dell’ufficio a Simone Pietro, Gesù immediatamente intimò ai discepoli di non dire a nessuno che egli è il Cristo (Matteo, 16, 20). Gesù giudicava non essere ancora venuto il tempo di divulgare l’annunzio, sia perché le turbe non erano preparate, sia anche perché gli stessi discepoli valutavano certamente in maniera imperfetta la qualità messianica di Gesù. Egli quindi si dette a rettificarla e perfezionarla. «Da allora cominciò Gesù Cristo a mostrare ai discepoli suoi che egli deve andare a Gerusalemme, e molto patire dagli Anziani e sommi sacerdoti e Scribi, ed essere ucciso e al terzo giorno risuscitare» (ivi, 21). Quale differenza fra il rumoroso e folgoreggiante Messia atteso dalle plebi, e questo Messia che schiva d’esser riconosciuto per tale e predice i patimenti e la morte violenta che l’aspettano! Per i discepoli, ai quali appunto era rivolto l’energico ammonimento, fu un colpo rude. Il generoso Pietro, sia per il suo carattere sia per l’ufficio testé ricevuto, si credette in dovere d’intervenire; «e Pietro presolo seco (da parte), cominciò a rimproverarlo, dicendo: “(Dio sia) a te propizio, Signore! Non ti avverrà punto ciò!”. Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: “Vattene dietro a me, Satana! Mi sei di scandalo, perché non hai i pensieri d’Iddio, bensì quelli degli uomini”». Il tentatore per eccellenza era Satana (§§ 78, 273), e qui la Roccia della Chiesa e il maggiordomo del regno dei cieli riceve l’appellativo di tentatore. La ragione di questa umiliazione, cioè l’aver egli vagheggiato il Messia dominatore deprecando il Messia sofferente, era imputabile più ai suoi tempi che a lui personalmente: ad ogni modo dimostra bene quanto bisogno c’era di rettificazioni messianiche anche nelle coscienze dei più intimi discepoli di Gesù. E le rettificazioni seguitarono, prendendo sempre più il tono di crude disillusioni. Che s’aspettavano quei discepoli andando appresso a Gesù Messia? Forse di trionfare, forse di goder vita suntuosa a fianco a un dominatore? Provvede Gesù a dissipare cotesti loro sogni con altrettante smentite anticipate, che risuonano come schiaffi sulla faccia d’un morfinizzato delirante. Gesù dichiara che chi vuole andargli appresso dovrà rinnegare se stesso, prendere la sua croce e seguirlo (Matteo, 16, 24). L’allusione alla croce acquistò certamente un senso più chiaro dopo la morte di Gesù; ma fin da allora i discepoli potevano comprenderla benissimo, giacché da quando i Romani si erano insediati in Palestina il supplizio della croce vi era applicato largamente (§ 597), e in modo particolare ai suscitatori di sommosse popolari che molto spesso s’ispiravano a ideali messianici. Chi dunque vuole seguire Gesù si consideri già morto, e allora vivrà; perdendo la propria vita per causa di Gesù e della «buona novella», il suo seguace la salverà, mentre se rimane spasmodicamente attaccato alla propria vita la perderà (Marco, 8, 35); che profitto ha infatti l’uomo se acquista il mondo intero, ma perde poi l’anima non acquistando l’eterna vita vera? Quale riscatto può egli dare per l’anima sua (ivi, 36-37)? Qualcuno si vergognerà di Gesù e della «buona novella»? Ebbene, costui crederà di aver salvato la propria vita in questa generazione adultera e peccatrice; ma quando il figlio dell’uomo verrà nella gloria del Padre suo, circondato dagli angeli, si vergognerà di chi si è vergognato di lui, e renderà a ciascuno secondo le proprie azioni (Marco, 8, 38; Matteo, 16, 27). Per Gesù, insomma, la vita presente è essenzialmente transitoria, e in tanto ha valore in quanto è indirizzata alla vita stabile, che è quella futura. Egli, Messia, guida alla vita stabile attraverso le aspre vicende di quella transitoria; chi non vuole seguirlo, e rimane nella vita transitoria, rimane nella morte.
• § 401. A questi detti di Gesù tutti e tre i Sinottici ne soggiungono un altro che ha tutta l’apparenza di essere stato pronunziato in altra occasione. «E diceva loro: “In verità vi dico, vi sono alcuni dei qui presenti i quali non gusteranno morte finché vedano il regno d’Iddio venuto in possanza”» (Marco, 9, 1). Con fine accorgimento i Sinottici hanno collocato questo detto dopo le altre rettifiche messianiche: tale, in sostanza, è anch’esso. [Dalla nota 1 alla pagina 475: Parecchi antichi commentatori giudicarono questo passo un preannunzio della seguente Trasfigurazione, supponendo tra i due argomenti un collegamento cronologico (cfr. § 402). In realtà il passo si riferisce all’attuazione del «regno d’Iddio» (vedere § 525 e segg.)]. La fragorosa apparizione del Messia politico non si sarebbe avverata; alla sua volta, il regno del sofferente ed assassinato Messia avrebbe dispiegato nella sua venuta tale possanza esterna ed interna da dissipare per sempre il sogno del Messia politico: e taluni dei presenti non sarebbero morti prima di aver assistito al dispiegamento di quella possanza. Infatti un quarantennio dopo, cioè nel giro di una “generazione” secondo computi giudaici, la Gerusalemme dei sogni messianici è distrutta, il giudaismo politico è stroncato per sempre, mentre invece la «buona novella» di Gesù è annunziata nell’intero mondo (Romani, 1, 8; cfr. Coloss., 1, 23).

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, auguri a tutti per questo santo Natale. Diciamo con Sant’Alfonso: «Beato me che ho questa fortuna! Che mai posso più desiderare? O Maria - Speranza mia - mentre io piango (per i miei peccati), prega Tu, anche per me, il Bambin Gesù: Pensa che sei fatta Mamma anche dei peccatori» (da «Canzoncine spirituali», «Per la Nascita di Gesù»). Sospendiamo, per oggi, il nostro studio del libro «Vita di Gesù Cristo» dell’Abate Ricciotti e concentriamoci sullo scritto «Il santo giorno di Natale», del compianto Dom Prosper Guéranger, da «L’anno liturgico», Alba, 1959.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, auguri a tutti per questo santo Natale. Diciamo con Sant’Alfonso: «Beato me che ho questa fortuna! Che mai posso più desiderare? O Maria - Speranza mia - mentre io piango (per i miei peccati), prega Tu, anche per me, il Bambin Gesù: Pensa che sei fatta Mamma anche dei peccatori» (da «Canzoncine spirituali», «Per la Nascita di Gesù»). Sospendiamo, per oggi, il nostro studio del libro «Vita di Gesù Cristo» dell’Abate Ricciotti e concentriamoci sullo scritto «Il santo giorno di Natale», del compianto Dom Prosper Guéranger, da «L’anno liturgico», Alba, 1959.
• Il lieto giorno della Vigilia di Natale volge al termine. La santa Chiesa ha già chiuso i divini Uffici dell’Attesa del Salvatore con la celebrazione del grande Sacrificio. Nella sua materna indulgenza, ha permesso ai suoi figli di rompere, a mezzogiorno, il digiuno di preparazione; i fedeli si sono seduti alla tavola frugale, con una gioia spirituale che fa loro presentire quella che inonderà i loro cuori nella notte che darà loro l’Emmanuele. Ma una solennità sì grande come quella di domani deve, secondo l’usanza della Chiesa nelle sue feste, avere un preludio nel giorno che la precede. Tra pochi istanti, l’Ufficio dei Primi Vespri nel quale si offre a Dio l’incenso della sera, chiamerà i cristiani alla Chiesa; e lo splendore delle cerimonie, la magnificenza dei canti apriranno tutti i cuori alle emozioni d’amore e di riconoscenza che li debbono disporre, a ricevere le grazie del momento supremo. Aspettando il sacro segnale che chiamerà alla casa di Dio, impieghiamo gli istanti che ci restano a meglio penetrare il mistero di sì grande giorno, i sentimenti della santa Chiesa in questa solennità e le tradizioni cattoliche mediante le quali i nostri antenati la hanno così degnamente celebrata.
• Sermone di San Gregorio Nazianzeno. Innanzitutto, ascoltiamo la voce dei santi Padri che risuonò con un’enfasi e una forza capaci di ridestare qualsiasi anima. Ecco per primo San Gregorio, il Teologo, il Vescovo, di Nazianzo, che inizia così il suo trentottesimo discorso, consacrato alla Teofania, o nascita del Salvatore. Chi potrebbe ascoltarlo e rimanere freddo davanti alle sue parole? «Cristo nasce; rendete gloria. Cristo discende dai cieli; andategli incontro. Cristo è sulla terra; uomini, alzatevi. Tutta la terra canta il Signore! E per riunire tutto in una sola parola: Si rallegrino i cieli ed esulti la terra, per Colui che è insieme del cielo e della terra. Cristo riveste la nostra carne: siate ripieni di timore e di gaudio: di timore a motivo del peccato; di gaudio a motivo della speranza. Cristo nasce da una Vergine: o donne, onorate la verginità per diventare madri di Cristo. Chi non adorerebbe Colui che era fin dal principio? Chi non loderebbe e non celebrerebbe Colui che è nato? Ecco che le tenebre svaniscono; è creata la luce; l’Egitto rimane sotto le ombre, Israele è illuminata da una lucente nube. Il popolo che era seduto nelle tenebre dell’ignoranza, scorge il lume d’una scienza profonda. Le cose antiche sono finite; tutto è ridiventato nuovo. Fugge la lettera e trionfa lo spirito [Questo non vuol affatto significare, come vogliono i modernisti, che, in nome di un non meglio precisato “spirito”, debbano cessare rigore ed osservanza. Anzi, Gesù ci dice: Chi non osserva (integralmente) i comandamenti, questi non mi ama, ndR]; le ombre sono passate, e la verità fa il suo ingresso. La natura vede le sue leggi violate: è giunto il momento di popolare il mondo celeste. Cristo comanda; guardiamoci bene dal resistere. Genti tutte, battete le mani; perché ci è nato un Bambino, ci è stato dato un Figlio. Il segno del suo principio è sulla sua spalla: perché la croce sarà il mezzo della sua elevazione; il suo nome è l’Angelo del grande consiglio, cioè del consiglio paterno. Esclami pure Giovanni: Preparate le vie del Signore! Per me, voglio far anche risuonare la potenza di sì gran giorno: Colui che è senza carne s’incarna; il Verbo prende un corpo; l’Invisibile si mostra agli occhi, l’Impalpabile si lascia toccare; Colui che non conosce tempo prende un principio; il Figlio di Dio è diventato figlio dell’uomo. Gesù Cristo era ieri, è oggi, e sarà sempre. Si senta pure offeso il Giudeo; se ne rida il Greco; e la lingua dell’eretico si agiti nella sua bocca impura. Crederanno quando lo vedranno, questo Figlio di Dio, salire al cielo; e se anche in quel momento si rifiutano, crederanno quando ne discenderà e comparirà sul tribunale di giudice».
• Sermone di San Bernardo. Ascoltiamo ora, nella Chiesa Latina, il devoto San Bernardo, che effonde una soave letizia in queste melodiose parole, nel IV sermone per la Vigilia di Natale. «Abbiamo ricevuto una notizia piena di grazia e fatta per essere accolta con trasporto: Gesù Cristo, Figlio di Dio, nasce in Betlemme di Giuda. La mia anima si è sciolta a queste parole: lo spirito ribolle in me, spinto come sono ad annunciarvi tanta felicità. Gesù significa Salvatore. Che cosa è più necessario di un Salvatore a quelli che erano perduti, più desiderabile a degli infelici, più vantaggioso per quelli che erano accasciati dalla disperazione? Dov’era la salvezza, dov’era perfino la speranza della salvezza, per quanto debole, sotto la legge del peccato, in quel corpo di morte, in mezzo alla perversità, nella dimora d’afflizione, se questa salvezza non fosse nata d’un tratto e contro ogni speranza? O uomo, tu desideri, è vero, la tua guarigione; ma, avendo coscienza della tua debolezza e della tua infermità, temi il rigore del trattamento. Non temere dunque: Cristo è soave e dolce; la sua misericordia è immensa; come Cristo, egli ha ricevuto in eredità l’olio, ma per effonderlo sulle tue piaghe. E se ti dico che è dolce, non temere che il tuo Salvatore manchi di potenza; perché è anche Figlio di Dio. Esultiamo dunque, riflettendo in noi stessi, e facendo risplendere al di fuori quella dolce sentenza, quelle soavi parole: Gesù Cristo. Figlio di Dio, nasce in Betlemme di Giuda!».
• Sermone di Sant’Efrem. È dunque veramente un grande giorno quello della Nascita del Salvatore: giorno atteso dal genere umano per migliaia di anni, atteso dalla Chiesa nelle quattro settimane dell’Avvento che ci lasciano così cari ricordi; atteso da tutta la natura che riceve ogni anno, sotto i suoi auspici, il trionfo del sole materiale sulle tenebre sempre crescenti. Il grande Dottore della Chiesa Sira, Sant’Efrem, celebra con entusiasmo la bellezza e la fecondità di questo giorno misterioso; prendiamo qualche brano dalla sua divina poesia, e diciamo con lui: «Degnati, o Signore, di permettere che celebriamo oggi il giorno stesso della tua nascita, che la presente solennità ci ricorda. Quel giorno è simile a te; è amico degli uomini. Esso ritorna ogni anno attraverso i tempi; invecchia con i vecchi, e si rinnova con il bambino che è nato. Ogni anno, ci visita e passa; quindi ritorna pieno di attrattive. Sa che la natura umana non potrebbe fare a meno di lui; come te, esso viene in aiuto alla nostra razza in pericolo. Il mondo intero, o Signore, ha sete del giorno della tua nascita; questo giorno beato racchiude in sé i secoli futuri; esso è uno e molteplice. Sia dunque anche quest’anno simile a te, e porti la pace fra il cielo e la terra. Se tutti i giorni sono segnati della tua liberalità, non è giusto forse che essa trabocchi in questo? Gli altri giorni dell’anno traggono la loro bellezza da questo, e le solennità che seguiranno debbono ad esso la dignità e lo splendore di cui brillano. Il giorno della tua nascita è un tesoro, o Signore, un tesoro destinato a soddisfare il debito comune. Benedetto il giorno che ci ha ridato il sole, a noi erranti nella notte oscura; che ci ha recato il divino manipolo dal quale è stata diffusa l’abbondanza; che ci ha dato la vite che contiene il vino della salvezza che deve dare a suo tempo. Nel cuore dell’inverno che priva gli alberi dei loro frutti, la vigna si è rivestita d’una divina vegetazione; nella stagione glaciale, un pollone è spuntato dal ceppo di Jesse. È in dicembre, in questo mese che trattiene nel grembo della terra il seme che le fu affidato, che la spiga della nostra salvezza spunta dal seno della Vergine dove era disceso nei giorni di primavera, quando gli agnelli vanno belando nei prati». Non è dunque da stupire che questo giorno il quale è caro a Dio stesso sia privilegiato nell’economia dei tempi; e conforta vedere le genti pagane presentire nei loro calendari la gloria che Dio gli riservava nella successione delle età. Abbiamo visto del resto che i Gentili non sono stati i soli a prevedere misteriosamente le relazioni del divino Sole di giustizia con l’astro mortale che illumina e riscalda il mondo; i santi Dottori e tutta la Liturgia sono molto prodighi riguardo a questa ineffabile armonia.
• Il battesimo di Clodoveo. Per incidere più profondamente l’importanza di un giorno così santo nella memoria dei popoli cristiani dell’Europa, stirpi preferite nei consigli della misericordia divina, il supremo Signore degli eventi ha voluto che il regno dei Franchi nascesse appunto il giorno di Natale (496) allorché nel Battistero di Reims, tra le pompe di tale solennità, Clodoveo, il fiero Sicambro, divenuto mite come l’agnello, fu immerso da San Remigio nel fonte della salvezza, dal quale uscì per inaugurare la prima monarchia cattolica fra le monarchie nuove, quel regno di Francia, il più bello - è stato detto - dopo quello dei cieli.
• La conversione dell’Inghilterra. Un secolo più tardi (597), era la volta della razza anglosassone. L’Apostolo dell’Isola dei Bretoni, il monaco Sant’Agostino, dopo aver convertito al vero Dio il re, avanzò alla conquista delle anime. Essendosi diretto verso York, vi fece risuonare la parola di vita, e un intero popolo si unì per chiedere il Battesimo. Il giorno di Natale è fissato per la rigenerazione di quei nuovi discepoli di Cristo; e il fiume che scorre sotto le mura della città viene scelto per servire da fonte battesimale a quell’armata di catecumeni. Diecimila uomini, non contando le donne e i bambini, scendono nelle acque la cui corrente deve portar via l’immondezza delle loro anime. Il rigore della stagione non arresta i nuovi e ferventi discepoli del Bambino di Betlemme, che appena pochi giorni prima ignoravano perfino il suo nome. Dalle acque gelide esce piena di gaudio e risplendente d’innocenza tutta un’armata di neofiti; e nel giorno stesso della sua nascita, Cristo conta una nazione di più sotto il suo impero. Ma non era ancora abbastanza per il Signore che vuole onorare il giorno della nascita del suo Figliuolo.
• L’incoronazione di Carlo Magno. Un’altra illustre nascita doveva ancora abbellire questo lieto anniversario. A Roma, nella basilica di San Pietro, nella solennità di Natale dell’800, nasceva il Sacro Romano Impero al quale era riservata la missione di propagare il regno di Cristo nelle regioni barbare del Nord, e di mantenere l’unità europea, sotto la direzione del Romano Pontefice. In quel giorno, San Leone III poneva la corona imperiale sul capo di Carlo Magno; e la terra attonita rivedeva un Cesare, un Augusto, non più successore dei Cesari e degli Augusti della Roma pagana, ma investito di quei titoli gloriosi dal Vicario di Colui che si chiama, nei santi Oracoli, il Re dei re, il Signore dei signori.
• La gloria del giorno di Natale. Così Dio ha fatto risplendere agli occhi degli uomini la gloria del regale Bambino che nasce oggi; così egli ha preparato, di epoca in epoca attraverso i secoli, ricchi anniversari di quella Natività che dà gloria a Dio e pace agli uomini. Il susseguirsi dei tempi farà vedere al mondo in che modo l’Altissimo si riserva ancora di glorificare, in questo giorno, se stesso ed il suo Emmanuele. Nell’attesa, le nazioni dell’Occidente, colpite dalla dignità di tale festa, e considerandola con ragione come il principio di tutte le cose nell’era della rigenerazione del mondo, contarono a lungo gli anni cominciando dal Natale, come si vede su antichi Calendari, sui Martirologi di Usuardo e di Adone, e su un gran numero di Bolle, di Costituzioni e di Diplomi. Un Concilio di Colonia, nel 1322, ci dimostra che tale usanza ancora esisteva a quell’epoca. Parecchi popoli dell’Europa cattolica, soprattutto gli Italiani, hanno conservato l’usanza di festeggiare il nuovo anno alla Natività del Salvatore. Si augura il buon Natale, come altrove al primo gennaio il buon anno. Ci si scambiano i complimenti e i regali; si scrive agli amici lontani: preziose vestigia delle antiche usanze, di cui la fede era il principio e il baluardo invincibile. Ma è tale agli occhi della santa Chiesa la gioia che deve riempire i fedeli nella Nascita del Salvatore che, associandosi con una particolare indulgenza a così legittima allegrezza, abolisce per il giorno di domani il precetto dell’astinenza dalla carne, se il Natale cade il venerdì o il sabato. Questa dispensa risale al Papa Onorio III, che occupava la sede di Pietro nel 1216; ma già fin dal IX secolo San Nicola I, nella sua risposta ai quesiti dei Bulgari, aveva mostrato simile condiscendenza, per incoraggiare la gioia dei fedeli nella celebrazione non solo della solennità di Natale, ma anche nelle feste di Santo Stefano, di San Giovanni Evangelista, dell’Epifania, della Assunzione della Vergine, di San Giovanni Battista e dei Santi Pietro e Paolo. Ma questa indulgenza non fu universale, e l’abolizione non si è conservata che per la festa di Natale di cui accresce la popolare allegrezza. La legislazione civile medievale intese, a suo modo, mettere in risalto l’importanza di questa festa così cara a tutta la cristianità concedendo ai debitori la facoltà di sospendere il pagamento dei loro creditori durante tutta la settimana di Natale, che appunto per questo era, chiamata settimana di remissione, come quelle di Pasqua e della Pentecoste. Ma sospendiamo per un poco questi ricordi familiari, che ci piace raccogliere sulla gloriosa solennità il cui avvicinarsi commuove così dolcemente i nostri cuori. È tempo di dirigere i nostri passi verso la casa di Dio, dove ci chiama l’Ufficio solenne dei Primi Vespri. Durante il tragitto, rivolgiamo il pensiero a Betlemme, dove Giuseppe e Maria sono già arrivati. Il sole materiale volge rapidamente al tramonto; e il divino Sole di giustizia rimane nascosto ancora per qualche istante sotto la nube, nel seno della più pura delle vergini. La notte è vicina; Giuseppe e Maria percorrono le strade della città di David, cercando un asilo per mettersi al riparo. Che i cuori fedeli siano dunque attenti, e si uniscano ai due incomparabili pellegrini. È giunta ormai l’ora in cui il canto di gloria e di riconoscenza deve levarsi da ogni bocca umana. Accogliamo con sollecitudine, per la nostra, la voce della santa Chiesa: essa non è certo inferiore a così nobile compito.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, abbiamo ancora alcune copie disponibili dei due libri: «L’inferno. Se esiste. Che cos’è. Come possiamo evitarlo» e «Racconti miracolosi». Potete trovarli nella sezione «Sostienici» del nostro sito. Sursum Corda Onlus non ha alcun scopo di lucro ed usa tutte le donazioni per perseguire le finalità associative. L’editoriale di oggi è dedicato al ministero di Gesù a Cesarea di Filippo, secondo le preziose informazioni che ci ha lasciato l’Abate Giuseppe Ricciotti.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, abbiamo ancora alcune copie disponibili dei due libri: «L’inferno. Se esiste. Che cos’è. Come possiamo evitarlo» e «Racconti miracolosi». Potete trovarli nella sezione «Sostienici» del nostro sito. Sursum Corda Onlus non ha alcun scopo di lucro ed usa tutte le donazioni per perseguire le finalità associative. L’editoriale di oggi è dedicato al ministero di Gesù a Cesarea di Filippo, secondo le preziose informazioni che ci ha lasciato l’Abate Giuseppe Ricciotti.
• § 395. Da Bethsaida Gesù risalì verso settentrione, allontanandosi ancor più da contrade giudaiche, e raggiunse la zona di Cesarea di Filippo (§ 19). In quella zona, in prevalenza pagana, egli e i suoi discepoli non erano assillati da folle d’imploranti né disturbati da intrighi di Farisei e di politicanti; fu dunque per lui una specie di ritiro con i suoi prediletti. Quei discepoli, del resto, rappresentavano il miglior risultato dell’opera sua: saranno stati chi ruvido, chi zotico, e chi di dura cervice; avranno tutti, più o meno, risentito delle grette idee predominanti allora nella loro stirpe; ma uomini di cuore erano, sinceramente affezionati al maestro e pieni di fede in lui. Le solite turbe che assiepavano Gesù non avevano questi pregi: in Gesù esse cercavano ordinariamente il taumaturgo che guariva malati, risuscitava morti e moltiplicava pani, e se gradivano pure sentirlo parlare del regno di Dio e s’infiammavano anche alla sua parola, in parte era quella vampa nazionalista che Gesù deprecava e in parte era un fuoco di paglia che si spegneva poco dopo. Perciò Gesù prediligeva i discepoli, e ne curava particolarmente la formazione spirituale in vista del futuro. E oramai, dopo un anno e mezzo di operosità, egli poteva trattarli confidenzialmente nella questione più delicata per lui e forse più oscura per i discepoli stessi: la qualità messianica. Quel maestro così amato, quel taumaturgo così potente, quel predicatore così efficace, era veramente il Messia predetto da secoli ad Israele, ovvero era soltanto un tardivo profeta dotato di straordinari doni divini? Era un figlio di Dio, oppure era il figlio di Dio? Certamente, dentro di loro, i prediletti discepoli si erano rivolti già nel passato questa domanda: ma se personalmente si sentivano assai inclinati a rispondere che egli era proprio il Messia, il figlio di Dio, ne erano anche distornati dalla vigilantissima cura mostrata fino allora da Gesù affinché quella risposta affermativa non fosse proclamata ad alta voce. Perché mai quella ritrosia inesplicabile? Era questo un punto assai oscuro per i discepoli; i quali però pensavano che il maestro ne sapeva più di loro, e avendo fede in lui si rimettevano a lui, aspettando che quel punto oscuro fosse schiarito a suo tempo. Gesù giudicò che allora era venuto questo tempo. La lunga ed intima assiduità con Gesù aveva aperto gli occhi ai discepoli in molte cose; d’altra parte, là in terra pagana, non esistevano pericoli d’incomposti tumulti nazionalisti qualora i discepoli avessero avuto la certezza che Gesù era il Messia e di ciò avessero potuto parlare tra loro liberamente; è anche probabile che, nei giorni di tranquillo ritiro passato con i discepoli, Gesù li avesse predisposti spiritualmente a ricevere la delicata confidenza, sfrondando dalla loro immagina[zione] molte frasche politiche di cui era adornata ancora nelle loro menti la figura del Messia d’Israele. Infine, com’era solito fare nei momenti più decisivi della sua missione, Gesù si era appartato a pregare da solo (Luca, 9, 18).
• § 396. Ripreso tutti insieme il cammino, stavano per giungere a Cesarea di Filippo. S’avanzavano lungo la strada, ed erano già in vista della città (Marco, 8, 27): di fronte ad essi si ergeva la maestosa roccia su cui troneggiava il tempio di Augusto (§ 19). A un tratto, riferendosi certamente a discorsi precedenti, Gesù chiede ai discepoli: «Chi dicono gli uomini che io sia?». Gli fu risposto alla rinfusa: «Ho inteso dire che tu sei Giovanni il Battista!». Un altro: «C’è chi dice che sei Elia!». - Un altro ancora: «Secondo alcuni tu saresti Geremia!». Altri infine riferirono l’opinione più vaga secondo cui Gesù era uno degli antichi profeti risorto. Le opinioni riferite erano numerose; ma Gesù non dette loro alcuna importanza, né si fermò a discuterle. Quell’investigazione sul pensiero altrui era una semplice introduzione all’investigazione veramente importante, quella sull’opinione personale dei discepoli. Terminate infatti le risposte, Gesù disse loro: «Voi, invece, chi dite che io sia?». I discepoli ebbero certamente un sussulto: a quella domanda si sentirono toccati nell’intimo, e con stupore videro che Gesù da se stesso entrava nel campo fino allora gelosamente evitato. Dovette seguire un silenzio imposto più da felicità ritrosa che da vera esitanza, silenzio non dissimile da quello d’una fanciulla che sia chiesta in isposa dal giovane ch’ella nel suo cuore segretamente già amava: forse i discepoli ripensarono in quel momento alla parola di Gesù che si era paragonato, nei loro confronti, ad uno sposo fra gli «amici dello sposo» (§ 307). E rimasero lì in mezzo alla strada muti d’un silenzio eloquente, con gli occhi fissi sul tempio di Augusto che dominava su città e campagna dall’alto della roccia. Passati alcuni istanti il silenzio fu tradotto in parole da Simone Pietro, né poteva esser da altri che da lui impetuoso tra affezionati: «Tu sei il Cristo, il figlio d’Iddio il vivente!». La traduzione del verecondo silenzio era stata perfetta; lo si vide in quei barbuti visi, che esprimevano la felicità d’un cordiale consenso e dimostravano una giocondità da lungo tempo repressa.
• § 397. Gesù sfiorò col suo sguardo tutti quei visi; rivolto poi a chi aveva parlato disse: «Beato sei (tu), Simone figlio di Giona, poiché carne e sangue non rivelò (ciò) a te, bensì il Padre mio quello nei cieli!». [Nota 1 alla pagina 470: Figlio di Giona. Altrove (Giovanni, 1, 42 - greco 21, 15) Simone Pietro è chiamato figlio di Giovanni. Non è da pensare che Giona sia un vero abbreviativo grammaticale di Giovanni; forse (... dipende dalle trascrizioni ...), tuttavia la questione grammaticale non è chiara]. L’affermazione di Simone era confermata in pieno da colui ch’era il maggiormente interessato. Tutti i presenti si sentirono parimente confermati nella loro antica fede serbata in segreto. Dovette seguire ancora un breve silenzio, in cui fu alzato ancora uno sguardo al tempio lassù in cima alla roccia. Poi Gesù rispose: «Ebbene, anch’io ti dico che tu sei Roccia, e sopra questa roccia costruirò la mia chiesa, e porte d’inferi non prevarranno contro di essa. Darò a te le chiavi del regno dei cieli, e ciò che (tu) abbia legato sopra la terra sarà legato nei cieli, e ciò che (tu) abbia sciolto sopra la terra sarà sciolto nei cieli» (Matteo, 16, 16-19). Già in precedenza Simone era stato da Gesù chiamato Roccia, in aramaico Kephā (§ 278), ma quella prima volta non era stata comunicata la ragione e la spiegazione dell’appellativo. Adesso la spiegazione è comunicata, ed è tanto più chiara davanti alla visione della roccia materiale che sostiene il tempio dedicato al signore del Palatino. Il tempio spirituale che Gesù costruirà al Signore dei cieli, cioè la sua Chiesa, avrà per roccia di sostegno quel suo discepolo che per primo lo ha proclamato Messia e vero figlio di Dio. Anche le altre parole di Gesù sono chiare, alla luce delle circostanze in cui furono pronunziate. Gli Inferi (in greco Ade) corrispondono alla ebraica Sheol (§ 79), non però come generica dimora dei morti, bensì come dimora dei morti reprobi, ostili al bene e al regno di Dio; le porte di cotesta bolgia satanica, cioè tutte le sue massime forze (cfr. la sublime Porta), non prevarranno contro la costruzione di Gesù e contro la roccia che la sostiene. Tipicamente semitici sono anche i simboli delle chiavi e del legare e sciogliere. Ancora oggi in paesi arabi girano per le strade uomini con un paio di grosse chiavi legate ad una funicella e pendenti ostentatamente di qua e di là della spalla: sono i padroni di case, che fanno pompa in quella maniera della propria autorità. [Nota 2 alla pagina 470: L’usanza, e precisamente riguardo alla spalla, è già attestata da Isaia: «E porrò la chiave della casa di David sulla spalla di lui (di Eliacim, come maggiordomo della casa reale), ed egli aprirà e nessuno chiuderà, e chiuderà e nessuno aprirà]. Il simbolo del legare e sciogliere (cfr. Matteo, 18, 18) conserva qui il valore che aveva nella terminologia rabbinica contemporanea, ove si ritrova usato frequentemente: i rabbini “legavano” quando proibivano alcunché, “scioglievano” quando lo permettevano; Rabbì Nechonja, fiorito verso l’anno 70 dopo Cristo, usava premettere alle sue lezioni la seguente preghiera: «Ti piaccia, o Jahvè, Dio mio e Dio dei miei padri, che... noi non dichiariamo impuro ciò ch’è puro e puro ciò ch’è impuro; che noi non leghiamo ciò ch’è sciolto e non sciogliamo ciò ch’è legato». L’ufficio del discepolo Roccia è dunque ben definito. Egli sarà il fondamento che sosterrà la Chiesa, e la sosterrà così saldamente che le avverse potenze infernali non prevarranno contro di essa. Egli inoltre sarà il maggiordomo di quella casa, le cui chiavi saranno perciò affidate a lui. Egli infine detterà legge nell’interno di quella casa, proibendo oppure permettendo alcunché, e le sue sentenze pronunziate sulla terra saranno tali quali ratificate nei cieli.
• § 398. La replica di Gesù a Simone Pietro è di una chiarezza che si direbbe abbagliante; né minore è la sua sicurezza testuale, giacché tutti gli antichi documenti, senza alcuna eccezione, concordano nel trasmetterci con precisione sillabica il nostro odierno testo. Eppure, com’è ben noto, questo testo ha fatto scorrere torrenti d’inchiostro, e si è recisamente negato che Gesù abbia conferito a Simone l’ufficio di essere roccia fondamentale della Chiesa, depositario delle sue chiavi e arbitro di legare e di sciogliere. Come mai questa negazione? Gli antichi protestanti ortodossi assicuravano che Gesù non ha parlato affatto di Simone Roccia, ma di se stesso, e per il resto si sarebbe riferito a tutti gli Apostoli collettivamente ed alla loro fede. Quando dice «sopra questa roccia costruirò la mia chiesa, ecc.», Gesù allunga un dito e lo rivolge verso se stesso, sebbene stia a parlare con Simone e di Simone. Quel dito allungato risolve la questione: esso è chiarissimamente sottinteso dal contesto, e si accorda spontaneamente con le parole che seguono «darò a te le chiavi del regno dei cieli e ciò che (tu) abbia legato, ecc...». Come si vede subito, il ragionamento è perfetto (...). I negatori moderni dell’ufficio di Simone hanno preso la strada precisamente opposta. Essi hanno trovato che la spiegazione degli antichi protestanti è di una goffaggine tale da tradire subito la tendenziosità settaria che l’ispira. No, rispondono essi, le parole di Gesù hanno precisamente quel significato che la tradizione e il buon senso vi hanno sempre ritrovato; su ciò è inutile arzigogolare: - Uno di questi nuovi negatori si esprime così: «Simone Pietro... vive ancora, agli occhi di Matteo, in una potenza che lega e scioglie, che detiene le chiavi del regno di Dio e che è l’autorità della Chiesa stessa... Simone Pietro è la prima autorità apostolica in ciò che riguarda la fede, perché il Padre gli ha rivelato a preferenza il mistero del Figlio; in ciò che riguarda il governo delle comunità, perché il Cristo gli ha confidato le chiavi del regno; in ciò che riguarda la disciplina ecclesiastica, perché egli ha il potere di legare e di sciogliere. Non è senza motivo che la tradizione cattolica ha fondato su questo testo il dogma del primato romano» [Ricciotti sta usando il modernista Loisy per dimostrare che addirittura quest’ultimo, noto per i suoi faraonici errori, non se la sente di negare esplicitamente e goffamente l’evidenza. Abbiamo sottolineato alcune parole del Loisy che, a nostro avviso, nascondo il periglioso errore, ndR]. Gesù, dunque, ha veramente conferito a Simone l’ufficio in questione, secondo i nuovi negatori? Mai più! La ragione è che Gesù non avrebbe mai pronunziato quelle parole; quel testo sarebbe tutto, o quasi tutto, falso o inventato; esso sarebbe interpolato tra la fine del secolo I e gl’inizi del II o a Roma, a servizio della Chiesa romana, oppure in Palestina. E le prove di tutto ciò? Non si è addotto nessun codice antico, nessuna versione, nessuna citazione, che mostrino indizi sia pur vaghi d’interpolazione: si sono addotti argomenti a silentio (che tutti sanno quanto valgano) per cui scrittori cristiani dei secoli II e III o non citano il passo o ne citano solo una parte. Si potrebbe forse pensare che gli antichi protestanti, beffeggiati dai moderni negatori per avere scoperto il dito allungato di Gesù, siano in grado di vendicarsi trionfalmente applicando ai beffeggiatori le parole di Orazio: «Quodcumque ostendis mihi sic, incredulus odi!» - [Ricciotti sta giustamente ridicolizzando Loisy e, con lui, i moderni negatori del primato. Alcuni lo sono esplicitamente, altri dietro sofismi, altri nella prassi. Cogliamo l’occasione per segnalare che la moderna gerarchia modernista, che si fa chiamare “cattolica”, ordinariamente fa propri gli errori del Loisy e cantastorie simili, ndR].
• § 399. Queste sono le ragioni, addotte da una parte e dall’altra, per negare l’ufficio di Simone. Ma la ragione vera e reale, eppure non addotta mai francamente ed esplicitamente, è la previa «impossibilità» che Gesù abbia conferito quell’ufficio. Questa «impossibilità» sarebbe assoluta, indiscutibile, trascendente, e varrebbe ben più della chiarezza del senso e della sicurezza testuale. Soltanto da questa “roccia” sono scaturiti i torrenti d’inchiostro accennati sopra, e soltanto sopra questa “roccia” si adunano concordemente negatori antichi e moderni. [Si segnala che gli attuali modernisti che occupano impunemente la Chiesa, i quali non professano il Cattolicesimo ma professano la “Religione dell’ecumenismo”, devono necessariamente deprimere il primato romano, appunto in chiave ecumenica. Secondo la nostra opinione, pur talvolta non affermandolo chiaramente essi sempre e comunque dimostrano di non credere nel primato. Con ancor maggiore evidenza, dimostrano di non credere nel primato tutti quei cosiddetti “Tradizionalisti” di dottrina lefebvriana o simile, i quali asseriscono che un divulgatore di eresie e di errori sarebbe veramente Papa e che, per conservare la fede, sarebbe necessario praticare la disobbedienza ordinaria contro il Papa. Questi errori sono così palesi e contrari alla fede cattolica, ndR]. Scesi però dalla “roccia” e calati sul terreno esegetico-documentario, i concordi negatori discordano fra loro e si negano a vicenda. Secondo essi, dietro le spalle di chi si appella alla chiarezza del senso e alla sicurezza testuale s’erge l’ombra del papismo: papismo o no, i negatori alzerebbero tripudianti grida di trionfo se avessero a propria disposizione solo una metà degli argomenti strettamente storici di cui dispongono gli adombrati dal papismo. Ma hanno poi questi negatori pensato di riguardare qualche volta dietro le proprie spalle, per vedere se casomai là si ergano le ombre di Lutero o di Hegel, e se unicamente quelle ombre suggeriscano ad essi i loro argomenti “storici”?

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, rivolgiamo a tutti Voi i migliori auguri per la Festa dell’Immacolata Concezione della Santa Vergine Maria. Questo dogma fu proclamato da Papa Pio IX con la Bolla «Ineffabili Deus» il giorno 8 dicembre del 1854. Non significa che questa verità esiste, o è vera, solo da tal giorno, ma significa che esiste ed è vera da sempre e che, proprio in quel momento storico, la sapienza di Dio ne ha voluto la definizione. Nella ricerca «La questione del cosiddetto “Papa eretico”» (Cliccare qui), che abbiamo recentemente pubblicato sul nostro sito, si fa menzione anche alla mentovata infallibile definizione. Oltre la magnificenza di questa verità di fede, cosa si intende mettere in evidenza? Leggiamo alcune proposizioni del Pontefice: 1° Pio IX prende in considerazione la Sacra Scrittura e la Tradizione: «Dalle divine Scritture, dalla Tradizione, dall’autorità dei Padri, niente poteva essere desunto che fosse in contrasto con questa prerogativa (l’Immacolata Concezione) della Vergine»; 2° Pio IX considera il comune sentire della Chiesa: «Abbiamo udito i Cardinali di Santa Romana Chiesa rivolgerci l’insistente richiesta perché decidessimo di emanare la definizione dogmatica dell’Immacolata Concezione»; 3° Papa Pio IX definisce: «Dopo aver presentato senza interruzione, nell’umiltà e nel digiuno, le Nostre personali preghiere e quelle pubbliche della Chiesa, a Dio Padre per mezzo del suo Figlio, perché si degnasse di dirigere e di confermare la Nostra mente con la virtù dello Spirito Santo; dopo aver implorato l’assistenza dell’intera Corte celeste e dopo aver invocato con gemiti lo Spirito Paraclito; per sua divina ispirazione, ad onore della santa ed indivisibile Trinità, a decoro e ornamento della Vergine Madre di Dio, ad esaltazione della Fede cattolica e ad incremento della Religione cristiana, con l’autorità di Nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, dichiariamo, affermiamo e definiamo rivelata da Dio la dottrina che sostiene che la beatissima Vergine Maria fu preservata, per particolare grazia e privilegio di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, immune da ogni macchia di peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento, e ciò deve pertanto essere oggetto di fede certo ed immutabile per tutti i fedeli. Se qualcuno, dunque, avrà la presunzione di pensare diversamente da quanto è stato da Noi definito (Dio non voglia!), sappia con certezza di aver pronunciato la propria condanna, di aver subito il naufragio nella fede (...)». Dunque il cattolico, senza alcun dubbio, crede che «la beatissima Vergine Maria fu preservata (...) immune da ogni macchia di peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento».
Stimati Associati e gentili Sostenitori, rivolgiamo a tutti Voi i migliori auguri per la Festa dell’Immacolata Concezione della Santa Vergine Maria. Questo dogma fu proclamato da Papa Pio IX con la Bolla «Ineffabili Deus» il giorno 8 dicembre del 1854. Non significa che questa verità esiste, o è vera, solo da tal giorno, ma significa che esiste ed è vera da sempre e che, proprio in quel momento storico, la sapienza di Dio ne ha voluto la definizione. Nella ricerca «La questione del cosiddetto “Papa eretico”» (Cliccare qui), che abbiamo recentemente pubblicato sul nostro sito, si fa menzione anche alla mentovata infallibile definizione. Oltre la magnificenza di questa verità di fede, cosa si intende mettere in evidenza? Leggiamo alcune proposizioni del Pontefice: 1° Pio IX prende in considerazione la Sacra Scrittura e la Tradizione: «Dalle divine Scritture, dalla Tradizione, dall’autorità dei Padri, niente poteva essere desunto che fosse in contrasto con questa prerogativa (l’Immacolata Concezione) della Vergine»; 2° Pio IX considera il comune sentire della Chiesa: «Abbiamo udito i Cardinali di Santa Romana Chiesa rivolgerci l’insistente richiesta perché decidessimo di emanare la definizione dogmatica dell’Immacolata Concezione»; 3° Papa Pio IX definisce: «Dopo aver presentato senza interruzione, nell’umiltà e nel digiuno, le Nostre personali preghiere e quelle pubbliche della Chiesa, a Dio Padre per mezzo del suo Figlio, perché si degnasse di dirigere e di confermare la Nostra mente con la virtù dello Spirito Santo; dopo aver implorato l’assistenza dell’intera Corte celeste e dopo aver invocato con gemiti lo Spirito Paraclito; per sua divina ispirazione, ad onore della santa ed indivisibile Trinità, a decoro e ornamento della Vergine Madre di Dio, ad esaltazione della Fede cattolica e ad incremento della Religione cristiana, con l’autorità di Nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, dichiariamo, affermiamo e definiamo rivelata da Dio la dottrina che sostiene che la beatissima Vergine Maria fu preservata, per particolare grazia e privilegio di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, immune da ogni macchia di peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento, e ciò deve pertanto essere oggetto di fede certo ed immutabile per tutti i fedeli. Se qualcuno, dunque, avrà la presunzione di pensare diversamente da quanto è stato da Noi definito (Dio non voglia!), sappia con certezza di aver pronunciato la propria condanna, di aver subito il naufragio nella fede (...)». Dunque il cattolico, senza alcun dubbio, crede che «la beatissima Vergine Maria fu preservata (...) immune da ogni macchia di peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento».
• Ora, numerosi moderni “Tradizionalisti”, che sarebbe meglio chiamare fallibilisti, i quali comunque riconoscono infallibile questa definizione del Pontefice, sostengono che Papa Pio IX avrebbe usufruito dell’infallibilità - promessa da Nostro Signore - nella formulazione di questo dogma principalmente per quattro ragioni: 1° avrebbe inteso definire (noi lo capiamo facilmente dalle parole usate); 2° si sarebbe attenuto alla Sacra Scrittura; 3° si sarebbe attenuto alla Tradizione; 4° avrebbe assecondato il comune sentire della Chiesa. Dove sbagliano? Ai nostri occhi, avendo appena letto le proposizioni del Pontefice, e ben conoscendo il dogma dell’infallibilità (Cliccare qui), i punti 2, 3 e 4, presentati - in questo preciso senso e significato - dai fallibilisti, suonano certamente male. Rispondiamo, invece, che il Pontefice, 1° pur prendendo in considerazione Scrittura e Tradizione («... dalle divine Scritture, dalla Tradizione, dall’autorità dei Padri, niente poteva essere desunto che fosse in contrasto con questa prerogativa della Vergine ...»), 2° pur considerando il comune sentire della Chiesa («... li abbiamo uditi rivolgerci l’insistente richiesta perché decidessimo di emanare la definizione dogmatica dell’Immacolata Concezione ...»), 3° dichiara con Cristo e da sé (in quanto Papa): «Noi ... con l’autorità di Nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, dichiariamo, affermiamo e definiamo rivelata da Dio la dottrina che sostiene che la beatissima Vergine Maria fu preservata... immune da ogni macchia di peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento». Qui è il Papa che dichiara che questa dottrina è stata rivelata da Dio («Noi ... dichiariamo, affermiamo e definiamo rivelata da Dio la dottrina che ...»), è il Papa la garanzia infallibile.
• Mi spiego meglio. I moderni fallibilisti - ovvero gli autoproclamatisi “Tradizionalisti” - sostengono che garanzie infallibili sarebbero, in ordine, 1° la Sacra Scrittura; 2° la Tradizione; 3° il comune sentire - o consenso - della Chiesa. A loro dire, difatti, la definizione del Pontefice sarebbe quasi accessoria o superflua (e sempre suscettibile di giudizio privato), poiché, a sentir loro, il Papa avrebbe usufruito dell’infallibilità promessa da Nostro Signore sol perché si sarebbe attenuto ai 3 soggetti precedentemente menzionati (Scrittura, Tradizione, Consenso). In caso contrario, sempre in presenza di una definizione di pari solennità e nelle medesime circostanze, il Pontefice potrebbe facilmente definire il falso, rinunciando alla garantita infallibilità, a causa di una sua presunta - e per i fallibilisti possibilissima - defezione 1° dalla Scrittura; 2° dalla Tradizione; 3° dal consenso della Chiesa. Si capisce facilmente che il fallibilista ritiene che la prerogativa dell’infallibilità non sia propria del Romano Pontefice, ma esclusivamente della Scrittura, in alternativa della Tradizione, finalmente del comune sentire della Chiesa. Mentre il dogma cattolico ci insegna che è impossibile - poiché infallibilmente assistito dallo Spirito Paraclito - che il Pontefice, in una definizione di fede e costume, definisca il falso collocandosi palesemente contro le divine Lettere e contro la veneranda Tradizione; il fallibilista, al contrario, prevede che il Pontefice possa errare in una simile circostanza (ed anche di più solenne come in un Concilio universale), pur avendo conservato il carisma pontificio (quindi essendo veramente Papa), per di più pretende, almeno di fatto, che questa infallibilità sia propria della Scrittura, della Tradizione e del consenso della Chiesa: a palese detrimento dell’autorità del Vicario di Cristo o Pontefice.
• § 393. Essendo stata subitanea la partenza, i discepoli avevano dimenticato di far provviste, e lungo il tragitto si rammaricavano di aver con loro un solo pane. Gesù, udendo le loro parole, disse loro: «Guardatevi dal fermento dei Farisei e dal fermento di Erode!». Erode, cioè Antipa, fu menzionato certamente in conseguenza di discorsi o di avvenimenti precedenti; è probabile che fra coloro che avevano discusso testé con Gesù vi fossero agenti di Erode, o che i Farisei stessi agissero per conto di Erode, dato che costui aveva sempre la sua vecchia curiosità riguardo a Gesù (§ 357): la stessa partenza subitanea di Gesù indurrebbe a credere ch’egli volesse sottrarsi bruscamente alle insidiose e maligne investigazioni che venivano dalle due parti. I discepoli tuttavia, che si sentivano lo stomaco vuoto, non vedevano che relazione avesse il fermento con i Farisei e con Erode. Gesù, ricordando loro le due moltiplicazioni dei pani, li esortò a non preoccuparsi del pane materiale bensì nuovamente a star lontani dal suddetto fermento. Allora capirono ch’egli alludeva alle dottrine dei Farisei ed alle astuzie di Erode, che corrodevano lo spirito come un fermento corrode la pasta azima.
• § 394. Le ostilità trovate sulla riva occidentale del lago (e che dovettero essere molto più gravi di quanto risulti dagli scarsissimi accenni degli Evangelisti) avevano indotto Gesù a riportarsi a Bethsaida, forse per cercare animi meglio disposti; ma anche di ciò che avvenne là non ci è trasmesso nulla, salvo la guarigione riferita dal solo Marco (8, 22-26) il quale l’apprese certamente dalla catechesi di San Pietro. «E portano a lui un cieco, e gli raccomandano di toccarlo. E avendo preso il cieco per la mano, lo condusse fuori della borgata, e avendo sputato negli occhi di lui e postegli le mani sopra, lo interrogava: “Vedi alcunché?”. E (quello) guardando in su diceva: “Scorgo gli uomini, perché vedo come alberi che camminano!”. Allora di nuovo gli impose le mani sugli occhi, e (quello) vide distintamente e fu ristabilito e scorgeva nettamente da lontano tutte le cose. E (Gesù) lo mandò a casa sua dicendo: “Non entrar neppure nella borgata!”». Questa vivida descrizione, dovuta a San Pietro non meno che a San Marco, ci fa assistere ad una vera guarigione graduale; forse il cieco non era tale dalla nascita, perché riconosce subito uomini ed alberi, ad ogni modo la visione è dapprima torbida e confusa, e poi perfetta. Perché questa graduazione? Si possono ripetere le ipotesi fatte a proposito del sordomuto (§ 390), la cui guarigione ha qualche analogia con questa; ma, meglio che congetture, non siamo in grado di fare. Quanto all’impiego della saliva, si ritrova anche nelle prescrizioni dei rabbini per le malattie d’occhi; quindi anche questa volta i razionalisti seguaci del Paulus riusciranno a spiegare la guarigione in maniera naturalissima (sic! - Ricciotti sovente usa questo sarcasmo). [Dalla nota 1 alla pagina 467: Vale la pena di riportare alcune ricette rabbiniche, con lo sputo o senza, molto efficaci per il mal d’occhi. Conforme alla tradizione, lo sputo di un primogenito di padre ha virtù curativa (per gli occhi), mentre lo sputo di un primogenito di madre non ha virtù curativa (Baba Bathra, 126 b). Di Rabbi Meir si racconta che, per comporre un dissidio fra moglie e marito, si finse malato d’occhi, cosicché quella moglie, fingendo di curarlo, gli sputò sugli occhi, come appunto voleva il marito (Sotah pal., 16 d). Se si trattava di cataratta lo sputo non era necessario: «Per la cataratta prenda uno scorpione di sette colori, lo secchi all’ombra e ne macini una parte con due parti d’antimonio; ne metta tre piccoli cucchiaini in ogni occhio» (Ghittīm, 69 a). Altre ricette erano assai più complicate].

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, ci sembra opportuno segnalare nuovamente la pubblicazione sul nostro sito dell’inserto gratuito: «La questione del cosiddetto “Papa eretico”» (Cliccare qui). Si tratta di una ricerca suddivisa in 77 capitoli, più la conclusione, in cui viene affrontata la questione del «Papa eretico». Quali sono gli autori cattolici che hanno studiato questa ipotesi? Come hanno pensato di risolvere il problema? La ricerca che Vi segnaliamo intende difendere il dogma cattolico dalle infondate rivendicazioni e dalle abituali falsificazioni storiche degli acattolici e di un certo mondo che si autoproclama “Tradizionalista”. Il zelante Lettore potrà, altresì, approfondire sulle fonti puntualmente menzionate. Nell’editoriale di apertura del numero 138 di Sursum Corda ci siamo occupati della prima moltiplicazione dei pani operata da Nostro Signore Gesù Cristo; mentre oggi l’Abate Ricciotti ci parla della seconda moltiplicazione dei pani e del ministero di Gesù nella Fenicia e nella Decapoli. Ricordiamo che si tratta di episodi storici, realmente accaduti e sotto gli occhi di innumerevoli testimoni (migliaia), non semplicemente di allegorie o di metafore, come vogliono i moderni. Ci è noto, inoltre, che questi racconti storici che riguardano la vita di Nostro Signore giungono a noi dalla notte dei tempi e, sin dall’epoca dei fatti, mai nessuna voce si è levata, nemmeno fra i testimoni oculari, per contestarne l’autenticità e la veridicità. Se qualcosa di falso vi fosse stato in queste narrazioni, dapprima orali e poi tramandate per iscritto, già i testimoni oculari, allora viventi, avrebbero certamente mosso obiezioni ed aspre critiche. Ciò non è mai accaduto e, dunque, la sola evidenza ci dimostra che le obiezioni dei cosiddetti “razionalisti” tutte sono fuorché rivendicazioni razionali. Al contrario, impariamo dalla storia che l’odio dei Farisei nei confronti di Gesù Cristo cresceva di giorno in giorno e di miracolo in miracolo, fino all’epilogo del Golgota che tutto il mondo ragionevole conosce e riconosce. Veniamo finalmente al tema di oggi.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, ci sembra opportuno segnalare nuovamente la pubblicazione sul nostro sito dell’inserto gratuito: «La questione del cosiddetto “Papa eretico”» (Cliccare qui). Si tratta di una ricerca suddivisa in 77 capitoli, più la conclusione, in cui viene affrontata la questione del «Papa eretico». Quali sono gli autori cattolici che hanno studiato questa ipotesi? Come hanno pensato di risolvere il problema? La ricerca che Vi segnaliamo intende difendere il dogma cattolico dalle infondate rivendicazioni e dalle abituali falsificazioni storiche degli acattolici e di un certo mondo che si autoproclama “Tradizionalista”. Il zelante Lettore potrà, altresì, approfondire sulle fonti puntualmente menzionate. Nell’editoriale di apertura del numero 138 di Sursum Corda ci siamo occupati della prima moltiplicazione dei pani operata da Nostro Signore Gesù Cristo; mentre oggi l’Abate Ricciotti ci parla della seconda moltiplicazione dei pani e del ministero di Gesù nella Fenicia e nella Decapoli. Ricordiamo che si tratta di episodi storici, realmente accaduti e sotto gli occhi di innumerevoli testimoni (migliaia), non semplicemente di allegorie o di metafore, come vogliono i moderni. Ci è noto, inoltre, che questi racconti storici che riguardano la vita di Nostro Signore giungono a noi dalla notte dei tempi e, sin dall’epoca dei fatti, mai nessuna voce si è levata, nemmeno fra i testimoni oculari, per contestarne l’autenticità e la veridicità. Se qualcosa di falso vi fosse stato in queste narrazioni, dapprima orali e poi tramandate per iscritto, già i testimoni oculari, allora viventi, avrebbero certamente mosso obiezioni ed aspre critiche. Ciò non è mai accaduto e, dunque, la sola evidenza ci dimostra che le obiezioni dei cosiddetti “razionalisti” tutte sono fuorché rivendicazioni razionali. Al contrario, impariamo dalla storia che l’odio dei Farisei nei confronti di Gesù Cristo cresceva di giorno in giorno e di miracolo in miracolo, fino all’epilogo del Golgota che tutto il mondo ragionevole conosce e riconosce. Veniamo finalmente al tema di oggi.
• § 389. La relazione degli Evangelisti diviene nuovamente saltuaria e aneddotica, e improvvisamente ci presenta Gesù trasferitosi nelle regioni di Tiro e Sidone, ossia nella Fenicia. È la prima volta che Gesù esce fuori dalla Palestina dacché ha cominciato la vita pubblica e forse dacché è nato (salvo la fuga in Egitto durante la sua infanzia). Perché quella uscita? Certamente non fu per portare in terra di pagani la «buona novella», perché ciò non entrava nella sua missione personale e immediata come dichiarerà ben presto egli stesso (Matteo, 15, 24); neppure per sottrarsi a minacce di Antipa, perché di ritorno da Gerusalemme era venuto appunto nel territorio di lui: probabilmente fu per sottrarsi alle persecuzioni dei Farisei venuti a pedinarlo anche da Gerusalemme (§ 387), e, nello stesso tempo, per rifugiarsi in un luogo ove potesse rimanere sconosciuto e tranquillo (cfr. Marco, 7, 24) e provvedere ai suoi discepoli, che avevano tanto bisogno ancora di formazione spirituale. Ma anche in Fenicia, come già era avvenuto a Bethsaida (§ 327), il progetto di tranquillità e raccoglimento svanì. Anche quelle regioni pagane, confinanti con la Palestina, avevano inteso parlare di Gesù come di gran taumaturgo: andavano in giro per il mondo pagano d’allora tanti sedicenti operatori di miracoli, che là non si ebbe alcuna difficoltà ad annoverare fra essi anche il profeta della Galilea; se si attribuivano portenti a Esculapio e ad altri Dei, non c’era ragione di non attribuirli anche al Dio dei Giudei operante per mezzo d’un suo profeta: all’atto pratico si sarebbe giudicata la valentia (la bravura) di ciascuno. Questi, più o meno, dovevano essere i sentimenti d’una donna di Tiro che si presentò a Gesù. Era pagana, e mentre San Marco, che scrive per i Romani, la chiama «siro-fenicia» perché la Fenicia faceva parte della provincia romana di Siria, San Matteo, che scrive per i Giudei, la chiama «cananea» alludendo all’avanzo dell’antica popolazione pagana che abitava nella Siria-Palestina prima degli Ebrei. La donna era spinta a Gesù dal suo cuore di madre: una sua figlioletta - così la chiama San Marco - era malamente vessata dal demonio, e la madre aveva messo la sua speranza in Gesù. Espone ella la sua domanda; Gesù non le risponde parola. L’infelice madre insiste, e segue per la strada il gruppo di Gesù e dei discepoli implorando ad alta voce: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di David!». Era la maniera insistente e rumorosa che usavano in Oriente i mendicanti (§ 351); la donna, che non doveva ritrovarsi in povertà, era spinta ad imitare i mendicanti dal suo cuore di madre. Gesù continua a non udirla; ma dopo un poco i discepoli, seccati di quella pubblicità, dicono a Gesù di allontanarla, invitandolo con ciò implicitamente ad accordare la grazia. Gesù risponde asciuttamente di essere stato inviato soltanto alle pecorelle sperdute della casa d’Israele: i pagani, qual era la donna, sarebbero stati oggetto della missione personale di altri, non di Gesù. La donna interviene direttamente, e rinnova la supplica. Gesù allora le risponde con durezza: «Lascia prima che si satollino i figli. Non sta bene infatti prendere il pane dei figli e gettar(lo) ai cagnolini!». I privilegiati figli erano i Giudei, e i cagnolini erano i pagani. La durezza della risposta fu quasi amarezza di medicina che provochi la reazione, e con ciò la guarigione. La donna reagì rispondendo ancora da madre implorante: «Anzi (sta bene), Signore! Anche i cagnolini sotto la tavola mangiano dalle briciole dei ragazzi!». Era una reazione di fede. Per Gesù fede significava salvezza (§§ 349-351); perciò egli rispose all’implorante: «O donna, grande è la tua fede!» (Matteo, 15, 28). «Per questa parola, va’, è uscito dalla tua figlia il demonio» (Marco, 7, 29). La madre senz’altro credette, e tornata in casa trovò la bambina adagiata sul letto e libera dall’ossessione.
• § 390. Da Tiro Gesù s’inoltrò più a settentrione, fino a Sidone; di là piegò verso oriente, e con imprecisato giro attraverso la Decapoli (§ 4) si riportò nei pressi del lago di Tiberiade (Marco, 7, 31). Di questa peregrinazione randagia, che probabilmente fece trovare a Gesù quell’isolamento con i discepoli che non aveva trovato a Tiro, ci è trasmesso un solo episodio avvenuto nella Decapoli e narrato dal solo Marco (7, 31-37). Fu presentato a Gesù un sordomuto con vive raccomandazioni che gli imponesse le mani. Gesù lo prende in disparte dalla folla, gli mette le dita nelle orecchie, tocca con un po’ della propria saliva la lingua di lui, quindi guarda su in cielo sospirando; infine gli dice: «Ethpĕtah», cioè «Sii aperto»! L’Evangelista trascrive in greco la precisa parola aramaica, ripetuta fedelmente da Pietro nella sua catechesi, pur facendola seguire dalla traduzione greca (§ 133). Il sordomuto restò guarito all’istante. Gesù poi ordinò che non si parlasse dell’accaduto; ma anche questa volta il suo ordine fu poco o punto eseguito. Perché, invece di operare una guarigione immediata come in altri casi, Gesù premise quei vari atti preliminari? Il vecchio Paulus diceva che Gesù applicava qualche medicina naturale (§ 198); soltanto che l’acuto esegeta ha dimenticato di segnalare, a beneficio dell’umanità intera, quale fosse quella medicina. Parlando invece seriamente, si potrà congetturare che la circostanza di trovarsi Gesù nella regione pagana della Decapoli rendesse opportuno quella specie di simbolismo preparatorio, per ragioni che oggi a noi sfuggono; nello stesso tempo è ben probabile che, non potendo il sordomuto udire le parole di Gesù e volendo costui eccitarlo a quella fede che sempre richiedeva in chi domandava un miracolo, si servisse di quegli atti materiali appunto per eccitarlo alla fede viva.
• § 391. A questo punto i Sinottici, salvo Luca, narrano una seconda moltiplicazione di pani, somigliantissima alla prima ed avvenuta egualmente sulla riva orientale del lago di Tiberiade (§ 372). Accorrono attorno a Gesù grandi folle, che rimangono con lui tre giorni: in questo tempo le cibarie di cui si erano provviste sono consumate. Gesù ha compassione di quella gente, e non vuole rinviarla digiuna per timore che venga meno lungo la strada. I discepoli fanno osservare che lì, in luogo deserto, non c’è modo di trovar pane. Gesù chiede quanti pani disponibili ci siano; gli si risponde: «Sette, e pochi pesciolini» (Matteo, 15, 34). Come la prima, volta Gesù prende quel cibo disponibile, lo spezza e lo fa distribuire; tutti mangiano e si satollano, e si raccolgono sette sporte di avanzi. Coloro che avevano mangiato erano «quattromila uomini senza (contare) donne e bambini» (ivi, 38). Ambedue i Sinottici che raccontano, dopo la prima, anche questa seconda moltiplicazione dei pani, la distinguono espressamente dalla prima (Matteo, 16, 9-10; Marco, 8, 19-20). Ciò è più che sufficiente a dimostrare che la primitiva catechesi degli Apostoli, testimoni degli avvenimenti, parlava di due fatti ben distinti; non è però sufficiente a convincere di questa distinzione gli studiosi radicali moderni, che invece pensano allo sdoppiamento di un unico fatto. Ma sta in contrario che i due fatti, se sono somigliantissimi, mostrano anche divergenze sia quanto al tempo e sia quanto ai numeri; le loro somiglianze, invece, sono facilmente giustificate dalla corrispondenza delle circostanze. E se Gesù volle non una, ma due volte, provvedere miracolosamente ai bisogni materiali delle folle ricercanti il regno di Dio, fu per confermare sempre più l’ammonizione del Discorso della montagna: «Cercate prima il regno e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta» (§ 331). Trattandosi dell’urgentissima preoccupazione umana, quella del pane materiale, due esempi tipici, invece di uno solo, erano opportunissimi. Dopo il miracolo Gesù risalì in barca ed approdò, certamente sulla sponda occidentale, ad un luogo che San Matteo (15, 39) chiama Magadan, e invece San Marco (8, 10) Dalmanutha. I nomi sono del tutto sconosciuti, e nonostante varie congetture fatte non si sa a quali luoghi assegnarli. [Dalla nota 1 alla pagina 465: Non è impossibile, sebbene non dimostrato, che Magadan sia una scorrezione grafica di Magdala (§ 303), e che Dalmanutha provenga da una glossa aramaica (...) la quale sarebbe caduta nel testo soppiantandovi il nome geografico (Magdala?)].

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, si segnala sul nostro sito la pubblicazione dell’inserto al numero 140 di Sursum Corda: «La questione del cosiddetto “Papa eretico”» (Cliccare qui per la lettura). Durante la settimana appena conclusa siamo riusciti, grazie a Dio, a fare altre due donazioni: - una di abbigliamento ai cristiani poveri della Caritas; - una di sanitari e arredo bagno ad una famiglia povera del capoluogo. Con l’Abate Ricciotti vediamo, adesso, la vicenda del paralitico di Bezetha.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, si segnala sul nostro sito la pubblicazione dell’inserto al numero 140 di Sursum Corda: «La questione del cosiddetto “Papa eretico”» (Cliccare qui per la lettura). Durante la settimana appena conclusa siamo riusciti, grazie a Dio, a fare altre due donazioni: - una di abbigliamento ai cristiani poveri della Caritas; - una di sanitari e arredo bagno ad una famiglia povera del capoluogo. Con l’Abate Ricciotti vediamo, adesso, la vicenda del paralitico di Bezetha.
• § 384. I fatti precedenti erano avvenuti in Galilea e nell’imminenza della Pasqua: è anche possibilissimo che lungo il loro svolgimento la Pasqua fosse già trascorsa. San Giovanni narra questi avvenimenti al capitolo 6, ma nel precedente capitolo 5 egli ha narrato fatti che si svolgono a Gerusalemme; già accennammo alcune ragioni che raccomandano di considerare i fatti del capitolo 5 come posteriori cronologicamente a quelli del capitolo 6 (§ 177), per cui si tolgono alcune difficoltà testuali senza che s’introducano nuovi inconvenienti. Riprendendo pertanto il capitolo 5 lasciato in sospeso, troviamo che Gesù si è recato a Gerusalemme in occasione di una imprecisata festa dei Giudei; la quale poté esser la Pasqua (§ 177), ma più probabilmente era la Pentecoste dello stesso anno 29; in questo caso si era sul declinare del maggio. A settentrione di Gerusalemme, immediatamente fuori delle mura, stava sorgendo un quartiere nuovo, il quale - come avviene spesso in casi simili - si designava usualmente con un doppio nome, quello generico di Città Nuova o quello specifico di Bezetha (cfr. Flavio Giuseppe, Guerra giud., V, 151; II, 530). In questo quartiere, e precisamente vicino alla vecchia Porta della città chiamata “Probatica” ossia delle pecore, esisteva uno stagno o piscina chiamata anch’essa Bezetha. Vi si raccoglievano le acque di una sotterranea fonte che, come quella di Gihon (Siloe) situata nello stesso versante della città, era intermittente, scaturendo di tempo in tempo; a quelle acque si attribuivano particolari virtù curative, specialmente se un malato riusciva a tuffarvisi appena cominciavano a gorgogliare per il nuovo afflusso. Perciò erano stati costruiti a quadrilatero, torno torno allo stagno, quattro portici, con un quinto trasversale in mezzo, che le ricerche moderne hanno chiaramente riscontrato; in quei portici giaceva una moltitudine di infermi, ciechi, zoppi, rattrappiti, aspettando il movimento dell’acqua.
• § 385. Un giorno Gesù, aggirandosi fra quell’ammasso di miserie, si fermò davanti ad un uomo disteso su un giaciglio; era stato colpito da paralisi 38 anni prima, e si faceva trasportare là sperando la guarigione. Improvvisamente Gesù gli domandò: «Vuoi guarire?». - Naturalmente l’infelice pensò all’acqua; sperava egli in quell’acqua, sì, ma purtroppo non faceva mai in tempo ad entrarvi per primo perché, immobilizzato com’era e non avendo nessuno che lo spingesse dentro non appena cominciava il gorgoglimento, era sempre preceduto da altri. A questo rimpianto del paralitico Gesù non rispose, ma ad un tratto gli ordinò: «Alzati, prendi su il tuo giaciglio e cammina!». E subito l’uomo diventò sano; e prese su il suo giaciglio e camminava (Giov., 5, 8-9). Senonché quel giorno era sabbato. Ecco quindi che zelanti Giudei, al vedere quello scandalo, vanno incontro al risanato, e gli fanno stizzosamente osservare ch’egli non può trasportare di sabbato un giaciglio; pesava ben più quel giaciglio che un fico secco, eppure per i sommi maestri era norma sacrosanta che di sabbato non si poteva trasportare neanche un fico secco (§ 70). La risposta del ripreso fu spontanea: «Quello che mi ha guarito mi ha comandato di prendere il giaciglio e di camminare!». - Gli altri replicarono: «E chi è costui?». Il guarito non lo sapeva, perché non conosceva Gesù, e in quel momento Gesù si era occultato per evitare la folla accorsa al miracolo. Tuttavia più tardi Gesù incontrò nel Tempio il guarito, e gli ri-volse alcune parole d’esortazione. Allora il guarito, temendo forse di apparire un complice agli occhi dei Farisei, andò a riferire loro che autore della guarigione e del comando era stato Gesù. «Per questo perseguitavano i Giudei Gesù, perché faceva queste cose di sabbato». Non solo, dunque, perché aveva comandato di trasportare il giaciglio, ma anche per la guarigione operata; dunque i Farisei di Gerusalemme condividevano pienamente l’opinione dei loro colleghi della Galilea, già manifestata in occasione dell’uomo dalla mano rattrappita (§ 309). Ma Gesù, entrato in discussione, rispose loro: «Il Padre mio fino adesso opera, ed io opero». Per questo, dunque, «ancor più cercavano i Giudei d’ucciderlo, perché non solo abrogava il sabbato, ma diceva suo proprio Padre Iddio, facendo se stesso uguale a Dio». Quanto ad acume di mente, quei Giudei non lasciavano nulla a desiderare. Essi avevano ben seguito il ragionamento di Gesù, ch’era in sostanza questo: come Iddio creatore opera sempre, governando e conservando tutto il creato e non ammettendo alcun riposo sabbatico in questa sua operazione, così e per la stessa ragione io Gesù opero. Dunque - argomentavano quei Giudei - «Gesù fa se stesso uguale a Dio». Avevano afferrato perfettamente il ragionamento di Gesù; ma, poiché la sua conclusione rafforzata dal miracolo abbatteva uno dei capisaldi della casuistica farisaica, ragionamento e conclusione dovevano essere senz’altro rigettati.
• § 386. Seguì un lungo ragionamento di Gesù a difesa della sua missione; nella prima parte (Giov., 5, 19-30) egli illustra la sua eguaglianza col Padre e i còmpiti che ne derivano: di essere dispensatore di vita e giudice universale; nella seconda (ivi, 31-47) sono addotte le testimonianze che accreditano quella missione eppure sono misconosciute dai Giudei. Il ragionamento contiene quelle idee ed espressioni elevate che sono predilette dal IV Vangelo, e che scarsamente o quasi incidentalmente si riscontrano nei Sinottici. Dal punto di vista storico, come già rilevammo (§ 169), la differenza di tono si spiega agevolmente considerando la differenza degli interlocutori con cui Gesù discute: i montanari della Galilea, anche se Farisei, non raggiungevano certamente la finezza intellettuale dei dottori di Gerusalemme, con cui Gesù stava qui a discutere. Queste discussioni gerosolimitane, trascurate dai Sinottici, sono giustamente supplite dal solerte Giovanni. Il lungo ragionamento di Gesù (che dovrà essere letto direttamente nel testo) non convinse affatto i Giudei, i quali ricorsero ad argomenti d’altro genere: ossia decisero che quel fastidioso operatore di miracoli doveva esser soppresso. Cosicché, «dopo ciò Gesù s’aggirava nella Galilea: non voleva infatti aggirarsi nella Giudea, perché i Giudei cercavano d’ucciderlo» (Giovanni, 7, 1, ricollegantesi con 5, 47).
• La tradizione degli anziani. § 387. Trasferendosi in Galilea, Gesù si era sottratto alle insidie dei Farisei di Gerusalemme, ma costoro non abbandonarono però la partita; lassù, nella Galilea, essi non potevano certo spadroneggiare come a Gerusalemme, ma qualcosa potevano sempre fare: ad esempio, pedinare Gesù e raccogliere nuove accuse contro di lui. Difatti, già tornato Gesù in Galilea, si radunarono presso di lui i Farisei ed alcuni degli Scribi venuti da Gerusalemme (Marco, 7, 1). La tattica scelta da questi inviati fu quella di assillare l’irriducibile Rabbi con rilievi ed osservazioni sulla sua condotta, sia per umiliarlo in se stesso sia per screditarlo presso il popolo. Notarono subito che i discepoli del Rabbi non si lavavano le mani prima di mangiare: violazione gravissima della «tradizione degli anziani», gravissimo delitto che equivaleva - secondo la sentenza rabbinica (§ 72) - a «frequentare una meretrice» e attirava la punizione d’essere «sradicato dal mondo». Riscontrato il delitto, lo denunziarono subito al Rabbi, come al responsabile morale. Gesù accetta la battaglia, ma dal caso singolo s’innalza a considerazioni più ampie. Tutte quelle abluzioni di mani e di stoviglie sono prescritte dalla «tradizione degli anziani»: sta bene. Ma gli anziani non sono Dio, e la loro tradizione non è legge di Dio, la quale è infinitamente superiore; perciò in primo luogo bisogna badare alla legge di Dio, e non preferirle mai la tradizione di uomini. Ora, avveniva questo caso. La legge di Dio, ossia il decalogo, aveva prescritto di onorare il padre e la madre, e quindi di sovvenire ai loro bisogni fornendo aiuti materiali. I rabbini, dal canto loro, avevano stabilito la norma che, se un Israelita aveva deciso d’offrire un certo oggetto al Tempio, quell’offerta era inalienabile e l’oggetto non doveva finire che nel tesoro del Tempio: in tal caso bastava pronunziare la parola Qorbān (“offerta” sacra), e l’oggetto designato diventava proprietà sacra del Tempio in virtù di un voto irrevocabile. Spesso perciò accadeva che un figlio, maldisposto verso i suoi genitori, pronunziava Qorbān su tutto ciò ch’egli personalmente possedeva: cosicché i genitori, anche sul punto di morir di fame, non potevano toccar nulla di ciò che il figlio possedeva; costui, invece, continuava tranquillamente a godersi i suoi beni consacrati in voto (anche ciò permettevano i rabbini), fino a che li consegnava effettivamente al Tempio, oppure trovava una scappatoia per non consegnarli (anche qui le scappatoie rabbiniche non mancavano).
• § 388. Stando così le cose, Gesù rispose ai suoi pedinatori: «Bellamente (voi) dispregiate il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra! Mosè infatti disse: “Onora il padre tuo e la madre tua” e “Chi maledice padre o madre sia messo a morte”; voi invece affermate: “Se un uomo dice al padre o alla madre - (Sia) Qorbān ciò che ti potrebbe giovare - (deve mantenere)”; (cosicché) non gli lasciate più nulla da fare al padre o alla madre, abolendo la parola d’Iddio con la tradizione vostra che avete trasmessa» (Marco, 7, 9-13). Accennando poi ad altri casi non venuti in discussione aggiunse: «E cose simili di tal genere ne fate molte (§ 37). La conclusione fu tolta da un passo di Isaia (29, 13): Ipocriti! Bellamente profetò di voi Isaia dicendo: “Questo popolo con le labbra mi onora, ma il cuor loro lungi si tiene da me; e invano mi rendono culto insegnando insegnamenti (che sono) comandi d’uomini”» (Matteo, 15, 7-9). Farisei criticanti avevano avuto la loro parte, e sembra che non rispondessero. Gesù, però, si preoccupò delle turbe che avevano ascoltato, e che avevano la testa infarcita delle minute prescrizioni farisaiche riguardo a purità o impurità di cibi (§ 72); onde rivolgendosi ad esse continuò: «Uditemi tutti e capite! Non c’è nulla esteriormente all’uomo che entrando dentro di lui possa inquinarlo; bensì quelle cose che escono fuori dell’uomo sono quelle che inquinano l’uomo» (Marco, 7, 14-15). Come altre volte, Gesù aveva parlato anche qui da capovolgitore (§ § 318, 368); i Farisei se ne scandalizzarono: i discepoli stessi non capirono bene la forza del capovolgimento anti-farisaico, e quando furono soli con Gesù gliene domandarono la spiegazione. La spiegazione fu elementare: tutto ciò che entra nell’uomo, non raggiunge il cuore ch’è il vero santuario dell’uomo, bensì il ventre, donde i cibi ingenti sono emessi poco dopo; dal cuore dell’uomo invece escono fuori i pensieri malvagi, gli adulterii, le bestemmie e tutto il corteo di male azioni, e queste sole hanno la potenza d’inquinare l’uomo. Per Gesù, dunque, l’uomo era essenzialmente spirito e creatura morale; tutto il resto, in esso, era accessorio e subordinato a quella superiore essenza. [A proposito della parola Qorbān (“offerta” sacra), spiegata in precedenza. San Marco intende conservare la parola Qorbān (mancante nell’odierno testo greco di San Matteo, 15, 5), ma per i suoi lettori di Roma vi aggiunge a guisa di glossa: «cioè donativo»].

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, non è nostra abitudine occuparci di attualità, consapevoli che i moderni e soprattutto i modernisti sono verosimilmente fuoriusciti dal «pozzo d’Abisso» (Ap., IX, 3), dal quale San Giovanni vide salire tal fumo che il sole ne rimase oscurato, uscendone locuste innumerabili a devastare la terra. Papa Gregorio XVI, nella Mirari vos, biasima questi soggetti di «erronea sentenza o piuttosto deliranti», di «corrottissima sorgente», di «errore velenosissimo», la cui dottrina pretende di «ammettere e garantire a ciascuno la libertà di coscienza, la smodata libertà di opinione, che toglie ogni freno che - fino a quel momento - teneva nella via della verità l’uomo: già diretto al precipizio per la sua natura inclinata al male (quest’ultima proposizione è dogma)». Purtroppo il famigerato “Vaticano Secondo” ha evidentemente scoperchiato questo «pozzo d’Abisso» abbracciando ogni sorta di dottrina miasmatica e fraudolenta (dall’antropocentrismo al liberalismo), riconoscendo diritti all’errore e sprofondando, soprattutto a causa della prismatica mostruosità dell’ecumenismo (qui approfondimenti), interi popoli nell’eresia, nell’ateismo, nel neo-paganesimo e finalmente nell’Inferno. Ma già Sant’Agostino esclamava (Ep., 166): «Qual morte peggiore può darsi all’anima della libertà dell’errore?». A causa di questa ineluttabile consapevolezza, è nostra abitudine scansare l’attualità “vaticanosecondista” come la peste. La Chiesa, difatti, insegna e dimostra che anche i peggiori eretici hanno proclamato qualche verità mista ad errori, parimenti avviene nel Modernismo dove, secondo la dinamica del “gioco delle parti”, del “poliziotto buono e del poliziotto cattivo”, della “destra contro la sinistra”, eccetera ... (cfr. Gestire l'opposizione), si ammette ogni flato - profumato o puzzolente che sia - per mera strategia affaristica e per racimolare consensi. Orbene, in questo humus infernale prospera ogni opinione errata, inadeguata, inopportuna e pestifera.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, non è nostra abitudine occuparci di attualità, consapevoli che i moderni e soprattutto i modernisti sono verosimilmente fuoriusciti dal «pozzo d’Abisso» (Ap., IX, 3), dal quale San Giovanni vide salire tal fumo che il sole ne rimase oscurato, uscendone locuste innumerabili a devastare la terra. Papa Gregorio XVI, nella Mirari vos, biasima questi soggetti di «erronea sentenza o piuttosto deliranti», di «corrottissima sorgente», di «errore velenosissimo», la cui dottrina pretende di «ammettere e garantire a ciascuno la libertà di coscienza, la smodata libertà di opinione, che toglie ogni freno che - fino a quel momento - teneva nella via della verità l’uomo: già diretto al precipizio per la sua natura inclinata al male (quest’ultima proposizione è dogma)». Purtroppo il famigerato “Vaticano Secondo” ha evidentemente scoperchiato questo «pozzo d’Abisso» abbracciando ogni sorta di dottrina miasmatica e fraudolenta (dall’antropocentrismo al liberalismo), riconoscendo diritti all’errore e sprofondando, soprattutto a causa della prismatica mostruosità dell’ecumenismo (qui approfondimenti), interi popoli nell’eresia, nell’ateismo, nel neo-paganesimo e finalmente nell’Inferno. Ma già Sant’Agostino esclamava (Ep., 166): «Qual morte peggiore può darsi all’anima della libertà dell’errore?». A causa di questa ineluttabile consapevolezza, è nostra abitudine scansare l’attualità “vaticanosecondista” come la peste. La Chiesa, difatti, insegna e dimostra che anche i peggiori eretici hanno proclamato qualche verità mista ad errori, parimenti avviene nel Modernismo dove, secondo la dinamica del “gioco delle parti”, del “poliziotto buono e del poliziotto cattivo”, della “destra contro la sinistra”, eccetera ... (cfr. Gestire l'opposizione), si ammette ogni flato - profumato o puzzolente che sia - per mera strategia affaristica e per racimolare consensi. Orbene, in questo humus infernale prospera ogni opinione errata, inadeguata, inopportuna e pestifera.
• La recente questione del Pater. Si legge che l’attuale occupante materiale la Sede di Pietro (il divulgatore di eresie non può essere considerato formalmente Papa - qui approfondimenti), Giorgio Bergoglio, avrebbe «cambiato la preghiera del Padre nostro», così i sedicenti “Tradizionalisti”, per reazione, si sono stracciati le vesti rimpiangendo il “dotto Benedetto XVI”. Questo nostro intervento intende restituire verità ai fatti. La nuova, goffa (cosa intendono dimostrare? - qui i parametri di vera esegesi), versione del Pater... è, difatti, atto ufficiale del Modernismo almeno dal 2008, da quando, cioé, sotto l’occupazione altrettanto materiale di Giuseppe Ratzinger, la nuova “Bibbia CEI” traduce San Matteo VI, 13 in «... non abbandonarci alla tentazione ...». Con buon pace dei sedicenti “Tradizionalisti” (la cui dottrina pan-luterana si riassume in: «Il Papa sbaglia, quindi per salvarmi devo disobbedire al Papa» - sic! - qui le proposizioni luterane condannate dalla Chiesa), l’evidenza ancora una volta dimostra che il gesuita villano si limita squisitamente a propagandare con maggior risalto mediatico i già esistenti errori enunciati o permessi dal fine teologo. Ciò premesso, veniamo all’argomento del nostro editoriale d’apertura: «Gesù cammina sull’acqua. Discorso sul pane vivo», dagli scritti dell’Abate Ricciotti.
• § 376. Quando la barca si staccò da terra era notte fatta; prima d’imbarcarsi i discepoli probabilmente attesero, nella speranza che Gesù liberatosi dalle folle li raggiungesse, ma non vedendo alcuno ed essendo già tardi presero il largo. L’aveva comandato il Maestro, e perciò obbedivano; ma pienamente soddisfatti non si sentivano, sia perché il Maestro si era staccato da loro, sia perché quel viaggio notturno non era né piacevole né sicuro. Spesso sul lago di Tiberiade, in primavera avanzata, dopo una giornata calda e tranquilla, verso il tramontare del sole si scarica dalle montagne sovrastanti un vento freddo e violento in direzione meridionale, che continua e cresce sempre più fino al mattino, rendendo la navigazione assai difficile. Così avvenne quella notte; sorpresi di fianco dal vento e spinti verso mezzogiorno invece che verso ponente, i navigatori ammainarono la vela, ormai nociva e pericolosa, e fecero forza sui remi. Ma tra lo sballottamento delle onde la barca avanzava male, e alla quarta vigilia della notte, ossia dopo le 3 del mattino, s’erano fatti soltanto 25 o 30 stadi di tragitto, ossia dai 4,5 chilometri ai 5,5: mancava forse ancora un buon terzo del tragitto prima di raggiungere l’approdo. La stanchezza veniva ad accrescere il malumore dei naviganti. Ad un tratto, d’in mezzo alla foschia mattinale e agli spruzzi delle onde, essi vedono a pochi passi dalla barca un uomo che cammina sull’acqua. Un rematore dà un grido, e addita. Tutti guardano. Indubbiamente è una figura umana: sembra camminare di conserva con la barca e volerla oltrepassare. No: piega invece verso la barca per raggiungerla. «Tutti allora si turbarono dicendo: “È un fantasma!”, e dalla paura gridarono. Subito però Gesù parlò ad essi dicendo: “Coraggio! Sono io! Non abbiate paura!”» (Matteo, 14, 26-27). Se era veramente lui, non c’era da meravigliarsi: chi poche ore prima aveva moltiplicato i pani, poteva ben camminare sulle onde. Ma era veramente lui? Pietro volle esserne sicuro: «Signore, se sei tu, comanda che io venga a te sulle acque!». Gesù rispose: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, camminò sull’acqua e raggiunse Gesù. L’esperto pescatore di Cafarnao non si era mai inoltrato sull’acqua in quella maniera; ma appunto la sua esperienza lo tradì, e quando si trovò tutto solo avvolto tra i flutti turbinanti si spense in lui l’ardore di fede che lo aveva fatto scendere dalla barca e rimase soltanto l’esperto pescatore, il quale perciò ebbe paura. La paura lo portava a fondo; il pauroso gridò: «“Signore, salvami!”. E subito Gesù, stese la mano, lo prese e gli dice: “Scarso di fede, di che cosa dubitasti?”». Ambedue salgono in barca, il vento dà subito giù, e ben presto l’approdo è raggiunto.
• § 377. Nel breve tragitto tranquillo ci fu nella barca un inconsapevole stordimento. I naviganti si gettarono ai piedi del nuovo imbarcato esclamando: «Veramente di Dio sei figlio!». Non dicevano che era il “figlio di Dio” per eccellenza, il Messia; ma certo lo proclamavano un uomo straordinario, a cui Dio aveva elargito i più ampi favori. Appunto qui, però, rimaneva una macchia oscura: a voler inquadrare questo nuovo prodigio insieme con gli altri dentro una grande visione riassuntiva, quei naviganti, che avevano tuttora lo stomaco ripieno del pane miracoloso e gli occhi ripieni del presunto fantasma, non riuscivano a dare un giudizio complessivo sull’intera visione. Ripetevano essi dentro di sé l’identico ragionamento fatto poche ore prima dalle folle, che avevano mangiato il pane moltiplicato: «Se costui sa operare miracoli così potenti, perché non si decide ad agire come potente e re messianico» d’Israele? (§ 374). Chi mai lo trattiene? «E molto di più stupivano in se stessi; non avevano infatti capito riguardo a(ll’avvenimento dei) pani, bensì il loro cuore era indurito» (Marco, 6, 51-52). Lo sbarco avvenne a Gennesareth, la regione chiamata oggi el-Ghuweir e descritta come ubertosissima da Flavio Giuseppe (Guerra giud., III, 516 segg.): stava, come Tabgha (§ 375, nota), circa 3 chilometri più a sud di Cafarnao. Probabilmente Cafarnao fu evitata per non provocare le solite manifestazioni clamorose e pericolose. Tuttavia l’arrivo di Gesù fu subito segnalato, e tosto cominciò l’affluenza di malati e d’imploranti dai luoghi vicini, «e quanti lo toccavano erano salvati» (Marco, 6, 56). Molti della zona di Cafarnao erano intanto rimasti a Bethsaida sul posto della moltiplicazione dei pani. Sopraggiunta la notte, Gesù era scomparso e i discepoli senza di lui erano salpati sull’unica barca che stava sulla riva: non restava dunque niente da fare sul posto. Passata la notte alla meglio, la mattina seguente alcuni di quei ritardatari approfittarono di alcune barche venute là a pescare da Tiberiade (Giovanni, 6, 23) e si fecero trasportare a Cafarnao; altri presero altre direzioni. Giunti a Cafarnao, si dettero a cercare Gesù con la speranza forse di riprendere il fallito progetto di proclamarlo re, e d’indurlo o ad una piena accettazione ovvero ad un aperto rifiuto. Lo ritrovarono infatti come avevano previsto, ma probabilmente dopo due o tre giorni, durante i quali Gesù s’era trattenuto nella zona di Gennesareth; allora, tanto per attaccare discorso, gli dissero: «Rabbi, quando sei venuto qua?» (Giovanni, 6, 25).
• § 378. Con questa domanda ha inizio il celebre discorso sul pane vivo, riportato dal solo Giovanni (6, 25-71): noi già sappiamo che questo metodo integrativo è proprio al IV Vangelo nei confronti con i Sinottici (§ 164). Nel discorso ricompaiono tratti caratteristici a Giovanni, già rilevati nei due dialoghi di Gesù con Nicodemo e con la Samaritana: specialmente col dialogo della Samaritana (§ 294), il discorso sul pane vivo mostra varie affinità, anche di sviluppo logico. Tuttavia, analizzando minutamente la compagine del discorso stesso, appaiono qua e là delle saldature o riconnessioni che attestano un lavoro redazionale: se il Discorso della Montagna offrì ai due Sinottici che lo riportano, e specialmente a Matteo, occasione di esercitare la loro operosità redazionale (§ 317), un’eguale occasione fu colta e impiegata da San Giovanni per il Discorso sul pane vivo. In esso, infatti, si distinguono chiaramente tre parti: nella prima (6, 25-40) Gesù ha per interlocutori gli abitanti della regione di Cafarnao che avevano assistito alla moltiplicazione dei pani; nella seconda parte (6, 41-59) intervengono come interlocutori i Giudei, e in fondo una nota redazionale avverte che le precedenti parole di Gesù furono pronunziate nella sinagoga di Cafarnao; infine la terza parte (6, 60-71) riporta insieme con poche parole di Gesù vari fatti che furono conseguenze dei precedenti ragionamenti, le quali conseguenze non avvennero immediatamente ma richiesero senza dubbio un tempo più o meno lungo per svilupparsi. Dunque il discorso, quale oggi l’abbiamo, è una «composizione», la quale ha unito con un nucleo cronologicamente compatto altre sentenze di Gesù cronologicamente staccate ma riconnesse con quel nucleo dall’analogia dell’argomento: questa maniera di «composizione», in parte cronologica e in parte logica, era usuale alla «Catechesi» di San Giovanni non meno che a quella degli altri Apostoli, e gli antichi Padri o espositori l’hanno riconosciuta ed ammessa ben prima degli studiosi recentissimi (§ § 317, nota; 360, nota prima; 415, nota).
• § 379. La prima parte del discorso avviene a Cafarnao, ma fuori della sinagoga. Coloro che ricercano Gesù l’incontrano, forse per strada, e gli rivolgono la suddetta domanda: «Quando sei venuto qua?» - La mira segreta è ben altra. Gesù, riferendosi alla mira segreta e avvicinandosi alla sostanza della questione, risponde: «In verità, in verità vi dico, mi cercate non già perché vedeste segni, bensì perché mangiaste dai pani e foste satollati». I segni erano i miracoli fatti da Gesù a comprova della sua missione, e in tanto sarebbero stati efficaci come segni in quanto avessero indotto gli spettatori ad accettare quella missione: e invece quegli abitanti di Cafarnao che parlavano con Gesù erano stati spettatori di molti miracoli ma non li avevano accettati come segni, avevano goduto del beneficio materiale ma non avevano accolto il beneficio spirituale; ultimamente avevano mangiato il pane miracoloso ma subito appresso si erano infervorati per il regno politico del Messia. Perciò Gesù prosegue: «Producetevi non già il nutrimento che perisce, bensì il nutrimento permanente in vita eterna il quale vi darà il figlio dell’uomo: costui infatti il Padre, Iddio, segnò del suo sigillo». Il sigillo era lo strumento più importante nella cancelleria d’un re. Quegli ascoltatori di Gesù avevano tentato, poco prima, di eleggere Gesù “re”; ma qual re sarebbe stato egli dopo siffatta elezione? Donde la sua autorità regale? La sua autorità egli l’aveva ricevuta, non da uomini, ma dal Padre, Iddio. Gl’interlocutori replicano: «Che dobbiamo fare per produrre le opere d’iddio?». Con questa domanda si riferiscono chiaramente all’esortazione di Gesù di «produrre... il nutrimento permanente in vita eterna». Gesù risponde: «Questa è l’opera di Dio, che crediate in chi egli inviò»; che crediate cioè in lui anche quando la sua parola delude le vostre speranze e fa svanire i vostri sogni, che crediate nel suo regno anche se è la negazione totale del vostro regno. Insistettero gli altri: «Qual segno fai dunque tu, affinché vediamo e crediamo in te? Che produci? I padri nostri mangiarono la manna nel deserto, conforme a ciò che sta scritto: “Pane del cielo dette loro da mangiare”» (Esodo, 16, 4; Salmo, 78, 24). L’allusione mirava a due termini e li contrapponeva fra loro: da una parte l’opera di Mosè e il suo «segno», quello d’aver fatto scendere la manna dal cielo; dall’altra parte, l’opera di Gesù e il suo recentissimo «segno», quello d’aver moltiplicato i pani a Bethsaida. Fra i due termini del confronto, gl’interlocutori mostrano di preferire l’opera e il «segno» di Mosè all’opera e al «segno» di Gesù; gli altri «segni» di Gesù non sono neppur chiamati in causa, quasicché non avessero alcuna efficacia dimostrativa riguardo alla fede e quasi per dar ragione alle prime parole di Gesù, «mi cercate non già perché vedeste segni, bensì perché mangiaste dai pani e foste satollati». Gesù ad ogni modo è riprovato e posposto a Mosè: se egli vuole ottenere fede nel suo invisibile e impalpabile «regno», faccia dei «segni» almeno eguali a quelli di Mosè.
• § 380. La discussione è giunta ad un bivio, e bisogna decidersi fra i due termini del confronto: da una parte Mosè e la sua opera, dall’altra parte Gesù e il suo «regno». Quale di questi due termini è superiore? Qui sta il nodo della questione, e Gesù l’affronta in pieno: «In verità, in verità vi dico, non già Mosè vi ha dato il pane dal cielo, bensì il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero; il pane d’iddio infatti è colui che discende dal cielo e dà vita al mondo». Il giudizio dato dagli interlocutori è capovolto: dei due termini del confronto Gesù è tanto superiore a Mosè quanto il cielo è superiore alla terra; Gesù, non già Mosè, discende dal cielo e dà vita al mondo, egli è veramente il pane dal cielo. L’esposizione è interrotta un istante da un’esclamazione degl’interlocutori: «Signore, dacci sempre questo pane!»; la quale esclamazione è gemella di quella della Samaritana riguardo all’acqua, e dimostra che in un caso e nell’altro si pensava ad oggetti materiali. Replicò Gesù: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non sentirà fame, e chi crede in me non sentirà sete giammai. Ma io vi dissi che e mi avete veduto e non credete». Con altre affermazioni di Gesù (Giov., 6, 37-40) si chiuse questo primo incontro.
• § 381. Dell’incontro e delle affermazioni di Gesù si dovette parlar molto in paese, anche con desiderio di avere spiegazioni in proposito e di offrire a Gesù opportunità di darle. Probabilmente i fatti si svolsero come a Nazareth (§ 358), e fu offerta a Gesù occasione di spiegarsi nella prima riunione sinagogale che si tenne in paese, perché le nuove dichiarazioni furono fatte da lui «insegnando nella sinagoga in Cafarnao» (6, 59). Se però è detto, a principio di questa nuova parte del discorso, che i Giudei mormoravano di lui, non è necessario supporre che un gruppo di accaniti Farisei fossero giunti apposta dalla Giudea per dar battaglia a Gesù: i «Giudei», nello stile di San Giovanni, sono in genere i connazionali di Gesù che hanno respinto l’insegnamento di lui. Questi Giudei, pertanto, mormoravano di Gesù perché disse: «Io sono il pane disceso dal cielo»; e dicevano: «Non è costui Gesù il figlio di Giuseppe, di cui conosciamo il padre e la madre?». Come mai adesso dice: «Dal cielo sono disceso»? Gesù, dopo alcune considerazioni più ampie, torna sulla precedente questione del pane: «Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono nel deserto la manna e morirono; (invece) questo è il pane discendente dal cielo, affinché taluno mangi di esso e non muoia. Io sono il pane vivente, il disceso dal cielo: se alcuno mangi di questo pane, vivrà in eterno; e il pane poi che io darò, è la mia carne per la vita del mondo». Al suono di tali parole i Giudei, mal disposti quali erano, avevano da strabiliare ben più che Nicodemo e la Samaritana. Se a questi due antichi interlocutori Gesù aveva parlato di «rinascita dallo Spirito» e di «acqua zampillante in vita eterna», siffatte espressioni potevano a prima vista intendersi in senso simbolico: come in senso simbolico poteva intendersi adesso l’espressione «pane di vita» la prima volta che Gesù l’aveva impiegata ed applicata a se stesso. Ma Gesù non si era limitato a quella prima volta; egli era tornato sopra quella espressione e, quasi per escludere a bella posta l’interpretazione simbolica, aveva affermato che quel pane era «la sua carne» data per la vita del mondo. Questa precisazione non era tollerabile in un parlare metaforico: parlando della sua «carne-pane», Gesù non si esprimeva simbolicamente. Così ragionarono, con perfetta logica, gli uditori della sinagoga di Cafarnao, i quali perciò si dettero a discutere fra loro: «Come può darci costui la (sua) carne da mangiare?». Il momento era davvero decisivo e solenne; a Gesù spettava in quel momento di precisare ancor meglio la sua intenzione, esprimendo con limpidezza cristallina se le sue parole dovevano esser interpretate come metaforiche ovvero come piane e reali.
• § 382. La limpidezza cristallina si ebbe. Gesù, udita la discussione degli uditori, soggiunse: «In verità, in verità vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell’uomo e beviate il sangue di lui, non avete vita in voi stessi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò all’estremo giorno. La carne mia infatti è vero nutrimento, e il sangue mio è vera bevanda; chi mangia la mia carne e beve il mio sangue in me rimane, e io in lui. Come inviò me il Padre vivente e io vivo per il Padre, (così) anche chi mangia me, egli pure vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non (avverrà) come (a) i padri (vostri che) mangiarono (manna) e morirono: chi mangia questo pane, vivrà in eterno». Ascoltate queste spiegazioni, gli uditori non ebbero più il minimo dubbio; né, in realtà, avrebbero potuto averlo. Le parole ascoltate saranno state dure quanto si vuole, ma più chiare e precise di così non potevano essere; Gesù aveva nettamente e ripetutamente affermato che la sua carne era vero cibo e il suo sangue vera bevanda, e che per avere vita eterna bisognava mangiare di quella carne e bere di quel sangue. Non era possibile equivocare. Non equivocarono, infatti, gli ostili Giudei, che videro confermata la loro prima interpretazione; non equivocarono neppure molti dei discepoli stessi di Gesù, che trovarono scandalo in quelle parole. Molti pertanto dei discepoli di lui, avendo ascoltato, dissero: «Duro è questo discorso; chi può ascoltarlo?». L’aggettivo duro qui vale quasi per «ripugnante», «stomachevole», tanto che non si può ascoltarlo senza un certo ribrezzo. Evidentemente si era pensato ad un banchetto da antropofagi. Gesù in realtà non aveva precisato la maniera in cui si sarebbe mangiata la sua carne e bevuto il suo sangue; ma perfino davanti alla possibilità dell’interpretazione antropofaga e dello scandalo, egli non retrocedette d’un sol passo e non ritirò una sola parola. Sapendo che i suoi discepoli mormorano di ciò, disse loro: «Ciò vi scandalizza? Se dunque contempliate il figlio dell’uomo che risale dov’era prima? Lo spirito è il vivificante, la carne non giova a nulla; i detti ch’io ho parlati a voi sono spirito sono vita». L’ultimo periodo fu ritenuto sufficiente da Gesù per dissipare il timore del banchetto da antropofagi: i suoi detti erano spirito e vita. Ma gli stessi detti conservavano il loro pieno valore letterale, senza traslati metaforici; l’indispensabile era aver fede in lui, e l’ultimo argomento di tale fede sarebbe stato contemplare il figlio dell’uomo risalente al cielo, donde era disceso quale pane vivente. Pane celestiale, carne celestiale. Chi avesse avuto tale fede, avrebbe visto in che maniera si poteva veramente mangiare la carne di lui e bere il suo sangue senza ombra di antropofagia.
• [Dalla nota 1 alla pagina 455: Le infinite discussioni sollevate su questo discorso al tempo della (pretesa) Riforma protestante appartengono ormai alla storia del cristianesimo. L’interpretazione degli antichi protestanti, la quale nel pane di vita non scorgeva se non un’allegoria della redenzione e della dottrina di Cristo, è oggi abbandonata da moltissimi fra i più insigni studiosi protestanti (sebbene nel secolo XVI trovasse alcuni sostenitori anche fra i cattolici). Gli studiosi radicali odierni hanno svuotato il discorso nella maniera precisamente opposta: il discorso per essi allude indubbiamente al rito dell’Eucaristia, ma appunto ciò dimostra - a loro dire - che sarebbe un’invenzione dovuta all’Evangelista o alla sua catechesi, e non fu mai pronunziato da Gesù. In altre parole, l’unico punto su cui vanno d’accordo i radicali odierni e quelli di quattro secoli fa è, come sempre, nel dar torto alla tradizione: ma fuor di questo punto, quando cioè devono indicare per qual motivo essa avrebbe torto, sono in totale disaccordo fra loro].
• § 383. La reazione dei discepoli al discorso udito, nonostante le spiegazioni aggiuntevi da Gesù, non fu soltanto verbale: «da questo (tempo in poi) molti dei suoi discepoli si ritrassero addietro e non camminavano più con lui». Avvenne dunque una defezione, che allontanò da Gesù molti dei suoi discepoli; i dodici Apostoli invece rimasero fedeli. Un giorno, quando la defezione era già assai progredita, Gesù disse ai dodici: «Anche voi forse volete andarvene?». Gli rispose Simone Pietro: «Signore, da chi andremo? Parole di vita eterna (tu) hai; e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il santo d’Iddio» (Giovanni, 6, 67-69). Non è fortuita in uno scrittore quale San Giovanni quella consecuzione di pensiero, secondo cui i dodici avevano creduto e poi conosciuto. Su questo argomento Giovanni non torna più, e l’annunzio del pane di vita non risulta attuato in tutto il resto del suo Vangelo, perché egli sarà il solo Evangelista che non racconterà l’istituzione dell’Eucaristia alla vigilia della morte di Gesù. Ma appunto in questa sua omissione sta la più chiara indicazione che l’annunzio è stato attuato nella forma spirituale predetta. Giovanni omette l’istituzione dell’Eucaristia perché già narrata da tutti e tre i Sinottici e già notissima agli uditori della sua catechesi (§ 165); ha invece narrato l’annunzio, perché i Sinottici l’avevano omesso (§ 164).

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, siamo giunti finalmente alla seconda Pasqua pubblica di Nostro Signore e, sempre con l’ausilio della preziosa «Vita di Gesù Cristo» dell’Abate Ricciotti, vedremo i principali avvenimenti narrati dagli Evangelisti, fino all’ultima Festa dei tabernacoli.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, siamo giunti finalmente alla seconda Pasqua pubblica di Nostro Signore e, sempre con l’ausilio della preziosa «Vita di Gesù Cristo» dell’Abate Ricciotti, vedremo i principali avvenimenti narrati dagli Evangelisti, fino all’ultima Festa dei tabernacoli.
• § 372. Durante gli avvenimenti fin qui visti era passato del tempo, e si doveva stare allora a circa la metà di marzo; perciò era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei (Giovanni, 6, 4), cioè quella dell’anno 29, seconda Pasqua del ministero pubblico di Gesù (§ 177). A questo punto, quasi contemporaneamente, giungono a Gesù gli Apostoli di ritorno dalla loro missione (§ 354) e la notizia della morte di Giovanni il Battista (§ 355). I primi, oltre ad essere spossati dalle fatiche sostenute, erano così assillati da folle accorrenti a loro che neppur di mangiare avevano tempo (Marco, 6, 31). D’altra parte la tragica fine di Giovanni aveva profondamente attristato Gesù. In conseguenza quindi d’ambedue i fatti, egli prese con sé i reduci dalla missione e si allontanò con loro da Cafarnao in cerca di riposo per essi e di solitudine per sé, e partirono in barca per un luogo deserto in disparte (Marco, 6, 32) che stava nei pressi di una città chiamata Bethsaida (Luca, 9, 10, greco). Era la città che poco prima il tetrarca Filippo aveva ricostruito interamente chiamandola Giulia (Bethsaida-Giulia) in omaggio alla famigerata figlia di Augusto (§ 19); era anche la patria delle due coppie di fratelli, Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni (§ 279). Il luogo sembrava adatto. Non apparteneva alla giurisdizione di Antipa ma a quella di Filippo, e quindi Antipa non avrebbe potuto agire contro di Gesù del quale già era sospettoso come di un Giovanni risuscitato (§ 357); inoltre la città, situata di là dal Giordano poco sopra il suo sbocco nel lago, aveva più ad oriente una vasta estensione quasi disabitata che poteva offrire solitudine e riposo; infine dai pressi di Cafarnao, attraversando il lago obliquamente, si sarebbe raggiunto dopo breve navigazione il posto designato. Ma la partenza di Gesù con il suo gruppo fu notata dalle folle di Cafarnao, le quali dalla direzione presa dalla barca capirono facilmente qual era la mèta; allora molti presero la via di terra, risalendo lungo la curva settentrionale del lago e attraversando il Giordano nel punto dove il fiume entra nel lago, e così riuscirono a prevenire la barca di Gesù. Quando egli scese a terra nella solitudine d’oltre Bethsaida-Giulia trovò le turbe che già l’attendevano. Probabilmente, durante il viaggio a piedi, i volenterosi partiti da Cafarnao erano cresciuti di numero; nell’imminenza infatti della Pasqua tutta la regione era già percorsa da carovane dirette a Gerusalemme e composte di Galilei orientali, i quali colsero quell’occasione per ascoltare di nuovo Gesù che non vedevano da qualche tempo. L’incontro con tanta folla fece subito svanire il progetto di solitudine e di riposo; tanto più che Gesù, appena vide i volenterosi accorsi, si impietosì su di essi e si dette a guarire miracolosamente gli infermi e parlare a tutti del regno di Dio. Frattanto le ore passavano; il gruppo di Gesù doveva esser partito da Cafarnao di buon mattino e nella stessa mattinata era approdato alla sponda opposta: ma l’incontro con le turbe, le implorazioni dei malati e degli infelici, le loro guarigioni, i discorsi sul regno, avevano consumato l’intera giornata e già si era fatta molta ora (Marco, 6, 35). Le turbe, dimentiche di tutto, non si stancavano né si staccavano da Gesù; però i pratici Apostoli s’avvicinarono a Gesù e gli fecero osservare che il posto era solitario, l’ora tarda, e quindi sarebbe stato opportuno licenziare le turbe affinché si sparpagliassero nelle borgate più vicine per trovarsi un po’ di vitto e di alloggio. Gesù rispose: «Date voi (stessi) da mangiare a loro!». La risposta appariva molto strana: prima di tutto non c’era pane, e poi forse non c’era neppure denaro sufficiente per comprarlo; Filippo, fatto un calcolo sommario, fece osservare un po’ ironicamente che neppure se ci fosse stato pane per la rilevante somma di duecento denari d’argento (più di duecento lire oro) sarebbe bastato per darne appena un boccone a ciascuno. Gesù non rispose ai calcoli di Filippo, ma cambiando tono chiese: «Quanti pani avete?». Rispose Andrea fratello di Pietro: «C’e’ qui un ragazzetto che ha cinque pani d’orzo e due pesci»; anch’egli però volle aggiungere all’informazione un serio richiamo alla realtà: «ma che è ciò per tanti?». Ma neanche ai calcoli di Andrea replicò Gesù.
• § 373. Tutt’attorno si stendeva a perdita d’occhio la prateria, in pieno rigoglio alla stagione pasquale d’allora: sembrava un mare di verde ondeggiante, da cui affioravano qua e là a guisa di Cicladi (come isole, ndR) i raggruppamenti della folla. A un tratto Gesù ordinò agli Apostoli che facessero adagiare la folla sull’erba; quando tutti furono adagiati in tanti circoli, ciascuno di una cinquantina o di un centinaio di persone, l’aspetto della scena si delineò più nitidamente: il testimone Pietro, che l’avrà descritta con predilezione nella sua catechesi orale, la rassomiglia a uno sterminato giardino in cui gli adagiati formavano aiuole (ed) aiuole e l’interprete di Pietro ripete a parola la sua comparazione (Marco, 6, 40). Ma ancora non si vedeva a che mirasse quell’ordine: adagiarsi sui divani avveniva nei conviti di lusso (§ 341), ma lì fra quell’erba quali vivande si potevano imbandire? Gesù però, «presi i cinque pani e due pesci, avendo guardato su nel cielo, benedisse e spezzò i pani, e (li) dava ai discepoli affinché apprestassero a quelli: anche i due pesci spartì a tutti». E mangiarono tutti e furono satollati. Il carattere tradizionale del convito giudaico era stato osservato sia nell’adagiarsi, sia nella preghiera premessa e nello spezzamento del pane che spettavano al padre di famiglia; ma fu osservato anche al termine con la raccolta degli avanzi, la quale si praticava ad ogni desinare giudaico: «e raccolse i pezzi con cui si riempirono dodici sporte, e (gli avanzi) dei pesci». Con la comodità del ripartimento in «aiuole» fu facile fare un calcolo della folla: ed erano coloro che mangiarono i pani cinquemila uomini (Marco, 6, 41-44); Matteo conferma ch’erano cinquemila, ma da antico gabelliere ama precisare: senza (contare) donne e bambini (Matteo, 14, 21). Nel Discorso della montagna Gesù aveva ammonito: «Non vi affannate dicendo “Che mangeremo?” o “Che berremo?” o “Di che ci revestiremo?” (...) sa invero il vostro Padre celeste che abbisognate di tutte queste cose. Cercate invece prima il regno e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta» (§ 331). Questa ammonizione si dimostrò esattissima in quella prateria di Bethsaida. Tutta quella gente nella intera giornata aveva cercato il regno e la sua giustizia, ossia il pane dello spirito, ma senza pensarvi ritrovò anche il pane del corpo; tuttavia questo pane del corpo fu un soprappiù secondarissimo, un episodio accessorio della scena, mentre il fatto eccezionale di quella giornata fu la ricerca generosa del regno e la sua trionfale espansione. Giustamente fu messo in rilievo - e proprio da un razionalista (Loisy) - che tutta questa narrazione nel IV Vangelo è dominata dall’idea del Cristo considerato come pane di vita spirituale. [Tuttavia l’acuta osservazione (del Loisy) è tendenziosa, e finisce totalmente guastata dalla tesi a cui (egli) mira. Per il Loisy la moltiplicazione dei pani sarebbe un’allegoria mistica (benché sia riportata anche da tutti e tre i Sinottici) e vorrebbe simboleggiare la stessa dottrina del successivo discorso di Gesù sul pane vivo; ma né la moltiplicazione e né il discorso sarebbero realtà storiche. (Secondo Loisy, lugubre antesignano della pseudo-esegesi dei modernisti, i fatti miracolosi narrati dagli Evangelisti sarebbero ordinariamente metafore o allegorie, e non avrebbero nulla di veramente storico, ndR). (Anche in questo caso, la conclusione del Loisy) è la solita petitio principii («petizione di principio» o «risposta con la premessa»: indica un ragionamento fallace nel quale la proposizione che deve essere provata è supposta implicitamente o esplicitamente nelle premesse, ndR). Dalla nota 1 alla pagina 445]. Vista l’importantissima nota, torniamo al corpo del testo: E appunto questo dovevamo aspettarci dal «Vangelo spirituale» (§ 160), il quale molto più che agli episodi vistosi e sonori bada ai sottili insegnamenti profondi, e mette particolarmente in luce le analogie tra fatti materiali ed i princìpi spirituali.
• § 374. Egualmente però dovevamo aspettarci che le folle rimasero colpite molto più dal fatto materiale che dal resto. Avevano esse inteso parlare la giornata intera del «regno» e ne erano state commosse, infine avevano visto moltiplicarsi fra le mani di quel banditore del «regno» il cibo dei loro corpi. La conclusione fu immediata, in conformità con le loro aspettative messianiche (§ 362): chi operava prodigi siffatti, poteva altrettanto facilmente sterminare eserciti nemici come Isaia, poteva ricoprire di tenebre un’intera regione come Mosè, attraversare fiumi all’asciutto come Giosuè, correre vittorioso su tutta la terra come il pagano Ciro chiamato “messia” dallo stesso Dio d’Israele (Isaia, 45, 1), poteva insomma attuare in pochissimo tempo il tanto sospirato «regno del Messia» a maggior gloria d’Israele. Dunque, egli era l’atteso Messia: la sua potenza lo rivelava indubbiamente tale. Davanti ad una conclusione così chiara e stringente, quegli ardenti Galilei passarono subito all’azione: «Gli uomini pertanto, veduto il miracolo che aveva fatto dicevano: “Questo è veramente il profeta veniente (§ 339) nel mondo!”. Gesù dunque, conosciuto che stavano sul punto di venire a rapirlo affin di farlo re, si appartò di nuovo nella montagna egli solo» (Giovanni, 6, 14-15). Questa notizia, preziosa per il suo bel colorito storico, è anche più preziosa perché trasmessa dal solo Evangelista che oggi si vorrebbe (a torto) far passare per un incessante ideatore di astratte allegorie; qui invece abbiamo la realtà storica più cruda, proprio quella realtà che Gesù aveva previsto da lungo tempo e che si era proposto di evitare con la sua condotta prudenziale (§ 301).
• § 375. Anche quella sera Gesù si era premunito contro il pericolo. Appena terminata la refezione, prima ancora che i focosi elettori avessero deciso la proclamazione regale, «Gesù subito costrinse i discepoli suoi ad entrare nella barca e a preceder(lo) al di là alla volta di Bethsaida, finché egli licenzia la turba» (Marco, 6, 45). In altre parole Gesù, avendo notato l’eccitazione della folla e riconosciutine gl’intendimenti, volle in primo luogo preservarne i suoi discepoli rinviandoli avanti a sé a Cafarnao, e inoltre rimanere solo per esser più spedito nel suo contegno con gli eccitati messianisti politici. Il suo contegno da solo, come ci ha detto l’altro Evangelista, fu quello già seguito altre volte (§ 301), cioè di sottrarsi nascostamente; buona parte della notte fu poi passata da lui sulla montagna a pregare (Matteo, 14, 23). Frattanto i discepoli navigavano verso Cafarnao.
• [Dalla nota 1 alle pagine 446-448: Cafarnao è nominata espressamente come meta dei naviganti da San Giovanni (6, 17). Ma poiché nel citato Marco (6, 45) Gesù, stando sulla prateria a oriente di Bethsaida, ordina ai discepoli di precederlo al di là alla volta di Bethsaida, si è supposto che esistesse un’altra Bethsaida sulla riva occidentale del lago, oltre a Bethsaida-Giulia a oriente del Giordano. Senonché né la città è mai nominata nell’antichità, né il supporla ha autorevoli appoggi documentari o archeologici. Quanto all’ordine dato da Gesù ai discepoli di precederlo tragittando alla volta di Bethsaida (se pur le parole sono tutte genuine, e non contengono una glossa), non è necessario vedervi designata la meta ultima del tragitto, ma si spiega benissimo come indicazione della direzione generica che dovevano prendere quelli che stavano sulla prateria, poiché si trattava di una «retromarcia» e, nel venire, i discepoli erano passati vicino a Bethsaida-Giulia. Nell’accennata ipotesi, la Bethsaida occidentale sarebbe stata in un’insenatura che il lago fa a Khan Minijeh, presso al Monte delle beatitudini e a Tabgha (§ 316). Tabgha deve il suo nome all’appellativo bizantino Heptapegon («sette fonti»), con cui si designò l’antica fonte termale chiamata «Cafarnao» da Flavio Giuseppe (Guerra giud., III, 519); in questa zona, già ritenuta come prediletta da Gesù e messa in relazione col vicino Monte delle beatitudini, furono idealmente trasferiti luoghi evangelici della riva orientale del lago quando, ai tempi bizantini, cominciò ad esser difficile e pericoloso per i pellegrini cristiani visitare quei luoghi di là dal lago: fra essi fu anche Bethsaida. Ne sorsero confusioni ben grosse, come appare dai seguenti passi del Suriano (§ 261, nota): «Item, la città de Bethsaida, ovvero Tiberya (!), in la qual nasetero Pietro e Andrea, e chiamase Midine el Tiberie (in Trattato di Terra Santa e dell’Oriente, pag. 139). Item, la città de Bethsaida, ovvero Genesareth (!), ne la quale nascete Pietro et Andrea: la qual è sul lito del Mar di Galilea (...) Similiter dove Christo suscitò la fiola de l’Archisinagogo (!) fo facta una chiesta in memoria del miracolo; le qual chiesie etiam sono scargate. In questa città etiam sono li bagni: l’acqua de li quali è tanto calida che cote le ova, e non se usan de presente (ivi, p. 144). - Item, la città de Tiberya, la qual anticamente se chiamava Genesareth (!), ecc. (ivi, p. 145)»].

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, sentitamente ringraziamo per la Vostra partecipazione alla XIIIa Giornata per la Regalità sociale di Cristo (qui i video delle lezioni) e, nondimeno, per la Vostra discreta (ossia silente) generosità. Il Signore ci ammonisce: «Omne verbum otiosum, quod locuti fuerint homines, reddent rationem de eo in die iudicii». Orbene, se è vero che il Signore peserà ogni singola parola vana ed imprudente che esce dalla nostra bocca, quanto sarà inflessibile nel giudicare la nostra pigrizia e la nostra avarizia? Oltre le Sante Messe, pochissimi sono gli appuntamenti annuali che ci vedono direttamente coinvolti nella presenza, cerchiamo di non mancare mai e consideriamo, altresì, che ogni danaro silenziosamente usato per la causa di Gesù Cristo è atto non solo di generosità, ma di profonda umiltà. Nel silenzio della tomba, difatti, non può esserci superbia; e quell’uomo che muore al mondo non sente la necessità di declamare la sua generosità. Anche questo atteggiamento distingue il nobile animo cristiano, da quello villano del filantropo. È forse il piacere del mondo che noi cerchiamo? Nient’affatto, noi vogliamo piacere a Gesù, alla Vergine Maria, al casto San Giuseppe, agli Angeli ed ai Santi, che non sono cittadini di questo mondo. C’è forse qualche maestro fra noi? Qualche degna autorità ci ha assegnato una cattedra? Come potremmo insegnare ciò che non conosciamo? Il nostro compito è, forse, scaldare la sedia del computer e fare i “professori” su internet? Nient’affatto, noi non siamo nulla e non sappiamo nulla. Dice il Profeta che l’uomo che si innalza e si insuperbisce sarà abbattuto dal Signore degli eserciti (Is., II, 12). Dunque sforziamoci, sull’esempio del sommo Isaia, di prudentemente tacere, impariamo ad ascoltare, a comprendere, partecipiamo assiduamente e docilmente alla formazione dottrinale, finalmente preghiamo Iddio affinché ci faccia anonimi esemplari del Suo regno in terra. Milioni di uomini e di donne si sono santificati (cf. Apoc., VII, 9), eppure non avevano internet e non scaldavano sedie; facevano semplicemente il loro dovere sotto la guida di un buon Confessore. Ciò premesso, veniamo al venerando Abate Ricciotti. Oggi ci insegna qualcosa sulle «Parabole del Regno».
Stimati Associati e gentili Sostenitori, sentitamente ringraziamo per la Vostra partecipazione alla XIIIa Giornata per la Regalità sociale di Cristo (qui i video delle lezioni) e, nondimeno, per la Vostra discreta (ossia silente) generosità. Il Signore ci ammonisce: «Omne verbum otiosum, quod locuti fuerint homines, reddent rationem de eo in die iudicii». Orbene, se è vero che il Signore peserà ogni singola parola vana ed imprudente che esce dalla nostra bocca, quanto sarà inflessibile nel giudicare la nostra pigrizia e la nostra avarizia? Oltre le Sante Messe, pochissimi sono gli appuntamenti annuali che ci vedono direttamente coinvolti nella presenza, cerchiamo di non mancare mai e consideriamo, altresì, che ogni danaro silenziosamente usato per la causa di Gesù Cristo è atto non solo di generosità, ma di profonda umiltà. Nel silenzio della tomba, difatti, non può esserci superbia; e quell’uomo che muore al mondo non sente la necessità di declamare la sua generosità. Anche questo atteggiamento distingue il nobile animo cristiano, da quello villano del filantropo. È forse il piacere del mondo che noi cerchiamo? Nient’affatto, noi vogliamo piacere a Gesù, alla Vergine Maria, al casto San Giuseppe, agli Angeli ed ai Santi, che non sono cittadini di questo mondo. C’è forse qualche maestro fra noi? Qualche degna autorità ci ha assegnato una cattedra? Come potremmo insegnare ciò che non conosciamo? Il nostro compito è, forse, scaldare la sedia del computer e fare i “professori” su internet? Nient’affatto, noi non siamo nulla e non sappiamo nulla. Dice il Profeta che l’uomo che si innalza e si insuperbisce sarà abbattuto dal Signore degli eserciti (Is., II, 12). Dunque sforziamoci, sull’esempio del sommo Isaia, di prudentemente tacere, impariamo ad ascoltare, a comprendere, partecipiamo assiduamente e docilmente alla formazione dottrinale, finalmente preghiamo Iddio affinché ci faccia anonimi esemplari del Suo regno in terra. Milioni di uomini e di donne si sono santificati (cf. Apoc., VII, 9), eppure non avevano internet e non scaldavano sedie; facevano semplicemente il loro dovere sotto la guida di un buon Confessore. Ciò premesso, veniamo al venerando Abate Ricciotti. Oggi ci insegna qualcosa sulle «Parabole del Regno».
• § 365. La giornata delle parabole si svolse nei pressi di Cafarnao e sulla riva del lago. Essendo raccolta molta folla, Gesù ricorse all’espediente già usato in precedenza (§ 303) di salire in barca, e, scostatosi alquanto, parlava di là alla gente allineata sulla riva. La prima parabola riferita di questa giornata è quella del seminatore. Nella Galilea, collinosa e accidentata, si adibivano a semina piccoli appezzamenti di terreno che meglio si prestavano qua e là sulle ripe e negli avvallamenti; alle prime piogge, verso novembre, dopo una superficiale preparazione del terreno, il contadino passava man mano sugli appezzamenti da lui curati, e vi spargeva la sementa di grano e d’orzo. Ora, le vicende del regno dei cieli somigliano a quelle del seminatore della Galilea. Il seminatore esce di casa stringendosi al fianco il sacchetto di sementa ben colmo e, giunto su un appezzamento preparato, si dà a seminare. Ma in Palestina i campi sono luogo di transito per tutti, e anche nei tratti da poco lavorati si formano presto sentierucoli, là ove i passanti attraversando accorciano il loro cammino; perciò una parte della sementa sparsa va a finire su questi sentierucoli, ove però ben presto gli uccelli la beccano o i passanti la schiacciano. Altra parte della sementa cade sul suolo pietroso, ricoperto appena da leggiero strato di terriccio; là per il calore sottostante germoglia presto, ma non essendovi terreno sufficiente non mette radici profonde e basta qualche giornata di pieno sole per far disseccare tutto. Altra sementa cade su terreno profondo, ma non ben preparato; e allora insieme con i buoni germogli crescono i cardi e le spine, che li soffocano. Finalmente il resto del sacchetto è vuotato sul buon terreno, e là la sementa rende dove il trenta, dove il sessanta, dove anche il cento per uno. Gesù restrinse ad un solo caso questo fatto abituale, narrandolo come avvenuto ad un singolo seminatore, e così compose la sua parabola. Terminò poi dicendo: «Chi ha orecchie da udire, oda!». Più tardi, tuttavia, egli stesso fornì la spiegazione della parabola ai discepoli che l’avevano interrogato in privato (§ 363). La sementa era la parola di Dio, cioè l’annunzio del regno dei cieli. La sementa caduta sui sentierucoli e rapita dagli uccelli era l’annunzio del regno ricevuto dagli uditori non disposti, i quali lo accoglievano a mala pena con le orecchie ma non col cuore, perché veniva subito Satana che lo rapiva via. La sementa finita sul suolo pietroso rappresentava gli uditori superficiali che accoglievano l’annunzio con gioia momentanea, ma alla prima contrarietà abbandonavano tutto. La sementa caduta fra cardi e spine rappresentava gli uditori avviluppati da passioni e da cure di mondo, i quali custodivano per qualche tempo nei loro cuori la buona novella ma poi la lasciavano soffocare coi loro desideri materialeschi. Finalmente la sementa gettata sul buon terreno era costituita da coloro che con cuore ben disposto accoglievano la buona novella, sì da renderne frutto più o meno abbondante. Un comune Giudeo, di quelli che aspettavano il regno messianico-politico, avrebbe compreso poco o nulla del vero significato di questa parabola, salvo che si fosse rivolto per la spiegazione a Gesù come i discepoli. Il comune Giudeo aspettava il fulgente re conquistatore, e qui invece l’autore del regno non era neppur nominato e restava nell’ombra; aspettava che l’istituzione del reame calasse bella e pronta dalle nubi del cielo tra portenti fragorosi, e qui invece il reame spuntava umile e silenzioso dalla terra in mezzo a ostacoli d’ogni genere; aspettava la rivendicazione nazionale e la vittoria sui pagani, e qui invece si accennava a un segreto lavorio dello spirito ed alla vittoria sulle passioni e sugli interessi mondani. Il comune Giudeo, dunque, vedeva e non vedeva attraverso la parabola; e qualora fosse rimasto tenacemente attaccato alle sue vecchie concezioni, avrebbe reso sempre più crasso il suo cuore e sempre più dure le sue orecchie rifiutando il totale “cambiamento di mente” (§ 335) a cui la parabola prudentemente l’invitava.
• § 366. Ma il regno dei cieli trova ostacoli alla sua attuazione anche là dove è stato ben accolto; e questo è il principio adombrato nella seconda parabola. Un uomo seminò buona sementa nel suo campo; avendo egli preparato bene il terreno e sparso la sementa a stagione e misura opportune, poteva stare tranquillo e aspettar fiduciosamente la messe. Senonché un suo vicino, che aveva vecchi rancori contro di lui, venne nottetempo mentre i garzoni dormivano, e sopra il terreno testé seminato sparse a piene mani i semi della zizania, ossia del loglio (Lolium temulentum Linn.) Era un dispetto classico fra agricoltori, contemplato anche dalla legge romana; la zizania infatti, anche quando è germogliata, non si distingue praticamente dalle pianticelle del grano, perché la differenza appare chiara solo dopo la spigatura, quando però è troppo tardi per svellere le male piante e il grano ha già sofferto. Anche quella volta il dispetto non fu scoperto se non al tempo della spigatura; e allora i garzoni andarono dal padrone a dirgli: «Ma non hai tu seminato buona sementa nel campo? E come mai c’è la zizania?» - Il padrone capì subito donde proveniva la zizania, ed esclamò: «È stato quel mio nemico!». I garzoni allora gli proposero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla per liberare il frumento?». Ma il padrone replicò: «No, perché raccogliendo la zizania potreste sradicare anche il frumento; piuttosto lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, ed allora dirò ai miei mietitori di raccogliere la zizania a fascetti e gettarla nel fuoco, e di riporre invece il grano nel mio granaio». Anche di questa parabola ci è stata trasmessa la spiegazione data in privato da Gesù ai discepoli (Matteo, 13, 36-43). Chi sparge il buon seme è il figlio dell’uomo; il campo su cui lo sparge è il mondo; il buon seme sono i figli del regno; e la zizania i figli del Maligno; il nemico che la sparge a dispetto è il diavolo; la mietitura è la fine del “secolo” - o mondo - presente (§ 84); i mietitori sono gli angeli. Alla fine del mondo il figlio dell’uomo invierà i suoi angeli i quali, come fanno i mietitori con la zizania, toglieranno via dal regno di tutti gli scandalosi e gli operatori d’iniquità gettandoli nella fornace del fuoco; e allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre. La seconda parabola, dunque, insegnava che il regno predicato da Gesù avrebbe contenuto del buono e del cattivo, il buono proveniente dal figlio dell’uomo e il cattivo dal diavolo; inoltre, che questa mescolanza di bene e di male sarebbe stata tollerata in vista del pieno trionfo del bene, il quale sarebbe avvenuto soltanto al passaggio dal “secolo” presente a quello futuro. Perciò il regno era come un ponte che congiungeva i due “secoli”; era una specie di scala di Giacobbe che poggiava in basso sulla terra e finiva in alto nei cieli.
• § 367. Alla precedente parabola rassomiglia in parte quella riportata dal solo Marco (4, 26-29). Il regno d’Iddio è come un uomo che abbia seminato il suo campo; dorma egli o sia desto, di giorno e di notte, ripensi egli o no alla sementa gettata, essa germoglia e poi cresce e infine spiga e matura, perché è dotata di una forza intima: la quale tuttavia deve sprigionarsi lentamente e percorrere l’intero suo ciclo regolare. Dunque la buona novella predicata da Gesù avrebbe fatto anch’essa il suo corso regolare, sviluppandosi in estensione e profondità fra gli spiriti umani, senza i subitanei sconvolgimenti apocalittici ansiosamente aspettati dalle turbe, bensì in virtù di quella forza intima che le era stata immessa dall’alto.
• § 368. Che gl’inizi del regno di Dio manchino di esteriorità clamorosa, è affermato nuovamente nella parabola del chicco di senapa. La senapa è assai comune in Palestina, e sebbene pianta erbacea annuale può diventare in condizioni favorevoli anche un arbusto alto 3 o 4 metri; eppure i suoi semi sono chicchi piccolissimi, tanto che servono proverbialmente ancora oggi in Palestina come termine di paragone per cose quasi impercettibili: “Piccolo come un chicco di senapa”. Ora, questa curiosa sproporzione fra il seme piccolissimo e la pianta ch’è massima fra tutte le erbacee, offre a Gesù un’immagine della sproporzione storica fra gli inizi del regno di Dio, umili e silenziosi, e la sua successiva espansione, che supererà ogni altra. Anche qui ritroviamo il rinnegamento in pieno, anzi il preciso capovolgimento (§ 318), delle idee diffuse nel giudaismo dell’epoca. Pochi anni prima Orazio, trattando del vero poeta, aveva scritto che non fumum ex fulgore sed ex fumo dare lucem - cogitat (Ars. poët., 144-145). Le due parti di questo binomio, trasferito nel campo religioso, venivano allora scelte in Palestina rispettivamente dalla massa del popolo e da Gesù. Il popolo esaltava il fulgore dell’imminente regno messianico-politico: e invece, dopo un quarantennio, ebbe il fumo dell’incendio di Gerusalemme, con quelle tristi conseguenze che durano ancora dopo venti secoli. Gesù cominciava col Discorso della montagna, nubecola di fumo che sembrava doversi dileguare al primo soffio di vento: e, invece, da quella nubecola si sprigionò un fulgore tale che dopo venti secoli è più vivo che mai [e nonostante gli audaci e continui sforzi dei modernisti di distruggere la fede cattolica e la Chiesa stessa, se mai fosse possibile, ndR]. Questi riscontri non sono certamente una delle sottili teorie critiche basate su particolari filosofie e miranti a dimostrare che Gesù era un allucinato (§ 210) o qualcosa di simile: sono invece elementari considerazioni provocate dalla chiara parabola di Gesù, ma a differenza di quelle teorie hanno per base fatti storici di notorietà universale e di consistenza granitica.
• § 369. Analoga è la parabola del lievito. La sera la donna di casa, dopo aver riempito l’ampia madia con tre grosse misure di farina, ripone in fondo alla farina impastata un pugno di lievito; la mattina appresso, riaprendo la madia - [mobile rustico, costituito essenzialmente da una capace cassa rettangolare a coperchio ribaltabile, destinata specialmente alla lavorazione e conservazione del pane casalingo, ndR] -, la donna trova che quella piccola manciata di fermento durante una notte d’operosità recondita ha conquistato, pervaso, trasformato, tutta la massa cento volte più grande. Anche qui è posta in rilievo la sproporzione storica tra gli inizi del regno dei cieli, rappresentato dal lievito, e il suo pieno sviluppo, rappresentato dalla massa della farina fermentata: ma per di più è adombrata la natura intima, silenziosa, spirituale del regno, che si diffonderà non in forza d’armi, di denaro o di altri argomenti politici, ma conquistando segretamente le menti e soprattutto i cuori, come misterioso fermento divino.
• § 370. Altre parabole, recitate probabilmente ai soli discepoli dentro casa (cfr. Matteo, 13, 36), sono trasmesse in forma brevissima. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. C’era l’uso infatti, nei torbidi politici, di sotterrare oggetti preziosi in luoghi opportuni di campagna per preservarli da rapine di gente armata: un quarantennio dopo, durante l’assedio di Gerusalemme, essendo sbarrate le uscite della città, si nascosero i tesori ivi nelle fogne e nelle gallerie sotterranee (cfr. Guerra giud., VI, 431-432; VII, 114-115). Senonché talvolta avveniva che il padrone del tesoro sotterrato morisse prima di averlo ricuperato, e più tardi lo scoprisse per caso o il contadino che lavorava in quel terreno o qualche passante; naturalmente la prima cura del fortunato scopritore era di comprare quel campo, tacendo del ritrovamento, per divenire in tal modo legittimo proprietario del tesoro. Nella parabola di Gesù lo scopritore, appena assicuratosi che si tratta di un tesoro, lo ricopre e nasconde di nuovo, affinché nessun altro abbia a ritrovarlo; quindi, ripieno di segreta gioia, vende tutto ciò che ha per raggranellare la somma necessaria alla compera del campo, e così diventa padrone del tesoro. Giuoca insomma tutto per tutto, perché è sicuro che il tutto che lascia è molto meno del tutto che acquista. Dimitte omnia et invenies omnia. Così avviene a chi ha conosciuto e valutato il regno dei cieli: costui abbandonerà ogni altro suo bene, pur di acquistare quel sommo bene (Matteo, 13, 44).
• § 371. Lo stesso insegnamento scaturisce dalla brevissima parabola della perla. Un mercante di perle va lungamente in cerca di qualcuna di gran pregio, una di quelle perle rimaste famose nell’antichità per il loro valore, come le due grandissime di Cleopatra di cui parla Plinio (Natur. hist., IX, 35, 58). Trovatane finalmente una rarissima, vende ogni suo avere per acquistarla (Matteo, 13, 45-46). Si avvicinava invece alla parabola della zizania quella breve della rete, presa dagli usi del lago di Tiberiade. Il regno dei cieli è simile a una gran rete gettata in acqua e poi ritirata piena di pesci di vario genere; della preda catturata i pescatori fanno una scelta, mettendo i pesci buoni in serbo nei vasi e gettando via i cattivi. Parimente, alla fine del “secolo”, gli angeli separeranno d’in mezzo ai giusti i malvagi e li metteranno nella fornace del fuoco (Matteo, 13, 47-50). Il colloquio appartato con i discepoli, che conchiuse la giornata delle parabole, riceve il sigillo finale da un’altra breve parabola. Terminato che ebbe di parlare, Gesù chiese ai discepoli «Avete capito tutto ciò?» - «Si, gli risposero». - «Ebbene, soggiunse Egli, ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie». - Quei discepoli, ch’erano destinati a continuare l’opera di quel maestro, dovevano dunque continuare nella norma da lui stesso annunziata nel Discorso della montagna (§ 323), di non esser venuto ad abolire la Legge antica, bensì a compierla e perfezionarla. Cose antiche, integrate e perfezionate da cose nuove.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, segnaliamo la nostra recente pubblicazione «Racconti miracolosi» (ISBN 978-8890074714) del Padre Giacinto da Belmonte. Miracolo vuol dire opera meravigliosa e straordinaria che non può essere l’effetto di una causa naturale. Il miracolo è una derogazione alle leggi di natura: esso vince di molto le forze dell’uomo; Dio solo può farlo e gli uomini non possono operarne che per mezzo di Dio. Il miracolo è una prova sicura della verità. Dobbiamo distinguere il vero dal falso miracolo, chiamato prodigio ed operato da imbroglioni o da maliardi in combutta col demonio. Il vero miracolo è la più autentica ed incontestabile testimonianza che si possa avere della verità di una dottrina. Dio non può permettere miracoli in favore dell’errore; altrimenti si burlerebbe degli uomini e sarebbe Egli stesso autore dell’inganno. Gli iniqui fanno cose che sembrano miracoli, studiando alla gloria propria; i Santi fanno dei veri miracoli, mirando alla gloria di Dio. Con saggio introduttivo sui veri e sui falsi miracoli. Sursum Corda non ha scopo di lucro e l’intero ricavato delle donazioni viene utilizzato per le opere di misericordia spirituale e corporale, soprattutto per la divulgazione gratuita della «buona novella». Per richiedere il libro «Racconti miracolosi» e per fare una piccola donazione a Sursum Corda si può utilizzare il link: CLICCARE QUI!
Stimati Associati e gentili Sostenitori, segnaliamo la nostra recente pubblicazione «Racconti miracolosi» (ISBN 978-8890074714) del Padre Giacinto da Belmonte. Miracolo vuol dire opera meravigliosa e straordinaria che non può essere l’effetto di una causa naturale. Il miracolo è una derogazione alle leggi di natura: esso vince di molto le forze dell’uomo; Dio solo può farlo e gli uomini non possono operarne che per mezzo di Dio. Il miracolo è una prova sicura della verità. Dobbiamo distinguere il vero dal falso miracolo, chiamato prodigio ed operato da imbroglioni o da maliardi in combutta col demonio. Il vero miracolo è la più autentica ed incontestabile testimonianza che si possa avere della verità di una dottrina. Dio non può permettere miracoli in favore dell’errore; altrimenti si burlerebbe degli uomini e sarebbe Egli stesso autore dell’inganno. Gli iniqui fanno cose che sembrano miracoli, studiando alla gloria propria; i Santi fanno dei veri miracoli, mirando alla gloria di Dio. Con saggio introduttivo sui veri e sui falsi miracoli. Sursum Corda non ha scopo di lucro e l’intero ricavato delle donazioni viene utilizzato per le opere di misericordia spirituale e corporale, soprattutto per la divulgazione gratuita della «buona novella». Per richiedere il libro «Racconti miracolosi» e per fare una piccola donazione a Sursum Corda si può utilizzare il link: CLICCARE QUI!
• Oggi proveremo ad imparare qualcosa in più - grazie ai preziosi studi che ci ha lasciato l’Abate Ricciotti - sullo scopo delle parabole di Nostro Signore Gesù Cristo. § 362. Le parabole di Gesù mirano a presentare il regno di Dio, ossia dei cieli. Nel Discorso della montagna Gesù aveva parlato dei requisiti morali necessari per entrare in quel regno; ma adesso, essendo trascorso altro tempo, era necessario fare un ulteriore passo in avanti e parlare di quel regno in sé, della sua indole e natura, dei membri che lo costituivano, del modo come si sarebbe attuato e stabilito. Anche sotto questo riguardo, infatti, la predicazione di Gesù seguì un metodo essenzialmente graduale. La ragione di questa gradualità è nella importantissima circostanza storica che già accennammo (§§ 300-301), vera chiave di volta del contegno di Gesù nei confronti della sua vita sociale, cioè nell’ansiosissima aspettativa da parte dei Giudei di un regno messianico-politico. Parlare a quelle turbe di un regno di Dio senza schiarimenti e spiegazioni, significava far balenare alle loro fantasie la visione di un celestiale re onnipotente, circondato da falangi di uomini armati e meglio ancora da legioni di angeli combattenti, il quale avrebbe portato Israele di vittoria in vittoria fino alla signoria di tutta la terra, rendendo «maestro e donno» delle nazioni pagane quel popolo fino allora calpestato da tutti i pagani, e riducendo invece costoro a sgabello dei piedi di lui (§ 83). Eppure, precisamente a quelle turbe così deliranti Gesù doveva parlare dell’oggetto del loro delirio, e parlare in maniera tale da attirarle e insieme da disingannarle: il regno di Dio indubbiamente doveva venire, si, anzi già aveva cominciato ad attuarsi, ma non era il “regno” loro, bensì quello di Gesù, totalmente diverso. Perciò la predicazione di Gesù doveva insieme mostrare e non mostrare, aprire gli occhi alla verità e chiuderli ai sogni fantastici; era, dunque, necessaria una prudenza estrema, perché Gesù a questo punto s’inoltrava su un terreno vulcanico che poteva scoppiare da un momento all’altro. Questa amorevole prudenza fece sì che Gesù si servisse della parabola. La parabola, infatti, è chiara ma anche oscura, è eloquente ma anche reticente. Per chi la contempli con animo sereno e non preoccupato, è chiara ed eloquente; a chi la scruti con occhio torbidoso e con animo prevenuto essa non dice nulla, seppur non dice il contrario di ciò che in realtà vuol dire. È, dunque, non già tenebra, ma luce, e luce misericordiosamente adatta per occhi che si trovino in condizioni speciali; tuttavia quegli occhi devono essere puri, non già malati, mentre - come più tardi Sant’Agostino esperimenterà in se stesso - aegris oculis odiosa est lux, quae puris est amabilis [Che la luce è odiosa a chi ha gli occhi infermi, mentre è amabile a chi ha gli occhi sani, ndR]. Ma anche nel caso che la parabola non fosse subito compresa, rimaneva ancora un rimedio. Le parabole di Gesù erano recitate in pubblico, davanti a gente ben disposta e a gente mal disposta, affinché per tutti fosse aperta la porta del regno. Il velame della parabola era imperiosamente richiesto da misericordia e prudenza; ma rimaneva sempre la possibilità di squarciare quel velame, sottraendosi dal dominio pubblico e rivolgendosi in privato all’autore delle parabole. Gesù, se voleva veramente diffondere il suo regno, non avrebbe rifiutato di parlare fuori parabola, qualora fosse stato consultato in privato: in privato le ragioni prudenziali che moderavano la predicazione pubblica non esistevano, e quindi il velame poteva essere abolito. • § 363. Così in realtà avvenne. Un giorno imprecisato i discepoli gli si avvicinarono e gli chiesero: «Perché parli ad essi in parabole?» (Matteo, 13, 10). Questa domanda, e la risposta datale da Gesù, sono importantissime; ma per ben valutarle bisogna avere presente che domanda e risposta avvennero certamente non già nella giornata delle parabole, ma ben più tardi, quando cioè Gesù aveva recitato numerose parabole e i discepoli avevano riscontrato ch’esse producevano scarso effetto sulle turbe; inoltre, già prima di quella domanda, i discepoli si erano rivolti in privato a Gesù per chiedere spiegazioni di parabole udite in pubblico (Matteo, 13, 36; 15, 15) o anche spontaneamente Gesù le aveva spiegate in privato ad essi (Marco, 4, 34).
• [Dalla nota 1 alla pagina 434: Il dialogo è riportato da tutti e tre i Sinottici subito dopo la parabola del seminatore, che è la prima nella giornata delle parabole ; ma, come giustamente ritengono i commentatori moderni, qui si segue l’ordine logico, non quello cronologico. Iniziandosi l’insegnamento in parabole gli Evangelisti opportunamente soggiungono, subito dopo la prima, quel dialogo che getta luce su tutte. Il dialogo però non avvenne né in quella giornata né dopo la prima parabola: sia perché quella giornata Gesù parlò stando in barca e rivolto alle turbe affollate sulla riva, cosicché i discepoli non avrebbero potuto rivolgergli quella domanda delicata e in privato (cfr. Marco, 4, 10), sia perché dopo la sola prima parabola, non si poteva chiedere a Gesù perché parlasse in parabole. È dunque uno dei tanti casi in cui gli Evangelisti distribuiscono la materia indipendentemente dall’ordine degli avvenimenti].
• Alla domanda pertanto dei discepoli Gesù rispose: «Perché a voi è stato dato conoscere i misteri del regno dei cieli, a quelli invece non è stato dato. Chiunque infatti ha, gli sarà dato e sovrabbonderà: chiunque invece non ha, anche ciò che ha gli sarà tolto. Per questo in parabole parlo loro, perché vedendo non vedono, e udendo non odono nè comprendono; e si compie per essi la profezia di Isaia la quale dice: “Udendo udrete, e non comprenderete: vedendo vedrete, ma non scorgerete. Divenne infatti crasso il cuore di questo popolo, e con le orecchie difficilmente udirono, e rinserrarono i loro occhi affinché non mai scorgano con gli occhi, e con le orecchie odano, e col cuore comprendano e si convertano, e io li guarisca!”. Beati invece i vostri occhi perché vedono, e le vostre orecchie perché odono; eccetera...» (Matteo, 13, 11-16). Questa risposta è rivolta non soltanto agli Apostoli, ma anche ad altri volenterosi ch’erano insieme con essi (Marco, 4, 10, greco) e avevano fatto unitamente la domanda. La differenza tra i volenterosi e gli altri uditori consisteva in ciò, che ai primi era concesso di conoscere il regno in maniera perspicua (i suoi misteri), agli altri invece soltanto sotto il velame della parabola; ma questa differenza non era che la conseguenza della volenterosità dei primi, i quali, interrogando privatamente Gesù, ottenevano l’abolizione del velame parabolico, mentre gli altri rimanevano avviluppati in quel velame perché non avevano avuto il desiderio di uscirne: tuttavia la porta del regno era aperta agli uni e agli altri, e la sua soglia era rappresentata dalla parabola. Si poteva anche chiedere perché mai soltanto i volenterosi varcavano quella soglia in virtù della loro volenterosità; ma con ciò si sarebbe entrati in una questione ben differente e di sfera assai più alta, perché si sarebbe chiamato in causa il principio già enunciato a Nicodemo secondo cui chi «non sia nato da... Spirito, non può entrare nel regno d’iddio» (§ 288).
• § 364. Tutto ciò è abbastanza chiaro nel testo del dialogo secondo San Matteo, salvo un punto che si vedrà subito. Invece il testo degli altri Sinottici, ambedue più brevi, offre una particolare difficoltà, specialmente quello di San Marco che suona così: «A voi è stato dato (di conoscere) il mistero del regno d’Iddio; per quelli invece (che stanno) fuori (di voi volenterosi) il tutto avviene in parabole, affinché “vedendo vedano e non scorgano, e udendo odano e non com prendano, affinché non mai si convertano e sia rimesso (il peccato) ad essi”» (Marco, 4, 11-12). Si è discusso infinitamente su quel primo «affinché», che introduce l’anonima citazione di Isaia, per definire se abbia o no un valore finale e intenzionale; la questione deve esser risolta mediante il confronto degli altri due Sinottici, e specialmente di Matteo più ampio di tutti. Gesù nella sua risposta, dopo aver distinto fra i volenterosi e gli altri, si appella a ciò che già era avvenuto al ministero del profeta Isaia citandone le parole. Ma la citazione, nel testo odierno di San Matteo, è fatta secondo la versione dei Settanta (certamente dal traduttore greco di Matteo), mentre Gesù citò senza dubbio l’originale ebraico che suona così: «E (Dio mi) disse: “Vai e dirai a questo popolo udendo udite ma non (sia) che comprendiate, e vedendo vedete ma non (sia) che conosciate!”. Rendi crasso il cuor di questo popolo, e indura le sue orecchie e inungi i suoi occhi affinché non (avvenga che) veda con i suoi occhi e oda con le sue orecchie e comprenda col suo cuore, e (così) si converta e (il suo medico) lo guarisca» (Isaia, 6, 9-10). Riguardo al vero senso di queste parole non vi può essere alcun ragionevole dubbio. Dio parla qui come tradizionale e amorevole medico d’Israele, e tenta ancora una volta la guarigione del malato inviando Isaia a curarlo: ma il medico è sdegnato perché il malato si mostra, come sempre, caparbio e di dura cervice, e quindi per scuoterlo e impaurirlo il medico qui parla sarcasticamente e impiega l’ammonizione in forma di minaccia. In sostanza egli dice: «Giammai una volta che tu ascoltassi e ti lasciassi persuadere! Ebbene, respingendo la mia medicina, resta pure con i tuoi mali affinché io non ti guarisca in eterno!». Ora, chi non vede che il medico vuole seriamente ed effettivamente guarire (il malato), e che l’«affinché» è un sarcasmo amorevole ed una salutare minaccia, la cui responsabilità cade esclusivamente sul malato? Tanto è vero che, nel caso storico, Dio inviava Isaia per tentare effettivamente la guarigione spirituale d’Israele. Come, dunque, nel dialogo secondo San Matteo l’intero tratto va interpretato conforme all’originale ebraico di Isaia nominatamente citato, così gli altri due Sinottici vanno interpretati conforme a Matteo e al testo ebraico di Isaia. Questo testo, poi, in Luca e Marco, è citato non solo in maniera anonima, ma anche in forma accorciata e incompiuta: tuttavia siffatta maniera di citare non deve trarre in errore, quasi invitasse a limitarsi alle sole parole allegate. Si citava per summa verba affinché si riconoscesse esattamente il passo alluso, ma fermo restando che il suo vero senso doveva estrarsi dall’originale dell’intero passo alluso: il quale, come facilmente si poteva presupporre, era un passo classico nella polemica antigiudaica e variamente impiegato dalla primitiva catechesi cristiana (Giovanni, 12, 40; Atti, 28, 26-27; Romani, 11, 8). In conclusione, il disputato «affinché» conserva nella citazione di tutti e tre i Sinottici il valore che ha nell’originale ebraico di Isaia, e questo valore non è affatto di finalità e di intenzione; bensì d’accorata ammonizione in forma di minaccia salutare.
• [Dalla nota 1 alla pagina 436: I Padri e gli espositori antichi sono tornati sovente sulla questione dell’ «affinché», e, di conseguenza, sullo scopo delle parabole, prendendone occasione a ricerche sulla grazia, sul libero arbitrio e sulla predestinazione. Ottima fra tutte è la riflessione di San Giovanni Crisostomo il quale, sostenendo che lo scopo delle parabole era di illuminare e non di oscurare le menti, fa notare con perfetto buon senso che se Gesù «non avesse voluto istruirli e salvarli (i Giudei), doveva tacere, non già parlare in parabole; ora invece con ciò stesso li sprona, col parlare di cose avvolte nell’ombra; (...) potevano infatti sia avvicinarsi sia interrogare, come (fecero) i discepoli» - in Matth., hom. 45 (46), 2; in Migne, Patr. Gr., 58, 473. Lo Jülicher ha preso tutt’altra strada. Per lui il dialogo fra Gesù e i discepoli circa lo scopo delle parabole è una pura invenzione degli Evangelisti i quali, per trovare una spiegazione all’ostinazione dei Giudei nel respingere la predicazione di Gesù, attribuirono alle sue parabole il preciso scopo di accecare e di confondere e perciò inventarono il dialogo presentandolo come dichiarazione di Gesù. Il vero motivo di questa ipotesi è di trovare un pretesto di rincalzo per permettersi di scomporre e anatomizzare le parabole di Gesù secondo teorie preconcette, come già dicemmo (§ 360, nota seconda); e fin qui nulla di strano. Quello invece ch’è strano, e anche irritante, è che lo Jülicher si atteggi ad avvocato e a difensore di Gesù, dicendo che con ciò egli vuol conservare all’imperitura corona di Gesù il diamante più bello, che sarebbe l’intenzione di illuminare e non di accecare mediante le parabole (Gleichnisreden, I, pag. 148). Se si pensa che queste parole sono pronunziate da un critico radicalissimo, demolitore sistematico della tradizionale figura di Gesù, esse fanno l’impressione di una vera beffa ; preoccuparsi del diamante più bello, dopo che si è gettata via la corona e anche tagliata la testa al proprio eroe, non è cosa seria né di buon gusto.].

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, come già precisato nel Comunicato n° 134 di Sursum Corda del 14 ottobre 2018, questo numero - il 135 - viene divulgato sul Web e spedito in anticipo, dato che i giorni 20 e 21 ottobre saremo verosimilmente impegnati prima a Modena in occasione della XIIIa Giornata per la Regalità Sociale di Cristo, poi per la santa Messa di domenica all’Oratorio IMBC San Gregorio VII di Roma. Veniamo all’argomento del giorno. L’Abate Giuseppe Ricciotti, nella sua preziosa «Vita di Gesù Cristo» in contrapposto alle fantasie e bestemmie dei novatori, inaugura un capitolo dedicato alle parabole di Gesù, di cui oggi possiamo studiare il primo paragrafo. In questo nostro percorso formativo stiamo seguendo minuziosamente l’indice del citato volume
• § 360. Durante questo periodo dell’operosità (di Gesù) in Galilea, probabilmente nel giorno stesso che precedette la tempesta sedata (§ 346), avvenne l’ampio insegnamento in parabole, che si può praticamente designare come «la giornata delle parabole». Certamente anche prima Gesù aveva impiegato taluni elementi parabolici nei suoi discorsi (cfr. Marco, 2, 17.19.21.22; ecc.), compreso il Discorso della montagna (Matteo, 5, 13-16; 6, 22 segg.; ecc.); ma quella fu una giornata dedicata particolarmente alla vera parabola, come risulta dalle brevi introduzioni premessevi da tutti e tre i Sinottici (Matteo, 13, 1-3; Marco, 4, 1-2; Luca, 8, 4; cfr. Marco, 4, 35). È parimenti quasi certo che anche qui gli Evangelisti si siano comportati come per il Discorso della montagna, cioè che in occasione di questa giornata abbiano riferito parabole pronunziate da Gesù in altre occasioni (Matteo) o viceversa abbiano trasferito altrove parabole di questa giornata (Luca) (§ 317); tuttavia un nucleo storico di parabole pronunziate in quella precisa giornata ci fu indubbiamente, e il suo materiale fu ripartito con una certa larghezza dai singoli Evangelisti.
[Dalla nota 1 alla pagina 430: Questa larghezza di ripartizione o distribuzione, e precisamente a proposito delle parabole evangeliche, era già stata affermata in uno scritto che va sotto il nome di Sant’Agostino: «Nonnumqum sane alius evangelista contexit, quod diversis temporibus dictum indicat. Non enim omnimodo secundum rerum gestarum ordinem, sed secundum suae quisque recordationis facultatem, narrationem quam exorsus est ordinavit» (Qucestiones septem-decim in Matth., qu. XV) - Traduzione: Da notare che talvolta un Evangelista collega fra loro cose che un altro riferisce essere state dette in altro tempo. Ciascuno di loro, infatti, ordinò il racconto che intendeva comporre non secondo l’ordine reale dei fatti ma piuttosto come gli era consentito dal ricordo che ne serbava., ndR].
La parabola è quel genere letterario che consiste nel servirsi di un fatto immaginario, ma assolutamente possibile e verosimile, per illustrare una data verità morale e religiosa. È, dunque, molto simile alla favola; ma ne differisce in quanto la favola fa agire o parlare esseri inanimati o irragionevoli, ed è quindi storicamente impossibile, ed inoltre non si propone uno scopo edificativo [I moderni sostengono le che le favole hanno anche scopo edificativo, in verità vengono usate, da molti decenni ormai, per indottrinare i bambini alle peggiori ideologie ed avviarli alle più perverse pratiche, ndR].
Ambedue i generi, presso tutti i popoli ove sono fioriti, sono stati sempre d’indole popolare: la plebe ha sempre trovato un mezzo facile e perspicuo, per ricevere e trasmettere la sapienza spicciola, in quel riavvicinamento di teoretiche situazioni morali alle reali situazioni umane di tutti i giorni, illuminando così l’astratto impalpabile col concreto tangibile. E, sebbene prediletto dalla plebe, questo metodo è più filosofico di quanto sembri a prima vista: è noto che Socrate, appunto per opporsi ai Sofisti, ricorreva volentieri alla parabola e al paragone; anzi fin da principio, per definire il suo ufficio di maestro, egli si serviva di una specie di parabola, giacché affermava di continuare nel campo morale la professione che nel campo fisiologico aveva esercitata sua madre, la levatrice Fenarete: egli era il maieutico dello spirito. In sostanza, dunque, la parabola è un paragone. È naturale però che, a seconda della finezza concettuale dei vari autori e ascoltatori di tali paragoni, la parabola potrà essere più o meno sviluppata, e talvolta potrà anche prendere alcuni aspetti dell’allegoria. Ad esempio, l’ufficio d’un maestro di scuola potrà essere semplicemente paragonato a quello d’un giardiniere, e allora si avrà una parabola; ma se il paragone verrà spinto fino a particolarità minute, e nelle piccole piante del giardino si vedranno simboleggiati gli alunni del maestro, nei fiori e nei frutti le promozioni e i premi, nella fatica della vanga le cure dell’insegnamento, nelle forbici potatrici le punizioni e così di seguito, il paragone diventa anche simbolico, ossia diventa una parabola allegorica; se infine, non nominando mai la scuola ma intendendo soltanto essa, si parlerà unicamente di piante, di fiori, di vanga, di forbici, si avrà una pura allegoria, ossia una metafora continuata. È chiaro pertanto che, com’è difficile e raro mantenersi a lungo nella pura allegoria (un celebre esempio è l’ode «O navis» di Orazio, che tratta della Repubblica simboleggiata in una nave), così dalla semplice parabola si sconfina volentieri e facilmente nel campo allegorico impiegando taluni elementi simbolici. Le parabole di Gesù obbediscono a queste norme generiche.
[Dalla nota 1 alle pagine 431 e 432: Queste norme generiche, così evidenti e confermate dall’esperienza, erano state già espresse, dopo Aristotile, da Quintiliano: «Habet usum talis allegoriae frequenter oratio, sed raro totius: plerumque apertis permixta est... Illud vero longe speciosissimum genus orationis, in quo trium permixta est gratia: similitudinis (cioè la parabola), allegoriaa et translationis (cioè la metafora)» (Inst. orat., VIII, 6). Non valeva la pena di ricordare norme tanto note, se non fossero state negate focosamente proprio riguardo alle parabole di Gesù. Già accennammo al lavoro dello Jülicher sulle parabole evangeliche (Die Gleichnisreden Jesu, 2 voll., 2a ediz. 1910), giudicato «definitivo» dal Loisy (§ 211). Canoni fondamentali di questo lavoro sono: che la parabola e l’allegoria sono generi letterari i quali si escludono a vicenda né si possono mescolare in alcuna maniera; che la parabola è sempre chiara né ha mai bisogno di spiegazione, mentre l’allegoria è sempre oscura e dev’essere spiegata; che l’allegoria è genere, non popolare, ma da dotti e da studiosi (proprio il contrario di quanto afferma Quintiliano: «Ceterum allegoria parvis quoque ingeniis et cotidiano sermoni frequentissime inservit»): dai quali canoni si trae la conclusione che Gesù, rivolgendosi al basso popolo, ha parlato solo in parabole con precisa esclusione di ogni elemento allegorico; se dunque nelle parabole evangeliche si trovano oggi elementi allegorici, questi vi sarebbero stati aggiunti dagli Evangelisti e dalla primitiva tradizione ecclesiastica, ma devono essere sfrondati per ottenere di nuovo il pensiero genuino di Gesù. Questi canoni, in realtà, erano stati smentiti in anticipo già dai tempi di Menenio Agrippa, di Abimelech (Giudici, 9, 8-15), e anche prima; ma chi li ha formulati, vi è stato spinto da ragioni pratiche. Si aveva, cioè, bisogno di un pretesto qualsiasi per disarticolare le parabole di Gesù trasmesse nei Vangeli, di fare una cernita dei pezzi scomposti, e di rigettare quei tratti che non s’accordavano con teorie preconcette. Oltre a questo, si adduceva come giustificazione della cernita una ragione che, presentata da quegli studiosi, faceva l’impressione di una beffa (§ 364, nota). Oggi lo Jülicher e il Loisy sono ancora seguiti in questo campo per la stessa ragione pratica, ma solo da qualche raro ritardatario].
[Terminata la nota del Ricciotti, dobbiamo, purtroppo, avvertire i nostri Lettori che oggi, a causa del numero elevatissimo - quasi totale e globale - dei modernisti che «occupano la Chiesa dall’interno» (cfr. San Pio X, Pascendi), le insane ed assurde teorie dello Jülicher e dell’eresiarca Loisy, ma anche di personaggi addirittura peggiori, sono diventate la regola comune. Capiamo facilmente quanto siano ordinariamente errate, faziose e soprattutto blasfeme le esegesi moderne. Anni fa dedicammo numerosi punti di Sursum Corda alla corretta esegesi, ndR].
• § 361. L’antica letteratura ebraica aveva coltivato il genere parabolico designandolo col nome di māshāl, il quale termine, tuttavia, comprendeva anche altre forme oltre alla vera parabola. Com’era da aspettarsi, i rabbini anteriori e contemporanei a Gesù impiegavano la forma parabolica più o meno mescolata con le altre forme analoghe; in seguito s’impiegarono sempre più tali forme, ma dalla metà del secolo II dopo Cristo in poi il loro uso fu abbandonato. In questo tempo morì Rabbi Meir, e con lui morì - si disse - la parabola; gli si attribuivano infatti tremila favole, che avevano per protagonista sempre la volpe. Del resto a questo tempo la forma parabolica era diventata presso i rabbini stereotipata, convenzionale, priva d’energia e di vivezza. Presso Gesù la parabola è tutt’altra cosa: semplice e precisa, è ricalcata di sulle realtà più umili ma rispecchia con nettezza i concetti più alti, e nello stesso tempo è comprensibile dall’ignorante e meditabile dal dotto. Letterariamente è priva d’ogni artifizio, eppure supera per potenza affettiva i più elaborati artifizi letterari. Non sbalordisce, ma persuade; non solo vince, ma convince. Noi Italiani dalla voce parabola abbiamo derivato la voce parola: vorrebbe forse questa derivazione indicare che la parabola di Gesù è la parola più alta salita dall’uomo e insieme la più bassa discesa da Dio?.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, essendo presenti - a Dio piacendo - il giorno 20 ottobre a Modena in occasione della XIIIa Giornata per la Regalità Sociale di Cristo, abbiamo pensato di pubblicare in anticipo il numero 135 di «Sursum Corda» (del 21 ottobre 2018), che verrà spedito insieme al numero 134 e sarà pubblicato sul nostro sito già da domenica 14. Un’altra piccola comunicazione di servizio. Lo scorso 12 ottobre ci siamo recati presso la Casa circondariale (o Carcere) di Potenza ed abbiamo donato ai carcerati numero 10 copie del libro «L’inferno è dogma o favola?» (ISBN: 9788890074745 - Mons. Gaston de Ségur) e numero 10 copie del libro «Racconti miracolosi» (ISBN: 9788890074714 - Padre Giacinto da Belmonte). San Giovanni di Dio voglia proteggere la nostra piccola opera. L’Abate Ricciotti oggi ci descrivere e commenta l’espulsione di Gesù da Nazareth.
• § 357. Qualche tempo dopo (la decapitazione di Giovanni Battista, ndR) giunsero ad Antipa notizie di Gesù, come di predicatore straordinario che commoveva i suoi sudditi della Galilea. Il ricordo di Giovanni il Battista era recente, come pure l’indole morale e l’attività del profeta testé morto erano somigliantissime a quelle del profeta nuovamente comparso: perciò il superstizioso Antipa ne trasse la conclusione che Giovanni era risuscitato e, riapparendo in forma di Gesù, operava miracoli. Anche altri, del resto, erano di questa opinione scambiando l’annunziatore con l’annunziato; taluni, invece, preferivano riconoscere in Gesù o Elia o qualcuno degli antichi profeti (Luca, 9, 7-8). Da quel giorno Antipa sentì la curiosità di vedere personalmente Gesù, per riscontrare forse quali precise fattezze avesse assunto il Giovanni risuscitato (ivi, 9). Gesù, invece, non aveva alcun desiderio d’incontrarsi con l’adultero assassino di Giovanni. Era circa il tempo dell’invio dei dodici, e, mentre i discepoli dovevano svolgere la loro missione in zona più ampia, Gesù si riserbò una zona più ristretta ma più ardua. Partito da Cafarnao dopo aver risuscitato la figlia di Jairo (cfr. Marco, 6, 1), Gesù volle fare un tentativo speciale e personale riguardo a Nazareth, perché sapeva che nel villaggio dov’egli era cresciuto covavano forti risentimenti contro di lui. Da principio non era stato così, e a Gesù appena tornato dalla Giudea erano state fatte festose accoglienze certamente anche a Nazareth (§ 299); ma poi l’umore di quei compaesani si era mutato. Vi doveva avere buona parte l’altezzosità di quei parenti che già vedemmo essere avversi a Gesù (§ 344); ma ciò che più profondamente aveva ferito l’amor proprio dei Nazaretani era la preferenza data da Gesù a Cafarnao, divenuta a un certo tempo sua dimora abituale (§ 285). Le rivalità paesane e la fierezza dei villaggi più meschini erano abituali nell’antichità non meno di oggi; l’esclamazione dispregiativa di Nathanael appunto nei riguardi di Nazareth ne è una riprova (§ 279). I Nazaretani, perciò, non perdonavano a Gesù il pratico abbandono del suo villaggio, tanto più che nella preferita Cafarnao egli aveva operato quei fatti straordinari di cui parlava tutta la Galilea. Mancavano forse a Nazareth malati da guarire, storpi da raddrizzare, ciechi da illuminare? Perché, dunque, privare la propria patria di tanti benefizi, che sarebbero insieme ridondati a maggior lustro del tanto disprezzato villaggio? Quest’acredine paesana doveva aver innalzato una barriera morale anche contro la predicazione di Gesù: giacché egli faceva a meno del suo paese, il paese faceva a meno della sua dottrina. Di qui il tentativo personale di Gesù riguardo a Nazareth. La sua dimora ivi dovette protrarsi alcuni giorni, in attesa dell’occasione propizia per ottenere buoni effetti; avrà egli alloggiato da sua madre, nella casetta da cui era uscito più d’un anno prima (§§ 270, 282). Ma l’atteggiamento dei compaesani si mostrò subito tale da dare poco affidamento: se taluni lo accolsero cordialmente, se tutti indistintamente riparlarono dei miracoli da lui fatti poco prima nei paesi all’intorno e riconoscevano ch’egli predicava in maniera straordinaria, molti al contrario si domandavano che motivo c’era di prendere per oro colato la sua dottrina. Non era egli forse il figlio di Giuseppe il carpentiere? Sua madre non era quella Maria che tutti conoscevano? E i suoi fratelli non erano Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sorelle non erano notissime in paese? (§ 264). (Ovvero i suoi parenti: fratelli, sorelle = cugini, cugine, etc ... Ne abbiamo già parlato, ndR). Tutta gente comune, che non s’alzava d’un palmo sopra il livello comune. Donde aveva egli attinto, dunque, la sua dottrina? Non poteva essere tutto effetto dell’impressionabilità di chi non lo conosceva e non lo aveva visto, come essi di Nazareth, prima bambino e poi fanciullo e poi ragazzo e poi giovane come tutti gli altri? Restavano i miracoli; ma anche su questi c’era da discutere. Chi sa far miracoli, li fa dappertutto, in patria e fuori, fra amici e fra sconosciuti: anzi, se è ammissibile una preferenza, questa sarà riservata alla patria e agli amici. E invece quello strano Nazaretano proprio a Nazareth non operava miracoli; faceva davvero la figura di un medico che sa curare gli estranei, ma non è capace di curare né i suoi familiari né se stesso.
• § 358. Il paragone trovò fortuna in paese, e passò di bocca in bocca con la petulanza dei piccoli villaggi. I più focosi trovarono anche maniera di spiattellarlo apertamente a Gesù: «Medico! Cura te stesso! Quante cose udimmo avvenute a Cafarnao, fai anche qui nella patria tua!» (Luca, 4, 23). Gesù rispondeva cercando d’illuminare e di convincere, e insieme ammoniva che nessun profeta è accetto in patria sua. Fece egli anche miracoli curando infermi, ma pochi di numero, non già perché il paese si chiamava Nazareth invece di Cafarnao, «ma per l’incredulità loro» (Matteo, 13, 58): mancava infatti ciò che poco prima, nella giornata della fede, aveva trionfato con la figlia di Jairo, con la donna dal profluvio di sangue e con i due ciechi (§ 349 segg.). (Mancava la fede, ndR). L’urto finale avvenne quando Gesù tentò la prova solenne e quasi ufficiale per scuotere i suoi compaesani, e fu nell’adunanza sinagogale del sabbato, forse l’unico sabbato di quel soggiorno. All’adunanza abituale gli oppositori di Gesù si dovettero recare con intenzioni di sfida; c’era vento di battaglia, Gesù non sarebbe mancato all’adunanza e quella era una buona congiuntura per venire ad una totale spiegazione con lui e metterlo alle strette. Gesù infatti intervenne, e l’adunanza si svolse regolarmente secondo le norme che già esaminammo (§ 66 segg.). Quella volta il discorso istruttivo, che si teneva dopo la lettura dei «Profeti», fu fatto da Gesù: non è arrischiato supporre che l’archisinagogo, dirigente la funzione, invitasse a tenere discorso appunto il tanto discusso compaesano per dargli agio di esporre il suo pensiero. Recatosi pertanto Gesù sul pulpito destinato all’oratore, «gli fu porto il libro del profeta Isaia, e aperto il libro trovò il luogo dove stava scritto: “Lo spirito del Signore su me: perciò mi unse per dar la buona novella ai poveri, mi ha inviato ad annunziare a prigionieri liberazione ed a ciechi vista, a rinviare in liberazione piagati, ad annunziare annata accetta al Signore”. E ripiegato il libro, resolo al ministro, sedette; e gli occhi di tutti, nella sinagoga, erano intenti a lui. Cominciò pertanto col dire ad essi: “Oggi si è adempiuta questa scrittura (ch’è risonata) nelle vostre orecchie”» (Luca, 4, 17-21). Questo fu l’inizio del discorso di Gesù, ma purtroppo il restante non ci è conservato. Certamente l’oratore applicò ampiamente a se stesso il passo letto, dimostrando con appelli alle sue opere come egli avverasse in pieno l’antica profezia mediante l’annunzio della «buona novella». La dimostrazione fu efficace e l’oratore anche quella volta apparve come «avente autorità» (§ 209), cosicché tutti rimasero ammirati; senonché alla radice stessa dell’ammirazione stava il fomite dello scandalo. Non era costui l’umile figlio del carpentiere? Se aveva operato altrove tanti miracoli, da lui stesso citati nel discorso, perché non li operava anche li fra i suoi compaesani? Le domande, solo ripensate dentro la sinagoga, furono ripetute ad alta voce al di fuori dopo la funzione. Si discusse pro e contro, fra gli uditori; si abbordò direttamente l’oratore; lo si invitò ancora una volta a rispondere alle cruciali domande, ricordandosi soprattutto di essere Nazaretano. Voleva egli guadagnare veramente i compaesani alle sue dottrine? Ebbene operasse, lì, sulla pubblica piazza, miracoli dimostrativi, e allora sì che tutti si sarebbero dati anima e corpo a lui: «Medico! Cura te stesso!». La risposta di Gesù fu la stessa dei giorni precedenti: badassero a non render vero anche per Nazareth il principio che nessun profeta è accetto in patria sua; per lui, Gesù, Nazareth valeva quanto Cafarnao e quanto ogni altra borgata israelita, ma qualora egli fosse stato respinto da una di esse, aveva ben maniera di rivolgersi altrove; ai tempi del profeta Elia vivevano molte vedove in Israele, eppure il profeta fu inviato da Dio ad una vedova non israelita; e al tempo del profeta Eliseo vivevano molti lebbrosi in Israele, eppure il profeta fu inviato da Dio al lebbroso Naaman ch’era siro (Luca, 4, 25-27).
• § 359. La risposta di Gesù era un ammonimento, ma dai suoi maldisposti interlocutori fu interpretata come una provocazione dispregiativa. Dunque, egli dichiarava esplicitamente di non aver bisogno di Nazareth e d’esser pronto a preferirle qualunque altro paese, anche fuori d’Israele! Donde tanta albagia (alterigia, boria, ndR) nel figlio del carpentiere? Imparasse una buona volta la gratitudine per il luogo che l’aveva allevato! Se egli aveva ripudiato Nazareth, Nazareth doveva ripudiare lui! Allontanarlo immediatamente da Nazareth bisognava, e allontanarlo in maniera tale che gli togliesse per sempre la voglia di ritornare. Il furore divampò a un tratto, come avviene sempre fra turbe eccitate. Si stava ancora discutendo là nei pressi della sinagoga, quando si saranno levate grida contro l’indegno Nazaretano: «Fuori di qui il tracotante! A morte il traditore!». I pochi favorevoli a Gesù si saranno pavidamente allontanati; gli altri «lo scacciarono fuori della città e lo condussero fino a un ciglio del monte su cui stava costruita la loro città, in modo da precipitarlo giù. Ma egli, passando attraverso in mezzo ad essi, se ne andava» (Luca, 4, 29-30). Perché il progetto non fu condotto a termine? Non ci vien detto. Forse all’ultimo momento i paesani favorevoli a Gesù, ripreso un po’ di coraggio, saranno intervenuti ad impedire in qualche maniera l’odioso delitto; forse gli stessi facinorosi, quando fu l’istante decisivo, saranno rientrati in sé, contentandosi della minaccia già avanzata; non è escluso, tuttavia, che la superiorità dominatrice mostrata in quella circostanza da Gesù soggiogasse i tumultuanti, sì che al momento critico egli poté sottrarsi a loro. Neppure del preciso luogo, ove avvenne la minaccia, siamo informati. Si mostra oggi un picco chiamato Gebel el-Qafse, che domina da più che 300 metri la sottostante vallata di Esdrelon e già nel Medioevo aveva ricevuto il nome di Saltus Domini, mentre oggi è designato di solito come il «Colle del precipizio»; ma il luogo ha il grave inconveniente di esser situato a circa tre chilometri dall’antica Nazareth, distanza veramente eccessiva per una folla eccitata che si decida ad un’esecuzione sommaria. Nell’ambito del villaggio non potevano mancare scoscendimenti di terreno, che si prestavano benissimo al violento progetto: si è quindi pensato, non senza verosimiglianza, ad uno sbalzo di una decina di metri situato presso l’odierna chiesa dei Greci cattolici, la quale sarebbe sorta appunto presso il luogo già occupato dall’antica sinagoga. La pia riflessione cristiana ripensò più tardi anche a ciò che dovette provare Maria in questa occasione, e una cappella situata in direzione del Saltus Domini ricevette nel Medioevo il nome di «Santa Maria del Tremore» a ricordo del timore sofferto da Maria quando vide suo figlio in pericolo.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, la scorsa settimana abbiamo studiato, grazie alla preziosa «Vita di Gesù Cristo» dell’Abate Ricciotti, altri tre episodi storici (- La risurrezione della figlia di Jairo; - La guarigione della donna con profluvio di sangue; - La restituzione della vista ai due ciechi) che attestano la divinità di Nostro Signore Gesù-Cristo. Divinità negata, apertamente o dietro sofismi, dai modernisti che, con indicibile abominazione, occupano le nostre chiese pervertendo quasi ogni intelletto. Oggi leggeremo insieme e mediteremo altri due capitoletti del medesimo volume del Ricciotti: 1) «L’invio dei dodici Apostoli» e 2) «La morte di Giovanni il Battista».
• § 352. Fra questi episodi staccati continuava la generica operosità di Gesù in tutta la Galilea, quale è già stata riassunta da San Luca (§ 343). Ma nel frattempo l’affluenza della gente era cresciuta, e nonostante la cooperazione dei dodici, le cure crescevano a dismisura; e Gesù «vedendo le folle s’impietosì per essi, perché erano disfatti e abbattuti come pecore non aventi pastore (cfr. Numeri, 27, 17). Allora dice ai suoi discepoli: “La messe (è) bensì molta, ma gli operai pochi; pregate dunque il signore della messe, affinché invii operai nella sua messe”. E chiamati dappresso i dodici discepoli suoi, dette ad essi autorità sugli spiriti impuri, sì da scacciarli via e da curare ogni malattia e ogni languore» (Matteo, 9, 36; 10, 1). Investiti perciò di tale autorità, i dodici furono inviati da soli senza maestro, come squadra volante, per una missione particolare e con norme ben precise. La missione consisteva nell’annunziare che si era avvicinato il regno di Dio, come già aveva fatto Giovanni il Battista e fino allora anche Gesù; ma la squadra volante era inviata in zone ancora non raggiunte. Tuttavia fu prescritto che queste zone appartenessero al territorio d’Israele, perché ad Israele prima di tutte le altre genti era stata promessa la “buona novella” della salvezza dagli antichi Profeti; i dodici quindi non s’incamminassero verso i paesi dei Gentili né dei Samaritani, ma piuttosto si rivolgessero alle pecore sbandate del casato d’Israele. A dimostrare, poi, la verità del loro annunzio, ed in forza dell’autorità testé ricevuta, essi dovevano curare infermi, mondare lebbrosi, scacciare demonii, e perfino risuscitare morti. Era, insomma, la missione di Gesù la quale passava da uno solo a dodici, ma per lo stesso scopo e con gli stessi metodi. Anche le norme pratiche erano le stesse seguite fino allora da Gesù, e si possono riassumere in una totale noncuranza degli argomenti politici, dei mezzi finanziari, delle preoccupazioni economiche. L’annunzio del regno di Dio doveva ignorare affatto i regni umani, non avendo alcuna connessione con essi. Le finanze spirituali da cui era accreditato il regno di Dio erano i mezzi dimostrativi della sua solvibilità, cioè curare infermi, mondare lebbrosi, scacciare demonii, risuscitare morti; ma siccome i banchieri a cui era stato affidato questo credito lo avevano ricevuto senza pagamento, così dovevano comunicarlo senza pagamento: «gratuitamente riceveste, gratuitamente date» (Matteo, 10, 8). [Precetto, poi, strumentalizzato dall’odioso errore del pauperismo e da quello, più moderno, del farisaico miserabilismo, ndR]. Le preoccupazioni economiche erano egualmente proibite agli annunziatori del regno di Dio, salvo per quello che era rigorosamente indispensabile. Infine, gli annunziatori dovevano mettersi in giro a due a due, come già usavano fare i messi del Sinedrio, sia per assistenza sia per sorveglianza reciproca, e nelle loro peregrinazioni si dovevano distinguere dagli altri viandanti per varie ragioni.
• § 353. I soliti viandanti, in primo luogo, si servivano possibilmente dell’asino, classico mezzo di trasporto in Oriente; ad ogni modo all’atto della partenza si provvedevano di cibarie, di monete d’oro e d’argento riposte nella cintura o nel turbante, di una seconda tunica per proteggersi meglio dal freddo o cambiarsi dopo un acquazzone, di accurati e solidi calzari per reggere bene sulle strade scabrose, di un nodoso bastone in forma di mazza per difendersi in pericolosi incontri, di una bisaccia da viaggio ove si mettevano altre minute provviste o anche ciò che per caso si veniva acquistando lungo il cammino. Questa bisaccia era importante soprattutto per coloro che viaggiavano a scopo di questue religiose, perché tali questue fruttavano bene in Oriente anche presso i pagani: un’iscrizione greca trovata nella zona orientale dell’Hermon (§ 1) ricorda come un certo Lucio di Aqraba, che andava in giro questuando a nome della dea sira Atargate, riportasse a casa da ogni suo viaggio settanta bisacce ricolme. Ebbene, appunto la mancanza di tutti questi amminicoli [sostegni, supporti, ndR] doveva distinguere da tutti gli altri viandanti i dodici inviati da Gesù: «Non vi procurate oro né argento né (spiccioli di) rame nelle vostre cinture, non bisaccia da viaggio né due tuniche né calzari né bastone» (Matteo, 10, 9-10). A queste prescrizioni San Marco (6, 8-9) aggiunge quella di non provvedersi di cibarie (pane), ma in cambio permette di portare sandali e anche di recare il bastone soltanto.
[Dalla nota 1 alle pagine 418 e 419: Sulla doppia divergenza (§ 147) si è scritto molto, anche troppo. Si è voluto distinguere il sandalo più leggiero dal calzare più pesante e accurato, come pure si è supposto che il bastone permesso in Marco sia quello per appoggiarsi cammin facendo, differente perciò da quello proibito in Matteo che sarebbe il bastone in forma di mazza per difesa personale. La doppia distinzione è certamente possibile; ma, anche se non sia accettata perché giudicata troppo sottile, la suddetta divergenza non dovrebbe ragionevolmente suscitare tanto strepito, salvo che presso gli adoratori della lettera materiale. Chi, invece, avrà presente la dipendenza degli Evangelisti dalla catechesi primitiva (§ 110), preferirà forse la spiegazione proposta, conforme ai principii di Sant’Agostino, dal Maldonato: «Contrariis autem verbis eamdem uterque (evangelista) sententiam eleganter expressit. Uterque enim non Christi verba (e ciò vale contro gli adoratori della lettera materiale), sed sensum exponens voluit significare Christum apostolis praecepisse ne quid haberent, praeter ea, quae essent in praesentem usum necessaria». Questo significato comune ad ambedue gli Evangelisti sarebbe stato espresso, secondo il Maldonato, da Matteo con la formula «Non prendete nemmeno un bastone», perché anche un povero qualsiasi già possedeva almeno un bastone, e da Marco con la formula «Prendete solo un bastone», perché quando non si aveva che quello si aveva il solo necessario, conforme all’esclamazione di Giacobbe: «Avevo con me (solo) il mio bastone» (Genesi, 32, 10) (in Matth., 10, 10). Accettando questa spiegazione, si potrà discutere quale delle due formule, esprimenti lo stesso senso, sia letteralmente più vicina a quella impiegata da Gesù; ad ogni modo questa divergenza di forma è un bell’esempio per dimostrare che gli Evangelisti erano immuni da quel servilismo verbale che fu loro attribuito dalla “Riforma” protestante, ma che gli stessi critici radicali recenti non riconoscono (§ 112). In conclusione, bisognerà dar ragione a Sant’Agostino quando, trattando di siffatte divergenze verbali fra gli Evangelisti, affermava: «Una sententia est, et tanto melius insinuata, quanto quibusdam verbis, manente ventate, mutata» (De consensu evangelist., II, 27, 61) - Ovvero: Identico dunque il senso della frase: il quale senso poi risulta tanto più efficacemente espresso quanto più, nella differenziazione di alcuni termini, resta immutata l’identica verità, ndR].
Neppure dell’alloggio dovevano preoccuparsi i dodici. Giunti che fossero ad un gruppo di case, si dovevano informare di qualche capo di famiglia degno e di buona fama, e poi rimanere in casa sua senza più cambiare. Il caravanserraglio (§ 242) col suo andirivieni era luogo inadatto per quegli araldi del regno di Dio, i quali si dovevano occupare soltanto di affari spirituali, ed in nessun modo di negozi politici o commerciali. Il loro prezioso tempo doveva esser impiegato tutto nella loro missione; quasi certamente anche a questi dodici, come più tardi ai settantadue discepoli (§ 437), fu proibito di perdere il loro tempo per «salutare» quanti incontrassero nel cammino (Luca, 10, 4). In Oriente il “saluto” fra viandanti, specialmente se s’incontravano in luoghi solitari, poteva prolungarsi per ore ed ore parlandosi di tutto un po’ in segno di confidenza e quasi per obbligo di buona creanza: anche oggi, del resto, il beduino che si presenta per la prima volta allo sportello d’una stazione ferroviaria si crede spesso obbligato a chiedere dapprima al bigliettaio se sta bene di salute, se i figli crescono floridi, se il gregge o il raccolto sono soddisfacenti, e solo dopo questi e altri segni di buona educazione domanda il biglietto per il treno. Gli inviati del regno di Dio dovevano fare a meno di siffatti convenevoli, valendo per loro la norma Maiora premunt [lat. «urgono cose maggiori, più importanti», ndR]. Se qualche borgata non avesse accolto gli inviati del regno o avesse prestato loro scarsa attenzione, essi dovevano allontanarsi senza rimostranze, ma nello stesso tempo attestare che la responsabilità dell’allontanamento ricadeva su quella gente. A tale scopo dovevano compiere il gesto simbolico, appena usciti dalla borgata, di scuotere dai propri piedi la polvere raccolta in quel luogo: era come polvere di terra pagana, da non riportarsi sul sacro territorio d’Israele. • § 354. Ricevute queste istruzioni, i dodici partirono per la missione; è probabile che, nello stesso tempo ma separatamente da essi, partisse anche Gesù (cfr. Matteo, 11, 1). La missione non poté durare che poche settimane, sugli inizi dell’anno 29 (§ 355). Anche il suo risultato non ci viene comunicato; è detto solo in genere che i missionari predicando il «“cambiamento di mente”, scacciavano via molti demonii e ungevano con olio molti malati e (li) guarivano» (Marco, 6, 13). La loro predicazione del regno di Dio è dunque accompagnata, come presso Gesù, da segni miracolosi; come tali indubbiamente sono presentate le guarigioni qui accennate, pur essendo riconnesse con l’unzione d’olio. L’unzione d’olio aveva allora notevole importanza come medicamento usuale (§ 439); ma qui il contesto mostra chiaramente che il suo impiego non era quello fattone dalla terapia comune, bensì da una più alta e spirituale, che tutt’al più si serviva di quell’unzione come di simbolo materiale: analogamente l’usuale lavanda corporale era già stata impiegata da Giovanni, e anche dai discepoli di Gesù, per simboleggiare la mondezza spirituale del “cambiamento di mente” (§ 291). Più tardi, nel cristianesimo pienamente istituito, questa unzione d’olio sarà un rito particolare e stabile (Giacomo, 5, 14-15).
• § 355. Verso il tempo della missione dei dodici avvenne l’uccisione di Giovanni (il Battista), forse tra il febbraio e il marzo dell’anno 29. Se egli era stato chiuso in prigione verso il maggio del 28 (§ 292), erano già passati una decina di mesi; ma ne sarebbero passati molti di più, se non fosse avvenuto un caso imprevisto. [Erode] Antipa, infatti, s’intratteneva volentieri col venerato prigioniero e non voleva in realtà la morte di lui (Marco, 6, 20, greco); la voleva invece Erodiade, l’uno e l’altra per i motivi che già sappiamo (§ 17). Nel contrasto fra i due, prevalse l’astuzia e il rancore femminile. Erodiade, che stava in agguato, colse per agire l’occasione in cui Antipa festeggiava il suo giorno genetliaco. La festa era solenne, e vi erano stati invitati i maggiorenti della corte e dell’intera tetrarchia: tutta gente autorevole e danarosa, ma provinciale e ansiosissima di tenersi al corrente nel conoscere ed ammirare le ultime finezze dell’alta società metropolitana. L’occasione era opportunissima per Erodiade, giacché aveva sotto mano il mezzo per far rimanere sbalorditi quei provincialoni e nello stesso tempo ottenere ciò che agognava: aveva presso di sé Salome, figlia del suo vero marito di Roma, la quale nell’alta società dell’Urbe aveva imparato a ballare stupendamente, ad eseguire danze tali di cui quella gente grossolana non aveva neppur l’idea. La madre risvegliò l’amor proprio della ragazzetta, e la ragazzetta messa sul punto si comportò egregiamente. Introdotta che fu nella sala del gran banchetto al momento buono, quando i fumi del vino e della lussuria avevano già annebbiato i cervelli, la ballerina con le sue gambe piroettanti e lanciate in aria in tutti i sensi suscitò fra quegli imbambolati un delirio. Antipa ne fu addirittura intenerito. Con simili spettacoli la sua corte dimostrava di essere veramente “up to date”, aggiornata, e superiore alle altre corti orientali; soltanto in essa si davano esibizioni che appena nella corte del Palatino e in qualcuna delle più aristocratiche domus di Roma era possibile ammirare. L’infrollimento del monarca fu tanto, che fattasi venir dappresso la ballerina tuttora ansante e sudata le disse: «Chiedimi quello che vuoi e te lo darò!». E per maggior solennità aggiunse alla promessa un giuramento: «Qualunque cosa (tu) mi chieda te la darò, fin la metà del mio regno!» (Marco, 6, 23). Tra gli applausi frenetici dei convitati e le mirabolanti offerte del monarca la ballerina tornò ad essere inesperta fanciulletta, e si sarebbe forse smarrita: ma appunto questo momento delicato era già stato previsto dalla navigata madre, che le aveva dato consigli in proposito. Di quei “saggi” consigli materni si ricordò ella nel suo smarrimento, e subito riavutasi attraversò di corsa la sala per andare a consultarsi da sua madre, che teneva banchetto nella sala riservata alle dame: Mamma, il re è disposto a darmi fin la metà del suo regno, e l’ha giurato pubblicamente. «Che cosa chiederò?» (Marco, 6, 24). La navigata femmina capì che il suo uomo era caduto in trappola, e quindi ch’ella aveva vinto. Rivolta allora alla ballerina, fra una carezza e l’altra, le disse recisamente: Lascia tutto il resto, che non conta, e chiedi una cosa sola: «la testa di Giovanni il Battista» (ivi). L’adultera, per essere sicura nel suo adulterio, aveva bisogno dei servigi di una prosseneta e di un carnefice, ed affidava queste nuove incombenze all’inconscia sua figlia. Anche questa volta la ragazzetta si comportò egregiamente. «Ed entrata subito in fretta dal re, chiese dicendo: “Voglio che all’istante (tu) mi dia sopra un vassoio la testa di Giovanni il Battista!”. E, (pur) divenuto afflittissimo il re per i giuramenti fatti e (per) i commensali, non volle dare a lei un rifiuto. E subito, inviato il re un boia, ordinò di portare la testa di lui. E (il boia) partitosi, lo decapitò nella prigione, e portò la testa di lui su un vassoio e la dette alla ragazzetta e la ragazzetta la dette a sua madre» (Marco, 6, 25-28). L’afflizione del tetrarca, che si ritenne impegnato dal giuramento fatto in presenza dei convitati, non impedì che tutto si svolgesse con la massima naturalezza, come se si fosse trattato di accontentare il capriccio di una bambina che desidera un frutto maturo pendente da un albero: si manda un servo a staccare il frutto per porgerlo alla bambina, come allora si mandò il boia a tagliare la testa a Giovanni per porgerla alla ballerina. Dalle mani della ballerina, a cui non interessava affatto, quella testa ancora calda e grondante sangue passò nelle mani della madre, a cui interessava moltissimo: secondo una tardiva notizia data da San Girolamo, l’adultera avrebbe sfogato il suo odio forando con uno stiletto la lingua di quella testa, come già aveva fatto Fulvia con la testa di Cicerone (Adv. Rufinum, in, 42). Più tardi i discepoli del Martire riuscirono a ricuperare la salma, e le dettero sepoltura.
[Dalla nota 1 a pagina 422: Se nessuno studioso moderno avesse negato la storicità del racconto evangelico circa la morte di Giovanni, avremmo avuto una piacevole stranezza; per evitare la quale, la storicità è stata negata da pochissimi e per pretesti che si riducono ai seguenti: sarebbe stato indecoroso per la principessina erodiana far da ballerina in un convito, e la decapitazione del prigioniero ordinata durante il convito sarebbe stata un fatto di crudeltà inaudita e inverosimile; tutto il racconto quindi - dicono alcuni - è artificioso e falso. Certamente è molto cavalleresco difendere il decoro delle principesse erodiane, tuttavia lo studioso dei fatti reali darà ascolto piuttosto a Flavio Giuseppe quando narra pur con un certo ritegno le turpitudini di quelle principesse, per citare un solo esempio quelle dell’autorevole sorella di Erode il Grande, chiamata anch’essa Salome (cfr. Guerra giud., I, 498; Antichità giud., XVI, 221 segg.)].
Interrompiamo per un attimo la nota del Ricciotti e vediamo il “nobile comportamento” di queste principesse erodiane: «Alessandro, quando vide che non era possibile far cambiare idea al padre, decise di affrontare la situazione e scrisse un atto di accusa in quattro fascicoli contro i suoi nemici, in cui confessava il complotto ma ne denunziava come complici la maggior parte di loro, a cominciare da Ferora e Salome; quanto a quest’ultima, poi, dichiarava che una notte aveva voluto per forza unirsi con lui, nonostante le sue resistenze», ndR.
[Riprendiamo la nota: Quanto alla crudeltà della decapitazione ordinata durante un banchetto, senza ricorrere a scrittori di cose orientali, basta leggere Cicerone il quale narra di L. Flaminino,. fratello di T. Flaminino, l’identico fatto: «Cum esset consul in Gallia, exoratus in convivio a scorto (si noti la persona!) est, ut securi feriret aliquem eorum, qui in vinculis essent damnati rei capitalis; (e la domanda fu appagata, ma) mihi... neutiquam probari potuit tam flagitiosa et tam perdita libido, quas cum probro privato coniungeret imperii dedecus» (De senectute, XVII, 42; lo stesso racconto con variazioni è ripetuto da Plutarco, Flaminino, XVIII). Se ciò accadeva presso i Romani, molto peggio poteva accadere presso gli Orientali. Del resto Erodoto (IX, 108-113) narra del persiano Serse un aneddoto di crudeltà somma benché diversa, ma in cui appare ugualmente la promessa fatta con giuramento da Serse a una donna di concederle tutto ciò che gli avesse domandato: anche questa volta il giuramento, sebbene a malincuore, fu mantenuto].
• § 356. Il luogo del martirio non è nominato dagli Evangelisti, ma secondo Flavio Giuseppe (Antichità giud., XVIII, 119) prigionia e martirio avvennero a Macheronte. Ivi, dunque, si svolse anche l’infame banchetto: dalla narrazione evangelica, infatti, risulta chiaramente che il prigioniero stava a pochi passi dai banchettanti, cosicché la domanda della ballerina poté essere appagata immediatamente. La circostanza non deve meravigliare: Macheronte era bensì una fortezza che faceva da baluardo contro gli Arabi Nabatei - anzi Plinio (Natur. hist., V, 16, 72) la chiamava la fortezza più agguerrita della Giudea, dopo Gerusalemme - ma era una di quelle costruzioni nello stesso tempo ben salde e ben comode che Erode il Grande aveva innalzato un po’ dappertutto nei suoi dominii; Giuseppe Flavio che la descrive a lungo (Guerra giud.,VII, 165 segg.) dice, fra le altre cose, che Erode costruì nel mezzo del recinto fortificato una reggia suntuosa per grandezza e bellezza di appartamenti, fornendola anche di molte cisterne e di magazzini d’ogni genere. Vi si stava dunque benissimo, e proprio in quel tempo Antipa vi doveva rimanere volentieri per sorvegliare più da vicino gli Arabi Nabatei, con i quali era in rotta per il divorzio della sua legittima moglie (§17). Oggi il fortunato viaggiatore che riesce a spingersi fino al luogo di Macheronte non vi trova che desolazione e squallore. Dell’antica costruzione, circondata da una larghissima zona totalmente deserta, non resta che un cono mozzato alla cima e interrato; sulla vetta affiorano basamenti d’antiche torri; alla sua base si aprono ampie caverne, che sono forse le antiche cisterne della fortezza e oggi servono a ricoverare d’inverno greggi di beduini nomadi. In qualcuna di quelle caverne, o li dappresso, Giovanni il Battista stette rinchiuso per molti mesi aspettando. Improvvisamente una sera in quel sotterraneo, dopo che vi era giunto il prolungato frastuono d’un lontano tripudio, giunse anche un boia con una spada in mano. Il prigioniero capì, denudò e protese il collo; un lampeggio, un tonfo, e il figlio di Zacharia e di Elisabetta non era più. Oggi il solitario beduino a cui il viaggiatore si rivolge in quel deserto per essere indirizzato, addita da lontano il cono mozzato di Macheronte, e ne pronunzia con ribrezzo il nome arabo: al-Mashnaqa («luogo d’impiccagione», «patibolo»). Sembra che da quel cono, come da un vulcano, parta una vampa esiziale che faccia desolazione all’intorno; la sagoma del cono si presenta proiettata all’ingiù, verso occidente, e le fa da sfondo il Mar Morto e la regione di Sodoma.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, oggi studieremo, con il dotto Abate Giuseppe Ricciotti, altre tre importanti testimonianze storiche della divinità di Nostro Signore Gesù-Cristo: «La figlia di Jairo. La donna con profluvio di sangue. I due ciechi».
• § 349. Ripassato il lago, Gesù tornò a Cafarnao ove l’accolse la folla perché tutti l’aspettavano (Luca, 8, 40). Più ansiosamente forse di tutti l’aspettava un Giudeo di riguardo, archisinagogo (§ 64), di nome Jairo; costui, saputo che Gesù è arrivato, corre e cade ai piedi di lui e si raccomanda molto a lui dicendo: «La figliolina mia è agli estremi! Vieni dunque, imponi le mani su lei, affinché sia salva e viva!» (Marco, 5, 22-23.) Il racconto di San Luca non è altrettanto vivido, ma aggiunge il particolare che la moribonda fanciulla era unigenita e di circa dodici anni. Gesù senz’altro si avvia insieme con l’angosciatissimo padre, ed è seguito naturalmente da molta folla che si accalca attorno al taumaturgo: chi lo sospinge, chi l’acclama, chi lo supplica, chi gli bacia le vesti, chi tenta d’aprirgli un varco. Nell’avanzarsi in questa maniera, a un tratto Gesù si ferma, si rivolge, e guardando attorno domanda: «Chi mi ha toccato?». A quella inaspettata domanda tutti rimangono perplessi, non sapendo che cosa veramente intenda egli dire. Pietro ed i discepoli che sono presenti esprimono a parole la ragione della perplessità: «Maestro, le folle ti costringono ed opprimono!» (Luca, 8, 45). Ma la spiegazione di Pietro non spiega nulla; il maestro replica ch’egli ha sentito uscire da sé potenza al toccamento speciale di qualcuno. Ecco infatti che una povera donnetta, tutta tremante, viene a prostrarsi davanti a Gesù e narra alla folla quant’è avvenuto. La donna soffriva di perdite di sangue da dodici anni e molto aveva sofferto da parte di molti medici, e dopo aver consumato tutte le sue sostanze non aveva tratto alcun giovamento, ma piuttosto era andata peggio; questa franca informazione di San Marco è pudicamente accorciata dal medico San Luca, e noi già sappiamo perché (§137). Veramente i rimedi contro questo incomodo erano molti, e i rabbini che spesso facevano anche da medici ci hanno conservato una buona lista di opportune ricette (cfr. Shabbath, 110 a). Ad esempio, un rimedio molto efficace era quello di far sedere la donna malata alla biforcazione d’una strada facendole tenere in mano un bicchiere di vino; qualcuno, a un tratto, venendole di soppiatto alle spalle, doveva gridarle che cessasse il profluvio di sangue. Un rimedio poi assolutamente decisivo era quello di prendere un granello d’orzo trovato nello stabbio di un mulo bianco: prendendolo per un giorno il profluvio sarebbe cessato per due giorni, prendendolo per due giorni sarebbe cessato per tre giorni, e prendendolo per tre giorni si sarebbe ottenuta la guarigione completa e per sempre. [Dalla nota 1 a pagina 414: Pare tuttavia che gli stessi rabbini non avessero sempre una fede cieca in queste ricette, giacché troviamo nella Mishna una sentenza come questa: «Il migliore dei medici merita la Gehenna» (Quiddushīn, IV, 14) - Notiamo la spiccata ironia del polemista Abate Ricciotti, ndR]. Altre ricette richiedevano impiego di droghe rare e costose, e quindi grandi spese da parte della malata. La donna ricorsa a Gesù le aveva forse sperimentate tutte, giacché aveva consumato tutte le sue sostanze, ma rimanendole egualmente il suo incomodo. Perduta ogni fede nelle medicine, la malata trovò la sua medicina nella fede. Quel Gesù di cui tanto si parlava in quei luoghi era certamente in grado di guarirla; ella concepì di ciò tanta fede, che andava ripetendo a se stessa: «Se (io) tocchi anche sol le vesti di lui sarò salva»; non pretendeva la fiduciosa di toccare proprio la persona del taumaturgo, ma solo la sua veste, o anche solo quell’orlatura o frangia (... Matteo, 9, 20) che ogni Israelita osservante doveva portare ai quattro angoli del suo mantello conforme alle prescrizioni della Legge (Numeri, 15, 38 segg.; Deuteron., 22, 12). Sorretta da tale fede, la donna aveva toccato nascostamente quell’orlatura della veste di Gesù e all’istante si era sentita guarita. Il medico, a guarigione ottenuta, approvò la medicina scelta dalla malata, perché voltatosi a lei le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace, e sii guarita dal tuo male!».
• § 350. L’incidente della donna era chiuso e Gesù avrebbe potuto riprendere il cammino verso la casa di Jairo, ma ecco che appunto da quella casa si viene ad annunziare al povero padre: «Tua figlia è morta; non disturbare più il maestro!». Gesù ode l’annunzio, e quasi proseguendo il discorso sulla fede fatto alla donna, soggiunge al padre: «Non temere! Soltanto credi, e sarà salva!». La casa della morta è presto raggiunta, ma Gesù non permette di entrare se non ai discepoli prediletti, Pietro, Giacomo e Giovanni, ed ai genitori della morta; si sono già adunati flautisti e lamentatrici, di prammatica nelle adunanze funebri, ma Gesù dice che la loro presenza è inutile: «Che strepitate e piangete? La fanciullina non morì ma dorme». Gli accorsi trovano che lo scherzo è di cattivo gusto vicino a un cadavere, e rispondono con scherni. I genitori stanno come trasognati fra la realtà dei fatti e le ferme parole dell’invocato taumaturgo; Gesù li spinge insieme con i tre discepoli dentro la camera della morta, dopo che ne sono usciti tutti gli estranei. Là dentro stanno cinque uomini imbambolati; oltre ad essi c’è uno che non è più uomo, e uno che è più che uomo. Dal di fuori giunge il brusio confuso della folla. Il più che uomo si avvicina a chi non è più uomo, gli prende la mano già fredda e pronunzia due sole parole; il discepolo del testimonio Pietro ci ha conservato nel suo suono originario queste due parole, ch’egli avrà udite ripetute tante volte dal suo maestro: «Tĕlita qūmī», cioè Ragazza sorgi! - L’effetto di queste due parole è descritto così dall’evangelista medico: «E ritornò lo spirito di lei, e si levò all’istante, e (Gesù) ordinò che le fosse dato da mangiare. E rimasero fuor di sé i genitori di lei; ma egli prescrisse loro di non dire a nessuno l’accaduto». Questa prescrizione era conforme alla norma seguita da Gesù, che già rilevammo (§ 300); ma quei rasserenati genitori, con tutta la loro buona volontà, avranno potuto osservarla solo in minima parte, giacché troppo eloquentemente parlava la stessa presenza in casa di quella figliuola, che tutti avevano vista partire per l’oltretomba e poi ad un tratto ne era ritornata: tanto è vero che il pratico San Matteo conclude il racconto dicendo che «uscì la fama di questo (avvenimento) in tutta quella regione». Che fine avrà fatto la fanciulla risuscitata? Avendo dodici anni, era in età da marito (§ 231); forse poco dopo si sarà maritata, avrà poi avuto figli e nipoti, ma alla fine ritornò stabilmente in quell’oltretomba già da lei visitato per poco tempo. Su questo bel caso scritti apocrifi e leggende tardive pare che non abbiano fantasticato, mentre invece si ricamò attorno alla donna dal profluvio di sangue. Negli apocrifi Atti di Pilato, VII, la donna è chiamata Veronica (§ 193). Secondo una voce riportata da Eusebio (Hist. eccl., VII, 18) era una pagana nativa di Panion, ossia Cesarea di Filippo (§ 395 segg.), e tornata in patria fece erigere alla porta di casa sua un monumento di bronzo raffigurante lei stessa inginocchiata davanti a Gesù: ai piedi di Gesù spuntava una pianta esotica, che guariva ogni sorta di malattie; Eusebio vide sul posto il gruppo e afferma soltanto: «Dicono che questa statua riproduca l’immagine di Gesù». È molto probabile che il gruppo originariamente rappresentasse qualche divinità pagana curatrice di morbi, e che più tardi la leggenda cristiana la interpretasse come dice Eusebio; secondo una notizia di Sozomeno, il gruppo sarebbe poi stato abbattuto da Giuliano l’Apostata.
• § 351. Con la donna guarita e la fanciulla risuscitata, gli insegnamenti taumaturgici della fede non erano finiti. A Gesù uscito dalla casa di Jairo tennero dietro due ciechi, due di quegli infelici di cui doveva abbondare la Palestina antica non meno dell’odierna: ancora oggi, del resto, in Palestina i ciechi spesso s’uniscono a coppia per aiutarsi bene o male fra loro, e mostrano come tutti gli altri mendicanti quella tenacia nel chiedere mostrata da questi due. Al sentir raccontare i recentissimi miracoli, nei due brillò un lume di speranza e fattisi accompagnare presso Gesù si dettero a seguirlo gridando con immutabile costanza: «Abbi pietà di noi figlio di David!». Data la norma prudenziale seguita da Gesù (§ 300), quell’appellativo non poteva tornargli per allora gradito, perché era un appellativo messianico che designava usualmente il grande Atteso, e perciò era anche più pericoloso in quell’effervescenza suscitata fra il popolo dai miracoli. Gesù non si ferma né si rivolge a quell’incessante grido, ma non per questo il grido cessa; Gesù, infine, entra nella casa ove dimora, certamente a Cafarnao, e i due lo seguono anche dentro casa. Tutto sommato, la tenacia dei due ciechi era fede, precisamente quella fede poco prima lodata e raccomandata da Gesù alla donna malata e a Jairo; inoltre, nell’interno d’una casa l’appellativo messianico non era più pericoloso, cosicché Gesù entrò in discussione con i due imploranti. Ma la prima e forse l’unica domanda fu sulla fede: «Avete fede che posso far ciò?». I due ciechi naturalmente rispondono: «Si, Signore!». Allora Gesù toccò loro gli occhi, dicendo: «Secondo la vostra fede avvenga a voi». E i due videro. Allora Gesù comandò con somma energia - l’Evangelista usa la parola fremette, (Matteo, 9, 30) - di non parlare con nessuno del fatto; ma quelli, usciti di là con la luce negli occhi e nel cuore, ne parlarono in tutta la regione. Fu una vera disobbedienza? Vari studiosi protestanti l’hanno stimata tale; antichi Padri l’hanno giudicata un incoercibile moto di gratitudine. Forse gli antichi conoscevano il cuore umano meglio dei moderni.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Raccolta di prodotti per i poveri, settembre 2018
- Comunicato numero 131. La tempesta sedata e l’indemoniato
- Comunicato numero 130. Il ministero ordinario di Gesù
- Comunicato numero 129. La penitenza e la peccatrice innominata
- Comunicato numero 128. Il Battista rinchiuso a Macheronte
- Comunicato numero 127. Il centurione e la vedova
- Comunicato numero 126. Il Discorso della montagna (parte 3 ed ultima)
- Comunicato numero 125. Il Discorso della montagna (parte 2)
- Comunicato numero 124. Il Discorso della montagna (parte 1)
- Comunicato numero 123. I dodici Apostoli

































![[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1](/images/stories/virtuemart/product/resized/[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1_0x130.jpg)