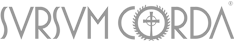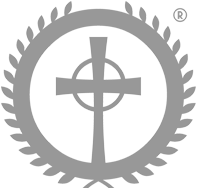Comunicati e Note
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
La nostra piccola Associazione - che intende perseguire le opere di misericordia spirituale e corporale secondo le indicazioni del Catechismo maggiore di San Pio X - ha organizzato - nel 2018 - una quarta raccolta di prodotti per i cristiani in difficoltà. La consegna è stata effettuata il giorno 24 settembre 2018 presso la Caritas di Potenza. Abbiamo consegnato: 1) numerosi capi d'abbigliamento per uomo, donna e, soprattutto, bambino. Prodotti in ottimo stato, tenuti bene, lavati e sistemati; 2) alcune scarpe da donna; 3) dei set di bicchieri ancora imballati; 4) delle catene da auto nuove per il periodo invernale. Gli Associati ed i Sostenitori che intendono contribuire possono inviare prodotti, non rovinati e puliti, possibilmente nuovi di negozio, da destinare alla beneficenza all'indirizzo dell'Associazione. Si consiglia di avvisare telefonicamente o via mail prima di effettuare spedizioni. Nel mese di ottobre 2018 è in programma una donazione di numerose copie dei nostri ultimi libri ai carcerati della Casa circondariale di Potenza. Affidiamo la nostra piccola opera alla protezione di San Giovanni di Dio.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, in occasione della XIIIa Giornata per la Regalità Sociale di Cristo, annuale seminario di studi (qui i video delle lezioni precedenti) a cura dell’Istituto Mater Boni Consilii, della rivista Sodalitium e del Centro Studi Giuseppe Federici, che si svolgerà a Modena sabato 20 ottobre 2018, probabilmente sarà disponibile il nostro nuovo libro «Racconti miracolosi», del compianto Padre Giacinto da Belmonte. Siamo in attesa di novità sui tempi di stampa e di consegna da parte della tipografia. Gli argomenti di oggi, sempre tratti dalla preziosa «Vita di Gesù Cristo» dell’Abate Giuseppe Ricciotti, sono principalmente due: «La tempesta sedata e l’energumeno di Gerasa».
• § 346. Di questa uniforrne operosità (di Gesù) nella Galilea ci sono tramandati soltanto pochi fatti particolari. In questo periodo certamente cadde la giornata dedicata da Gesù all’insegnamento per mezzo di parabole, della quale tuttavia è più opportuno trattare a parte, staccandola dal suo inquadramento cronologico (§ 360). Altri episodi tramandati sono i seguenti. Forse la sera stessa della giornata delle parabole (cfr. Marco, 4, 35) Gesù, che aveva parlato alle turbe sulla riva occidentale del lago di Tiberiade, salì in barca con i discepoli e comandò loro di passare alla riva opposta. La partenza, a quanto sembra, fu improvvisa ed affrettata: forse, ancora una volta, Gesù voleva sottrarsi alle fervorose dimostrazioni della folla che l’aveva ascoltato. La traversata è di pochi chilometri (§ 376) ma può esser pericolosa, specialmente se compiuta sul far della notte come quella volta, a causa dei venti freddi che si scaricano giù improvvisamente dal sovrastante nevoso Hermon e suscitano tempeste violentissime per quel lago e per le fragili imbarcazioni che lo percorrono. Così avvenne in quella serata. Gesù, stanco della faticosa giornata, si distese a poppa della barca e si addormentò: Marco (4, 38), che più volte avrà udito il racconto dalla bocca di Pietro, menziona anche il cuscino su cui Gesù appoggiò la sua testa, il piccolo cuscino di cui erano provviste le più umili barche; inoltre, il solo Marco ricorda che altre barche accompagnavano quella di Gesù. Ad un tratto un turbine violento s’abbatte sul lago, e ben presto la barca di Gesù è in pericolo e fa acqua; i barcaioli tentano manovrare, ma tutto è inutile e da un momento all’altro può esser la fine. Frattanto Gesù continua a dormire a poppa della squassata navicella. Dante, alla prima visione sovrumana che ebbe nel Purgatorio, scorse un «vasello snelletto e leggiero» guidato da un angelo; «da poppa stava il celestial nocchiero», ma stava eretto e vigile «con l’ale sue... dritte verso il cielo». Al contrario, a poppa di quella barchetta del lago, Gesù era disteso e dormiva, sembrava estraneo a quanto accadeva all’intorno, e nell’oscurità della notte lo si sarebbe scambiato per un ammasso di cordami o per una vela deposta e ripiegata. I discepoli non si spiegano quel sonno tra tutta quella furia degli elementi, e stanno ansiosi fra il desiderio di non disturbarlo e lo spavento della catastrofe imminente, fra il rispetto per il maestro e l’abitudine di ricorrere fiduciosi a lui. Ma, passato ancora del tempo, si convincono che oramai non si può più titubare: bisogna senz’altro svegliare ed avvisare il maestro, affinché pure egli provveda in qualche maniera alla propria salvezza. Gli si fanno perciò dappresso gridando: «Maestro, siamo perduti! Sàlvaci!». Gesù si sveglia: insieme col turbamento degli elementi egli nota il turbamento dei cuori. Voltatosi allora al turbine, comanda imperioso: «Taci! Fa’ silenzio!». - Voltatosi quindi ai cuori esclama misericordioso: «Che paura avete? Gente di poca fede!». - Il turbamento degli elementi cessa ad un tratto, e si fa gran bonaccia. Il turbamento dei cuori è sostituito da un altro d’altro genere, ché i presenti si dànno a riflettere: E chi è dunque costui, che perfino il vento e il mare gli obbediscono? Per i razionalisti il miracolo, naturalmente, è fittizio. I seguaci dell’antico Paulus (§ 198) lo spiegheranno forse immaginando che sulla barca di Gesù stessero deposti molti otri d’olio, e l’esperto maestro ad un certo punto li facesse svuotare nel lago in modo da calmarne le onde; i moderni mitologi, invece, penseranno che si tratti di una pura allegoria. Una volta tanto, con i mitologi concordano in parte gli studiosi spiritualisti, in quanto anche costoro trovano nella narrazione un significato allegorico ma insieme con quello storico. Ambedue reali furono la tempesta e la bonaccia che avvennero attorno a quella barca: ma compiendo quel miracolo Gesù venne a preadombrare altre tempeste e altre bonacce che da secoli si avvicendano attorno a un’altra barca, non di legno ma non meno reale e storica, e i cui protagonisti sono gli stessi di quella notte là sul lago di Tiberiade. «Da poppa stava il celestial nocchiero». Questa volta l’interpretazione allegorica non è un postulato filosofico, come abitualmente presso i mitologi, ma è fondata su fatti storici che ognuno può riscontrare e che uno storico (serio) non deve fingere d’ignorare.
• § 347. Con quella bonaccia presto si toccò terra e si sbarcò. La riva raggiunta fu certamente quella orientale del lago, circa dirimpetto a Cafarnao o a Magdala, ma il suo nome varia presso i Sinottici; Matteo la chiama «regione dei Gadareni», Marco «dei Geraseni», Luca «dei Gergeseni» o più probabilmente «dei Geraseni» [La lezione «dei Gergeseni» sembra dovuta ad una correzione di Origene, mentre il testo lucano originale doveva avere «dei Geraseni» o «dei Gadareni»; tuttavia Origene sembra appellarsi ad una tradizione locale (§ 348) che egli crede di poter integrare con dati dell’Antico Testamento, quali Genesi, 10, 16; 15, 21; eccetera]. Gli appellativi da prendersi in considerazione, «dei Gadareni» e «dei Geraseni», si riferiscono rispettivamente alle due città di Gadara e di Gerasa, che appartenevano ambedue alla Decapoli di là dal Giordano (§ 4); tuttavia ambedue erano situate a sud del lago e, specialmente Gerasa, assai lontane da esso, cosicché è difficile che i rispettivi territori s’estendessero fin sulla sponda del lago dandole il proprio nome. Limitandosi pertanto agli appellativi derivati da Gadara e da Gerasa, non è impossibile che i rivieraschi a occidente del lago designassero le opposte rive col nome delle città più celebri nella cui direzione essi guardavano: questi appellativi geografici di direzione non sono rari negli usi paesani. Tuttavia la spiegazione dell’apparente incongruenza può forse essere suggerita dal terzo appellativo «dei Gergeseni», meno autorevole sotto l’aspetto documentario ma più raccomandato dai riscontri archeologici (§ 348). Giunto pertanto Gesù col suo seguito a oriente del lago, uno dei giorni seguenti alla notte dell’approdo, avvenne un fatto che è narrato da tutti e tre i Sinottici, nella maniera più breve da Matteo, nella più ampia da Marco: tuttavia il riassunto di Matteo fornisce una particolarità non trasmessa dagli altri due Sinottici, cioè che del fatto furono attori due indemoniati, e non già uno solo come risulterebbe da Marco e da Luca. Certamente il fatto è il medesimo, e questa differente maniera di narrarlo è un bell’esempio della mancanza di servilismo letterario presso gli Evangelisti (§ 122) e della loro particolare maniera di trattare gli argomenti: Marco e Luca si accentrano sull’attore principale e neppure ricordano quello secondario; Matteo, sebbene più ristretto, li ricorda ambedue. Lo stesso avverrà nuovamente nel caso dei ciechi di Gerico (§ 497). A Gesù, dunque, si fece incontro un indemoniato. Era un essere selvaggio e imbestialito, che aveva scelto la sua dimora abituale fra impure tombe e s’aggirava in quella zona tutto nudo; dotato di forza mostruosa, aveva sempre spezzato funi e catene con cui avevano tentato più volte di legarlo, tratto tratto gridava furiosamente o si percoteva con sassi, e ispirava tanto terrore che nella zona ove egli si aggirava nessuno più voleva passare. Quando costui ebbe scorto Gesù da lontano, gli corse incontro, ma invece di aggredirlo si prostrò davanti a lui urlando: «Che c’è fra me e te»; (cfr. § 283), «Gesù figlio d’Iddio altissimo? Ti scongiuro per Iddio, non mi tormentare!» (Marco, 5, 7). Aveva parlato l’uomo imbestialito, ma la risposta di Gesù s’indirizzò a colui che stava dentro l’uomo ad imbestialirlo. Disse infatti Gesù: «Esci, spirito impuro, dall’uomo!». Più che un comando, le parole furono un annunzio; Gesù infatti interrogò, subito appresso, l’imbestialente: «Che nome hai?». E quello: il nome mio è “Legione”, perché siamo molti». La parola «legione» non risonava allora in Palestina e fuori senza suscitare un arcano sbigottimento; quella moltitudine d’armati fusi in compattezza mirabile a formare un travolgente congegno guerresco sembrava un’istituzione sovrumana, e più tardi Vegezio, ripetendo certamente idee anteriori a lui, parlerà di istituzione divina: «non tantum humano consilio, sed etiam divinitatis instinctu legiones a Romanis arbitror constitutas» (Vegezio, II, 21). Ai tempi di Gesù la romana legione variava dai 5000 ai 6000 uomini: ma qui l’interpellato impiega certamente la parola per alludere in maniera generica a una moltitudine grande e compatta.
• § 348. Fatta questa confessione, la moltitudine degli interpellati si raccomandava molto a lui, a Gesù, «affinché non li inviasse fuori della regione», intendendo certamente la circostante regione: ma questo punto di partenza è sostituito presso Luca (8, 31) col punto d’arrivo, perché ivi si dice che la raccomandazione era di «non inviarli nell’abisso». La raccomandazione fu rincalzata da una proposta concreta: «Era la’ verso il monte un grosso branco di porci che pascolava; e (quelli) si raccomandavano a lui dicendo: “Màndaci nei porci, affinché entriamo in essi!” Ed (Egli lo) permise loro. E usciti, gli spiriti impuri entrarono nei porci, e il branco si slanciò giù per il precipizio nel mare - circa duemila - e affogarono nel mare». La presenza di un branco di porci conferma che si era fuori del territorio giudaico, perché nella vera Palestina per le note prescrizioni della Legge non si allevavano quegli animali impuri: i quali, perciò, qui appaiono come asilo ricercato dagli spiriti impuri, costretti ad uscire dall’uomo. Visto ciò ch’era successo, i pastori dei porci se la dettero a gambe, corsero nella città vicina a narrare il fatto e a giustificarsi del danno subito presso i padroni del branco. Dalla città si venne a riscontrare la realtà degli avvenimenti: si trovò che quel notissimo energumeno (l’indemoniato), già così feroce ed imbestialito, stava adesso vicino a Gesù ma tranquillo, «seduto», vestito e sano di mente; interrogati poi i testimoni si riseppe per filo e per segno com’erano andate le cose. Quegli Ellenisti accorsi non dubitarono minimamente del portento, anzi, appunto perché lo credettero pienamente miracoloso, s’impensierirono per il futuro: da uomini pratici ed economici quali erano, pensarono che con un taumaturgo di quella forza in giro per i loro territori non si sapeva mai quel che potesse succedere; perciò, rivoltisi a Gesù, «cominciarono a raccomandargli di partirsene dai loro confini». Gesù acconsentì e si avviò verso la barca; l’indemoniato guarito voleva che l’accogliesse al suo seguito, ma Gesù gli prescrisse di tornare in seno alla propria famiglia e di far conoscere il beneficio ricevuto da Dio. Il beneficato obbedì, e «se ne andò e cominciò ad annunziare nella Decapoli quanto Gesù gli fece, e tutti ammiravano». Il riconoscimento del luogo ove avvenne il fatto è oggi seriamente probabile. Sulla riva orientale del lago, quasi dirimpetto a Magdala, si estende la zona dell’antica città di Hippos, ove in realtà le colline digradano a qualche distanza dalle acque del lago; tuttavia, a settentrione di questa zona, sbocca il wadi es-Samak che è chiuso a sud da un piccolo promontorio alto qualche centinaio di metri e così dirupato sull’acqua che ai suoi piedi resta una spiaggia di poche decine di passi; varie caverne, aperte nei fianchi del promontorio, hanno tutto l’aspetto di essere state in antico tombe. Geologicamente, dunque, lo scenario corrisponde, giacché il promontorio sarebbe il precipizio da cui si gettarono i porci andando per il loro impeto a finire nell’acqua, e le tombe sarebbero l’abituale dimora dell’indemoniato. Ma forse c’è anche una corrispondenza onomastica: presso lo sbocco del wadi es-Samak è situato un villaggio chiamato oggi dagli Arabi Korsi, ma che ha ricevuto il suo nome da un abitato più antico che ai tempi dei Bizantini era chiamato (...) e situato circa un chilometro più ad oriente. Ora, se si hanno presenti le facili oscillazioni di pronunzia di un dato nome lungo i secoli - oscillazioni tanto abituali che, oggi stesso, Korsi è pronunziato da quei del luogo anche Kersa o Ghersa - si comprende come Origene riavvicinasse il Kersa o il Ghersa da lui uditi pronunziare, al Gergesa e ai Gergeseni dell’Antico Testamento (§ 347, nota) e li sostituisse con questi nomi credendo di appoggiarsi su una tradizione locale; senonché mentre la tradizione era buona come quella odierna, la sostituzione era arbitraria. Si avrebbe così non solo la corrispondenza geologica, ma anche quella toponomastica, giacché l’antica Korsi sarebbe la città donde uscirono gli abitanti per pregare Gesù d’allontanarsi; essendo però un nome poco o punto noto, sarebbe stato sottoposto dai copisti o dai traduttori dei testi evangelici a quelle variazioni con cui è giunto fino a noi.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, l’Abate Ricciotti intitola questo capitolo: «Ministero spicciolo», per indicare l’ordinaria operosità di Nostro Signore Gesù Cristo.
• § 343. Subito dopo il racconto del convito di Simone, San Luca soggiunge: «E avvenne in seguito, ed egli viaggiava per città e borgate predicando e annunziando la buona novella del regno d’Iddio, e i dodici con lui» (Luca, 8, 1). Queste parole possono valere come un generico riassunto dell’operosità spiegata da Gesù in Galilea nel restante di questo tempo, fino alla seconda Pasqua del suo ministero pubblico. Quell’operosità dovette essere intensa, benché forse non molto varia, e probabilmente la primitiva catechesi della Chiesa ne raccontava episodi più numerosi dei pochi trasmessi fino a noi. Fu una vita da missionario ambulante, per cui Gesù si trasferiva da regione a regione e da borgata a borgata, predicando in pubblico ed in privato, nelle sinagoghe e nelle case, e confermando le sue predicazioni con miracoli; naturalmente le turbe accorrevano a lui attratte, non soltanto dall’efficacia dei suoi insegnamenti, ma anche più dall’utilità immediata dei miracoli. Gesù non era solo: aveva con sé un gruppetto di persone a lui devote, e anche un codazzo mutevole di gente animata da altri sentimenti. Fra le persone a lui devote erano in primo luogo i dodici Apostoli da lui scelti, che erano suoi abituali cooperatori nel ministero e forse solo saltuariamente e per poco tempo si allontanavano da lui; vi erano certamente anche altri discepoli, sebbene non Apostoli, legati da particolare affetto al maestro. Ma in quella vita di continua peregrinazione il gruppetto di Gesù e dei suoi cooperatori aveva bisogno di qualche assistenza materiale per le esigenze imperiose della vita, tanto più che l’incessante ministero non doveva lasciare loro il tempo di provvedersi da essi stessi, né si poteva pretendere che una ventina e forse più di persone trovasse vitto e alloggio, sempre gratuiti e pronti, in qualunque misero villaggio della Galilea. Per questa ragione, subito dopo la precedente notizia, l’accorto San Luca ci comunica che insieme a Gesù e i dodici erano anche «talune donne ch’erano state curate da spiriti maligni e infermità, Maria quella chiamata Magdalena dalla quale erano usciti sette demonii, e Giovanna moglie di Chuza sovrintendente di Erode, e Susanna e molte altre, le quali ministravano ad essi dalle loro proprie sostanze». Già osservammo che queste donne dovettero essere, più tardi, fonti di notizie per l’Evangelista (§ 142); qui egli ci dice ch’esse erano anche le solerti massaie del gruppetto di Gesù, e la cosa appare naturalissima: non è però necessario credere che tutte sempre seguissero Gesù nelle sue continue peregrinazioni, ma basterà supporre che fra di esse fosse in uso una specie di organizzato avvicendamento per provvedere ai bisogni dei missionari, assistendoli a proprie spese e spesso anche servendoli di persona. (Verosimilmente oggigiorno anche qualche “cattolico” storcerebbe il naso, strillando, in cuor suo o pubblicamente, al maschilismo ed al clericalismo, ndR). Queste donne erano state curate da spiriti maligni ed infermità per opera di Gesù: dunque la gratitudine le aveva spinte ad incaricarsi di un’opera particolarmente appropriata a donne, quale il governo materiale di una specie di famiglia. I mezzi per fronteggiare le spese - che del resto certamente non erano gravi - non dovevano difettare: Giovanna, come moglie di un sovrintendente di Erode (Antipa), era senza dubbio facoltosa, e forse anche altre erano ben provviste: le meno fornite di beni materiali avranno supplito specialmente con l’opera personale. Delle donne qui mentovate, Giovanna e Susanna sono ricordate dal solo San Luca, Maria la Magdalena anche dagli altri Evangelisti. Il suo appellativo di Magdalena la designa come originaria di Magdala, cioè Tarichea (§ 303), sulla riva occidentale del lago, e quindi nativa della Galilea e non della Giudea; se poi è detto che da essa erano usciti sette demonii, ciò significa soltanto ch’era stata liberata per opera di Gesù da qualche potente ossessione diabolica, mentre non avrebbe il minimo fondamento nelle narrazioni evangeliche supporre che ella fosse stata in precedenza una donna di mala vita e tanto meno l’innominata peccatrice del convito di Simone (§ 341 - della quale si è scritto la scorsa settimana, ndR).
• § 344. Ma, oltre a questo gruppo di gente fedele, ronzava attorno a Gesù anche un codazzo di persone in parte nettamente ostili, quali i Farisei, in parte diffidenti o almeno dubbiose e incerte. Su queste ultime ci informa incidentalmente una breve notizia di Marco (3, 20-21). Durante una peregrinazione avvenuta in questo tempo, probabilmente in qualche borgata della zona tra Cafarnao e Nazareth, «Gesù viene ad una casa, e di nuovo si raduna folla, tanto che essi (Gesù e i discepoli) non potevano neppure prender cibo»; era dunque una delle solite affluenze di popolo, ma questa volta anche più incomoda per la ristrettezza di spazio. Ora, tali abituali affluenze, e anche l’operosità infaticabile di Gesù, avevano richiamato l’attenzione pure delle persone neutrali e indifferenti, che non sentivano né l’affetto dei discepoli né l’astio dei Farisei; tali persone avevano anche espresso il loro giudizio su Gesù, e dicevano: «È fuori di sé». Questa espressione, pur non escludendo un senso dispregiativo, non lo include per necessità affatto: poteva essere fuori di sé tanto un uomo psichicamente anormale, quanto un uomo normalissimo ma tutto preso da un entusiasmo sapiente e santo (cfr. II Cor., 5, 13). Cotesti neutrali e indifferenti si erano cavati d’impaccio giudicando Gesù in maniera ambigua e riferendosi solo a ciò che appariva palesemente al di fuori, cioè alla sua incessante operosità missionaria che presupponeva uno stato d’animo fuor dell’ordinario: ma sulla vera indole di quello stato d’animo essi non avevano dato alcun giudizio. L’ambigua sentenza era giunta alle orecchie dei parenti di Gesù, e saputo che proprio allora egli si trovava «come assediato in quella casa, i suoi uscirono per impadronirsi di lui, poiché dicevano: È fuori di sé». L’espressione «i suoi» designa certamente la parentela di Gesù, di cui già sappiamo che taluni erano sfavorevoli a lui (§ 264); ma ciò non basta per riferire necessariamente a costoro la sentenza: «È fuori di sé», perché il verbo reggente «dicevano» può benissimo valere per un impersonale (si diceva,... la gente diceva) come si ritrova altre volte in Marco (3, 30; ecc.). Inoltre, da chiunque fosse stato espresso quel giudizio, la venuta dei parenti aveva secondo ogni verosimiglianza uno scopo amichevole e benigno: essi accorrevano, non già per legare e portar via Gesù come pazzo, bensì per indurlo a moderarsi nel suo entusiasmo missionario, a prendersi cura della sua persona, a fare, insomma, una vita comoda e normale tra «i suoi» al riparo dalle minacce dei Farisei. Ma, anche sotto tale luce benigna, quei parenti di Gesù figuravano egualmente come eroi della mediocrità, i quali non sapevano capacitarsi che quel loro singolare congiunto, ignaro di scuole e d’accademie, si fosse messo in testa di prender di petto i Farisei e di sconvolgere la Galilea, invece di starsene tranquillo e pacifico a casa sua.
[Dalla nota 1 a pagina 406: Un altro eroe della mediocrità, Don Abbondio, farà più tardi un ragionamento in sostanza uguale: «È finita: quando son nati con quella smania in corpo, bisogna che facciano sempre fracasso. Ci vuole tanto a fare il galantuomo tutta la vita, come ho fatto io?...». È vero che Gesù insegnava, non solo a fare il galantuomo, ma anche a fare penitenza; tuttavia anche a questo rispondeva Don Abbondio: «La penitenza, quando si ha buona volontà, si può farla a casa sua, quietamente, senza tant’apparato», ecc. (I promessi sposi, cap. 23). Il fondo dell’animo umano, a distanza di millenni, è sempre uguale].
• § 345. Gesù, giudicato fuori di sé, risponde precisamente come era stato giudicato, cioè da persona totalmente dedicata a un’altissima idea morale. Alla precedente notizia, San Marco fa seguire la discussione con i Farisei su Beelzebul “scacciatore di demonii” (§ 444), ma subito appresso riporta nuovamente in scena i parenti di Gesù insieme con sua madre Maria: tutto induce a credere che le due comparse dei parenti si riferiscano a due momenti successivi dello stesso fatto storico. Gesù, pertanto, è tuttora assediato dalla folla nella casa, quando gli si annunzia che sua madre con i suoi “fratelli” stanno fuori desiderosi di parlargli e senza poter entrare. Dunque gli eroi della mediocrità, per meglio riuscire e per far più colpo, avevano contato anche sull’autorità di Maria, dimostratasi così efficace fin dalle nozze di Cana (§ 283). Il che non significa però che Maria assentisse ai loro propositi: se ella venne con loro, fu in parte perché una donna in Palestina ben difficilmente poteva sottrarsi alle decisioni prese da capi di parentela che presumessero agire per il decoro del casato o in favore di un consanguineo, e in parte perché poteva aver molte ragioni personali per rivedere il peregrinante suo figlio, e anche per essere presente come moderatrice quando i parenti lo avessero incontrato. All’annunzio della visita, Gesù rispose che sua madre e i suoi fratelli erano tutti coloro che ascoltavano e praticavano la volontà di Dio, e con un gesto accennò agli uditori che gli si assiepavano attorno. Probabilmente, a questa risposta, gli eroi della mediocrità compresero subito che non c’era niente da fare, e ripeterono anch’essi: «È fuori di sé». Maria, a sua volta, dovette ritrovare gran somiglianza fra questa risposta e quella già avuta dal dodicenne suo figlio nel Tempio (§ 262), e perciò ella depose anche la nuova risposta nel «forziere del suo cuore» per esservi custodita insieme con altre (§ 142).

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, pensiamo alla Benignità di Dio nel modo di rimettere i peccati. Insegna il Catechismo del santo Concilio di Trento: «Il modo stesso che Dio, Padre clementissimo, ha stabilito per cancellare i peccati del mondo, deve efficacemente eccitare l’animo dei fedeli a contemplare la grandezza di questo beneficio. Egli infatti volle che i nostri peccati venissero espiati col sangue del Suo Figlio unigenito, affinché questi pagasse la pena da noi meritata per i nostri peccati ed Egli, giusto, fosse condannato per i peccatori; innocente, subisse una acerbissima morte per i colpevoli. Quante volte perciò ricorderemo che noi non fummo già riscattati con vile moneta, ma col prezioso sangue di Cristo, Agnello incontaminato e senza macchia (1 Pt., 1, 18-19), ci sarà facile dedurre che nulla di più salutare ci poteva essere concesso da Dio, di questa facoltà di rimettere i peccati; dono che mostra tutta la misteriosa provvidenza di Dio e il Suo immenso amore per noi. E altresì necessario che ciascuno ritragga da questa meditazione il maggior frutto possibile, poiché chi offende Dio col peccato mortale, perde i meriti che gli venivano dalla passione e morte di Cristo; cosi gli è negato l’accesso a quel Paradiso, che il Redentore gli aveva aperto a prezzo del Suo preziosissimo sangue. Perciò ogni volta che pensiamo a questo, non possiamo non pensare seriamente alla profonda miseria nostra. Ma se consideriamo quale ammirabile potere fu da Dio concesso alla Sua Chiesa; e se, fermi in questo articolo di fede, crediamo che a ognuno è dato, con l’aiuto divino, di ritornare al primitivo stato di grazia e dignità, allora col cuore pieno di esultanza, ci sentiamo spinti a rivolgere a Dio le più vive grazie. Se quando siamo gravemente malati, ci sembrano buoni e gradevoli perfino i farmaci che la scienza medica ci somministra, quanto più soavi dovranno essere per noi quei rimedi, che la sapienza di Dio istituì a cura delle anime e quindi a restaurazione della vita? Soprattutto perché portano con sé non già una dubbia speranza di salvezza, come le medicine che si prendono per il corpo, ma una sicura salvezza a coloro che bramano di essere sanati».
• Ed ancora: «I fedeli, dopo aver conosciuto la preziosità di così insigne beneficio, saranno esortati a sforzarsi di usarne religiosamente. Poiché è impossibile evitare che chi rifiuta uno strumento utile, anzi necessario, non ne risulti suo spregiatore. Tanto più che il Signore affido alla Chiesa questa potestà di rimettere i peccati, appunto perché tutti facessero ricorso al salutifero rimedio. Come infatti senza il Battesimo nessuno può riacquistare l’innocenza, così chiunque voglia ricuperare la grazia del Battesimo, perduta con colpe mortali, dovrà ricorrere a un altro genere di espiazione, e precisamente al sacramento della Penitenza. Però si devono ammonire i fedeli perché, essendo stata prospettata una possibilità di perdono così ampia da non essere circoscritta da alcun limite di tempo, non si sentano più proclivi al peccato o più pigri alla resipiscenza. Nel primo caso, evidentemente irrispettosi e sprezzanti verso tale divina potestà, sarebbero indegni della misericordia di Dio; nel secondo, dovrebbero vivamente paventare che, colti dalla morte, non si trovino ad avere inutilmente creduto in un perdono dei peccati, che il continuo procrastinare hafatto loro perdere per sempre».
• Cosa fare nella sciagurata ipotesi di aver commesso peccato mortale? Bisogna confessarsi (ovviamente da un vero Prete) il prima possibile. Ma facciamo attenzione, poiché sulla Penitenza è necessario sapere:
a) «La materia di questo Sacramento differisce dagli altri sopratutto perché, mentre la materia degli altri è qualche cosa di naturale, o di artificiale; della Penitenza sono quasi materia gli atti del penitente: cioè la contrizione, la confessione e la soddisfazione, com’è stato dichiarato dal Concilio di Trento»;
b) «La sua (della Penitenza) efficacia nel rimettere i peccati le è in tal modo propria che senza di essa è impossibile non solo ottenere, ma neppure sperarne il perdono, essendo scritto: Se non farete penitenza, perirete tutti allo stesso modo (Lc., 13, 3)»;
c) «Questo Sacramento, oltre alla materia e alla forma, che ha in comune con gli altri Sacramenti, contiene, come abbiamo già detto, tre elementi necessari a renderlo integro e perfetto: la contrizione, la confessione e la soddisfazione. Dice in proposito San Giovanni Crisostomo: La penitenza induce il peccatore a sopportare tutto volentieri: nel suo cuore è la contrizione, sulla bocca la confessione, nelle opere grande umiltà, ossia la salutare soddisfazione. Ora queste parti sono indispensabili alla costituzione di un tutto. La ragione della necessità di queste tre parti è che noi offendiamo Dio in tre maniere: in pensieri, parole ed opere. Perciò è giusto e ragionevole che noi, sottomettendoci alle chiavi della Chiesa, ci sforziamo di placare l’ira di Dio e di ottenere da Lui il perdono dei peccati con quegli stessi mezzi adoperati per offendere il Suo santissimo Nome. Vi è un’altra ragione. La Penitenza è una specie di compenso dei peccati, che procede dalla volontà del peccatore; ed è stabilita dalla volontà di Dio, contro cui si è peccato. Bisogna quindi da un lato che il penitente voglia dare questo compenso, e questo costituisce la contrizione; dall’altro, che egli si sottometta al giudizio del Sacerdote il quale tiene il luogo di Dio, affinché si possa fissare una pena proporzionata alle colpe; ed ecco la necessità della confessione e della soddisfazione»;
d) «La contrizione è un dolore dell’animo e una detestazione del peccato commesso con il proposito di non più peccare per l’avvenire. Parlando più oltre dellacontrizione, bisogna aggiungere con i Padri: Questo atto prepara alla remissione dei peccati, purché sia accompagnato dalla fiducia nella misericordia di Dio e dalla volontà di fare quanto è necessario per ben ricevere il Sacramento della Penitenza»;
e) «Secondo la dottrina della Chiesa Cattolica, tutti devono credere e affermare senza riserva che se uno è sinceramente pentito dei suoi peccati e risoluto di non più commetterli per l’avvenire, quand’anche non sentisse un dolore sufficiente a ottenergli il perdono, otterrà il perdono e la remissione di tutte le colpe in virtù delle chiavi (del regno dei Cieli che Cristo Nostro Signore ha dato alla Chiesa), purché li confessi nel debito modo al Sacerdote. In questo senso tutto i santi Padri hanno proclamato con ragione che il cielo ci è aperto dalle chiavi della Chiesa; e il Concilio di Firenze ha messo questa verità fuori dubbio, dichiarando che l’effetto della Penitenza è la remissione dei peccati... Inoltre l’esperienza prova che nulla giova tanto ad emendare i costumi di persone che menano una vita corrotta, quanto la manifestazione dei segreti pensieri del loro animo, delle loro parole ed azioni, ad un amico prudente e fedele, che li possaaiutare coi suoi servigi e consigli (il vero Confessore)»;
f) «Nessuno osi pensare che la confessione sia stata istituita dal Signore in modo che la pratica non ne sia necessaria. I fedeli sono tenuti a credere che chi ha la coscienza gravata da peccato mortale, deve essere richiamato alla vita spirituale mediante il Sacramento della Confessione (o Penitenza). Vediamo che il Signore espresse questa necessità con una magnifica immagine, quando definì il potere di amministrare questo Sacramento: chiave del regno dei cieli (Mt., 16, 19). Chi può penetrare in un luogo chiuso senza ricorrere a chi ne ha le chiavi? Così nessuno può entrare in Cielo, se i Sacerdoti, alla fedeltà dei quali il Signore consegno le chiavi, non ne dischiudano le porte. Altrimenti sarebbe assolutamente inutile l’uso delle chiavi nella Chiesa»;
g) «La soddisfazione è l’integrale pagamento di quello che è dovuto: poiché è soddisfacente ciò a cui nulla manca. Sicché trattando della riconciliazione per riottenere la grazia, soddisfare significa offrire quel che a un animo irato apparisce sufficiente a vendicare l’ingiuria. In altre parole, la soddisfazione è il compenso offerto per l’ingiuria arrecata ad altri. Nel caso nostro i teologi usarono il vocabolo soddisfazione, per indicare quel genere di compenso che l’uomo offre a Dio per i peccati commessi.... Il santo Concilio Tridentino spiega luminosamente la ragione, per cui non tutta la pena viene condonata nel Sacramento della Penitenza, come invece accade nel Battesimo, con queste parole: “L’essenza della giustizia divina esige che in modo diverso siano ricevuti in grazia coloro che per ignoranza peccarono prima del Battesimo, e coloro che, una volta affrancati dalla schiavitù del peccato e del demonio, insigniti del dono dello Spirito santo, non esitano a violare consapevolmente il tempio di Dio e a contristare lo Spirito santo. In questo caso conviene alla divina clemenza che non siano condonati i peccati senza alcuna soddisfazione, perché alla prima occasione, reputando poca cosa la colpa, disprezzando lo Spirito santo, non cadiamo in misfatti più gravi, accumulando l’ira divina per il giorno della vendetta. Senza dubbio le pene soddisfattorie trattengono efficamente dal peccato e ci stringono con un freno potente, rendendoci piùcauti e vigili per l’avvenire”»;
h) «La soddisfazione può essere di due tipi: Tipo uno) La più alta ed eccellente soddisfazione è quella con la quale, a compenso delle nostre colpe, è stato dato a Dio tutto ciò che da parte nostra gli si doveva, pur supponendo che Dio abbia voluto trattarci a rigore di diritto. Tale soddisfazione, che ci rese Dio placato e propizio, fu offerta unicamente da Gesù Cristo Signor nostro; che sulla croce scontò l’intero debito dei nostri peccati. Nessuna creatura avrebbe potuto sgravarci di così pesante onere; per questo, Egli, secondo la parola di San Giovanni, si diede pegno di propiziazione per le colpe nostre e per quelle di tutto il mondo (1 Jn., 2, 2); Tipo due) Un secondo genere di soddisfazione è detto canonico; e si compie in un determinato periodo di tempo. È antichissima consuetudine ecclesiastica che, nel momento dell’assoluzione, sia assegnata ai penitenti una penitenza determinata, il cui soddisfacimento è appunto chiamato soddisfazione. Col medesimo nome è pure indicato ogni genere di penalità, che spontaneamente e deliberatamente affrontiamo a sconto dei nostri peccati, anche senza l’imposizione del Sacerdote».
• Ciò premesso, dunque avendo capito che cos’è la Penitenza e come si deve compiere, torniamo ad usare lo splendido volume «Vita di Gesù Cristo» secondo gli edotti studi dell’Abate Giuseppe Ricciotti, che oggi ci parla della «Peccatrice innominata». § 341. A questo punto il solo San Luca, lo scriba mansuetudinis Christi secondo la definizione dell’Alighieri (§ 138), narra un episodio che dimostra quella mansuetudine. I Farisei continuano a sorvegliare Gesù; ma non è necessario che la sorveglianza abbia sempre un aspetto aggressivo, anzi talvolta è maniera più astuta darle un sembiante amichevole. Per questa ragione un Fariseo, dal nome comunissimo di Simone, invita Gesù a pranzo: il luogo non è nominato, ma doveva essere una borgata della Galilea. Il pranzo, secondo l’uso del tempo, è tenuto in una stanza con nel mezzo una tavola a semicerchio: nell’interno del semicerchio s’aggirano i servi con le vivande, e i convitati stanno in piccoli divani che sono disposti radialmente all’esterno del semicerchio; quindi ogni convitato è sdraiato sul suo divano in modo da appoggiarsi su un gomito e da avere il busto vicino alla tavola, mentre i suoi piedi rimangono un po’ fuori del divano e lontani dalla tavola. Il pranzo offerto da Simone ha vari convitati, e probabilmente non è stato imbandito apposta per Gesù: tuttavia Simone ha colto l’occasione per invitare anche l’indomito predicatore e studiarselo comodamente da vicino nella sincerità che suscitano i fumi d’un convito; ad ogni modo a Gesù, convocato più a un esame che a un convito, sono negati i complimenti riserbati ordinariamente a un invitato insigne, quali la lavanda dei piedi appena entrato, l’abbraccio e il bacio da parte del padrone di casa, lo spruzzo di profumi sulla testa prima di mettersi a tavola. Gesù nota queste negate attenzioni, ma non dice nulla e si mette a tavola con gli altri. Ma ecco che, nel colmo del convito, entra nella stanza una donna: confusa tra i familiari che servono, ella non parla a nessuno, va di filata al divano di Gesù, s’inginocchia all’esterno nella parte più lontana dalla tavola, e lì scoppia in pianto. Le sue lacrime sono così abbondanti che rigano i piedi di Gesù: ella però non vuole che quei piedi rimangano rigati dai segni del dolore, ma trovandosi nell’imprevisto e non avendo con sé un panno per asciugarli, per maggior deferenza scioglie i suoi capelli e così asciuga quei piedi; poi li bacia e ribacia, poi ancora li spruzza col profumo d’un vasetto d’alabastro che ha portato con sé per ungere la testa della persona venerata (§ 501). Tutto avviene senza una parola da parte della donna o di Gesù. Solo un sottile sorriso illumina la faccia di Simone: l’esaminatore ha già giudicato l’esaminando e l’ha riprovato. Simone, infatti, a quella vista ragiona dentro di sé: Costui, se fosse profeta, saprebbe chi e che razza di donna è colei che lo tocca: è infatti una peccatrice! (Luca, 7, 39). Per i Farisei peccatrice aveva un significato vario: poteva designare tanto una donna di perversi costumi, quanto una donna che non osservava le prescrizioni farisaiche; nel Talmud è equiparata a una peccatrice anche la moglie che dia a mangiare a suo marito cibi di cui non sia stata pagata la decima. Seguendo una via di mezzo, si potrà supporre che la donna introdottasi nel convito di Simone fosse una persona di reputazione dubbia, giacché, se fosse stata una vera meretrice, ben difficilmente i familiari del Fariseo l’avrebbero lasciata penetrare dentro la casa: lo scandalo, davanti ai convitati, sarebbe stato troppo grave. L’ignota donna certamente già conosceva Gesù almeno di vista: l’aveva udito parlare in pubblico, aveva ascoltato dalla sua bocca quelle parole che richiamavano inesorabilmente tutti al “cambiamento di mente” (§ 335) ma nello stesso tempo suonavano così benigne e confortevoli ai più traviati ed abietti; ella ne era stata dapprima sconvolta ed atterrata nell’abiettezza della sua vita, poi sentendosi risollevata e sorretta dalla misericordiosa speranza diffusa nel suo cuore in virtù di quelle stesse parole, aveva fermamente creduto in una vita nuova, e al momento d’iniziarla si era presentata al suo rigeneratore per esprimergli i propri sentimenti in maniera squisitamente femminea.
• § 342. Il sottile sorriso beffardo di Simone forse fu notato da Gesù, il suo occulto pensiero di riprovazione certamente fu letto dal riprovato, che perciò gli rivolse pacatamente la parola: Simone, ho qualche cosa da dirti! - E l’altro, condiscendente: Maestro, dì pure! - Gesù allora: Ci fu una volta un creditore che doveva riscuotere da un debitore la somma di 500 denari e da un altro una somma dieci volte minore, cioè soltanto 50 denari; ma poiché nessuno dei due debitori era in grado di pagare e il creditore era un uomo di buon cuore, rimise ad ambedue i loro debiti rispettivi. Di questi debitori condonati chi credi tu, Simone, che sarà più grato e più affezionato al generoso creditore? - Simone rispose: Mi immagino che sarà colui al quale è stato condonato di più. - La risposta era tanto elementare quanto giusta. Gesù allora replicò: Vedi questa donna? Entrai in casa tua, acqua ai miei piedi non desti: costei invece mi bagnò con le lacrime i piedi ed asciugò con i suoi capelli. Bacio non mi desti: costei invece, da quando entrai, non cessava di baciarmi i piedi. Con olio la mia testa non ungesti: costei invece con unguento mi unse i piedi. In grazia di che, ti dico, sono rimessi i peccati di lei i quali (sono) molti perché amò molto; a chi invece poco si rimette, poco ama (Luca, 7, 44-47). Non sono mancati i mestieranti della logica che hanno scoperto una conclusione illogica nel ragionamento di Gesù: la conclusione legittima, in armonia con la parabola dei due debitori, sarebbe stata che la peccatrice doveva amare di più perché di più le era stato condonato. Senonché l’obiezione suppone che Gesù avesse voglia d’insegnare la maniera di fare i compassati sillogismi «in forma», sostituendosi nel mestiere ad Aristotele: ma Gesù aveva altro da fare, e ragionava seguendo la logica pratica di tutti gli uomini, che spessissimo saltano alla conclusione tralasciando talune premesse facilmente comprensibili. Nel caso nostro, la peccatrice conseguì la molta remissione perché amò molto, ma, se amò molto, la ragione a sua volta è che ella ricercò e quasi prevenne la molta remissione: l’amore fu unico, e dapprima spinse la peccatrice a cercar la remissione e ne fu causa, poi la confermò nella remissione e ne fu effetto, come fu effetto della remissione nel debitore della parabola. Le due conseguenze si richiamano a vicenda, e Gesù senza limitarsi alla conseguenza che sarebbe scaturita a rigore dalla parabola, insiste piuttosto sull’altra, giacché parlava a Simone il quale da buon Fariseo aveva poco di esteriore da farsi perdonare ma aveva anche poco amore interiore. Ora, per Gesù, ostacolo ad entrare nel regno di Dio erano certamente i peccati, ma questi potevano esser sempre perdonati: ostacolo insuperabile era invece la mancanza di spinta ad entrare, la mancanza d’amore. Un Fariseo, posto anche sulla soglia del regno, difficilmente vi sarebbe entrato perché era soddisfatto di se stesso e gli mancava la spinta a fare i due o tre passi per entrare; una meretrice invece, quando si fosse accorta di ciò che era, avrebbe avuto ribrezzo di se stessa e avrebbe corso le mille miglia per entrare nel regno, sospinta nella sua corsa dall’amore. Amore pondus e amore praemium, come rifletterà più tardi l’esperto Agostino. Del resto Gesù, recandosi in casa di Simone, aveva veramente donato molto, pur essendone contraccambiato male dal Fariseo; la donna invece aveva ricercato ella stessa Gesù offrendogli ogni prova di devozione, e con ciò aveva donato molto, pur non essendo stata prevenuta apparentemente da Gesù. Di qui la sua ampia retribuzione; la quale, inoltre, servirà a confermarla sempre più nel suo amore. Terminato il ragionamento a Simone, Gesù si rivolse alla donna e le disse: Ti sono rimessi i peccati. Come rimanesse Simone non sappiamo; ci è riferito soltanto che gli altri convitati, della tempra di Simone, cominciarono a dire dentro di sé: Chi e costui che rimette pure i peccati? La stessa riflessione era stata fatta dai Farisei presenti alla scena del paralitico calato dal soffitto (§ 305), e allora Gesù aveva chiuso loro la bocca con un miracolo; questa volta il miracolo non fu compiuto, perché Gesù non aveva alcun motivo di compierne uno ogni qual volta delle oche messesi a far da guardiane ad un presunto campidoglio d’ortodossia avessero cominciato a gracchiare. Preferì invece confermare la donna nella sua nuova via, e le disse: La fede tua ti ha salvata: va’ in pace! Pace e amore erano la stessa cosa. [Libro utilizzato: «Vita di Gesù Cristo» - Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941, dell’Abate Giuseppe Ricciotti - riposi in pace!].
Oggigiorno molti cattolici nominali - ed è inutile perdere tempo a menzionare gli sventurati delle false religioni - credono che amare significhi fare sesso. E dietro il paravento della parola amore pretendono di giustificare e di imporre ogni mostruosa perversità e follia. In verità amare è fare la volontà della persona amata. Gesù definisce chi veramente Lo ama: «Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama» (Gv., 14, 21).

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, il compianto Abate Giuseppe Ricciotti - autore della splendida «Vita di Gesù Cristo» - dopo aver analizzato le vicende storiche della vedova di Naim, alla quale Nostro Signore resuscita il figlio (vera resurrezione e non episodio simbolico), e del giusto centurione di Cafarnao, per la cui fede Gesù restituisce la salute all’amico schiavo ammalato, torna a parlarci di San Giovanni Battista e della sua predicazione. Capitolo: «Il messaggio di Giovanni il Battista».
• § 338. Frattanto nei sotterranei di Macheronte (§ 292) Giovanni fremeva come un leone racchiuso. Quanto più il tempo passava e la prigionia si prolungava, tanto più il suo spirito si struggeva di vibrante attesa: egli era nato e vissuto per essere il precursore del Messia, e non aveva sottratto un sol giorno della sua esistenza a quella missione; ma adesso che la sua esistenza, da un giorno all’altro, poteva esser troncata dalla prepotenza degli uomini, egli ancora non vedeva coronata la sua missione da una palese e solenne manifestazione del Messia. Questa ansiosa aspettativa era grave al prigioniero ben più dell’estenuante inerzia a cui era condannato e ben più della spada di Erode Antipa che gli roteava sulla testa. La segregazione non era però totale: il tiranno, che nutriva per Giovanni una superstiziosa venerazione (§ 17), gli permetteva di ricevere nella prigione i suoi discepoli rimastigli attaccati anche dopo la comparsa in pubblico di Gesù, per il quale del resto taluni di essi nutrivano una certa avversione (§§ 291, 307). Mediante le notizie che riceveva da questi visitatori, il prigioniero seguiva i progressi che faceva il ministero di Gesù ed i fatti straordinari che l’accompagnavano; ma quelle notizie, se rinsaldavano sempre più nel suo spirito l’opinione ch’egli aveva di Gesù e che aveva pure espressa pubblicamente, aumentavano sempre più la sua ansiosa aspettativa. I visitatori gli annunziavano che il nuovo Rabbi operava miracoli, sì ma giammai in nessuna occasione si era proclamato Messia, anzi redarguiva severamente coloro che lo proclamavano tale e fuggiva ogni occasione a che le turbe facessero ciò (§ 300); è anche molto probabile che i visitatori, riferendogli questo, se ne compiacessero nella gelosia che nutrivano per Gesù insieme con l’affetto per Giovanni. Il prigioniero invece ne doveva essere accorato: forse si domandava se il suo ufficio di precursore era totalmente terminato, e se egli, pur dalla prigione, non dovesse ancora compiere qualche cosa per far riconoscere Gesù come Messia. Perché dunque il figlio di Maria tardava tanto a proclamarsi Messia? Solo con questa solenne proclamazione l’ufficio di lui, Giovanni, si sarebbe concluso per sempre, mentre senza di essa egli sarebbe rimasto il precursore di uno che in realtà non compariva. Eppure oramai egli era tagliato fuori dalla vita del popolo, e da un momento all’altro poteva anche partire da questo mondo, senza aver la consolazione di vedere che il popolo accorreva compatto al Messia da lui additato, anzi vedendo che perfino i suoi propri discepoli sentivano una certa ripulsa per Gesù. Che poteva fare egli ancora dalla prigione? Come sospingere Gesù all’attesa proclamazione, e come insieme sospingere verso Gesù i suoi propri discepoli?
• § 339. Un giorno il prigioniero prese la sua risoluzione. Da Macheronte egli inviò due suoi discepoli a Gesù con l’incarico di rivolgergli questa domanda: «Sei tu il Veniente, o (bisogna) che aspettiamo un altro?» (Luca, 1, 19-20). L’espressione il Veniente designava per i Giudei un «termine fisso d’eterno consiglio», cioè quel Messia che «doveva venire» (§§ 213, 296, 374, 505), di cui gli antichi profeti erano stati lontani araldi e Giovanni il Battista si era presentato quale immediato precursore. La domanda, perciò, costringeva ad una precisa dichiarazione sia Gesù che la riceveva, sia i discepoli di Giovanni che la rivolgevano: Gesù non poteva negare in pubblico quella sua qualità di cui Giovanni era assolutamente certo; i discepoli interroganti, udendo anche dalla bocca di Gesù quella stessa affermazione che a suo riguardo avevano udito dalla bocca del venerato Giovanni, non potevano esitare ad abbandonare la loro diffidenza verso Gesù e ad aderire a lui. D’altra parte la domanda, pur essendo così contingente, aveva un’intonazione generica: era in sostanza la medesima domanda che i maggiorenti di Gerusalemme avevano rivolto alcuni mesi prima allo stesso Giovanni (§ 277). La risposta di Gesù fu diversa da quella aspettata: egli non pronunziò il «no» ch’era impossibile, ma neppure pronunziò il chiaro ed esplicito «si» che Giovanni aveva tentato di provocare. Quando i due inviati esposero la domanda a Gesù, «egli in quell’ora curò molti da malattie e infermità e spiriti maligni, e a molti ciechi fece grazia di vedere; poi rispondendo disse a quelli: “Andate ad annunziare a Giovanni le cose che vedeste e udiste: Ciechi vedono, zoppi camminano, lebbrosi sono mondati, e sordi odono, morti risorgono, poveri ricevono la buona novella: ed è beato colui che non si scandalizzi in me”» (Luca, 7, 21-23). In conclusione, invece di rispondere con parole Gesù rispondeva con fatti, i quali valevano a dimostrare se egli era o no il Veniente Messia. Ma i fatti miracolosi presenti si richiamavano a parole profetiche passate, perché già da Isaia era stato annunziato che ai tempi messianici i ciechi avrebbero visto, i sordi udito, gli zoppi camminato (Isaia, 29, 18; 35, 5-6), ed i poveri avrebbero ricevuto la buona novella (Is., 61, 1); se dunque Gesù avverava con le sue opere le profezie messianiche, le stesse opere lo proclamavano Messia. Tuttavia, questa esplicita proclamazione dalla bocca sua non uscì. L’inaspettata risposta fu certo riportata al prigioniero, ma non ci è riferito che impressione facesse su lui. È ben possibile che Giovanni avesse preferito sentirsi riportare come Gesù si fosse proclamato apertamente e sonoramente Messia, e come a quella proclamazione tutti i Giudei di Palestina e di fuori fossero accorsi osannanti al loro re: molto più tardi gli stessi discepoli di Gesù, edotti per lunghi mesi alla scuola di lui, s’aspetteranno ancora qualcosa di simile. Se questa fu realmente l’aspettativa di Giovanni, bisognerebbe applicare anche a lui l’osservazione che lo stesso San Luca fa sui genitori di Gesù, i quali non capirono la parola che pronunziò loro (§ 262); Giovanni non avrebbe capito la risposta di Gesù per varie possibili ragioni, fra cui quella di non sapere che Gesù seguiva una linea di manifestazione graduale della propria messianicità per motivi altamente spirituali (§ 300 segg.).
• § 340. L’onorevole provocazione di Giovanni, sebbene non assecondata, fu gradita da Gesù. Per mostrare che il precursore non era certamente uno di coloro che si sarebbero scandalizzati di lui, Gesù, dopo la partenza dei due invitati, fece il più alto elogio di Giovanni proclamandolo più che profeta, a nessuno inferiore fra i nati di donna, e infine precursore del Messia conforme alla profezia di Malachia, 3, 1. Senonché, mentre la povera gente ed i pubblicani avevano accolto la predicazione di Giovanni ed accettato il suo battesimo, la massima parte degli Scribi e dei Farisei era rimasta retriva rendendo «vano il consiglio d’Iddio a loro riguardo» (Luca, 7, 30). Perciò Gesù soggiunse una similitudine: «A chi dunque rassomiglierò gli uomini di questa generazione, e a chi sono somiglianti? Sono somiglianti a quei ragazzetti che stanno nella piazza, e si apostrofano tra di loro dicendo: ”Il flauto vi sonammo e non ballaste! - Lamentele facemmo e non piangeste!”». La similitudine è presa dagli usi di quei tempi. I ragazzi della Palestina si divertivano sulle piazze ad imitare le carie costumanze sociali, perciò anche i cortei nuziali e quelli funebri: nel primo caso, alcuni suonavano o fingevano di suonare flauti, mentre gli altri dovevano ballare come se fossero gli «amici dello sposo» (§ 281); nel secondo caso, gli uni imitavano le manifestazioni di cordoglio fatte dalle lamentatrici di professione ch’erano chiamate ai funerali, e gli altri dovevano piangere come se fossero i parenti del defunto. Tuttavia spesso il giuoco non riusciva bene, perché il gruppo di ragazzi che doveva o ballare o piangere non faceva con diligenza la sua parte, e allora sorgevano recriminazioni e apostrofi interminabili. L’applicazione della similitudine fu fatta da Gesù stesso, che proseguì: «È venuto infatti Giovanni il Battista non mangiando pane né bevendo vino, e dite: “Ha un demonio”; è venuto il figlio dell’uomo mangiando e bevendo, e dite: “Ecco un uomo mangiatore e bevitore di vino, amico di pubblicani e peccatori”» (Luca, 7, 33-34). I Farisei non avevano accettato la predicazione di Giovanni perché, oltre il resto, egli era troppo rigoroso ed austero, tanto da sembrare un fanatico spiritato (anche oggi gli Arabi chiamerebbero un uomo siffatto un maģnūn, ossia posseduto dal ginn, «spirito folletto»; ma ecco che, comparso Gesù, anche la sua predicazione era respinta col pretesto ch’egli mangiava come tutti gli uomini, lasciava mangiare i suoi discepoli quando avevano fame (§§ 307-308), e trattava con pubblicani e peccatori. Cosicché, o si suonasse il flauto o si alzassero lamenti funebri, il giuoco non riusciva mai bene con i Farisei, ma perché essi, appunto, non volevano farlo riuscire bene. Eppure sarebbe riuscito egualmente, perché «la Sapienza (divina) fu riconosciuta giusta da tutti i suoi figli (in Matteo, 11, 19, greco: dalle sue opere). Fine.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, il compianto Abate Giuseppe Ricciotti - autore di una vera «Vita di Gesù Cristo»: contro le mondane fantasticherie e mistificazioni dei modernisti - oggi ci presenta altri due personaggi: «Il centurione di Cafarnao e la vedova di Naim».
• § 336. Tanto San Luca quanto San Matteo mettono dopo il Discorso della montagna l’episodio del centurione di Cafarnao: la circostanza cronologica sembra dunque assicurata, ed essa, insieme con le divergenze interne, basta a distinguere questo episodio dall’altro dell’impiegato regio (§ 298), sebbene in realtà i due episodi abbiano vari tratti somiglianti. Poco dopo il Discorso, Gesù rientrò a Cafarnao, dov’era di guarnigione un centurione: probabilmente faceva parte delle truppe mercenarie del locale tetrarca Erode Antipa, non di qualche distaccamento romano. Era pagano, ma ben disposto verso il giudaismo, tanto che aveva costruito a sue spese la sinagoga di Cafarnao (§ 285); la sua bontà di cuore è confermata anche dal fatto che aveva uno schiavo al quale era affezionatissimo, trattandolo più da figlio che da schiavo. Ora, questo schiavo si era ammalato e stava in punto di morte; il desolato centurione, che aveva certamente tentato tutte le cure ma invano. Conosceva di fama Gesù, anzi proprio in quel giorno Cafarnao si doveva essere quasi svuotata perché molti si erano recati sulla vicina montagna ove il famoso taumaturgo teneva un gran discorso. Disperando dei medici, il centurione pensò spontaneamente al taumaturgo; ma non osava di proporgli il suo caso, anche perché non era stato in relazioni personali con lui. Si rivolse allora a Giudei insigni del paese, affinché parlassero a Gesù del moribondo pregandolo di far qualcosa per lui. I Giudei fecero l’ambasciata e raccomandarono vivamente a Gesù il desiderio del centurione: «È degno che tu gli conceda ciò: ama infatti la nostra nazione, e la sinagoga ci costruì (proprio) egli» (Luca, 7, 15). Gesù, giudeo, fu accessibile a questa domanda giudaica: quel pagano era stato un benefattore anche di lui, perché della sinagoga di Cafarnao anche Gesù si era servito per pregare e predicare; senz’altro, quindi, s’avviò insieme con gli intercessori alla volta della casa del centurione. Ne era già in vista, quando fu incontrato da una seconda ambasceria inviatagli dal centurione. Costui sentiva una certa titubanza, motivata da scrupolo e da rispetto: la sua casa era pagana, cioè tale che un Giudeo osservante non avrebbe potuto entrarvi senza stimarsi contaminato; ed il famoso Gesù non avrebbe sentito interiormente ripugnanza a tale ingresso, o almeno non ne avrebbe riportato esteriormente disonore presso i suoi correligionari? Perciò la nuova ambasceria avvertì delicatamente Gesù da parte del centurione: «Signore, non ti disturbare! Non sono infatti degno che entri sotto il mio tetto; perciò neppure mi stimai degno di venire da te: ma comanda a parola, e sia sanato il mio servo! Anch’io, infatti, sono uomo ch’è messo sotto autorità, avendo sotto di me soldati, e dico a questo “Vai!” ed (egli) va, e ad un altro e “Vieni!” ed (egli) viene, ed al mio schiavo e “Fai ciò!” ed (egli lo) fa» (Luca, 7, 6-8). Il centurione voleva giustificare la propria deferenza verso Gesù col suo spirito soldatesco. Egli conosceva bene ciò che i Romani d’allora chiamavano l’imperium e noi oggi chiamiamo la disciplina militare, e la esercitava sui propri soldati essendone sempre obbedito; Gesù, quindi, non si abbassasse fino a venire in casa sua, ma pronunziasse una sola parola d’imperium, e il suo comando sarebbe subito riconosciuto ed eseguito dalle forze della natura che opprimevano il moribondo. Udite tali cose, Gesù l’ammirò, e rivoltosi alla folla che lo seguiva disse: «Vi dico, neppure in Israele trovai tanta fede!». E subito la parola d’imperium aspettata dalla bocca di Gesù fu pronunziata, ed il malato fu guarito all’istante. Ma nel racconto evangelico tutto ciò passa quasi in seconda linea, mentre in prima linea rimane la tanta fede.
• § 337. A questo episodio il solo Luca soggiunge quello di Naim. In greco il nome è Nain, e si è conservato in quello arabo odierno. Il villaggio è situato alle falde del Piccolo Hermon, a una dozzina di chilometri da Nazareth e a una cinquantina da Cafarnao per la strada odierna, e oggi consta di poche e miserabili case con neppure 200 abitanti tutti musulmani; ai tempi di Gesù era certo in condizioni migliori, ma era egualmente di poca ampiezza e sembra che avesse un’unica porta nelle mura. A questa «borgatuccia» Gesù un giorno giunse accompagnato dai discepoli e da molta folla. Mentre egli stava per entrare nella porta delle mura, ecco uscirne un corteo funebre, indirizzato certamente a quel cimitero ch’è ancora oggi superstite a breve distanza dalle case e contiene antiche tombe scavate nella roccia. Portavano alla tomba un giovanetto; la madre del morto, ch’era vedova ed aveva quel solo figlio, seguiva la salma. Il caso era particolarmente pietoso, e forse ciò spiega anche perché «c’era molta folla della città insieme con essa», con la vedova (Luca, 7, 12): certamente tutti della borgata avevano risaputo della disgrazia e volevano condolersi con l’infelicissima madre. Di tutto il resto che Gesù vide in quest’incontro, non dice nulla il sapiente San Luca; per lo scrittore medico il triste corteo si riassume tutto nella madre piangente, e Gesù non vede che lei: «E vedutala, il Signore s’intenerì su di lei, e le disse “Non piangere!”». Queste due parole erano state certamente ripetute centinaia o migliaia di volte in quella giornata alla povera donna, ma rimanevano soltanto parole. Gesù andò oltre le parole; «e avvicinandosi toccò la bara - i portatori allora si fermarono - e disse: “Giovanetto, dico a te, alzati!”. E il morto si alzò a sedere, e cominciò a parlare; e (Gesù) lo dette alla sua mamma». La descrizione, come ognuno vede, è quanto di più vivo ed immediato si possa immaginare; ha perfino il realismo di far notare come i portatori si fermassero sorpresi da quell’inaspettato intervento, e come il morto, tornato in vita (ma sbalordito ben più dei portatori), per prima cosa si mettesse a sedere sulla bara, quasi per prendere tempo ad orientarsi e rendersi conto di quanto era successo. Se dunque si trattasse della descrizione d’un corteo nuziale qualsiasi, oppure d’una scena in cui Gesù semplicemente accarezzi bambini, nessun critico avrebbe trovato alcunché da ridire e tutti sarebbero stati d’accordo nell’accettare la narrazione tale quale, senza scoprirvi dei sottintesi. Ma qui c’è di mezzo il morto che risuscita; ed ecco perciò che il testo di Luca è stato collocato insieme con le presunte allegorie del IV Vangelo e considerato come un simbolo continuato: la madre vedova sarebbe - (secondo il violentatore della Scrittura e sfortunato modernista Alfred Loisy) - Gerusalemme, il figlio unico sarebbe Israele, il quale è strappato dalla morte e restituito alla madre mercé la potenza di Gesù. Basta però rileggere il testo di Luca per riscontrare se interpretazioni siffatte siano dettate da critica e storica, oppure da prevenzioni “filosofiche”, e se queste prevenzioni rispettino l’indole della narrazione oppure la deformino totalmente. [Libro utilizzato: «Vita di Gesù Cristo» - Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941, dell’Abate Giuseppe Ricciotti - riposi in pace!]. Fine.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, col numero 126 di Sursum Corda - anche questo pubblicato in forma ridotta - terminiamo la serie di editoriali dedicati al «Discorso della montagna», secondo gli eruditi e competenti studi dell’Abate Ricciotti.
• § 330. Riprendiamo con la citazione del Discorso di Gesù: «Qualora poi digiuniate non diventate, come gli ipocriti, mesti: sfigurano infatti le loro facce, affinché appaiano digiunanti agli uomini; in verità vi dico, sono in possesso della loro mercede. Tu invece, digiunando, ungiti la testa e lavati la faccia, affinché (tu) non appaia digiunante agli uomini bensì al Padre tuo quello (ch’è) nel segreto, e il Padre tuo che guarda nel segreto renderà a te». Per la pratica del digiuno presso i Farisei, vedere il § 77; all’ostentazione usata da loro, Gesù qui contrappone un’espressa dissimulazione, senza però affatto riprovare il digiuno in sé. «Non tesoreggiate per voi tesori sulla terra, dove verme e tignuola manda in rovina e dove ladri perforano e rubano; tesoreggiate invece per voi tesori in cielo, dove né verme né tignuola manda in rovina e dove ladri non perforano né rubano: dove infatti è il tesoro tuo, ivi sarà pure il cuore tuo». La sanzione ultraterrena che è alla base di tutto il Discorso della montagna (§ 319) sembra più appariscente qui ove si tratta del bene più palpabile per gli uomini, che è quello delle ricchezze; ma è solo un’apparenza, e la stessa sanzione ultraterrena è altrettanto indispensabile nelle trattazioni precedenti. «La lucerna del corpo è l’occhio: qualora dunque l’occhio tuo sta puro, tutto il corpo tuo sarà illuminato; qualora invece l’occhio tuo sia (in) malo (stato), tutto il corpo tuo sarà ottenebrato: se dunque la luce quella (ch’è) in te è tenebra, la tenebra quanta (sarà mai)?». Anche questo tratto, dei verss. 22-23 di Matteo, è riferito in altra circostanza storica da Luca (11, 34-36) e molto più opportunamente: qui invece il tratto non si ricollega con ciò che precede né con ciò che segue, anzi ciò che segue si ricollega direttamente, scavalcando cioè questo tratto, con ciò che precede.
• § 331. «Nessuno può servire a due padroni: o infatti (egli) l’uno odierà e l’altro amerà, oppure all’uno s’attaccherà e l’altro disprezzerà; non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò vi dico, non v’affannate per la vostra vita riguardo a ciò che mangerete o che berrete, nè per il vostro corpo riguardo a ciò che indosserete: non è forse la vita dappiù del nutrimento e il corpo dell’indumento? Riguardate i volatili del cielo, giacché non seminano né mietono né radunano su granai, e(p pure) il Padre vostro celeste li nutrisce: non valete voi forse più di loro? Chi di voi poi affannandosi può aggiungere alla propria età un solo cubito? E circa l’indumento di che vi affannate? Riflettete sui gigli del campo come crescono: non s’affaticano né filano: eppure vi dico che nemmeno Salomone in tutta la sua gloria fu rivestito come uno di questi; se dunque l’erba del campo che oggi esiste e domani si getta nel forno Iddio riveste così, non (rivestirà) molto più voi, (o) scarsi di fede? Non v’affannate dunque dicendo “Che mangeremo?” o “Che berremo?” o “Di che ci rivestiremo?”, Tutte queste cose, infatti, i pagani ricercano: sa invero il vostro Padre celeste che abbisognate di tutte queste cose. Cercate invece prima il regno e la Sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non v’affannate dunque per il dimani, perché il dimani s’affannerà per se stesso: sufficiente a (ciascun) giorno (è ) la sua pena.
[Dalle note alla pagina 389: 1) Nel verso 24 «Mammona» è voce ebraica e aramaica (matmon, māmōnā, trascritta in greco ...), e sebbene si discuta sulla derivazione della forma aramaica, il significato generico era certamente quello di «ricchezza» (anche presso i Cartaginesi, secondo Sant’Agostino, «lucrum Punice mammon dicitur»): qui è la Ricchezza personificata e contrapposta a Dio, senza però che sia necessario supporre - come taluni fantasiosi moderni hanno fatto - che esistesse una divinità pagana chiamata Mammona. (...) I gigli del campo del vers. 28 non erano quelli dei nostri giardini, ma fioretti assai più piccoli, benché appariscenti, che sbocciavano numerosi in primavera sulle colline della Galilea: quand’erano secchi s’impiegavano a riscaldare il forno, il piccolo arnese domestico in cui si coceva la focaccia. 2) Il versetto «Non date la cosa santa ai cani, né gettate le vostre perle davanti ai porci» si presenta come uno dei tipici logia (§ 98), e il suo collegamento col presente contesto è reso difficile dal fatto che non si comprende chiaramente la sua precisa allusione storica. La Chiesa antica fondò su esso la disciplina arcani stabilita a venerazione dell’Eucaristia (Didachè, IX, 5; cfr. Tertulliano, De praescript., 41), e ancora oggi la liturgia bizantina chiama «perle» i frammenti del pane Eucaristico; ma secondo la serie di Matteo il versetto non avrebbe potuto essere compreso dagli uditori del Discorso della montagna, ai quali ancora non era stata fatta alcuna allusione alla futura Eucaristia. Le ipotesi fatte dagli studiosi moderni sono numerose, ma molte gratuite e non poche false. Il senso generico del versetto non può essere che questo, di non trasmettere l’insegnamento di Gesù (la cosa santa) a persone che siano indegne (...cani... porci...) e per di più pronte a profanarlo ed a servirsene a scopi di male (...rivoltatisi...)].
• § 332. «Non giudicate (a condanna), affinché non siate giudicati (a condanna): con quel giudizio, infatti, con cui giudicate sarete giudicati, e con quella misura con cui misurate si misurerà per voi. Perché poi vedi la pagliuzza che (è) nell’occhio del tuo fratello, mentre della trave (ch’è) nell’occhio tuo non t’accorgi? Ovvero, come dirai al tuo fratello “Permetti che (io) cavi la pa-gliuzza dall’occhio tuo”, ed ecco la trave (è) nell’occhio tuo? Ipocrita, cava prima dall’occhio tuo la trave, e allora guarderai di cavare la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. Non date la cosa santa ai cani, nè gettate le vostre perle davanti ai porci, affinché mai non (sia che) le calpestino con le loro zampe e rivoltatisi (contro voi) vi sbranino. [La nota 2 prima citata - dalla pagina 389 - commenta questo versetto]. Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate e vi sarà aperto. Ognuno infatti che chiede riceve, e chi cerca trova, e chi picchia gli sarà aperto. Ovvero qual uomo è tra voi a cui suo figlio chiederà un pane - gli darà forse un sasso? O anche chiederà un pesce - gli darà forse un serpente? Se dunque voi, (pur) essendo cattivi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro quello ch’è nei cieli darà cose buone a quei che gli chiedono? Tutte le cose, dunque, quante possiate volere che facciano a voi gli uomini, in questa maniera fate(le) anche voi a loro. Questa, infatti, è la Legge e i Profeti».
• § 333. Prosegue: «Entrate per la porta stretta, perché (è) larga la porta e spaziosa la strada che conduce alla perdizione e molti sono quei che entrano per essa: perché stretta è la porta e angusta la strada che conduce alla vita e pochi sono quei che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in rivestimenti di pecore, al di dentro invece sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si colgono forse dalle spine grappoli, o dai rovi fichi? Così ogni albero buono fa frutti belli, invece l’albero guasto fa frutti cattivi: non può un albero buono produrre frutti cattivi, né un albero guasto produrre frutti belli. Ogni albero che non fa bel frutto è reciso via e gettato nel fuoco. Dunque dai loro frutti li riconoscerete. Non chiunque mi dica “Signore! Signore!” entrerà nel regno dei cieli, bensì chi faccia la volontà del Padre mio [chi osserverà i Comandamenti e la Legge della Chiesa, ndR], quello ch’è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: “Signore! Signore! Non profetammo nel tuo nome, e nel tuo nome scacciammo demonii, e nel tuo nome facemmo molti prodigi?”. E allora dichiarerò ad essi: “Giammai vi conobbi: allontanatevi da me, operatori d’iniquità!”». [Gesù si riferisce al momento del giudizio].
• § 334. «Chiunque, pertanto, ascolta da me questi discorsi e li fa, si rassomiglierà ad un uomo saggio il quale edificò la sua casa sopra la roccia: e scese la pioggia e vennero i fiumi e soffiarono i venti e s’abbatterono su quella casa, e(ppure) non cadde; era infatti basata sulla roccia. E chiunque ascolta da me questi discorsi e non li fa, si rassomiglierà a un uomo stolto il quale edificò la sua casa sopra l’arena: e scese la pioggia e vennero i fiumi e soffiarono i venti e irruppero addosso a quella casa, e cadde, e la rovina di essa era grande». Con questa comparazione della casa termina, in ambedue le recensioni, il Discorso della montagna. Se chi ascoltava e praticava i precetti di questo Discorso era un costruttore di casa su roccia, tale era tanto più Gesù nel fare questo Discorso per i fini del suo ministero. Già vedemmo che anch’egli costruiva una casa (la Chiesa) per riparo da una nuvola annunziatrice di tempesta (§ 310); aveva già scelto e collocato in opera dodici pietre fondamentali (gli Apostoli) secondo il numero delle tribù d’Israele (§ 311), e altre pietre minori impiegate erano rappresentate da molti altri Israeliti che lo seguivano; adesso egli cementava il tutto con una dottrina (magisteriale) che in parte era l’antica dottrinad’Israele, e in parte era dottrina personale di lui Gesù. Mancava ancora di portare avanti la costruzione e di rifinirla in molti punti, ma le linee maestre della casa furono stabilite appunto dal Discorso della montagna.
• § 335. Che rappresenta questo Discorso nell’insegnamento generale di Gesù? È stato definito il «codice fondamentale» o una «Summa della dottrina» di lui, ma sono definizioni da prendersi in senso molto vago perché solo in parte corrispondono alla verità. Codice elaborato non è, e nemmeno Summa, perché troppe sono le affermazioni dottrinali che Gesù farà più tardi attribuendo loro capitale importanza, e che invece nel Discorso della montagna non sono neppure adombrate: nulla infatti dice il Discorso né della morte redentrice di Gesù, né del battesimo, né dell’Eucaristia, né (esplicitamente) della Chiesa, né (altrettanto esplicitamente) dell’escatologia, senza le quali cose non si ha l’insegnamento storico di Gesù. Neppure è propriamente una confutazione del fariseismo ovvero una rettificazione perfettiva del giudaismo, sebbene anche questi scopi siano presi di mira: ma sono scopi soltanto posteriori, quasi conseguenze di una mira più ampia e generale. In realtà il Discorso della montagna non è altro che la presentazione del «cambiamento di mente» che già era stato predicato, sia da Giovanni il Battista sia da Gesù (§§ 226, 299), come condizione per l’attuazione del regno di Dio. E quale cambiamento di mente, più sconvolgente e più capovolgente che quello di proclamare beati, in vista d’un remoto futuro, i poveri, i piangenti, gli affamati, gli arrendevoli, e quanti altri fino ad allora erano stati proclamati infelici da tutti gli uomini concordemente? Il Discorso, dunque, meglio che un codice, è lo spirito che ispirerà più tardi tutto un codice: meglio che una Summa, è l’idea centrale che sarà sviluppata più tardi in un ampio commentario. Il carattere personale e singolare del Discorso della montagna, e specialmente delle sue Beatitudini iniziali, è tanto palese che non ha bisogno d’essere dimostrato: quegli studiosi moderni, (all’epoca del Ricciotti) scarsissimi di numero e d’autorità, (ma oggi divenuti numerosissimi ed occupanti le più prestigiose cattedre), che hanno negato una verità così evidente, non meritano risposta e non sono da prendersi sul serio. Tuttavia il Discorso ha pure numerosi punti di contatto col patrimonio spirituale sia biblico sia rabbinico, ed è merito delle più recenti investigazioni aver messo in luce quest’ultimo punto; specialmente dalla sua metà in giù, il Discorso mostra parecchie analogie con pensieri ed espressioni (poi) conservate nel Talmud e negli altri scritti giudaici. Ciò è regolare per chi parlava a gente del suo tempo abituata a certe frasi ed espressioni, e soprattutto per chi era venuto non già ad abolire, bensì a compiere. Ad ogni modo anche da queste analogie risulta sempre meglio la sproporzionata superiorità del Discorso della montagna, che riunisce a fascio in pochissime pagine ciò che si può solo stentatamente e parzialmente spigolare nell’immenso campo degli scritti giudaici, e risulta specialmente l’inimitabilità del suo spirito, unico e solitario. Questo spirito fa che esso sia il più rivoluzionario (nel bene) discorso umano, appunto perché discorso divino. Fine.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, anche il numero 125 del nostro Settimanale viene pubblicato in forma ridotta. Continuiamo a studiare - con la preziosa guida dell’Abate Ricciotti - «Il discorso della montagna».
• Prosegue dalla scorsa settimana... § 321. Affiancando pertanto le due recensioni (quella di Matteo, 5 e quella di Luca, 6) si ottiene questa sinossi, che ci riporta più vicini allo schema della primitiva catechesi. [Abbiamo adattato la sinossi come segue (M sta per Matteo; L sta per Luca)]: «- Beati i poveri in ispirito, perché di essi è il regno dei cieli! (M); - Beati i poveri, perché vostro è il regno d’iddio! (L); - Guai a voi, ricchi, perché siete in possesso della consolazione vostra! (L); - Beati i dolenti, perché essi saranno consolati! (M); - Beati i piangenti adesso, perché riderete! (L); - Guai ai ridenti adesso, perché vi dorrete e piangerete! (L); - Beati i miti, perché essi possederanno la terra! (M); - Beati gli affamati ed assetati di giustizia, perché essi saranno saziati! (M); - Beati gli affamati adesso, perché sarete saziati! (L); - Guai a voi, i saziati adesso, perché sarete affamati! (L); - Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia! (M); - Beati i puri di cuore, perché essi Iddio vedranno! (M); - Beati gli operanti pace, perché (essi) figli d’Iddio saranno chiamati! (M) - Beati i perseguitati a causa di giustizia, perché di essi è il regno dei cieli! (M); - Beati siete quando vi insultino e perseguitino e dicano ogni male contro di voi mentendo a causa di me! (M); - Beati siete quando vi odino gli uomini e quando vi scomunichino ed insultino e proscrivano il nome vostro come cattivo a causa del figlio dell’uomo! (L); - Gioite in quel giorno e balzate; ecco infatti la mercede vostra è molta nel cielo: nello stesso modo infatti facevano ai profeti i padri loro! (L); - Godete ed esultate, perché la mercede vostra è molta nei cieli: così infatti perseguitarono i profeti anteriori a voi! (M); - Guai quando dicano bene di voi tutti gli uomini! Nello stesso modo infatti facevano ai falsi profeti i padri loro! (L)». [Riuniamo in nota alcune osservazioni sulle due recensioni. I poveri sono gli ebraici ’ănijjīm, i «miserabili», i «meschini» sia per mancanza di sostanze sia per generica condizione sociale. Luca tralascia la precisazione di Matteo «(poveri) in ispirito» (§ 145), per la quale la beatitudine è riserbata a quei «poveri» che accettino questa loro condizione e ne siano paghi nel loro spirito, mentre i forzati e i riluttanti non sono «poveri in ispirito». Invece del più generico «dolenti» (...) di Matteo, Luca ha il più specifico «piangenti» - cfr. Isaia, 61, 2. I «miti» (...) non sono i dolci di carattere, ma gl’infimi della società, i tenuiores dei Romani, i «guitti» abietti ed umiliati; tutta l’espressione è presa dal Salmo 37, 11 (ebr.), ove si dice che questi «miti» (ebr. ’ănāwīm, quasi sinonimo del precedente ’ănijjīm; Vulgata «mansueti») possederanno la terra. I «puri di cuore» sono, non soltanto i casti di pensiero e d’affetto, ma più generalmente i mondi da macchia spirituale, gli innocenti davanti a Dio; la frase dipende dal Salmo 24, 4 (ebr.), ov’è detto che il puro di cuore (bar-lebab) può presentarsi al santuario di Jahvè. Gli «operanti pace» (...) sono i pacifici nel senso non soltanto passivo, che godono della pace, ma anche attivo, che producono e apportano la pace. Le beatitudini ottava e nona di Matteo (verss. 10-11) si riferiscono allo stesso soggetto: ad ambedue in comune si riporta la sanzione del versetto 12]. Questo sbalorditivo prologo ha presentato fin qui lo spirito generico del programma di Gesù, cioè della Legge messianica; conclude poi annunziando che questo spirito dovrà essere come un sale che preserverà da corruzione il mondo intero e come una luce che illuminerà tutta la terra (Matteo, 5, 13-16; in altro contesto Luca, 4, 34-35, e 8, 16; 11, 33). Ma subito dopo questo sguardo al futuro il Discorso si rivolge al passato, ed affronta la questione delle relazioni tra futuro e passato nei riguardi della Legge ebraica, procedendo secondo il seguente schema.
• § 322. Gesù non è un demolitore della Legge [oggi diremmo che Gesù non era un modernista, non era un ribelle, ndR], ma un rinnovatore [ed in quanto Dio poteva esserlo, ndR] che in parte abolisce e in parte conserva perfezionando (Matteo, 5, 17-20). La legge messianica perfeziona quella mosaica nei precetti della concordia, della castità, del matrimonio, del giuramento, della vendetta e della carità (ivi, 21-48). Essa supera di gran lunga le usanze dei Farisei riguardo all’elemosina, alla preghiera e al digiuno (6, 1-18). Essa, per chi l’accoglie, è l’unico e vero tesoro e libera da ogni altra preoccupazione (ivi, 19-34). Essa richiede una carità più perfetta ed una preghiera più insistente (7, 1-2). Essa è una porta angusta, ma salva dai falsi profeti e fa compiere buone opere (ivi, 13-23). In conclusione, la nuova Legge è una casa costruita sulla viva roccia che resisterà alle tempeste (ivi, 24-27). Già da questo rapido sommario appare evidente che il Discorso della montagna ha, fra altri scopi, quello di presentarsi come un contrapposto non distruttivo ma perfettivo della Legge di Mosè. E questo scopo è confermato anche dalla sceneggiatura materiale: come infatti la Legge antica era stata promulgata sul monte Sinai, da Mosè, assistito dagli anziani della nazione ed alla presenza del popolo; così la legge nuova è promulgata sulla montagna della Galilea, da Gesù Messia, assistito dai dodici Apostoli ed alla presenza delle turbe. Che da questa corrispondenza di sceneggiatura si è tratta recentemente la conclusione che tutto sarebbe fittizio, e che la sceneggiatura sarebbe ideale, e che il Discorso non fu mai tenuto: ma se tale conclusione è (totalmente falsa ed) arbitraria, non per questo le premesse sono false. La sceneggiatura corrisponde, appunto perché si volle a bella posta mostrare una riconnessione anche materiale fra l’antica e la nuova Legge, come poco prima si era ricercata una riconnessione numerica fra i dodici Apostoli e le dodici tribù d’Israele (§ 311), e come pure con l’alternativa di benedizioni e di maledizioni si volle probabilmente seguire il metodo di altre antiche promulgazioni della Legge di Mosè (§ 320). Il Discorso della montagna ha uno stile popolare ed un frasario orientale. Sottigliezze ed astrazioni mancano, spesseggiano invece i casi pratici e immediati che il popolo ha sempre prediletto e da cui sa ben ricavare norme generali: numerose vi sono anche le iperboli orientali, che gli ascoltatori sapevano interpretare nel loro giusto valore ma senza le quali avrebbero trovato letterariamente insipido il discorso. Per un orientale davano sapore al discorso frasi come quelle che dicevano: «Se la tua mano destra ti scandalizza, mozzala via e getta(la) da te», oppure «chiunque ti schiafleggia sulla guancia destra rivoltagli pure l’altra»; tuttavia i primi seguaci di Gesù non si mozzarono mai la mano destra nè offrirono la guancia sinistra, per la semplice ragione che capivano lo stile in cui si parlava nei loro paesi e soprattutto perché avevano del buon senso. Quando invece subentrò l’idolatria del letteralismo o al buon senso si sostituì il fanatismo, allora si ebbero i casi di Origene nell’antichità e di Leone Tolstoi ai tempi nostri; ma a differenza dell’allegorizzante alessandrino, che diviene improvvisamente letteralista, e del sognatore russo, che rimane un sensuale nelle sue utopie mistiche e predica aggressivamente la mansuetudine, San Francesco di Assisi apparirà sempre il più perfetto interprete del Discorso della montagna, interprete tanto perspicace nel riconoscerne lo spirito, quanto entusiasta nel praticarlo.
• § 323. Ecco il resto del Discorso: (Matteo, cap. 5): «Voi siete il sale della terra: ma se il sale sia diventato insipido con che si salerà? Non serve più a niente salvo che, gettato fuori, ad essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo: non può star nascosta una città collocata sopra un monte, nè accendono una lucerna e la pongono sotto il moggio bensì sul lampadario e risplende a tutti quei (che sono) nella casa: così risplenda la luce vostra davanti agli uomini, affinché vedano le vostre belle opere e glorifichino il Padre vostro, quello ch’è nei cieli. Non crediate che venni ad abolire la Legge o i Profeti: non venni ad abolire, bensì a compiere. In verità infatti vi dico, finché passi il cielo e la terra un solo iota o un solo trattino non passerà dalla Legge, fino a che tutto avvenga. Chi pertanto abbia disciolto uno solo di questi minimi comandamenti ed abbia insegnato così agli uomini, minimo sarà chiamato nel regno dei cieli: chi invece abbia praticato ed insegnato, costui grande sarà chiamato nel regno dei cieli. Vi dico, infatti, che se non abbondi la vostra giustizia più che (quella) degli Scribi e dei Farisei, non (avverrà) che entriate nel regno dei cieli».
[Dalle note (pagg. 382 e 383): 1) Il «sale della terra» non significa sale estratto dalla terra, ma sale che dovrà preservare dalla corruzione la terra, cioè il genere umano, come preserva materialmente le carni macellate e specialmente è cosparso sui sacrifizi offerti al Tempio (Levitico, 2, 13); quando svanisce la forza di questo sale, perché bagnato o inquinato, non resta che gettarlo fuori di casa, cioè sulla strada pubblica, ove vanno a finire tutti i rifiuti di una casa palestinese. 2) La «luce del mondo» ha senso analogo al precedente sale della terra. La città collocata sopra un monte è ritenuta da parecchi essere Safed, borgata ben visibile dalle rive del lago essendo all’altezza di 838 metri: ma è una pura congettura, e qualunque città o borgata posta in alto può render ragione di queste parole. Il «moggio» era il modius dei Romani, misura per aridi di quasi 9 litri; capovolto che fosse, avrebbe potuto benissimo conservare accesa una lucerna usuale, di terracotta e di piccole dimensioni. 3) «Abolire» (..., «sciogliere gettando», demolire totalmente) in opposizione a «compiere» (...) che parte abolisce, parte conserva, e parte aggiunge perfezionando il tutto. «Legge e Profeti», le due prime e più importanti delle tre sezioni in cui erano divise le sacre Scritture ebraiche ; designano praticamente l’intera Bibbia. La lettera jota è greca e fu introdotta certamente dal traduttore greco di Matteo (§ 120), ma l’originale aramaico non poteva avere che jod, che è la lettera più piccola dell’alfabeto ebraico quadrato (allora già in uso); «trattino» (... «cornetto») è uno di quei piccoli prolungamenti di linea per cui una lettera ebraica si distingue da un’altra molto simile. Qui i vari segni materiali rappresentano il relativo precetto, e non tanto la sua lettera quanto il suo spirito : in ciò appunto consisteva il «compiere» annunziato da Gesù e la sua divergenza dagli Scribi e dai Farisei. 4) Il punto 4 commenta il § successivo: Il «giudizio» (ossia «tribunale») del vers. 22 è lo stesso di quello del vers. 21; è il tribunale giudaico locale (§ 61), e per esser deferito a questo tribunale basterà d’ora innanzi un semplice moto d’ira, la quale è già una predisposizione all’omicidio. Rakà è l’aramaico rēqā, «vuoto», nel nostro caso «(testa) vuota»; questo insulto sarà deferito al tribunale supremo del Sinedrio (§ 59). «Stolto» è in senso morale e religioso, perciò «empio», «ateo»; questo insulto sarà passibile della Geenna, la quale era la Valle di Hinnon (Gē-hinnom) posta immediatamente a sud di Gerusalemme, e poiché serviva da scarico delle immondizie della città vi si tenevano sempre accesi a scopo igienico dei grandi fuochi: perciò simboleggiava il luogo di tormenti d’oltretomba (§ 79 segg.)].
• § 324. Prosegue col Discorso: «Udiste che fu detto agli antichi “Non ucciderai”, chi poi abbia ucciso sarà passibile di giudizio. Ma io vi dico che chiunque s’adira contro il suo fratello sarà passibile di giudizio; chi poi abbia detto al suo fratello «Rakà! » sarà passibile di Sinedrio; chi poi abbia detto «Stolto!» sarà passibile della Geenna del fuoco. Se dunque presenti il tuo dono sull’altare e colà ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia colà il tuo dono davanti all’altare, e va’ prima, riconciliati col tuo fratello, e allora vieni a presentare il tuo dono. Sii condiscendente col tuo avversario subito, fintanto che stai con lui per la strada: affinché mai non (sia che) l’avversario (l’accusatore) ti consegni al giudice e il giudice all’inserviente, e (così) sarai gettato in carcere. In verità ti dico, non (sarà) che (tu) esca di là fino a che (tu) abbia pagato l’ultimo quadrante (Quadrante = piccola moneta romana che rappresenta la quarta parte dell’asse».
• § 325. Ed ancora: «Udiste che fu detto “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderar(la), già commise adulterio con essa nel cuor suo. Se poi il tuo occhio destro ti scandalizza, càvalo e getta(lo) da te: è un vantaggio infatti per te che perisca uno dei tuoi membri, e non sia gettato l’intero corpo tuo nella Geenna. E se la tua mano destra ti scandalizza, mòzzala via e getta(la) da te: è un vantaggio infatti per te che perisca uno dei tuoi membri, e non vada l’intero corpo nella Geenna. Fu poi detto “Chi rimandi la sua moglie, le dia il (documento di) ripudio”. Ma io vi dico che chiunque rimandi la sua moglie, eccettuato (il) caso di fornicazione, fa che ella sia resa adultera, e chi sposi una (donna) rimandata commette adulterio». • § 326. «Di nuovo, udiste che fu detto agli antichi “Non spergiurerai, ma manterrai col Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico di non giurare affatto, né per il cielo perché è trono d’Iddio, né per la terra perché è sgabello dei piedi Suoi, né per Gerusalemme perché è città del gran re; neppure per la tua testa non giurare, perché non puoi fare bianco o nero un sol capello. Sia invece il vostro discorso “Si” (se è) si, “No” (se è) no: quel che sovrabbonda da queste (parole) è dal maligno».
• § 327. «Udiste che fu detto “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non contrastare al maligno; bensì chiunque ti schiaffeggia sulla tua guancia destra rivoltagli pure l’altra, e a chi vuole citarti in giudizio per prenderti la tunica lasciagli pure il mantello, e chi ti requisirà per un miglio va’ insieme con lui per due (miglia). A chi chiede a te da’, e da chi vuole prendere in prestito da te non voltarti via. Udiste che fu detto “Amerai il prossimo tuo” e odierai il nemico tuo. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per i persecutori vostri, affinché siate figli del Padre vostro quello ch’è nei cieli, perché fa sorgere il Suo sole sopra maligni e sopra buoni e piove sopra giusti e sopra ingiusti. Qualora infatti amiate quei che vi amano, quale mercede avete? Non fanno forse lo stesso anche i pubblicani? E qualora salutiate i fratelli vostri soltanto, che cosa di sovrabbondante fate? Non fanno forse lo stesso anche i Pagani? Sarete dunque voi perfetti come il vostro Padre celeste è perfetto»
[Dalla nota a pagina 385: Il precetto «Amerai il prossimo» tuo sta formulato in Levitico, 19, 18, mentre il seguente «odierai il nemico tuo» non si trova in nessun passo dell’Antico Testamento, anzi in Esodo, 23, 5, si prescrivono all’israelita taluni atti di assistenza verso il proprio nemico. Tuttavia queste prescrizioni si riferivano soltanto ad atti verso il «prossimo» (ebreo) cioè verso l’israelita, e tutt’al più potevano essere estese al «forestiero» (ger) che dimorava su terra israelita e si era come associato ad Israele (Levitico, 19, 33-34; Deuteron., 10, 19); ma in queste categorie non entravano i gojīm, i non Israeliti, che perciò non erano «prossimo». Per costoro l’Antico Testamento se non aveva formulato un espresso precetto di odio, aveva tuttavia comandato quelle guerre di sterminio religioso (herem) da cui troppo facilmente si estraeva il precetto generale dell’odio (Esodo, 17, 14-16; Numeri, 25, 17-18; Deuteron., 7, 16; 23, 3-6; 25, 17-19). Questa estrazione era stata fatta dal giudaismo dei tempi di Gesù, che regolarmente trattava da gojīm i circostanti Greci e i Romani ; inoltre pure prima la stessa norma pratica era stata applicata, non solo ai non Israeliti, ma anche a quegli Israeliti da cui si fossero ricevute ingiustizie: a costoro, invece del precetto «Amerai il prossimo tuo», si applicava la gran legge del taglione. Si trovano infatti nell’Antico Testamento sentimenti di questo genere espressi da un Israelita riguardo a un suo «prossimo», sul quale invoca il giusto castigo di Dio (Salmo, 109, ebr.; cfr. Atti, 1, 20)].
• § 328. «Badate poi a non fare la vostra giustizia in presenza degli uomini per esser guardati da loro, se no mercede non avete presso il Padre vostro quello ch’è nei cieli. Qualora dunque (tu) faccia elemosina non sonar la tromba davanti a te, come gl’ipocriti fanno nelle sinagoghe e nelle strade affinché siano glorificati dagli uomini: in verità vi dico, sono in possesso della loro mercede. Tu invece facendo elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, affinché la tua elemosina sia nel segreto, e il Padre tuo che guarda nel segreto renderà a te. E quando preghiate, non sarete come gl’ipocriti; giacché amano star ritti a pregare nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze affinché appaiono agli uomini: in verità vi dico, sono in possesso della loro mercede. Tu invece, quando preghi, entra nella tua stanza e chiusa a chiave la porta prega il Padre tuo quello (ch’è) nel segreto, e il Padre tuo che guarda nel segreto renderà a te».
• § 329. Finalmente: «Pregando, poi, non blaterare come i pagani: credono infatti che con il loro molto parlare saranno ascoltati; non vi rassomigliate dunque a loro, sa infatti il Padre vostro di quali cose avete bisogno prima che voi glie(le) chiediate. Così pertanto pregate voi: Padre nostro che (sei) nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la volontà tua come in cielo anche su(lla) terra. Il pane nostro necessario dà a noi oggi, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettemmo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno. [Stiamo riportando solo la recensione di Matteo, sebbene il Ricciotti affianchi anche quella di Luca]. Qualora infatti rimettiate agli uomini i falli loro, rimetterà anche a voi il Padre vostro celeste; qualora invece non rimettiate agli uomini, neppure il Padre vostro rimetterà i falli vostri. Prosegue sul prossimo numero ...

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, i numeri 124, 125 e 126 del nostro Settimanale saranno pubblicati in formato ridotto. Pur dimezzando il numero di pagine, siamo certi che apprezzerete l’importanza dottrinale e storica dell’argomento che, con l’Abate Ricciotti, andremo a trattare: «Il discorso della montagna».
• § 315. L’elezione dei dodici fu una scelta materiale, che sarebbe valsa a ben poco se non fosse stata seguita da una spirituale, ossia da un’informazione dottrinale. Nonostante il loro affetto per il maestro i dodici dovevano essere informati assai scarsamente circa il pensiero di lui, e si sarebbero trovati certamente in un serio impaccio se qualche dotto Fariseo li avesse invitati a fare un’esposizione precisa e compiuta delle dottrine di Gesù. Lo avevano visto operare miracoli per fare del bene agli afflitti; lo avevano udito predicare come avente autorità (§ 299) ed affermare princìpi di giustizia e di bontà; essi stessi si erano sentiti dominati da lui ed attratti a lui, e lo amavano cordialmente: ecco tutto, altro non avrebbero potuto dire. Ma ciò evidentemente diventava troppo poco in quel giorno in cui essi pure erano stati eletti suoi cooperatori, né Gesù aveva fatto loro alcuna comunicazione ulteriore circa i suoi insegnamenti ed intendimenti. Inoltre, anche per il popolo era necessaria un’esposizione fondamentale della dottrina di Gesù, perché i popolani, che fino allora lo avevano udito predicare occasionalmente, dovevano averne un’idea anche più imprecisa e vaga di quella che ne avevano i dodici (gli Apostoli). Le ostilità sempre crescenti degli Scribi e dei Farisei rendevano, anch’esse, opportuna una dichiarazione di programma, affinché le rispettive posizioni fossero nettamente definite: il popolo, sì, aveva subito notato che Gesù «insegnava loro ... non come gli Scribi» (§ 299), ma se anche quei popolani avessero dovuto scendere al particolare elencando i punti di consenso e quelli di dissenso fra Gesù e i Farisei, sarebbero rimasti certamente anche più impacciati dei dodici. A queste varie esigenze corrispose il Discorso della montagna.
• § 316. Gesù oramai era ben noto non soltanto nella Galilea ma anche fuori; con quella sorprendente rapidità ed ampiezza con cui si diffondevano oralmente le notizie nel mondo semitico, sempre avaro di documenti epistolari, la fama di lui si era sparsa sia a mezzogiorno nella Giudea e nell’Idumea ambedue giudaiche, sia nella ellenizzata Decapoli ad oriente (§ 4), sia nei grandi centri mediterranei della pagana Fenicia ad occidente. Gruppi di gente salivano su da questi paesi verso il profeta galileo per vederlo e udirlo, ma insieme, e anche più, «per esser guariti dalle loro malattie» (Luca, 6, 18); «molti infatti egli curò, tanto da gettarsi addosso a lui per toccarlo quanti avevano malori» (Marco, 3, 10). Le ondate di gente dovettero susseguirsi e crescere per qualche tempo, finché un giorno Gesù giudicò opportuno tenere alla numerosa folla ed ai dodici (agli Apostoli) il discorso espositivo del suo programma. Tutti e tre i Sinottici indicano come luogo del Discorso «la montagna», con l’articolo ma senza una precisa determinazione dunque, una delle colline della Galilea. La tradizione che riconosce questa collina nell’odierno «Monte delle beatitudini» ha ragioni non spregevoli in suo favore: è attestata esplicitamente solo nel secolo XII, ma se si considera in sostanza tutt’una con la tradizione riguardante Tabgha (§ 375 nota) essa risale al secolo IV. La montagna sarebbe la collina alta circa 150 metri posta sulla sponda occidentale del lago di Tiberiade sopra a Tabgha, e distante 13 chilometri da Tiberiade e circa 3 da Cafarnao; il preciso luogo del Discorso non sarebbe sulla cima della collina, ove oggi sorge l’ospizio dell’Associazione Nazionale per i Missionari Italiani, ma alquanto più in basso su una spianata a sud-ovest della collina. Era un posto preferito da Gesù per trattenersi con le turbe, come vuole l’antica tradizione, e non lontano da Cafarnao, come esige la narrazione sinottica.
• § 317. Del Discorso abbiamo due recensioni, quella di San Matteo e quella di San Luca, ma ben differenti fra loro. La principale differenza è nella quantità e disposizione della materia, perché la recensione di Matteo è circa tre volte e mezzo più ampia che quella di Luca (107 versetti contro 30); tuttavia, in compenso, Luca riporta in altre circostanze della vita di Gesù ampie parti del Discorso come è trasmesso da Matteo (circa 40 versetti). Questa attribuzione ad altre circostanze è molto importante; essa si ritrova non solo in Marco, che pur tralasciando l’intero Discorso ne riporta qua e là poche sentenze staccate, ma inaspettatamente anche nello stesso Matteo, che fa ripetere a Gesù sentenze del Discorso in altre circostanze (cfr. Matteo, 5, 29-30, con 18, 8-9; e 5, 32, con 19, 9). Tutti questi fatti non sorprendono chi abbia presente quanto già dicemmo sia riguardo alla dipendenza diretta degli Evangelisti dalla catechesi viva della Chiesa (§110 segg.), sia riguardo agli scopi ed ai metodi particolari a ciascun Evangelista: su quest’ultimo punto è necessario ricordare particolarmente che San Matteo è l’Evangelista che scrive con ordinamento (§ 114 segg.) e San Luca è quello che si è proposto di scrivere secondo consecuzione (§ 140 segg.). Si potrà quindi ammettere senza difficoltà che talvolta Luca abbia staccato dal Discorso della montagna alcuni tratti riferendoli in altre circostanze storiche, e per contrario che Matteo abbia conglobato nel Discorso sentenze pronunziate da Gesù in altre occasioni. Per citare un solo esempio del secondo caso, Matteo porta l’orazione del Pater noster in questo Discorso (6, 9-13); Luca invece la porta molto più tardi, nel secondo anno inoltrato della vita pubblica di Gesù e pochi mesi prima della sua morte, ed inoltre fa che l’insegnamento di quell’orazione sia provocato dalla domanda di uno dei discepoli che chiede a Gesù in quale maniera dovessero pregare (Luca, 11, 1-4). È certo possibile che Gesù abbia insegnato più d’una volta il Pater noster, tanto più che le due recensioni di esso sono abbastanza diverse; tuttavia in favore della circostanza storica di Luca sta la domanda del discepolo che provoca la risposta, mentre nel Discorso della montagna tale “provocazione” manca, e il Pater noster si potrebbe anche staccare dal Discorso senza interromperne il filo logico. E, come questo, si potrebbero addurre altri esempi per un caso e per l’altro: i quali tuttavia non sarebbero né sempre sicuri, né tali da offrire la base ad una norma generale. Un’altra e maggiore possibilità è che il Discorso della montagna, quale fu pronunziato da Gesù, fosse anche più ampio di ciascuna delle due recensioni odierne. Quella di Matteo, ch’è la più estesa, si potrebbe oggi recitare ad alta voce come predica per una folla in una ventina di minuti, e aggiungendovi le poche sentenze che sono particolari a Luca si allungherebbe la predica solo di tre o quattro minuti: non era certamente una predica troppo lunga per folle che venivano da lontano ad ascoltare Gesù. È dunque molto probabile che questo Discorso fondamentale fosse riportato nella primitiva catechesi orale in maniera molto più ampia di come noi l’abbiamo adesso e che, mentre Marco lo ha tralasciato quasi totalmente, gli altri due Sinottici ne abbiano riprodotto solo quelle parti che meglio rispondevano ai loro scopi. Inoltre più tardi, presentandosi l’occasione, Gesù può essere benissimo ritornato su alcuni punti di quella sua esposizione programmatica, fors’anche ripetendo le stesse sentenze e impiegando le stesse comparazioni, come hanno sempre fatto i maestri di qualunque età e di qualunque argomento. In conclusione, la recensione secondo Matteo sembra la più vicina alla forma che il Discorso aveva nella catechesi primitiva, e quindi la più opportuna ad essere scelta come base.
• § 318. Impiegando una terminologia musicale, il Discorso della montagna può esser rassomigliato ad una maestosa sinfonia che fin dalle prime battute, senza preparazione di sorta, e con l’attacco simultaneo di tutti gli strumenti, enunzi con precisione nettissima i suoi temi fondamentali: e sono i temi più inaspettati, più inauditi di questo mondo, totalmente diversi da qualunque altro tema formulato giammai da altre orchestre, eppure presenti come se fossero i temi più spontanei e più naturali per un orecchio bene educato. E in realtà fino al Discorso della montagna tutte le orchestre dei figli dell’uomo, pur fra variazioni d’altro genere, all’unisono avevano annunziato che per l’uomo la beatitudine consiste nella felicità, la sazietà è data da saturità, il piacere è l’effetto di appagamento, l’onore è prodotto da stima; al contrario, e fin dalle prime battute del suo attacco, il Discorso annunzia che per l’uomo la beatitudine consiste nell’infelicità, la sazietà nella famelicità, il piacere nell’inappagamento, l’onore nella disistima, in vista però del premio futuro. L’ascoltatore della sinfonia rimane allibito all’enunciazione di siffatti temi: ma l’orchestra, proseguendo imperturbata, ritorna sopra i singoli enunciati, li scevera ad uno ad uno, li ribadisce, ricama variazioni attorno ad essi: raccoglie quindi nello squillo degli ottoni altri temi accennati timidamente dagli archi, li corregge, li trasforma, li sublima lanciandoli su altissime vette: sommerge invece in un fragore di toni talune vecchie risonanze riecheggiate da lontane orchestre, escludendole dal suo quadro sinfonico; fonde poi il tutto in un’ondata sonora che, salendo su su dall’umanità reale e dal mondo materiale, raggiunge e si riversa su un’umanità non più umana e su un mondo immateriale e divino. Gli antichi stoici avevano chiamato «paradosso» un enunciato che andava contro l’opinione comune: in questo senso il Discorso della montagna è il più ampio e più radicale paradosso che sia stato mai enunciato. Nessun discorso recitato sulla terra fu più sconvolgente, o meglio, più capovolgente, di questo: ciò che tutti prima chiamavano bianco qui è chiamato non già bigio o scuro ma addirittura nero, mentre il nero è chiamato precisamente candido; l’antico bene è ivi assegnato alla categoria del male, e l’antico male a quella del bene; dove prima si sublimava la vetta adesso è posta la base, e dove si sprofondava la base è collocata la vetta. In confronto con la “rivoluzione” contenuta nel Discorso della montagna, le massime rivoluzioni operate dall’uomo sulla terra sembrano finte battaglie fatte per giuoco da bambini, in confronto con la battaglia di Canne o quella di Gaugamela. E questo capovolgimento è presentato, non già come conseguenza di lunghe investigazioni intellettuali, bensì con un tono decisamente imperativo che trova il suo appoggio soltanto sull’autorità dell’oratore. «Così è, perché ve lo dico io Gesù»; «altri vi hanno detto bianco, ma io, Gesù, vi dico nero»; «vi è stata prescritta la somma di cinquanta, ma essa sta bene solo in parte ed io, Gesù, vi prescrivo la somma totale di cento».
• § 319. E quali sono le sanzioni di questo nuovo ordinamento? Non esistono sanzioni umane ma solo divine, non sanzioni terrene ma solo ultraterrene. I poveri sono beati perché di essi è il regno dei cieli, ma non un regno della terra; i dolenti sono beati perché saranno consolati, ma in un imprecisato futuro lontano; i puri di cuore sono beati perché vedranno Iddio, ma non perché la loro purità sarà pregiata ed encomiata dagli uomini; in genere, poi, tutti i tribolati per amore della giustizia sono beati, ma nuovamente perché di essi è il regno dei cieli e non perché spetti loro un’ampia ricompensa sulla terra. Cosicché il nuovo ordinamento promulgato da Gesù ha una regolare base giuridica soltanto per chi accetti ed aspetti il regno dei cieli; invece un qualunque Nicodemo - che sia nato dalla carne e, vedendo soltanto materia, non accetti né aspetti un regno dei cieli - troverà che l’ordinamento di Gesù manca di base ed è, ben più che un paradosso, addirittura un assurdo: ma appunto la ragione di questa ripulsa era stata prevista e spiegata da Gesù quando nel suo colloquio con Nicodemo lo aveva ammonito, «se qualcuno non sia nato dall’alto, non può vedere il regno d’Iddio, perché ciò ch’è nato dalla carne, è carne; e ciò ch’è nato dallo Spirito, è spirito» (§ 288). Infine il Discorso della montagna non prescinde dalla realtà storica, ma in molti ed essenziali punti si ricollega con fatti reali dell’ebraismo passato e contemporaneo. La Legge mosaica non è annientata, ma integrata e perfezionata; essa è conservata, ma come un pianterreno su cui venga sovrimposto un piano superiore. Le costumanze e perfino le elucubrazioni casuistiche degli Scribi e dei Farisei sono tenute presenti, ma considerate come un cadavere in cui bisogna infondere un’anima: dappertutto si ricerca la moralità dello spirito, assai più che la materialità dell’azione. Non sfugge neppure la questione finanziaria ed economica, ma anche questa è inquadrata in un atto di fede, in una visione della provvidenza di Dio. Sopra ogni cosa, poi, domina l’amore, nelle sue due ramificazioni verso Dio e verso gli uomini. Dio non è un monarca dispotico che invii da lontano i suoi ordini all’umanità e ne attenda i tributi; è, invece, il padre di tutta l’umana famiglia, che conosce quando i Suoi figli hanno fame e vuol essere onorato da essi con la richiesta insistente del pane. Gli uomini tutti, come figli tutti egualmente di questo Padre sovrumano, sono fratelli, hanno lo stesso sangue spirituale, sono altrettanti «io» davanti a cui deve scomparire l’«io» del singolo. Tanta è l’importanza di questo amore per gli uomini, che perfino l’amore per Dio non può essere vero e legittimo se non è accompagnato da quello per gli uomini: chi stia per fare un’offerta all’altare con sincere disposizioni di spirito, ma in quel momento gli sovvenga che un altro uomo ha ricevuto una qualche ingiustizia da lui, prima vada a riparare l’ingiustizia e poi torni a fare l’offerta, giacché Dio cede volentieri la precedenza cronologica all’uomo aspettando tranquillamente, mentre non gradirebbe l’offerta fatta da chi ha un rimorso di coscienza contro il proprio fratello. [Con queste parole il Ricciotti intende piuttosto segnare la netta demarcazione fra il fariseismo, ed in generale il deteriorato pensiero giudaico, ed il cristianesimo. Nulla a che vedere con le tante, e talvolta esteriormente simili, elucubrazioni dei modernisti. Questi ultimi hanno dimostrato e dimostrano di avere ben altre mire, ndR].
• § 320. Il Discorso della montagna si svolge conforme ad uno schema abbastanza chiaro, soprattutto nella recensione secondo Matteo: ma questo Evangelista, benché «ordinatore» per eccellenza (§ 114), non deve aver creato qui l’ordinamento e piuttosto lo ha ritrovato già nella catechesi primitiva, sebbene qua e là vi abbia potuto introdurre piccole modificazioni. Il prologo, ch’entra subito nella maniera più risoluta, è rappresentato dalle beatitudini (5, 3-12): altrettanto avviene in Luca (6, 20-26), sebbene con divergenze. In Matteo la felicitazione «Beati...!» è ripetuta nove volte, ma le beatitudini sono in sostanza soltanto otto perché l’ultima è quasi una ripetizione della penultima e come un riassunto di tutte le precedenti; in Luca la felicitazione è ripetuta solo quattro volte, ma subito appresso sono aggiunte quattro maledizioni - «Guai...!» - indirizzate agli opposti dei felicitati di prima. Questa forma letteraria, per cui si cominciava con affermare un’idea e subito appresso si negava un suo contrario, si ritrova usitatissima nella poesia biblica (parallelismo antitetico - per esempio Genesi, 9, 25-26; Giudici, 5, 23-24; Geremia, 17, 5-8) ; ma anche più importante è notare che precisamente in antiche promulgazioni della Legge mosaica era stata seguita questa alternativa di benedizioni e di maledizioni (Deuteronomio, 11, 26-28; 27, 12-13; 28, 2 segg. e 15 segg.; Giosuè, 8, 33-34). Ora, poiché il Discorso della montagna indubbiamente vuole essere, sia per il contenuto sia per lo scenario, il contrapposto messianico alla Legge mosaica (§ 322), è molto probabile che il suo prologo nella primitiva catechesi consistesse in un elenco di beatitudini seguite o alternate da altrettante maledizioni; da questo complesso Matteo estrasse soltanto otto beatitudini, Luca, invece, soltanto quattro beatitudini ma rafforzate da quattro maledizioni. Prosegue sul prossimo numero ....

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, l’Abate Giuseppe Ricciotti oggi ci parlerà dei Dodici Apostoli.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, l’Abate Giuseppe Ricciotti oggi ci parlerà dei Dodici Apostoli.
• § 310. Sull’orizzonte della vita di Gesù si era profilata oramai nettamente una nuvola, ancora abbastanza lontana, ma annunziatrice sicura di tempesta: la nuvola dei Farisei. Né c’era da dubitare sui suoi effetti, giacché il recente caso di Giovanni il Battista dimostrava quale fosse la sorte di chi finiva ravvolto in quella nuvola. Gesù, quindi, provvide ai ripari, non già per la sua propria persona, bensì per la sua opera. Dall’inizio della sua vita pubblica erano già passati vari mesi, forse un sei o sette, e la sua operosità nella Galilea gli aveva procurato molti e cordiali seguaci. Da costoro egli avrebbe tratto le pietre fondamentali del suo edificio morale, e collocandole in opera avrebbe cominciato a tirare su quella casa che doveva resistere allo scaricarsi della nuvola. Più tardi l’evangelista teologo rifletterà: «Nella (casa) propria (egli) venne, e i propri (familiari) non lo accolsero!» (Giovanni, 1, 11). Eppure le antiche Scritture avevano predetto che il Messia sarebbe comparso nella casa d’Israele, per far sì che proprio essa divenisse la casa comune di Dio e degli uomini, e tutti gli uomini indistintamente potessero affermare: «(Dio) s’attendò fra noi!» (Giovanni, 1, 14); ma poiché la sua casa naturale non lo accoglieva, il Messia cominciava a segregarsi da essa e gettava i fondamenti della casa umano-divina ch’era lo scopo della sua missione: il rifiuto dei familiari che si rinnovasse la vecchia costruzione fatiscente costringeva il rinnovatore a predisporre una costruzione tutta nuova. A rigore un vero scisma ancora non era: erano tuttavia provvedimenti in vista d’uno scisma. Fra i seguaci ordinari di Gesù alcuni già erano in condizioni di particolare aderenza e comunanza col maestro: tali Simone Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni figli di Zebedeo (§ 302), poi anche Levi cioè Matteo (§ 306), Filippo e Nathanael ossia Bartolomeo § 279-280). A questi sette furono aggiunti altri cinque, che certamente seguivano già da qualche tempo Gesù senza però che a noi risulti quando fossero entrati in relazione con lui. La scelta di questi dodici è posta da Marco (3,13-19) e da Luca (6, 12-16) prima del Discorso della montagna, e questa collocazione è senza dubbio giusta cronologicamente; Matteo (10, 1-4) enumera i dodici dopo il Discorso della montagna, in occasione della loro missione temporanea nelle città d’Israele, ma non dice che la loro scelta avvenisse allora, ché anzi dalla narrazione risulta ch’era avvenuta in precedenza.
• § 311. Prima di questo singolare atto della sua missione, come già prima d’iniziare la sua vita pubblica, Gesù si appartò nella montagna a pregare, e stava pernottando nella preghiera d’Iddio. Quando poi si fece giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e si prescelse da essi dodici, che nominò pure Apostoli (Luca, 6, 12-13). La parola «apostolo» significava in greco «inviato», e corrispondeva etimologicamente all’ebraico shaluah. o shaliah e all’aramaico shaluhā; era quindi un «apostolo» nella vita civile chi era inviato a trattare d’un matrimonio o di una separazione, sia a comunicare una decisione giudiziaria, come erano stati «apostoli» nella vita religiosa i profeti e gli altri inviati di Dio. Anche il Sinedrio di Gerusalemme aveva suoi «apostoli», ed erano quei messi di cui esso si serviva per far pervenire le sue notificazioni alle varie comunità (§ 58) specialmente della Diaspora (cfr. Atti, 9, 1-2; 28, 21); sembra anzi che questi «apostoli» continuassero a funzionare anche dopo la distruzione di Gerusalemme, quando le supreme autorità giudaiche si erano stabilite a Jamnia. Ma fra gli «apostoli» ordinari del giudaismo (astraendo cioè dai profeti e da altre antiche manifestazioni carismatiche) e gli Apostoli istituiti da Gesù non c’era niente di comune, fuori del nome. I primi erano dei semplici incaricati e rappresentavano una data persona in un ben determinato affare (tal senso anche in Giovanni, 13, 16), come anche potevano essere umilissimi portatori materiali di messaggi ossia portalettere: tutti quindi rispondevano bene al titolo di «inviati», senza però essere inclusi in una vera istituzione giuridica. I secondi invece costituivano una precisa istituzione permanente, mentre in un senso altrettanto vero, ma ben più nobile, erano «inviati» perché dovevano essere i portatori materiali e spirituali della «buona novella» (§105 segg.). Il loro numero di dodici aveva un’evidente analogia con i dodici figli d’Israele e con le dodici tribù che ne erano discese per formare la nazione già prediletta dal Dio Jahvè: poiché la casa d’Israele minacciava ora di non accogliere il Messia di Jahvè che ad essa veniva, la nuova casa impiantata dal Messia a sostituzione di quella avrebbe avuto a sua direzione egualmente dodici capitribù spirituali. Ciò sarebbe stato un memoriale dell’êra passata ed una testimonianza per l’êra futura; e questo numero di dodici fissato da Gesù fu tenuto in tanto onore nella prima generazione cristiana, che non solo essa v’incluse immancabilmente anche il nome del traditore Giuda, ma quando costui morì la prima cura del capo dei dodici, Pietro, fu di sostituire il morto con un nuovo dodicesimo apostolo e così reintegrare il numero solenne (Atti, 1, 15-26). Assai più spesso, infatti, che col nome di «apostoli», essi sono designati nel Nuovo Testamento con quello di «dodici» (34 volte contro 8).
• § 312. L’elenco dei dodici è dato quattro volte, cioè dai tre Sinottici Matteo, 10, 2-4; Marco, 3, 16-19; Luca, 6, 14-16) e dagli Atti (1, 13). Nessuno dei quattro elenchi concorda in tutto con un altro riguardo alle serie con cui sono nominati i dodici, neppure gli elenchi di Luca e degli Atti che sono dello stesso autore; tuttavia vi si riscontrano le seguenti disposizioni costanti. Simone (Pietro) è sempre nominato per primo, e Giuda il traditore sempre per ultimo (salvo che in Atti, essendo già morto); inoltre i dodici sono sempre elencati in tre gruppi formati da quattro nomi, e costantemente in cima al primo gruppo è nominato Simone, in cima al secondo Filippo, in cima al terzo Giacomo figlio d’Alfeo. Ecco l’elenco com’è dato da Matteo: «Simone detto Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo (figlio) di Zebedeo, Giovanni suo fratello; Filippo, Bartolomeo, Tommaso, Matteo il pubblicano; Giacomo (figlio) d’Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo, Giuda Iscariota il traditore». Soltanto il terzo gruppo mostra al confronto con gli altri elenchi variazioni di nomi, trattandosi certamente del caso allora frequente fra i Giudei di avere due nomi. Invece di Taddeo, che in qualche manoscritto riceve la forma di Lebbeo, appare in altri elenchi un Giuda (figlio) di Giacomo, che è però la stessa persona di Taddeo. Come l’aggiunta patronimica di Giacomo serviva a distinguere questo Giuda dall’omonimo traditore, cosi l’aggiunta il Cananeo serviva a distinguere il secondo Simone dall’omonimo Pietro. Questo appellativo Cananeo è una semplice trascrizione dall’aramaico, ma in altri elenchi esso appare tradotto con zelota, come già rilevammo (§ 43); ad ogni modo l’appellativo ha qui il suo senso etimologico originale e non quello storico più tardivo, né implica che questo Simone appartenesse al partito degli Zeloti, i quali del resto intensificarono la loro operosità solo più tardi.
• § 313. Se Bartolomeo è effettivamente la stessa persona che Nathanael (§ 280), i primi sei di questo elenco ci sono già noti: così pure l’ottavo, cioè Matteo. Degli altri non abbiamo precise notizie circa il tempo e l’occasione in cui si misero al seguito di Gesù: soltanto sappiamo che Giacomo figlio d’Alfeo, ossia Giacomo il Minore (mentre «il Maggiore» è Giacomo figlio di Zebedeo), aveva per madre una Maria e per fratelli un Giuseppe, un Simone, ed un Giuda (cfr. Marco, 15, 40; Matteo, 13, 55; 27, 56) e che era chiamato «fratello del Signore» (§ 264); probabilmente per quest’ultima ragione gli è serbato sempre il primo posto nel gruppo degli ultimi quattro. Il nome Tommaso è grecizzato dall’aramaico tomā, (ebraico těōm), che significa «gemello»; perciò al nome è aggiunta la sua traduzione greca (...), da Giovanni (11, 16; 20, 24). Il traditore Giuda è distinto con l’appellativo Iscariota, ma da Giovanni (6, 71, greco) apprendiamo che Iscariota era chiamato anche Simone padre di Giuda; era dunque una designazione trasmessa di padre in figlio. Quasi certamente l’appellativo è una trascrizione dell’ebraico ’ish Qerijjoth, «uomo di Qerijjoth», ed è perciò un appellativo geografico riferentesi alla città della Giudea chiamata Qerijjoth (cfr. Giosuè, 15, 25) da cui provenivano gli antenati di Giuda. Nell’elenco di Marco (3, 17) si legge che ai due fratelli Giacomo e Giovanni fu imposto da Gesù il nome di Boanergès cioè figli del tuono. L’appellativo non è etimologicamente chiaro, e oggi è difficile riportarlo ad una forma semitica. La meno improbabile sembra essere bĕnē-rigshā, "figli del fragore». Il solo Marco riferisce questo appellativo, in occasione dell’elenco degli Apostoli: certamente però esso non fu attribuito in questa elezione, ma solo più tardi quando in varie circostanze dovette apparire il carattere impetuoso e ardente dei due giovani che lo provocò; una di tali occasioni fu verosimilmente quando Giacomo e Giovanni volevano invocare fuoco dal cielo per incenerire i Samaritani che rifiutavano ospitalità a Gesù (Luca, 9, 54).
• § 314. Quanto alla condizione sociale ed al grado culturale dei dodici possiamo concludere, da qualche vago accenno della loro condotta successiva, che essi in genere appartenevano a quel ceto sociale del giudaismo che stava un poco sotto alla classe media dei piccoli possidenti e parecchio sopra alla classe infima dei veri poveri. Era un ceto che non ha un esatto riscontro nelle nostre condizioni sociali odierne, ma che all’ingrosso si potrebbe riavvicinare al piccolo commerciante o al basso impiegato. Il lavoro manuale, di pesca o altro, era abituale, come del resto era comune anche fra i rabbini dedicati allo studio della Legge (§167), ma la sua necessità economica non era così imperiosa come presso di noi; le condizioni generiche della vita permettevano d’astenersi dal lavoro anche per molti giorni di seguito, e simili astensioni tanto più erano permesse a coloro che avevano una base economica migliore, per esempio ai membri della famiglia di Zebedeo che esercitavano una industria peschereccia piuttosto ampia. Non è arrischiato supporre che, sotto l’aspetto economico, la famiglia di Gesù fosse in condizioni meno agiate che le famiglie di tutti o quasi tutti gli Apostoli. Del resto le esigenze materiali erano poche, e con poco si viveva senza desideri e rimpianti. In compenso, molti di questo ceto così modesto s’interessavano vivamente di problemi spirituali, specialmente se avevano attinenza con argomenti religiosi e nazionali. Si lasciavano volentieri gli agi della propria casetta per prender parte ad una discussione, per ascoltare un celebre maestro, per andare addietro anche vari giorni di seguito ad un potente dominatore di turbe. Ciò che s’imparava in questi incontri era custodito amorosamente nell’archivio preferito dai Semiti, quello della memoria (§ 150), e forniva argomento a continue riflessioni personali e a frequenti dispute collettive, e così si formava il principale patrimonio culturale di questo ceto. Il quale leggeva e scriveva poco, senza però che tutti vi fossero analfabeti: l’analfabetismo in Palestina dovette imperversare molto più dopo la catastrofe del 70 che prima di essa; alle singole sinagoghe, prima della catastrofe, era per lo più annessa una scoletta elementare (§ 63) e bene o male molti imparavano le lettere, sebbene in seguito se ne servissero poco. Di questa condizione sociale e levatura culturale erano, in genere, i dodici scelti da Gesù, pur ammettendo che taluno di essi emergesse alquanto fra gli altri. Già rilevammo, ad esempio, che l’antico pubblicano Matteo fu scelto a mettere in iscritto la catechesi apostolica probabilmente appunto per la sua maggiore perizia nello scrivere (§ 117); inoltre, se i Greci che volevano conoscere personalmente Gesù si rivolsero per tale scopo a Filippo (Giovanni, 12, 20-21, greco) l’apostolo dal nome greco, si può congetturare che questo apostolo si segnalasse fra i suoi colleghi per cultura o condizione sociale (§ 508). I caratteri personali dei dodici variavano naturalmente da individuo a individuo: all’impetuoso Simone Pietro pare che somigliasse ben poco suo fratello Andrea, che doveva esser d’indole calma e serena, né i due figli del tuono avevano molte analogie con Tommaso lo sfiduciato e il diffidente (Giovanni, 11, 16; 14, 5; 20, 25). Quando si dettero a seguire Gesù erano certamente accesi da vivo affetto e da entusiasmo per lui, ma nelle loro intime personalità erano rimasti uomini come tutti gli altri, e presi in complesso rappresentavano più o meno l’umanità intera. Anche per questo non poteva mancare il traditore. Fine.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
 Stimati Associati e gentili Sostenitori, riteniamo di fare cosa buona iniziando l’editoriale della settimana con il seguente pronunciamento di Papa Leone XIII: «Conta moltissimo che si vada largamente diffondendo la buona stampa. Coloro che avversano con mortale odio la Chiesa, hanno preso l’abitudine di combattere con pubblici scritti, che adoperano come armi adattissime a danneggiare. Quindi una pestifera colluvie di libri, quindi giornali sediziosi e funesti, i cui furiosi assalti né le leggi raffrenano, né il pudore trattiene. Sostengono come ben fatto tutto ciò che in questi ultimi anni è stato compiuto per mezzo di sedizioni e di tumulti; coprono o falsano la verità; scagliano quotidianamente brutali contumelie e calunnie contro la Chiesa e il Sommo Pontefice, e non vi è alcuna sorta di dottrine assurde e pestilenziali che non si risparmino di diffondere ovunque. È necessario dunque fare argine alla violenza di questo grande male che va ogni giorno più largamente serpeggiando; e per prima cosa conviene con tutta severità e rigore indurre il popolo a guardarsene il più possibile, e ad usare scrupolosamente il più prudente discernimento sulle cose da leggere. Inoltre occorre contrapporre scritto a scritto, affinché lo stesso mezzo che tanto può nel rovinare, sia rivolto alla salute e al beneficio dei mortali, e i rimedi vengano appunto da dove vengono preparati i micidiali veleni» (dalla Etsi nos).
Stimati Associati e gentili Sostenitori, riteniamo di fare cosa buona iniziando l’editoriale della settimana con il seguente pronunciamento di Papa Leone XIII: «Conta moltissimo che si vada largamente diffondendo la buona stampa. Coloro che avversano con mortale odio la Chiesa, hanno preso l’abitudine di combattere con pubblici scritti, che adoperano come armi adattissime a danneggiare. Quindi una pestifera colluvie di libri, quindi giornali sediziosi e funesti, i cui furiosi assalti né le leggi raffrenano, né il pudore trattiene. Sostengono come ben fatto tutto ciò che in questi ultimi anni è stato compiuto per mezzo di sedizioni e di tumulti; coprono o falsano la verità; scagliano quotidianamente brutali contumelie e calunnie contro la Chiesa e il Sommo Pontefice, e non vi è alcuna sorta di dottrine assurde e pestilenziali che non si risparmino di diffondere ovunque. È necessario dunque fare argine alla violenza di questo grande male che va ogni giorno più largamente serpeggiando; e per prima cosa conviene con tutta severità e rigore indurre il popolo a guardarsene il più possibile, e ad usare scrupolosamente il più prudente discernimento sulle cose da leggere. Inoltre occorre contrapporre scritto a scritto, affinché lo stesso mezzo che tanto può nel rovinare, sia rivolto alla salute e al beneficio dei mortali, e i rimedi vengano appunto da dove vengono preparati i micidiali veleni» (dalla Etsi nos).
• Prosegue il Pontefice: «Per questo è necessario che coloro che si dedicano alla professione dello scrivere, tengano presenti diverse considerazioni: che tutti, nello scrivere, mirino ad un medesimo scopo [la salvezza delle anime: alla maggior gloria di Dio e della Santa Romana Chiesa, ndR]; vedano di stabilire con giudizio sicuro ciò che torna più vantaggioso [per tale scopo] e si sforzino di realizzarlo; non lascino da parte alcuna di quelle cose che sembrino utili e desiderabili a sapersi; gravi e temperati nel dire, confutino gli errori e i difetti, ma in modo che la critica sia senza acerbità, e si porti rispetto alle persone; infine, si esprimano con piano e chiaro discorso, in modo che la moltitudine possa comprenderlo agevolmente».
• Papa Leone XIII scrive la Etsi Nos - il 15 febbraio 1882 - contro «la dannosissima setta [della massoneria, ndR], i cui autori e corifei non celano né dissimulano affatto le loro mire, già da gran tempo ha preso posto in Italia e, intimata la guerra a Gesù Cristo, si propone di spogliare in tutto i popoli di ogni cristiana istituzione». Purtroppo da quel lontano 1882 la situazione globale, non solo italiana, è davvero peggiorata. Dapprima l’alacre e indomito lavoro dei suoi successori - da San Pio X a Pio XII - fu di grande giovamento per la difesa della fede e della santità pubblica dalla mortifera peste dottrinale e morale del Modernismo; e per ristabilire quei diritti che erano stati usurpati alla Santa Sede. Successivamente, dopo la morte di Papa Pio XII, dobbiamo riconoscere con grande dolore che la cospirazione della «dannosissima setta» ha proliferato anche all’interno della Chiesa di Roma. Così la «setta diabolica» è stata in grado di espandere la propria «guerra a Gesù Cristo» non più solo in Nazioni ben circoscritte ma, usando la struttura della Chiesa, di «eruttare veleno sul mondo intero». Serviva tuttavia una parvenza di universalità per sdoganare globalmente il funesto progetto, pertanto essi credettero necessario convocare addirittura un “Concilio”. Dal “Vaticano Secondo” in avanti, poi, si sono quasi perse le tracce del cattolicesimo. Tutto sembra poggiare, oramai, sulle personalità degli individui: che più o meno si distinguono nelle cosiddette “parrocchie” o nelle - altrettanto cosiddette - “realtà ecclesiali”. Siamo in presenza di un vero teatro, anzi di un lugubre circo. La società si manifesta, quindi, mossa dal pensiero eretico, dagli istinti più passionali (che in alcuni casi vengono definiti addirittura “carismi” - sic!) e dallo spirito di scisma; basta percorrere pochi chilometri per imbattersi in tante fedi differenti; ma, addirittura all’interno delle medesime chiese (edifici), possiamo incontrare sedicenti cattolici - talvolta infervorati o grandi maratoneti di pellegrinaggi (a cosa servono queste azioni se non si possiede la vera fede? - Ubi est ergo gloriatio? Exclusa est. Per quam legem? Operum? Non, sed per legem fidei) - tutti con idee differenti e con dottrine tanto fantasiose quanto eretiche, cosicché sembra essersi avverata la sentenza di Papa San Pio X: «Il Modernismo distrugge ogni religione». Possiamo dire, senza timore di sbagliare, che la società d’oggi - anche quella che pretende rivendicare la sua cattolicità - appare piuttosto il trionfo del demonio protestante e finalmente dell’ateismo pratico. È nostra intenzione, perciò, insistere nella pubblicazione della sola buona stampa di cui parla Papa Leone XIII, ed anzi vogliamo - se Dio ce ne darà tempo, salute e mezzi - incrementare questo lavoro con indefessa volontà. Parimenti dobbiamo biasimare quei tanti autori contemporanei, anche i proclamatisi «cattolicissimi», che scrivono sciocchezze per vanità e non «a vantaggio del vero scopo».
• Facciano attenzione, poiché su di loro pende già la sentenza di Nostro Signore: «Omne verbum otiosum, quod locuti fuerint homines, reddent rationem de eo in die iudicii». Chi vi scrive [Carlo Di Pietro] in passato ha molto sbagliato in tal senso; ed oggi, ringraziando Iddio di avermi temporaneamente risparmiato dalla spada del Suo giudizio, sto provando a rimediare. Mi auguro e prego affinché altri rigettino i loro tanti flati, scaccino vanità e vanagloria come nemico infernale, corrano al confessionale e si lascino guidare da quei pochi veri Preti rimasti sulla faccia della Terra: affinché, deposta ogni impurità ed ogni resto di malizia, accolgano con docilità la parola che è stata seminata da Dio e che sola può salvare tutte le anime (cf. Gc., I, 21). Posta la mia lunga premessa, oggi l’Abate Ricciotti dedica un capitolo agli «altri miracoli iniziali di Gesù» ed ai «primi ostacoli».
• § 304. Il ministero di Gesù proseguì nella Galilea, e di esso i Sinottici ci presentano taluni episodi senza un ben sicuro ordine cronologico: ma, insieme col diffondersi della fama del nuovo profeta, sorgono anche ostacoli: in primo luogo dai Farisei com’era da aspettarsi, poi anche da altri. Una volta, forse poco dopo l’elezione dei quattro, si avvicinò a Gesù un lebbroso che cadendogli ai piedi non gli chiese esplicitamente nulla, ma disse soltanto: «Signore! Qualora (tu) voglia, puoi mondarmi!» (Luca, 5, 12). I lebbrosi nell’antico Israele erano oggetto di sommo orrore; esclusi per la Legge mosaica dal consorzio umano, avevano l’obbligò di mantenersi appartati in luoghi solitari, e di gridare «Scostatevi! c’è un impuro!» (Lament., 4, 15) quando un viandante si avvicinava inconsapevole al luogo di loro dimora. In premio di questo lugubre grido s’inviava nella loro solitudine qualche cibo; ma fuor di questo, la società non voleva saperne di loro, come di spurghi dell’umanità, di personificazioni dell’impurità stessa, di vittime della massima collera del Dio Jahvè. Non di rado, tuttavia, i lebbrosi violavano la segregazione loro imposta; e così fece quella volta il lebbroso che si presentò a Gesù. Certamente aveva inteso parlare di lui e dei prodigi che operava con miseri di ogni sorta: chissà se, buono e potente com’era, il profeta galileo non avesse fatto qualcosa anche per la sua estrema sciagura! Il suo caso però era tanto spaventoso, che l’implorante neppure ardì esprimere ciò che implorava, ma solo espresse fiducia nell’implorato. Gesù ebbe pietà di lui e dell’illegale audacia che l’aveva spinto fra uomini mondi; perciò, stese la mano, con un gesto orribile per quanti avranno assistito toccò lui, quel lebbroso tutto marciume e fetore, e rispondendo alle sue precise parole ma più ancora al segreto pensiero disse: «Voglio! Sii mondato» (Marco, 1, 41). Il lebbroso fu mondato all’istante. Subito però Gesù lo fece allontanare per il solito motivo di evitare l’entusiasmo della gente, e severamente gli comandò di non divulgare ciò ch’era avvenuto; ma insieme gli ricordò di adempiere quanto la Legge mosaica prescriveva nei rarissimi casi di guarigione d’un lebbroso, cioè di presentarsi al sacerdote per far riscontrare la guarigione e di offrire il sacrificio di purificazione. Fu da parte di Gesù un atto d’ossequio alla Legge ufficiale, e nello stesso tempo un qualche compenso alla violazione fattane dal lebbroso col presentarsi in mezzo alla società. È probabile che il guarito eseguisse più tardi le prescrizioni legali, ma frattanto cominciò col violare il comando di Gesù divulgando quant’era avvenuto; tuttavia, anche s’egli avesse taciuto, avrebbe parlato in altra maniera la sua faccia, che da quella d’un mostro era diventata quella d’un uomo normale. Le conseguenze della divulgazione non si fecero attendere. Accorsero al taumaturgo altre folle per udirlo ed altri infelici per esser guariti, cosicché egli non poteva più entrare palesemente in città ma stava fuori in luoghi solitari (Marco, 1, 45). E là, nella solitudine, stava a pregare (Luca, 5, 16).
• § 305. Più tardi, quando la commozione della gente si fu abbastanza calmata, Gesù rientrò a Cafarnao. Ormai la sua popolarità aveva messo sull’avviso Farisei e Scribi, i quali non potendo ancora dare un giudizio sicuro sul nuovo profeta cominciavano a sorvegliarlo, come già avevano fatto con Giovanni il Battista (§ § 269, 277); troviamo perciò, durante questa permanenza a Cafarnao, che essendo Gesù in una casa ad insegnare vi stavano anche seduti Farisei e Dottori della Legge, i quali erano venuti da ogni borgata della Galilea e Giudea e Gerusalemme (Luca, 5, 17). È importante rilevare come fin da Gerusalemme si fossero mossi per sorvegliarlo; tuttavia apparentemente il contegno di quei dottori non doveva essere aggressivo, e sembrava piuttosto che stessero lì unicamente per apprendere, come tanti altri che avevano riempito la casa e facevano anche ressa all’uscio. Mentre Gesù sta parlando, alcuni uomini cercano di aprirsi un passaggio tra la folla accalcata all’ingresso: Essi portano un paralitico steso su un giaciglio, e sperano d’arrivare fino al maestro per presentarglielo. Ma il passaggio è impossibile; la folla è troppo fitta e non si sposta. Eppure, se non si vuol perdere la buona occasione, bisogna far presto: il maestro può terminare improvvisamente il suo discorso, e poi ritirarsi subito appresso in qualche luogo solitario e sconosciuto per pregare, com’è solito fare. Ecco quindi che, mentre il maestro parla ancora nello stanzone principale dell’interno, il paralitico con tutto il giaciglio cala giù davanti a lui dal soffitto dello stanzone. Che era avvenuto? I portatori erano stati sbrigativi; poiché in Palestina le case di povera gente consistevano di solito nel solo pianterreno, coperto da una terrazza di terra battuta, essi erano saliti per la scaletta esterna sulla terrazza, avevano rimosso la terra battuta, spostando qualche tavola e qualche travicello, e dalla buca ottenuta avevano per mezzo di funi calato giù giaciglio e paralitico. Naturalmente, al comparire di quell’uditore di nuovo genere, la predica cessò. Gesù, per prima cosa, ammirò la fede di quei portatori e di quel portato; quindi, rivolto al paralitico, gli disse soltanto: «(Figlio,) sono rimessi i tuoi peccati!». In ebraico la parola «peccato» può indicare sia una colpa commessa sia le conseguenze della colpa stessa: presso gli Ebrei una fra le principali di tali conseguenze era stimata l’infermità corporale, specialmente se grave e cronica. In qual senso impiegò Gesù la parola? Probabilmente in ambedue i sensi, quello invisibile della colpa morale e quello visibile della conseguenza materiale. Senonché, appena udite quelle parole, i sorveglianti s’inalberarono; gli Scribi e i Farisei cominciarono a ragionare dicendo: «Chi è costui che parla (con) bestemmie? Chi può rimettere peccati, se non solo Iddio?» (Luca, 5, 21). Evidentemente l’obiezione si atteneva al solo senso invisibile della parola peccato, cioè a quello di colpa, la cui remissione non poteva essere riscontrata fisicamente da nessuno. Ma c’era anche il senso visibile, quello della malattia corporale; qui il riscontro fisico era ben possibile, ed ognuno avrebbe potuto vedere se Gesù aveva parlato a vanvera. E Gesù appunto rispose adducendo la remissione visibile come prova della remissione invisibile. Conosciuti però Gesù i ragionamenti loro, rispondendo disse loro: «Di che cosa ragionate nei vostri cuori? Che è più facile dire: “Ti sono rimessi i tuoi peccati” oppure dire: “Sorgi e cammina”?». Gli sfidanti dovettero capire subito che si metteva male per loro, giacché la loro sfida era stata accettata; e lì non si trattava di qualche elegante questione di casuistica rabbinica, ad esempio di sapere se fosse lecito di sabbato sciogliere il nodo d’una fune o trasportare un fico secco (§ 70), bensì si trattava di far saltare in piedi un paralitico, e da quell’operatore di miracoli c’era da aspettarsi tutto. Perciò alla domanda di Gesù dovette seguire un silenzio piuttosto lungo e molto imbarazzato, come di chi abbia paura di far peggio se parli. Non ottenendo risposta, Gesù prosegui: «Ebbene, affinché sappiate che il figlio dell’uomo ha autorità sulla terra di rimettere i peccati - a questo punto si voltò verso il paralitico - dico a te: “Sorgi, e preso il tuo lettuccio cammina a casa tua!”». E quello, saltato in piedi all’istante, arrotolò il suo giaciglio e se n’andò. Ci viene riferito che tutti rimasero stupefatti, ma non quale atteggiamento prendessero i Farisei: probabilmente pensarono che non era quella la maniera di rispondere ad un’elegante questione di teologia giudaica, ad ogni modo sicuramente a Gesù non dettero ragione.
• § 306. Anzi, neppure rallentarono la loro sorveglianza. Infatti poco dopo la guarigione del paralitico, secondo la serie di tutti e tre i Sinottici, avvenne un fatto d’altro genere. Passando Gesù per Cafarnao vide un pubblicano, Levi figlio di Alfeo, che al suo banco di dogana riceveva pagamenti, rilasciava ricevute attirandosi, da quei che pagavano le imposte, maledizioni ed esecrazioni certo più numerose dei denari lasciati sul banco. Forse quel pubblicano già conosceva Gesù di fama, o anche di persona, e nutriva venerazione per lui; forse nutriva pure una certa invidia per i discepoli di lui, poveri ma benedetti ed amati dal popolo, mentre egli con i suoi mucchietti d’argento e d’oro allineati sul banco era riguardato dalla gente come un cane rognoso. Fatto sta che Gesù, nel passare vicino al suo banco, lo guardò e gli disse soltanto: «Seguimi!». Quella parola fu scintilla caduta su materia infiammabile; il pubblicano, appena l’udì, lasciata ogni cosa, alzatosi lo seguì (Luca, 5, 28). Il pubblicano, secondo il costume allora frequente, aveva oltre al nome di Levi anche quello di Matteo (ebraico Mattai, contratto da Mattenai), che equivaleva al greco Teodoro e al latino Adeodato. È l’autore del primo Vangelo. Ora, questo nuovo seguace di Gesù che aveva ripudiato così prontamente la sua condizione sociale, non ne ripudiò immediatamente i vantaggi materiali, ma se ne servì per fare onore al nuovo maestro. Facoltoso com’era, tenne un suntuoso banchetto a cui invitò Gesù con i suoi discepoli e fianco a fianco con essi anche i propri antichi colleghi, cioè molti pubblicani e peccatori: così si esprime egli stesso (9, 10; Marco, 2, 15), mentre il fine Luca (5, 29) lascerà l’odioso termine di peccatori, e dirà pubblicani e altri (§ 143). Ma appunto questo affiancamento promiscuo apparve indecoroso, anzi obbrobrioso, agli Scribi ed ai Farisei che continuavano a sorvegliare: scandalizzatissimi, essi s’astennero dall’entrare nella casa di quel peccatore per non contarninarsi, ma sulla porta avvicinarono i discepoli di Gesù e fecero osservare: «Ma come? Voi e il vostro maestro vi abbassate a mangiare e bere insieme con i pubblicani e i peccatori? Dove va il vostro decoro? Dove la purità legale?». Le osservazioni giunsero all’orecchio di Gesù, il quale rispose per tutti: «Non hanno bisogno i validi di medico, ma quelli che stanno male. Andate quindi ad imparare che cosa significhi (il detto): “Misericordia voglio e non sacrifizio”. Non venni infatti a chiamare giusti ma peccatori». Il detto citato appartiene agli scritti profetici (Osea, 6, 6): il che mostra che l’insegnamento di Gesù, risalendo più in su della tradizione rabbinica, si ricollegava con quello degli antichi profeti, i quali avevano mirato molto più alla formazione spirituale che alle formalità rituali, come aveva fatto poco prima anche Giovanni il Battista (§ 267).
• § 307. Naturalmente i farisei non rimasero affatto persuasi di quella risposta, che si attaccava proprio a una delle sentenze più pericolose dei già pericolosi profeti. A prenderla alla lettera, quella sentenza avrebbe abolito tutta la Legge di Mosè e tutte le osservazioni giudaiche: e allora come sarebbe rimasto in piedi l’immenso castello della legislazione rabbinica, somma delizia di Dio nei cieli e degli uomini sulla terra? E, a proposito, che opinione aveva Gesù delle pratiche devozionali dei Farisei, ad esempio del digiuno (§77)? Su questo punto i sorveglianti pedinatori di Gesù trovarono un sostegno in alcuni discepoli di Giovanni il Battista ingelositi della popolarità del nuovo maestro, cosicché un giorno vennero insieme e chiesero a Gesù: «Come mai noi, sia seguaci di Giovanni sia Farisei, facciamo frequenti digiuni, e i tuoi discepoli invece mangiano e bevono? Come acquisteranno essi santità presso Dio e autorità presso il popolo, se non diverranno mesti e macilenti a forza di digiuni?» - Gesù rispose: «Possono forse i figli della camera nuziale (cioè gli “amici dello sposo”; § 281) essere mesti fino a che lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando sia tolto via da essi lo sposo, e allora digiuneranno» (Matteo, 9, 15). La risposta s’impernia sulla persona di Gesù, pur difendendo i discepoli: per essi verrà indubbiamente il tempo d’esser mesti e di digiunare ma non è il presente, in cui sta fra loro il loro maestro a guisa di sposo fra gli “amici dello sposo”; faranno essi cordoglio quando, con improvvisa separazione, il maestro sarà tolto d’in mezzo ad essi e la festa nuziale si svolgerà in lutto. Se non totalmente, almeno parzialmente, la risposta poteva esser compresa da quanti l’udirono: anche Giovanni, poco prima, era stato tolto violentemente ai suoi discepoli e li aveva lasciati nel lutto, e qui Gesù predice una sorte analoga ai discepoli propri. Del resto, perché insistere tanto sul digiuno materiale? Se esso era diventato di somma importanza presso i Farisei, non aveva avuto eguale importanza presso la Legge antica, né i Farisei avevano ottenuto grandi risultati spirituali introducendo quel culto della pratica materiale. Se si voleva adornare a festa il proprio spirito bisognava addirittura cambiargli veste, non già rattoppare quella vecchia: Nessuno invero rattoppa con un rattoppo di panno grezzo una veste vecchia, giacché il rappezzo (con la sua durezza) ne fa qualche lacerazione alla veste, e lo strappo diventa peggiore. Né si mette vino nuovo in otri vecchi, se no si squarciano gli otri, ed il vino si versa e gli otri si rovinano: ma si mette vino nuovo in otri nuovi, e ambedue si conservano (Matteo, 9, 16-17). A sentire enunciati siffatti princìpi, quei Farisei - che non erano certamente degli imbecilli - dovettero capire che dal nuovo Rabbi non c’era nulla da sperare, e che giammai egli si sarebbe aggregato a qualche scuola dei grandi maestri della “tradizione”. Tuttavia, o essi o altri, seguitarono ancora a pedinare, se non altro per sorprendere Gesù in altri attentati alla “tradizione”.
• § 308. L’occasione si offrì di lì a poco. Dal colloquio con la Samaritana, avvenuto in maggio, erano trascorse alcune settimane: la messe quindi era ben matura, anche in Galilea, e forse qua e là s’era cominciato a mietere. In un sabbato (§ 178), attraversando Gesù e i discepoli un campo, qualche discepolo sentì appetito, perciò si dette a cogliere spighe, e strofinandole con le mani ne mangiava i chicchi. Non era un furto, perché il caso era espressamente contemplato ed esplicitamente permesso dalla Legge (Deuteron., 23, 25); c’era però la violazione del sabbato, perché il mietere era appunto uno dei 39 gruppi di lavori proibiti nel sabbato (§70) ed anche lo stropicciare fra le mani una spiga era un mietere secondo i rabbini; se costoro avevano sentenziato essere illecito mangiare un frutto caduto spontaneamente dall’albero di sabbato o un uovo fatto dalla gallina di sabbato (§ 251) perché ambedue i casi erano violazioni del riposo prescritto, tanto più dovevano condannare la deliberata azione dei discepoli. Sorpresili perciò in questo bel caso flagrante, si presentarono a Gesù additandogli i colpevoli: «Non vedi? Fanno ciò che non è lecito di sabbato!» - E chi aveva detto che non fosse lecito far delle eccezioni al sabbato? Gesù rispose discutendo su questo principio, e ricordando per analogia che anche David, quando fuggiva affamato, entrò nel tabernacolo di Jahvè e mangiò e fece mangiare ai suoi compagni quei «pani della proposizione» di cui era lecito cibarsi ai soli sacerdoti (I Samuele, 21, 2-6): dal caso di David era facile e spontaneo passare a quello del sabbato. Evidentemente per quei Farisei il caso di David era troppo remoto e apparteneva alla preistoria, mentre la vera storia delle istituzioni ebraiche cominciava per essi col sorgere del fariseismo. Tuttavia la stessa storia del fariseismo doveva esser loro poco nota: da principio infatti anche gli Asidei, cioè gli antenati immediati dei Farisei (§ 29), avevano rinunziato a difendere con le armi la propria vita per non violare il sabbato (§ 70), e con logicità perfetta si erano lasciati ammazzare dai loro nemici senza reagire; ma i superstiti venuti a più miti consigli, avevano stabilito il principio ch’era lecito di sabbato difendersi a mano armata da un assalitore (I Maccabei, 2, 40-41). C’era però la differenza che quegli antenati dei Farisei avevano creato e donato la libertà alla loro nazione, combattendo eroicamente sui campi di battaglia: al contrario, i classici Farisei dei tempi di Gesù combattevano solo sofisticamente nelle accademie rabbiniche, e quindi si potevano permettere il lusso di mostrarsi più rigorosi e più intransigenti di chi aveva procurato loro la possibilità di tenere accademie. Salendo poi al principio generico Gesù affermò: «Il sabbato fu fatto a motivo dell’uomo, e non l’uomo a motivo del sabbato», ch’era precisamente il contrario di quanto nella vita ordinaria pensavano i Farisei; e infine concluse: «... cosicché il figlio dell’uomo è signore anche del sabbato» (Marco, 2, 27-28). Il collegamento espresso dal «cosicché» è importante: il sabbato era stato fatto per l’uomo, e perciò aveva autorità anche sul sabbato colui che poco prima aveva dimostrato la propria autorità sui peccati dell’uomo (§ 305).
• § 309. Ma troppo gelosi del sabbato erano i Farisei perché la cosa finisse lì, con la sola affermazione che Gesù era padrone anche del sabbato: quella volta era mancata la prova visibile, che invece era stata data riguardo ai peccati dell’uomo. E la prova venne poco dopo, come risulta dalla serie di tutti e tre i Sinottici. È di nuovo un sabbato, e Gesù recatosi in una sinagoga vi predica secondo il suo solito. Ai Farisei che continuano a pedinare Gesù si presenta un’ottima occasione per dargli battaglia e metterlo alle strette nella questione del precetto sabbatico: è venuto alla sinagoga un uomo che ha una mano rattrappita, e può darsi che quell’operatore di miracoli sia tentato di guarirlo; osserveranno se egli cederà a sì sconcia tentazione, violando in maniera pubblica e scandalosa il precetto. Pare anzi che non si limitassero ad osservarlo, ma qualcuno per provocarlo a bella posta (Matteo, 12, 10) gli domandò se fosse lecito curare un infermo in giorno di sabbato. La questione era grossa assai, ed i rabbini continuarono anche più tardi a discuterla in tanti casi particolareggiati come già vedemmo (§ 71): ad ogni modo vigeva la norma che, salvo il pericolo di morte imminente, qualunque cura o medicamento erano assolutamente proibiti. Anche questa volta, come per il paralitico calato dal soffitto, Gesù non entra in discussione, ma adduce una prova visibile che dimostri se sia lecito o no curare di sabbato. Chi aveva imposto il precetto sabbatico secondo i Farisei? Certamente Dio. Chi era il signore delle leggi naturali? Certamente Dio. Se dunque una legge naturale era sospesa di sabbato, questa sospensione era opera di Dio. Questo fu il ragionamento che Gesù dette in risposta, ma lo espresse non a parole bensì a fatti. Disse pertanto all’uomo che aveva la mano rattrappita: «Alzati e mettiti nel mezzo!». E alzatosi (ci) si mise. Disse poi Gesù a quelli: «Domando a voi se è lecito di sabbato far del bene o far del male, salvare o mandare in rovina una vita?» (Luca, 6, 8-9). Come nel caso del paralitico, anche questa volta e per la stessa ragione fu risposto col silenzio. Ma quelli tacevano. E guardatili torno torno con sdegno, contristato per l’indurimento del cuore loro, dice all’uomo: «Stendi la mano!». E (la) stese, e fu ristabilita la mano di quello. Una risposta tuttavia ci fu, e consistette in questo che, usciti i Farisei, tennero subito consiglio insieme con gli Erodiani (§ 45) contro di lui, sulla maniera di mandano in rovina (Marco, 3, 4-6). La ragione era chiara. Poiché questa maniera di rispondere già usata dai Farisei nei riguardi di Giovanni il Battista si era mostrata efficace (§ 292), essi volevano applicarla anche a Gesù. Ma Gesù, saputa la macchinazione, si allontanò da quel luogo, come già aveva fatto alla notizia dell’imprigionamento di Giovanni, e molti gli andarono appresso (Matteo, 12, 15). Fine. Libro utilizzato: «Vita di Gesù Cristo» - Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941, dell’Abate Giuseppe Ricciotti - riposi in pace!

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, è possibile reperire su internet la nostra ultima pubblicazione «L’inferno è dogma o favola?» (ISBN: 978-88-900747-4-5) del Monsignore cieco Gaston de Ségur, del quale abbiamo già ripubblicato la preziosa opera «La Rivoluzione». La società contemporanea profonde ignoranza - conseguenza ineluttabile del Modernismo e della Laicità - anche perché sforna milioni di libri ed articoli densi di errori più o meno gravi: una vera pestilenza per lo spirito e per il corpo. Una impervia società che ipocritamente - quasi a voler mascherare la sua natura intimamente bruta - si gloria della parola «cultura» e si vanta di ogni «flato» che viene diffuso. Ma è forse questo il giusto termometro per misurare la vera cultura? La cultura si può misurare col solo numero dei libri e degli articoli prodotti? Non è forse vero che un buon libro - unito alla grazia di Dio - aiuta l'uomo nell'umiltà e nella sapienza; mentre, al contrario, le cattive pubblicazioni fanno l’uomo ancor più superbo e radicato nella sua ignoranza? È nostra intenzione, al contrario dei «flati» moderni, coltivare l’umiltà cristiana anche mediante la pubblicazione della sola buona stampa. Preghiamo Iddio di renderci e di conservarci umili, proprio come lo fu Mons. de Ségur, sapiente teologo, che nel suo libro «L’inferno è dogma o favola?» umilmente accetta il pensiero di Dio, si sottomette all’immutabile dogma cattolico e ci restituisce un saggio - sull’eterna dannazione - insieme nobile, erudito e profondamente semplice. Ne caldeggiamo vigorosamente la lettura, oltre che per la nostra personale edificazione, anche per le finalità apologetiche. È cosa buona e giusta che il vero cristiano - entro i doveri del proprio stato e consapevole dei propri limiti - sappia controbattere, con perizia di dottrina ma con l’umiltà del semplice, alle varie correnti di pensiero bestemmiatore di Nostro Signore e della Sua docenza. Miasmatiche e perverse ideologie - diffuse sempre più capillarmente - sulla vita eterna, nello specifico sull’inferno e sulla dannazione. Ci troviamo a lottare contro gli increduli, contro gli utopisti, contro i superstiziosi e contro i tanti che, accecati dalle proprie passioni, ingannati dai cattivi maestri, abbagliati dalla falsa scienza del Modernismo, diffondono una sorta di peste intellettuale e morale cosicché - non facciamo fatica a desumerlo - trascinano con se stessi nell’inferno numerose ed ignare vittime.
• Ciò premesso, la settimana scorsa ci eravamo lasciati col nostro buon Gesù che «guarisce la suocera di Pietro» e, «nonostante le insistenze dello stesso Pietro e della sua famiglia», decide di spostarsi altrove: «Egli deve annunziare la buona novella del regno di Dio». L’Abate Giuseppe Ricciotti - autore della «Vita di Gesù Cristo» che stiamo utilizzando - oggi ci descrive la vocazione dei primi quattro Discepoli in «L’elezione dei quattro».
• § 302. A questo punto San Luca (5, 1-11) narra la vocazione dei quattro principali Discepoli, Simone Pietro con suo fratello Andrea, e Giovanni con suo fratello Giacomo; al contrario gli altri due Sinottici (Matteo, 4, 18-22; Marco, 1, 16-20) collocano questa narrazione, molto più breve, proprio al principio dell’operosità di Gesù in Galilea, subito dopo la notizia dell’imprigionamento di Giovanni il Battista. La serie seguita da Luca appare più verosimile cronologicamente. È infatti da notare che né Matteo né Marco hanno parlato in precedenza di relazioni fra Gesù ed i quattro, ma esse sono state già accennate da Luca e spiegate ampiamente da Giovanni (§ 278 segg.); d’altra parte questa vocazione presuppone che l’operosità di Gesù sia già iniziata da qualche tempo, perché attorno a lui si accalca molta folla desiderosa di vederlo e udirlo, e ciò non si spiegherebbe agevolmente se si riferisse ai primi giorni del ritorno di Gesù in Galilea, subito dopo l’imprigionamento di Giovanni il Battista: essa dunque avvenne quando il ministero esercitato da Gesù già da qualche tempo gli aveva procurato larghi consensi nella Galilea. Ma specialmente le notizie date da Giovanni importano un’altra e più seria questione: se i quattro erano già stati al seguito di Gesù in Giudea, e poi in Galilea a Cana ed a Cafarnao, come mai qui Gesù sembra chiamarli a sé per la prima volta? Che questa sia la prima volta, è certo l’impressione che si ha da Matteo e Marco; tuttavia essa va corretta e integrata con quanto dicono gli altri due Evangelisti. Quanto alle notizie di San Giovanni, che è l’Evangelista integratore per eccellenza, esse ci permettono di concludere che Gesù anche nella scelta dei discepoli, come nella sua manifestazione messianica, procedette gradualmente. Dapprima egli accettò i quattro che spontaneamente in Giudea erano passati a lui dalla sequela di Giovanni il Battista: ma anche così accettati essi non rimasero costantemente uniti a lui né lo seguirono in tutte le sue peregrinazioni attraverso la Galilea, da lui fatte in massima parte da solo (§ 301); più tardi invece, allorché i quattro furono sufficientemente edotti del genere di vita che richiedeva da essi Gesù e si mostrarono disposti ad accettarla, egli li legò definitivamente a sé con una formale elezione. La quale avvenne in questa maniera, secondo la narrazione di Luca ch’è la più ampia e particolareggiata delle tre.
• § 303. Una mattina Gesù, trovandosi lungo la sponda occidentale del lago di Tiberiade, fu circondato da numerosa folla che desiderava udirlo parlare; ma la folla era tanta che, per trattenerla e insieme per farsi udire più comodamente, egli ricorse a un mezzo assai pratico. Quando quel lago è calmo, è quasi immobile né produce alcun frastuono che impedisca di udire chi parli a voce alta: perciò, allontanandosi di qualche metro dalla spiaggia su una barca, si poteva di là parlare benissimo alla folla che sarebbe rimasta schierata sulla spiaggia ad ascoltare. Così fece Gesù. Lì presso c’erano due barchette, i cui padroni erano scesi a terra e stavano riattando le reti; uno di essi era appunto Simone Pietro. Questo particolare suggerisce due conclusioni probabili: che l’episodio avvenisse nei pressi di Cafarnao (§ 300), e che Simone Pietro avesse sospeso in quel tempo la sua saltuaria sequela appresso a Gesù per ritornare frattanto al proprio mestiere insieme col fratello Andrea, onde provvedere ai bisogni della propria famiglia. Quando Gesù ebbe terminato di parlare da quella tribuna dondolante, provvide anche a ricompensare chi gliel’aveva fornita, e voltandosi a Simone gli disse di prendere il largo per gettare le reti. Senonché l’invito di Gesù dovette sembrare al destinatario un’involontaria ironia: proprio la notte testé scorsa era stata una nottataccia, e Simone aveva faticato assai con i suoi compagni senza prender nulla. Tuttavia, giacché aveva parlato il maestro, egli non si sarebbe rifiutato: ma avrebbe accondisceso giusto per deferenza verso di lui e senza alcuna fiducia nel nuovo tentativo; la luce del giorno infatti era un nuovo ostacolo, e se di notte era andata male di giorno sarebbe andata anche peggio. E così le reti furono gettate. Subito però si cominciò a imbarcare tanto pesce, che gli attrezzi non reggevano a tutto quel peso e le maglie delle reti si disfacevano. Si gettò allora una voce ai compagni dell’altra barca, rimasta inoperosa, affinché corressero a dare una mano; la barca venne, ma si continuò ancora a lungo a caricare, tanto che tutte e due le barche rimasero colme di pesce quasi da affondare. Il lago di Tiberiade era nell’antichità, ed è ancora oggi, assai ricco di pesce. Nell’antichità ne parla già Flavio Giuseppe (Guerra giud., III, 508, 520), e della pesca viveva gran parte dei rivieraschi occidentali: poco a nord di Tiberiade, la borgata di Magdala («Torre») era chiamata dai rabbini «Torre dei pesci» (Migdal Nunajā) e dagli ellenisti Tarichea ... cioè «Salamoie di pesce», con chiara allusione all’industria principale dei paesani. Oggi, chi ha visitato i luoghi può aver visto pescatori del lago fare buona pesca all’amo in pochi minuti, come può aver sentito parlare di colpi di paranza o di sciabica particolarmente fortunati, tanto da portare a terra parecchi quintali di pesce. Ma non è detto che sia, o sia stato, sempre così: anche i pescatori di Tiberiade hanno avuto in ogni tempo giornate e nottate di cattiva fortuna, in cui sembra che tutti i pesci siano emigrati dal lago. Quella pesca di Simone fu fortunata per caso? Simone, che se ne intendeva, non era di questa opinione e aveva previsto un risultato ben diverso; e non fu il solo, perché anche i pescatori dell’altra barca, che erano Giacomo e Giovanni, rimasero sbalorditi del risultato effettivo. Il focoso Simone si gettò allora ai piedi di Gesù esclamando: «Allontanati da me, perché sono un indegno peccatore!» - Ma Gesù replicò: «Non ti spaventare! D’ora in poi sarai pescatore d’uomini». Dunque, ciò ch’era avvenuto aveva, oltre il resto, anche il valore d’un simbolo per il futuro. Scesi infine tutti a terra, lo stesso invito fu rivolto a Giacomo e Giovanni che col loro padre Zebedeo erano «soci» di pesca con Simone e suo fratello Andrea, e le due coppie di fratelli, lasciato barche e tutto, seguirono da quel giorno costantemente il maestro. Libro utilizzato: «Vita di Gesù Cristo» - Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941, dell’Abate Giuseppe Ricciotti - riposi in pace!

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
La nostra piccola Associazione - che intende perseguire le opere di misericordia spirituale e corporale secondo le indicazioni del Catechismo maggiore di San Pio X - ha effettuato altre tre raccolte per i cristiani poveri e bisognosi. Sono state effettuate tre consegne presso la Caritas di Potenza nelle seguenti date: 7 marzo, 2 maggio e 9 luglio 2018. Abbiamo raccolto, sistemato e consegnato i prodotti come segue. Consegna numero uno: 1 aspiracenere elettrico per camino, 4 pantaloni da uomo, 5 polo da uomo, 1 maglietta ed 1 felpa da uomo, 5 jeans e tute da uomo, 6 capi di abbigliamento da donna, 3 cappelli da uomo, 1 telefono a cornetta, 1 paio di scarpe da uomo, 1 paio di scarpe da donna, 1 giacca da lavoro per uomo, vari altri oggetti. Oltre ai numeri di Sursum Corda. Consegna numero due: 40 capi d'abbigliamento per bambini (sempre in ottimo stato e lavati), vari paia di scarpe da donna, 1 portagioie e dei prodotti di bigiotteria. Consegna numero tre: 6 paia di scarpe assortite, 2 borse da donna, 6 pantaloni da uomo, 4 giubbotti da uomo, 4 giacche eleganti da uomo, 5 camicie da uomo (tre nuove e con cartellino), 5 cappotti da uomo, 10 capi d'abbigliamento da donna. Gli Associati ed i Sostenitori che intendono contribuire possono inviare prodotti, non rovinati e puliti, possibilmente nuovi di negozio, da destinare alla beneficenza all'indirizzo dell'Associazione. Si consiglia di avvisare telefonicamente o via mail prima di effettuare spedizioni. Ve ne siamo grati. Affidiamo la nostra piccola opera alla protezione di san Giovanni di Dio.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, passati due giorni con i Samaritani in Sychar - di cui abbiamo parlato la scorsa settimana - Gesù ritorna in Galilea. Ecco come prosegue l’Abate Giuseppe Ricciotti nella sua preziosa ed ortodossa «Vita di Gesù Cristo»:
• § 298. La ragione di questo ritorno è comunicata da San Giovanni (4, 44) con le seguenti parole: «Gesù stesso, infatti, attestò che un profeta nella propria patria non ha onore». Qual è la patria a cui allude qui San Giovanni? I Sinottici attribuiscono la stessa sentenza a Gesù ma in un occasione posteriore, quando cioè egli sarà scacciato in malo modo da Nazareth (Luca, 4, 16-30, e paralleli), e allora si comprende subito che la patria è Nazareth. In Giovanni ciò non è altrettanto chiaro, ma non per questo è da pensare che egli alluda alla Giudea da cui si allontanava per gl’intrighi dei Farisei (§ 292). Si dica piuttosto che Giovanni, presupponendo già noti i Sinottici (§165) e la sentenza di Gesù da essi riportata, la anticipi qui all’inizio della sua operosità in Galilea quasi per preammonire del mesto risultato di essa. Tuttavia, a principio, i Galilei accolsero Gesù con gioia: parecchi di essi erano stati testimoni delle opere straordinarie fatte da Gesù in Giudea, e al loro ritorno ne avevano parlato in Galilea suscitando fierezza fra i compatrioti del profeta. Recatosi nuovamente a Cana, il paese del primo miracolo (§ 281), Gesù fu subito ricercato per la sua fama di taumaturgo. Giaceva gravemente malato a Cafarnao il figlio d’un impiegato della corte reale; suo padre, saputo dell’arrivo di Gesù, andò in fretta a Cana pregandolo di venir subito a guarire il malato, ormai agli estremi. A quella preghiera Gesù si mostrò retrivo, e preoccupandosi soprattutto della propria missione rispose: «Qualora non vediate segni e prodigi, non (sarà) che crediate!». L’angosciato padre non si preoccupava che del figlio morente, e insistette: «Signore, vieni giù (a Cafarnao) prima che il mio ragazzo muoia!». Per esser sicuro della guarigione il padre esigeva la presenza personale di Gesù, come d’un medico. Gesù gli replicò: «Va’; tuo figlio vive!». Queste ferme parole infusero nel padre la fermezza di credere: se il taumaturgo aveva parlato così, non poteva essere altrimenti. Era l’ora settima, cioè l’una del pomeriggio; dopo il viaggio affannato del mattino da Cafarnao a Cana che sono più di 30 chilometri, non si poteva ripetere subito il percorso inverso spossando le bestie e gli uomini di scorta. Perciò il padre ripartì il mattino seguente. Nell’avvicinarsi a Cafarnao, i familiari gli vennero incontro per annunziargli che il ragazzo stava bene; alla sua domanda, da quando avesse cominciato a riaversi, risposero: «Ieri, all’ora settima, lo lasciò la febbre». L’accurato Giovanni (4, 54) fa notare che questo fu il secondo miracolo di Gesù, dopo quello di Cana egualmente in Galilea, ma astraendo dalla permanenza in Giudea (§ 287, nota seconda). Anche qui appare la mira di San Giovanni di integrare i Sinottici.
• § 299. Tornato così in Galilea, Gesù iniziò senz’altro la sua missione predicando la «buona novella» d’Iddio e dicendo: «Si è compiuto il tempo e si è avvicinato il regno d’Iddio; cambiate di mente (= pentitevi; § 266) e credete alla “buona novella”». In questo tempo egli dovette recarsi volta a volta un po’ dappertutto nei vari centri della Galilea, poiché ci si dice che insegnava nelle sinagoghe di quelli ed era ascoltato da tutti con molta deferenza, e sicuramente anche con una certa fierezza regionale (Luca, 4, 14-15). Tuttavia i soggiorni più lunghi e più frequenti avvenivano a Cafarnao, ch’egli già aveva praticamente sostituita alla sua Nazareth (§ 285). Nulla vieta, anzi tutto induce a supporre che nel corso di queste peregrinazioni egli si recasse anche a Nazareth; ma l’episodio della sua predica nella sinagoga di Nazareth che si concluse con la sua cacciata dal villaggio (§ 357 segg.) dovette avvenire al termine e non al principio di questa operosità in Galilea, perché in quella occasione sono espressamente ricordati i miracoli fatti da lui a Cafarnao (Luca, 4, 23). Perciò, sebbene San Luca ponga questo episodio a principio, è da preferirsi l’ordine cronologico qui seguito dagli altri due Sinottici (Matteo, 13, 54-58; Marco, 6, 1-6), i quali lo pongono sul finire di questo periodo di tempo, quando cioè Gesù era già stato lungo tempo a Cafarnao. Nelle varie borgate ove si recava, Gesù parlava soprattutto nella sinagoga del posto. Come già sappiamo (§ 2), ogni minimo centro palestinese ne era provvisto, e ivi puntualmente gli abitanti s’adunavano il sabbato e talvolta anche altri giorni; ma, oltre all’uditorio bell’e pronto, c’era anche l’opportunità di parlare ad esso in piena conformità con le norme tradizionali, quando cioè l’archisinagogo, dopo la lettura della Bibbia, invitava qualcuno dei presenti a tenere l’usuale discorso istruttivo (§ 67): è naturale che Gesù si offrisse frequentemente per tale incombenza, che rispondeva così bene ai suoi scopi. Altre volte, tuttavia, egli parlava all’aperto o in edifici privati, quando si presentava l’opportunità o si era adunata presso di lui una certa folla. I suoi ascoltatori, infatti, crescevano rapidamente, perché avevano notato subito che egli «insegnava loro come avente autorità e non come gli Scribi» (Marco, 1, 22; Luca, 4, 32; cfr. Matteo, 7, 29). Anche la plebe, nel suo semplice buon senso, trovava una profonda differenza fra le dottrine di Gesù e quelle degli Scribi; costoro si rifugiavano sempre sotto l’autorità degli antichi, e il loro ideale era di trasmettere integralmente gl’insegnamenti ricevuti senza nulla aggiungere e nulla tralasciare: Gesù invece apriva certi forzieri di cui egli possedeva l’unica chiave e sui quali egli solo «aveva autorità», non rifuggendo neppure dal contraddire agli insegnamenti degli antichi quand’era necessario perfezionarli. «Fu detta agli antichi» la tal cosa; «io invece vi dico» la tal altra (Matteo, 5, 21 segg.). Gli Scribi, insomma, erano la voce della tradizione; Gesù invece era la voce di se stesso, e si attribuiva il diritto tanto di approvare quella tradizione quanto di respingerla e correggerla. Indubbiamente chi si attribuiva questo diritto, sotto la dittatura spirituale degli Scribi e dei Farisei, agiva come «avente autorità».
• A Cafarnao e altrove. § 300. Ma il nuovo predicatore, se era avente autorità nel campo delle dottrine, si mostrava fornito di non minore autorità nel campo della natura operando «segni» straordinari; e questa seconda autorità, mentre confermava la prima, attirava sempre più l’attenzione delle folle, le quali su questo punto dovevano ragionare come Nicodemo: «Nessuno può fare questi “segni” ... se non sia Iddio con lui» (§ 288). Ai due «segni» di Cana, il cui ricordo era recente, ne tennero dietro altri in altri luoghi. A Cafarnao un giorno di sabbato, dopo aver predicato nella sinagoga, Gesù guarì pubblicamente un uomo indemoniato che, al comando di lui, prima dette in grida convulsive e poi rimase libero dall’ossessione; la gente che aveva udito la predica e visto la liberazione, ricollegando i due fatti si domandava: «Che è ciò? Un insegnamento nuovo secondo autorità! inoltre, comanda gli spiriti impuri e gli obbediscono!» (Marco, 1, 27). Mentre ancora risuonano queste esclamazioni, che diffondendosi porteranno altrove la fama di Gesù, egli esce dalla sinagoga e subito si reca alla casa di Simone Pietro (§ 285) e di suo fratello Andrea, dove trova la suocera di Pietro che giace malata: l’Evangelista medico fa notare che essa era in preda a «febbre grande» (Luca, 4, 38), la quale secondo la terminologia clinica d’allora era di genere diverso dalla «febbre piccola» (cfr. Galeno, Diflerent. febr., 1, 1). Insieme con Gesù stanno Giacomo e Giovanni, i due figli di Zebedeo, e certamente anche altre persone che hanno assistito alla liberazione del-l’indemoniato e forse pregano il liberatore di far del bene anche alla vecchia malata: Gesù si curva sul giaciglio di lei, la prende per mano, e la rialza che è guarita. Sta così bene la donna appena in piedi, che si dà subito da fare per preparare qualcosa all’ospite straordinario e per servirlo. In paese si sta ancora parlando dell’indemoniato guarito, quando sopraggiunge la notizia che pure la suocera di Pietro è stata guarita. Avere un uomo di tal fatta in paese e non servirsene, sarebbe la massima delle stoltezze: basterà portare alla sua presenza i malati che stanno per le case, e saranno guariti. Ma è sabbato, e non si può trasportare alcunché né fare più d’un limitato numero di passi (§ 70); ebbene, si aspetterà il tramonto del sole, con cui cessa il riposo sabbatico e si può trasportare un malato. La sera, infatti, i malati d’ogni sorta e gli indemoniati furono radunati presso la casa di Pietro, e tutta la città si era radunata presso la porta (Marco, 1, 33). Gesù, «su ciascuno di essi imponendo le mani, li guariva; uscivano poi da molti i demonii gridando e dicendo: “Tu sei il figlio d’iddio!”. E intimando (Gesù), non permetteva loro di parlare perché sapevano esser lui il Cristo (Messia)» (Luca, 4, 40-41). Quel Gesù che in terra di Samaritani aveva spontaneamente dichiarato di essere il Messia (§ 296), qua in terra di Giudei non permetteva che la stessa dichiarazione fosse fatta da un testimonio autorevole in materia, quale il demonio; ma qua appunto esisteva il pericolo che là mancava, ed era che i presenti, seguendo la corrente comune, considerassero quel Messia come condottiero politico: mentre, come poco prima Giovanni il Battista non si era occupato di politica, così adesso non se ne occupava Gesù, né egli predicava un regno del mondo o dell’uomo, bensì il regno dei cieli e di Dio.
• § 301. Ad ogni modo, se Gesù era veramente il Messia ed era venuto per farsi riconoscere come tale dai suoi connazionali, bisognava pur che una buona volta annunziasse apertamente ad essi questa sua qualità. Senza dubbio: e difatti questi annunzi palesi e ripetuti verranno da parte di Gesù, ma solo più tardi. Da principio invece, cioè durante questa sua prima operosità in Galilea, egli non fa che prolungare la predicazione del precursore Giovanni, annunziando soltanto che si è avvicinato il regno di Dio (Matteo, 4, 17; Marco, 1, 15); parla cioè del regno ma non del suo capo, dell’istituzione ma non dell’istitutore. Quando poi in seguito egli avrà radunato attorno a sé un piccolo nucleo di seguaci, i quali abbiano compreso genericamente che il suo regno non è un’istituzione politica e che ha per suo istitutore un re spirituale, allora a questi migliori intenditori egli confiderà di essere il Messia, sebbene anche a costoro da principio imporrà di non svelare ad altri questo segreto. L’affermazione messianica, dunque, avvenne realmente e chiaramente da parte di Gesù, ma fu graduale: dapprima egli annunziò il regno messianico, quindi il Messia ad alcuni pochi in segreto, infine a tutti palesemente. Ora, questa graduazione d’annunzio fu cagionata soprattutto dalla preoccupazione d’evitare entusiasmi politici, che sarebbero stati troppo spontanei fra gente abituata da lungo tempo a raffigurarsi il futuro Messia nelle maniere nazionali-militaresche che già vedemmo (§ 83). In quel deposito di materie incendiarie, ch’era politicamente il giudaismo d’allora, troppo spesso venivano gettati accesi tizzoni da esaltati pseudoprofeti, mentre Gesù non voleva in nessuna maniera accomunarsi con essi; anzi espressamente seguì una condotta che era proprio l’opposta alla loro, circondando a principio di segreto la sua persona con la mira di fare accettare l’idea. Quando poi Gesù dovrà necessariamente parlare della sua persona, allora applicherà anche certi correttivi molto efficaci per raffreddare i bollenti spiriti degli stessi suoi confidenti: annunzierà perciò loro che egli è il Messia, sì, ma anche che è destinato ad una morte violenta e ignominosa, e che pure i discepoli i quali formano la sua corte sono destinati a ignominie e tribolazioni d’ogni genere. Era una delusione ben amara e una prospettiva assai mesta, per focosi messianisti giudei, quella di un re Messia che muore ammazzato invece di ammazzare i nemici d’Israele, e che ha per cortigiani un’accolta di miseri umiliati invece che di potenti umiliatori dei gojīm! Ma appunto questo era il correttivo necessario per far comprendere l’indole del Messia Gesù e del regno da lui predicato. La serata di quel sabbato era stata laboriosa, ma finalmente Gesù aveva potuto ritirarsi nella casa di Pietro. La mattina seguente, molto prima dell’alba, egli ne uscì segretamente e si appartò in un luogo solitario a pregare. Poco dopo cominciarono ad arrivare visitatori della borgata che avevano qualcosa da chiedere al taumaturgo, e soprattutto da pregarlo che non si allontanasse mai più da loro. Pietro e gli altri familiari, non trovando Gesù in casa, si dànno a cercarlo fuori; finalmente lo trovano, e gli comunicano l’aspettativa e il desiderio di tutti. Gesù risponde che anche altrove egli deve annunziare la buona novella del regno di Dio, e che appunto per questo egli è stato inviato. E riprese a recarsi qua e là per la Galilea, probabilmente senza avere con sé alcun discepolo. Libro utilizzato: «Vita di Gesù Cristo» - Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941, dell’Abate Giuseppe Ricciotti - riposi in pace!.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, la «Vita di Gesù Cristo» - Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941, dell’Abate Giuseppe Ricciotti - riposi in pace! - oggi ci descrive, con vera e cristiana scienza, la vicenda della Samaritana. La nostra premessa potrà sembrare superflua e quasi puntigliosa, tuttavia è buona norma ricordare - ogni qual volta se ne presenti occasione - che una cosa sono la vera esegesi ed il commento cattolico alla Scrittura (Cliccare qui per approfondimenti), come nel caso del Ricciotti; altro sono i sofismi e le vane elucubrazioni dei modernisti che - vuoi per ignoranza, vuoi per superbia, vuoi per mondanità, vuoi per interessi particolari, vuoi per tutte le elencate ed altre possibili deficienze messe insieme - abitualmente violentano la Scrittura, ne stravolgono il significato e trasmettono eresia ed immoralità. È sentenza di Papa Gregorio IX, Ab Aegyptiis argentea: «Anche l’intelletto teologico è in grado quasi come uomo di presiedere a qualsivoglia facoltà, e quasi come spirito di esercitare il dominio sulla carne e di dirigerla sulla via delle rettitudine, affinché non se ne allontani. (...) In verità Noi, colpiti da dolore nell’intimo del cuore, siamo ricolmi dell’amarezza dell’assenzio, perché alcuni di voi (...) spinti dalla profana novità si danno da fare per travalicare “i confini posti dai Padri” (nell'interpretazione della Scrittura), e infatti, la comprensione della Celeste Pagina, delimitata per le cure premurose dei santi Padri, coi sicuri confini delle loro interpretazioni, la trasgressione dei quali non solo è cosa temeraria, ma profana, essi piegano alla disciplina filosofica delle realtà naturali, per fare ostentazione di scienza e non per un qualche pregresso degli ascoltatori, e così si rivelano non esperti di Dio o teologi, ma diffamatori di Dio». È sentenza del Concilio di Trento (Papa Paolo III), Decreto sulla Vulgata: «Inoltre, per frenare certi spiriti indocili, (il Concilio) stabilisce che nessuno, fidandosi del proprio giudizio, nelle materie di fede e morale, che fanno parte del corpo della dottrina cristiana, deve osare distorcere la sacra Scrittura secondo il proprio modo di pensare, contrariamente al senso che ha dato e dà la santa madre Chiesa, alla quale compete giudicare del vero senso e dell’interpretazione delle sacre Scritture; né deve andare contro l’unanime consenso dei Padri, anche se questo genere di interpretazioni non dovesse essere mai pubblicato». È sentenza di Papa Leone XIII, Providentissimus Deus: «Con questa legge piena di sapienza la Chiesa non intende in alcun modo ritardare o proibire l’investigazione della scienza biblica (... ma solo) nei passi della divina Scrittura, ove si desidera ancora una interpretazione certa e definitiva (...). Negli altri casi (nei passi già definiti) si deve seguire l’analogia della fede e attenersi, come a norma suprema, alla dottrina cattolica, quale la si riceve dall’autorità della Chiesa (...). Somma è invero l’autorità dei santi Padri, per mezzo dei quali “la Chiesa, dopo gli Apostoli, ebbe incremento, come da piantatori, irrigatori, edificatori, pastori ed educatori”, ogni volta che all’unanimità interpretano con uguale senso una qualche testimonianza biblica, riguardante la dottrina della fede o dei costumi. Dal loro unanime consenso, infatti, appare chiaramente che così sia stato tramandato dagli Apostoli secondo la fede cattolica» Eccetera..., cfr. Spiritus Paraclitus, Papa Benedetto XV e Divino Afflante Spiritu, Papa Pio XII sulla «convergenza dei Padri» e sul «corretto uso della Scrittura» (Cliccare qui per approfondimenti). Veniamo al tema di oggi: il dialogo di Gesù con la Samaritana.
• § 293. Per tornare in Galilea Gesù scelse la strada che correva lungo il mezzo della Palestina, e perciò attraversava la Samaria; avrebbe potuto evitare questo passaggio se avesse seguito l’altra strada più a oriente che risaliva lungo il Giordano, ma la prima era più frequentata dai Galilei per il viaggio di Gerusalemme come ci attesta Flavio Giuseppe (cfr. Antichità giud., XX, 118; Vita, 269). Seguendo la strada scelta da Gesù, ad un certo punto s’entrava in una stretta valle, formata al nord dal monte Hebal e al sud dal monte Garizim: è la valle dove sta oggi la cittadina di Nabulus, fondata nel 72 dopo Cristo sotto Vespasiano e Tito, e chiamata ufficialmente Flavia Neapolis (donde Nabulus) ma usualmente Mabortha (cioè “passaggio”, “attraversata”) a causa della sua situazione geografica (cfr. Guerra giud., IV, 449). Poco prima di entrare nella valle da oriente, si trovava un luogo celebre nella storia dei patriarchi ebrei (Genesi, 12, 6; 33, 18; 48, 22) ove stava il «pozzo di Giacobbe» tuttora superstite. Inoltrandosi ancora poche centinaia di metri nella valle si raggiungeva sulla destra l’antichissima città di Sichem, esistente già verso il 2000 avanti Cristo ma che ai tempi di Gesù era in piena decadenza e scarsamente abitata: presso le sue rovine, recentemente investigate dagli archeologi, sorge il villaggio di Balata. Ad oriente di Balata-Sichem è situata la cosiddetta «tomba di Giuseppe», l’antico patriarca ebreo, e circa un chilometro e mezzo più in là verso nord-est si raggiunge il villaggio di Askar. Questo, lo sfondo geografico a cui si riporta la narrazione evangelica; essa presuppone anche la tradizionale avversione fra i Samaritani abitanti di quel luogo e i Giudei in genere, alla quale già accennammo in precedenza (§ 4). Partito dunque dalla Giudea, Gesù «giunge nella città della Samaria chiamata Sychar, presso il luogo che Giacobbe dette a Giuseppe suo figlio: era poi colà la fonte di Giacobbe. Gesù pertanto, straccato dal cammino, si sedette così presso la fonte. Era circa l’ora sesta» (Giovanni, 4, 5-6). Queste minuziose indicazioni di luogo pienamente confermate dai più recenti scavi, queste esatte indicazioni del tempo e delle altre particolarità dell’episodio, sono quanto si può immaginare di più alieno da un’invenzione puramente fantastica e d’indole simbolica: con tutto ciò le esigenze di teorie preconcette hanno indotto alcuni studiosi moderni a giudicare la narrazione una mera allegoria, scritta da un mistico dell’Asia Minore che forse non aveva mai visitato la Palestina. Senonché mai le teorie filosofiche prevarranno sulla realtà dei fatti, e sempre basterà rileggere spassionatamente la narrazione evangelica per ritornare alla vecchia conclusione del non sospetto Renan: «Soltanto un Giudeo della Palestina ch’era passato spesso per l’entrata della valle di Sichem, ha potuto scrivere queste cose».
• § 294. È dunque verso il mezzogiorno (ora sesta), probabilmente di maggio (§ 177, nota). Gesù stanco e sudato si riposa presso il pozzo: è solo, perché i discepoli sono andati nella città attigua a comprare da mangiare. Dalla città di Sychar una donna Samaritana viene verso il pozzo per attingere acqua. Gesù le dice: «Dammi da bere». La donna gli risponde con altezzosità: «Come? Tu che sei Giudeo chiedi da bere a me che sono donna Samaritana?». Veramente Gesù era Galileo, ma la donna, indovinando che egli tornava dalla visita al Tempio di Gerusalemme, lo ritiene giustamente per un seguace della religione giudaica; ella, perciò, vuoi far risaltare l’umiliazione di un uomo e di un Giudeo che spinto dal bisogno si rivolge per aiuto a una donna e a una Samaritana. Gesù replica: «Se sapessi il dono d’Iddio e chi è che ti dice “Dammi da bere”, tu l’avresti pregato e ti avrebbe dato un’acqua viva». L’aquila ha già ghermito un nuovo pulcino e comincia a sollevano in alto (§ 278). Come già Nicodemo, la donna comprende che in quelle parole c’è un pensiero recondito che le sfugge; ad ogni modo si attiene ancora al loro senso materiale, pur cominciando ad usare una certa deferenza per lo sconosciuto: «Signore, gli dice, non hai alcun oggetto per attingere e il pozzo è profondo; donde hai dunque l’acqua viva?». L’osservazione era giusta: il pozzo oggi è profondo 32 metri cioè uno dei più profondi di tutta la Palestina, sebbene ai tempi di Gesù potesse avere una misura alquanto minore. L’osservazione poi s’integrava con una considerazione storica: «Sei tu forse maggiore del nostro padre Giacobbe, che dette a noi il pozzo, e da esso bevve egli stesso e i suoi figli e i suoi greggi?». Il pulcino guarda ancora al suolo da cui è stato ghermito, e immagina di stare ancora a raspare là in basso. Ma Gesù risponde: «Chiunque beva di quest’acqua avrà sete di nuovo; ma colui che beva dell’acqua che io gli darò non avrà sete in eterno, bensì l’acqua che io gli darò diventerà in lui fonte d’acqua zampillante in vita eterna». La donna rimane ancora terra terra: «Signore, dammi cotesta acqua, affinché (io) non abbia sete né venga qua ad attingere». Per far comprendere al pulcino che si trovava già sopra le nuvole, era necessario ampliare l’argomento del dialogo, offrendo nello stesso tempo un «segno». Perciò Gesù dice alla donna: «Va’, chiama il tuo marito, e vieni qua!». In ebraico e in aramaico, come oggi nel contado toscano, «marito» si diceva «uomo», e così disse certamente anche Gesù: «Va’, chiama il tuo uomo, ecc.». Su questo termine equivoco gioca la donna, che risponde impavida: «Non ho uomo». Gesù schiva l’equivoco, approvando la risposta della donna nel suo significato peggiore: «Giustamente dicesti “Non ho uomo”; cinque uomini infatti avesti, e quello che hai adesso non è (il) tuo uomo. Ciò che hai detto è vero». L’«uomo» di quei giorni non era dunque «marito» e molto probabilmente non erano stati tali anche altri fra i cinque uomini precedenti: due o tre di essi avranno potuto o ripudiare la donna o anche esser morti, ma nelle cinque unioni ve ne erano state certo di illegittime com’era la sesta di allora. In conclusione, quanto a castigatezza di costumi quella Samaritana non era un modello.
• § 295. Il «segno» offerto da Gesù produce buon effetto. La donna, vedendo scoperti i suoi segreti, esclama: «Signore, vedo che tu sei profeta!». Ma questa stessa scoperta e questa esclamazione riconoscono la superiorità di colui che appartiene agli odiati Giudei; quindi sulla causa di questo odio si svolge adesso il discorso, anche per evitare lo scottante argomento dei segreti scoperti: «I padri nostri in questo monte adorano (Iddio), e voi dite che in Gerusalemme è il luogo ove bisogna adorare». Il monte Garizim si erge sulle teste dei due interlocutori; ma da Gerusalemme torna l’ignoto Giudeo, certamente dopo aver laggiù adorato Iddio nel Tempio di Jahvè. Che cosa dunque pensa egli, che è profeta, di questa secolare questione fra Samaritani e Giudei? Alla domanda della donna Gesù attribuisce un valore quasi soltanto storico, come di questione ormai inutile: ad ogni modo, pur sotto l’aspetto storico, Gesù parla da Giudeo e dà ragione ai Giudei contro i Samaritani; ma subito dopo, lasciato il passato, egli si trasferisce al presente in cui le vecchie odiose rivalità non hanno più ragione di essere: «Credimi, donna, che viene l’ora quando né in questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non sapete; noi adoriamo ciò che sappiamo, perché la salvezza è dai Giudei. Ma viene l’ora ed è adesso - quando i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E, infatti, il Padre tali ricerca gli adoratori suoi. Spirito è Iddio, e gli adoratori suoi in spirito e verità bisogna che adorino». Il profeta ha dato la sua risposta: d’ora innanzi il culto di Dio non sarà legato né al monte Garizim né al colle di Gerusalemme né ad alcun altro luogo della terra, bensì alle sole condizioni di esser fatto in spirito e verità. Parole rivoluzionarie e scandalose, queste, per un Fariseo che fosse stato lì ad ascoltare: non però del tutto nuove nella stessa tradizione d’Israele. Il novissimo profeta che le aveva pronunziate passava sopra alla «tradizione» farisaica e si riconnetteva con la tradizione anteriore e genuina dei profeti: già sei secoli prima il profeta Geremia aveva proclamato che il Tempio di Jahvè in Gerusalemme non serviva a nulla se frequentato da adoratori indegni (Ger., 7, 4 segg.), e aveva anche preannunziato che ai tempi del Messia la stessa santissima Arca dell’alleanza non sarebbe più stata venerata da alcuno (Ger., 3, 16) perché tutti porterebbero la nuova alleanza e la legge di Dio scritta nei loro cuori e nei loro spiriti (Ger., 31, 33).
• § 296. A questo punto la donna s’avvede di ritrovarsi in una sfera sconosciuta. Né Garizim né Gerusalemme, ma spirito e verità! Che mondo è questo? Certo non è il mondo piccino e pettegolo su cui stanno a battagliare Samaritani e Giudei; se i grandi dottori di Gerusalemme hanno praticamente dimenticato le predizioni di Geremia, tanto più può ignorarle una donnicciuola samaritana, che perciò si smarrisce in quel mondo predetto dall’antico profeta. Ella tuttavia intuisce che si tratta di visioni future, da contemplare attuate soltanto nei beati giorni del Messia; perciò nel suo smarrimento si rifugia col pensiero a quei giorni, e pur non osando contraddire l’ignoto profeta che le sta davanti esclama a guisa di consolazione. «So che Messia verrà (quello chiamato Cristo: l’Evangelista, preoccupato dei suoi lettori poco informati di cose giudaiche, aggiunge la spiegazione del nome Messia); quando sia giunto quello, ci annunzierà ogni cosa». Gesù le risponde: «Sono io, che ti parlo!». I Samaritani infatti aspettavano il Messia, e ancora oggi l’aspettano i loro pochi discendenti. È chiamato da essi Tahēb (Shahēb), «Colui che viene» o «Colui che farà rivenire (al bene)»; è immaginato come un riformatore simile a Mosè, che risolverà tutti i dubbi, comporrà tutte le divergenze e ristabilirà per mille anni dopo la sua morte un regno beato. L’interlocutrice di Gesù lo chiama qui «Messia», senza articolo, certamente perché l’appellativo valeva come nome proprio. Ora, proprio a questa donna non giudea e di razza ostile ai Giudei, Gesù rivela di essere il Messia, mentre più tardi comanderà ai suoi stessi discepoli di non palesare questa sua qualità (Matteo, 16, 20). Ma appunto nell’ostilità dei Samaritani sta il segreto di questa preferenza: presso di loro era ben difficile che a quell’annunzio si suscitasse un movimento di entusiasmo politico, il quale invece era probabilissimo presso i Giudei, mentre Gesù voleva evitarlo ad ogni costo. Se Giovanni ha dato questa notizia taciuta dai Sinottici, si può vedere anche in tale aggiunta il suo proposito di supplire almeno in parte alle narrazioni di quelli.
• § 297. Mentre Gesù sta scambiando le ultime parole con la Samaritana, i discepoli gli si avvicinano ritornando dalla città con i cibi comprati. Quando poi la donna ode da Gesù la dichiarazione ch’egli è il Messia, totalmente smarrita non ardisce replicare, bensì lascia la sua anfora al pozzo, corre alla città e a quanti incontra esclama: «Venite! Vedete un uomo che mi disse tutte le cose che ho fatte! È costui forse il Cristo?». I discepoli alla loro volta non ardiscono domandare a Gesù la ragione di quel dialogo insolito, pur essendone meravigliati, giacché i rabbini di allora schivavano di parlare in pubblico con donne e persino con le proprie mogli. Gli sconcertati discepoli vengono presso al maestro soltanto dopo che la donna improvvisamente è fuggita in direzione della città. «Rabbi, mangia!», gli dicono essi, offrendogli i cibi comprati. Gesù in risposta continua con essi la metafora dell’acqua spirituale impiegata con la donna: egli si nutre soprattutto di un cibo spirituale, che è fare la volontà di chi lo ha inviato a compiere la sua opera. Egli è l’agricoltore di una messe spirituale. In Palestina alla fine di dicembre, cioè terminati i lavori di semina, con un senso di sollievo si esclamava a guisa di proverbio «C’e’ ancora un quadrimestre, e verrà la messe», giacché i nuovi lavori di mietitura non cadevano che in aprile e maggio, cioè dopo un quadrimestre di riposo. Ma Gesù fa riscontrare ai discepoli che questo proverbio non ha valore per la sua messe spirituale: essa è già matura e pronta, né può sopportare indugi; perciò pure i mietitori siano pronti, anche se non ebbero il merito di aver essi seminato nel passato. Mentre Gesù pronunzia queste parole, le messi quasi mature al periodo pasquale (§ 117, nota) ondeggiano al sole lungo l’ampia pianura di el-Makhneh, che si stende ai suoi piedi verso il Giordano. Della messe spirituale furono raccolti subito alcuni manipoli. Alla garrula loquacità della donna, uscirono dalle case molti Samaritani, e si recarono al pozzo a vedere il profeta giudeo. Dovettero rimanere soggiogati fin dalle sue prime parole, perché l’invitarono a rimanere qualche tempo presso di loro; eppure erano Samaritani, cioè coloro che ordinariamente preferivano bastonare a sangue o addirittura ammazzare i Giudei di passaggio sulle loro terre (cfr. Guerra giud., II, 232; Antichità giud., XX, 118), e che più tardi negheranno ospitalità agli stessi discepoli dì Gesù (Luca, 8, 52-53). Questa volta, o almeno questi Samaritani di Sychar, furono cortesi, certamente perché mansuefatti dalla virtù personale del profeta. Gesù accettò l’invito e «rimase colà due giorni; e in molto maggior numero credettero per la parola di lui; alla donna poi dicevano: Non per la tua loquela crediamo! Noi stessi infatti abbiamo udito, e sappiamo che costui è veramente il salvatore del mondo» (Giovanni, 4, 40-42). Fine.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, con enorme gioia Vi comunichiamo che abbiamo iniziato i lavori per la futura pubblicazione - a Dio piacendo - del prezioso volume «Storia d’Italia», scritto da San Giovanni Bosco. La «Civiltà cattolica», quando era degna di portare tale nome, ossia quando le sue pagine trasmettevano scritti di venerandi uomini di fede e di dottrina integralmente cattolica, parlò molte volte di quest’opera. Intendiamo, in tale breve presentazione, riportarne alla luce alcuni stralci.
• Inizio della citazione. In un tempo come il nostro, nel quale della menzogna storica si fa un manicaretto per avvelenare le menti giovanili, molto importa rendere note le opere che nell’educazione della gioventù possono servire d’antidoto alle predette corruttele. E che tale sia questo veramente egregio libro del chiarissimo Don Bosco non bisogna di provarlo alla lunga. Altrove, parlando di questa storia, indicammo i meriti particolari che in sé contiene, e che sono di assai cresciuti nella nuova edizione che annunziamo. Per lo scopo che l’Autore si propone, che è d’insegnare la storia patria ai giovanetti Italiani con facilità, con brevità, con chiarezza, noi non esitiamo ad affermare che il libro nel suo genere non ha forse pari in Italia. È composto con grande accuratezza e con una pienezza rara a trovarsi nei compendi. Tutto il lavoro è diviso in quattro epoche, la prima delle quali incomincia dai primi abitatori della penisola, e l’ultima giunge sino alla guerra del 1859. Un confronto dei nomi geografici dell’Italia vetusta coi nomi moderni chiude il libro a maniera di appendice. Sotto la penna dell’ottimo Don Bosco la storia non si tramuta in pretesto di bandire idee di una politica subdola o principii di un’ipocrita libertà, come purtroppo avviene di certi altri compilatori di Epiloghi, di Sommarii, di Compendii che corrono l’Italia e brulicano ancora per molte scuole godenti reputazione di buone. Alla veracità dei fatti, alla copia della materia, alla nitidezza dello stile, alla simmetria dell’ordine, l’Autore accoppia una sanità perfetta di dottrine e di massime, vuoi morali, vuoi religiose, vuoi politiche. E questa è la qualità che ci sprona a raccomandare caldamente questo libro a quei padri di famiglia, a quei maestri, a quegli istitutori che desiderano di avere figliuoli e discepoli eruditi nella germana istoria patria, ma non intossicati dalla falsa storia patria. Conviene pur dirlo, giacché è per nostra grande sciagura troppo vero. Quella colluvie di scritti elementari e pedagogici che ora allaga la nostra penisola, è per la massima parte appestata dagli errori moderni contro il Papato, contro la Chiesa, contro il Clero, contro l’autorità divina ed umana. La diabolica congiura dei figliuoli delle tenebre contro la Luce eterna opera indefessamente a guastare fino dal seme le tenere anime dei giovanetti. Quindi noi stimiamo di fare un atto di amicizia suggerendo ai cattolici nostri lettori un libro elementare il quale né procede da un congiurato contro la verità, né ha le magagne che corrompono ai nostri giorni le menti inesperte. Fine della citazione.
• Probabilmente la nostra pubblicazione sarà pronta per il mese di ottobre, tuttavia, trattandosi di un lavoro abbastanza complesso, non ne siamo certi. Affidiamo questa opera alla potente intercessione dello stesso San Giovanni Bosco, oltre che di San Giovanni di Dio, Protettore della nostra piccola Associazione. Ciò detto, veniamo all’argomento del giorno: «Il tramonto di Giovanni», secondo le preziose istruzioni dell’Abate Giuseppe Ricciotti - riposi in pace!
• § 291. Nel colloquio con Nicodemo era stato accennato al battesimo in acqua e Spirito, che non era certamente quello di Giovanni [Battista, ndR]. Nel frattempo Giovanni continuava ad amministrare il suo rito, e a tale scopo si era recato ad Ainon presso Salim (§ 269). Dopo il colloquio con Nicodemo, Gesù rimase ancora qualche tempo in Giudea, ma sembra che si allontanasse alquanto dalla malfida capitale recandosi più a settentrione: l’aperta campagna offriva più libertà d’azione a lui ed a chi voleva ricorrere a lui, lontano dalla sospettosa sorveglianza dei maggiorenti sacri e dei Farisei. Certamente il luogo ove egli s’intratteneva era ben provvisto d’acqua, forse un’insenatura del Giordano, perché troviamo inaspettatamente che anche i discepoli di Gesù amministrano un rito battesimale come quello di Giovanni. Era questo il battesimo in acqua e Spirito a cui si era accennato nel colloquio con Nicodemo? No, quasi certamente. Il IV Vangelo, infatti, fa espressamente rilevare che non Gesù personalmente amministrava questo battesimo, bensì i suoi discepoli (Giov., 4, 2); del resto lo Spirito non era stato (loro) ancora dato (Giov., 7, 39; 16, 7), né i discepoli di Gesù erano stati ancora edotti sulla Trinità divina e sulla morte redentrice del Cristo, che saranno elementi essenziali del futuro battesimo in acqua e Spirito (Matteo, 28, 19; Romani, 6, 3 e seguenti). Era dunque anch’esso un rito puramente prefigurativo e simbolico, analogo a quello di Giovanni; perciò Giovanni continuò ad amministrare il suo, anche quando i discepoli di Gesù battezzavano, mentre avrebbe dovuto cessare se avessero battezzato in acqua e Spirito. Tuttavia avvenne un dissenso. Un giorno fra i discepoli di Giovanni ed un Giudeo sorse una disputa a proposito di purificazione; forse il Giudeo, dei dintorni di Gerusalemme e non Galileo, stimava più purificativo, perché più peregrino, il rito amministrato dai discepoli del Rabbi galileo, e quindi lo preferiva a quello di Giovanni. Amareggiati, i discepoli di costui ricorsero al loro maestro e gli riferirono la presunta rivalità di Gesù: «Rabbi, quello ch’era insieme con te di là dal Giordano, al quale tu hai reso testimonianza - guarda! - costui battezza e tutti vengono a lui!». I focosi discepoli forse s’aspettavano che Giovanni inveisse ingelosito, e invece l’udirono rallegrarsi consolato: «Non può un uomo acquistar nulla, se non gli sia dato dal cielo. Voi stessi mi rendete testimonianza che dissi: “Non sono io il Cristo (Messia), ma sono stato inviato avanti a lui” (§ 269). Chi ha la sposa è sposo: ma l’amico dello sposo, che sta (presente) e l’ascolta, gioisce di gioia per la voce dello sposo. Questa mia gioia, dunque, è compiuta. Bisogna che egli cresca, e io invece diminuisca (Giov., 3, 27-30)». Frequentissimo negli scritti poetici dell’Antico Testamento era stato l’uso di presentare il Dio Jahvè come lo sposo della nazione d’Israele. Qui, per Giovanni, lo sposo è il Messia Gesù, ed in queste mistiche nozze egli, come precursore, ha l’ufficio di “amico dello sposo” (§ 281). Ma lo sposo è già alla porta, ed egli ne ha udito la voce; gioire quindi bisogna, non già attristarsi e ingelosire! Lo splendore lunare diminuisce e si perde man mano che quello solare s’accresce: e cosi bisogna «ch’egli cresca e io invece diminuisca».
• § 292. Fu l’ultima testimonianza di Giovanni. Qualche settimana dopo, probabilmente nel maggio, l’austero censore dello scandalo di corte finiva imprigionato a Macheronte (§ 17). È difficile che i Farisei fossero del tutto estranei a questo imprigionamento, e non vi avessero una parte occulta e indiretta. I Sinottici attribuiscono l’imprigionamento alla riprovazione dello scandalo, Flavio Giuseppe alla malvista popolarità di Giovanni, ma ambedue i motivi sono giusti e si assommano insieme benissimo; tuttavia il IV Vangelo ci fa intravedere anche un terzo motivo: «Udirono i Farisei che Gesù fa discepoli e battezza più che Giovanni» (Giov., 4, 1), e allora Gesù abbandona la Giudea e fa ritorno in Galilea. Cosicché Gesù teme che la sua popolarità, maggiore di quella di Giovanni, lo esponga alle gelose insidie dei Farisei; per questo motivo s’allontana. Era dunque Giovanni già caduto in quelle insidie? Nessuno ce lo dice espressamente, ma in equivalenza i Sinottici ci comunicano che Gesù si allontanò dalla Giudea appena si riseppe dell’imprigionamento di Giovanni. Questa, dunque, fu l’insidia in cui era caduto Giovanni per colpa dei Farisei, oltreché per il suo merito d’aver censurato lo scandalo di corte. I Farisei, volendo disfarsi dal fastidioso e vigilato riformatore, astutamente si sarebbero serviti del rancore che la corte di Erode Antipa aveva contro di lui, aizzando il tetrarca ad imprigionare l’austero censore dello scandalo e il popolare dominatore di turbe. Se Giovanni si tratteneva ancora ad Ainon presso Salim, non era sul territorio del tetrarca Antipa, ma su quello della città libera di Scitopoli che faceva parte della Decapoli (§ 4), e quindi non poteva essere arrestato colà dal tetrarca. Ma Scitopoli s’incuneava fra i due tronconi del territorio di Antipa, la Galilea e la Perea; fu dunque facile attirare Giovanni sul territorio di Antipa con qualche pretesto presentato abilmente da compiacenti mediatori. Più tardi i Farisei tenteranno una mediazione inversa, perché fingendosi protettori di Gesù vorranno che egli si allontani spontaneamente dal territorio di Antipa: probabilmente anche questa nuova mediazione fu sollecitata dallo stesso Antipa, il quale perciò in questa occasione fu chiamato «volpe» da Gesù (Luca, 13, 31-32) (§ 463). Nelle oscure segrete di Macheronte, Giovanni languì molti mesi in estenuante attesa. Fine della citazione. La prossima settimana, Dio volendolo, il Ricciotti ci erudirà sulla vicenda evangelica che vede protagonista principale sempre Gesù, presso Sichem, alle prese con la donna Samaritana che va verso il pozzo. Il libro usato è «Vita di Gesù Cristo» - Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941, dell’Abate Giuseppe Ricciotti. Fine.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, all’epoca di Gesù viveva a Gerusalemme un «insigne Fariseo» di nome Nicodemo, uomo di rette intenzioni ma membro del Sinedrio. Impariamo a conoscere bene questo personaggio e studiamo la sua vicenda ricorrendo al prezioso aiuto del compianto Abate Giuseppe Ricciotti - riposi in pace!
• § 288. C’era allora in Gerusalemme un insigne Fariseo e «maestro» della Legge, uomo onesto e di rette intenzioni; ma era anche membro del Sinedrio, e questa sua condizione sociale imponeva evidentemente molta cautela e prudenza alla sua condotta pubblica. Si chiamava Nicodemo: il nome ritorna negli scritti rabbinici, ma è ben difficile che designi la stessa persona di qui. A vedere i segni fatti da Gesù, egli rimane scosso; forse era stato fra i pochi Farisei che avevano riconosciuto la missione del precursore Giovanni accettandone il Battesimo. D’altra parte la sua condizione sociale, e più ancora la sua formazione intellettuale farisaica, gli consigliavano oculato riserbo di fronte all’ignoto taumaturgo. Fra questo ansioso contrasto egli prende una via di mezzo, e si reca a visitare Gesù di notte: alla penombra d’una lucerna si ragiona con più raccoglimento, e soprattutto non si è facilmente riconosciuti da estranei. Il colloquio fu lungo e forse si protrasse per tutta la notte, ma l’Evangelista «spirituale» ne riferisce solo i punti più salienti che meglio rispondevano agli scopi del suo Vangelo «spirituale». Cominciò Nicodemo, e riferendosi a ciò che l’aveva scosso intimamente disse a Gesù: «Rabbi, sappiamo che da Dio sei venuto (quale) “maestro”, poiché nessuno può fare questi “segni” che tu fai se non sia Iddio con lui». L’onesto Fariseo riconosceva che la missione di Gesù non era umana, ma proveniva da una sfera più alta cioè divina. Gesù gli rispose ricollegandosi a questa allusione: «In verità, in verità ti dico, se alcuno non sia nato dall’alto, non può vedere il regno d’Iddio». Nicodemo era troppo intelligente per interpretare queste parole in senso materiale: anche i suoi colleghi rabbini parlavano di rinascita in senso spirituale applicandola specialmente a chi si riavvicinava al Dio d’Israele o dall’empietà o dal paganesimo, e altrettanto faceva con diverso impiego Filone in Alessandria. Ma a Nicodemo sfuggiva appunto il senso racchiuso nelle parole di Gesù, e quindi per provocarne la spiegazione s’atteggia a ottuso di mente: «Come può nascere un uomo che sia vecchio? Può forse entrare nel ventre di sua madre una seconda volta e (ri)nascere?». Senonché il finto ottuso è più acuto di quanto sembri: egli s’impanca (si dispone, ndR) a giudice della dottrina che Gesù sta per esporgli, ma Gesù gli risponde in modo da ricondurlo alla sua condizione di ignaro apprendista; non si può «vedere il regno d’Iddio» se non si è già entrati in esso, e l’entrarvi non è effetto d’industrie umane: «In verità, in verità ti dico, se alcuno non sia nato da acqua e (da) Spirito, non può entrare nel regno d’Iddio. Ciò ch’è nato dalla carne, è carne; e ciò ch’è nato dallo Spirito, è spirito». In ebraico spirito significava anche soffio (di vento); Gesù prende occasione del doppio significato per soggiungere un esempio materiale: «Non ti meravigliare perché ti dissi “Bisogna che voi nasciate dall’alto”; (anche) il soffio (di vento) dove vuole soffia e il rumore di esso (tu) ascolti, ma non sai donde e dove va. Così è (di) chiunque è nato dallo Spinto». Benché incontenibile ed invisibile, il soffio del vento è reale nel campo fisico; così nel campo morale, l’azione dello Spirito divino non è moderabile da argomenti umani né è scrutabile nella sua essenza, ma ben si manifesta nei suoi risultati. Questo Spirito fa nascere ad una vita nuova invisibile, in maniera tale che ricorda come la prima vita visibile del cosmo si sprigionasse dalla materia bruta e insieme dal soffio di Dio che si librava sulle acque del caos (Genesi, 1, 2). L’allusione al battesimo di Giovanni è chiara, e forse nel colloquio fra i due se ne parlò esplicitamente se anche Nicodemo aveva ricevuto quel rito; ad ogni modo la vita nuova qui annunziata da Gesù come data dallo Spirito e dall’acqua non è prodotta dal rito di Giovanni, ch’era soltanto di acqua e prefigurativo, bensì dal rito adempitivo amministrato in acqua e Spirito santo: questo secondo era il battesimo di Gesù, a testimonianza dello stesso precursore Giovanni (Matteo, 3, 11 e paralleli; Giovanni, 1, 33).
• § 289. Il paragone fra l’azione dello Spirito e quella del vento ha trasportato Nicodemo in un mondo a lui ignoto, in cui il Fariseo si sente sperduto. Cessa allora d’atteggiarsi a finto ottuso, ma ancora non si vuol riconoscere ignaro apprendista, e con sincerità non priva d’una certa sfiducia esclama: «Come può avvenire ciò?». La replica di Gesù s’inizia con una spontanea riflessione sull’ufficio di Nicodemo: «Ma come? Tu sei il “maestro” d’Israele, e non sai queste cose? E che cosa insegni, se non tratti dell’azione dello Spirito sugli spiriti?». - Dopo questo inizio il discorso di Gesù si dovette prolungare assai, non senza interruzioni e repliche da parte di Nicodemo. L’Evangelista tralascia totalmente le parole del Fariseo, e delle sentenze di Gesù fa soltanto una silloge; ma non è arrischiato riconoscere in questa silloge talune repliche ad osservazioni di Nicodemo (come là ove si accenna al serpente del deserto) o anche talune metafore tratte dalle circostanze del colloquio che si svolgeva al lume d’una lucerna (come là ove si accenna a luce e a tenebra). Ecco la silloge: «In verità, in verità ti dico, che di ciò che sappiamo parliamo, e ciò che abbiamo veduto testimoniamo: e la testimonianza nostra non ricevete. Se le cose terrestri vi dissi e non credete, come crederete se io vi dica le celestiali? E(ppure) nessuno è salito nel cielo se non il disceso dal cielo, il figlio dell’uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto (cfr. Numeri, 21, 8-9), così bisogna che sia innalzato il figlio dell’uomo affinché ogni credente in lui abbia vita eterna. Così invero amò Iddio il mondo, che dette il Figlio, l’unigenito, affinché ogni credente in lui non perisca ma abbia vita eterna. Non inviò infatti Iddio il Figlio nel mondo per giudicare (a condanna) il mondo, bensì affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Il credente in lui non è giudicato (a condanna): il non credente già è stato giudicato (a condanna), perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio d’Iddio. Questo poi è il (motivo del) giudizio (di condanna): che la luce è venuta nel mondo, ed amarono gli uomini piuttosto la tenebra che la luce; di essi infatti erano malvage le azioni. Ognuno invero che opera male, odia la luce e non viene verso la luce; chi invece fa la verità viene verso la luce, affinché siano manifestate le sue azioni (e si veda) che sono state fatte in Dio» (Giov., 3, 11-21).
• § 290. In quale stato d’animo avrà ascoltato Nicodemo queste sentenze? Probabilmente in uno stato simile a quello di Agostino nel periodo delle sue titubanze, quando leggendo le Lettere di Paolo gli sembrava di sentire come un profumo di vivande squisite, che tuttavia non riusciva ancora a mangiare, quasi olfacta desiderantem, quæ comedere nondum posset. Del resto alcune sentenze, se non furono schiarite da Gesù con spiegazioni omesse dall’Evangelista, non potevano essere ben comprese da Nicodemo: tale l’allusione alla crocifissione, prefigurata nel serpente nel deserto. Ad ogni modo Gesù, come già aveva fatto con i Giudei del Tempio dopo la cacciata dei mercanti (§ 287), non parlava per Nicodemo soltanto. Se il Fariseo andò a lui di notte, non è detto che lo trovasse assolutamente solo; in un angolo semibuio di quella stanza è ben lecito intravedere gli occhi intenti di un adolescente che segua con ansia il dialogo e stampi quelle parole nella sua vigile memoria: è il discepolo prediletto (San Giovanni Apostolo, ndR), colui che vecchissimo sarà il narratore dell’episodio. Nonostante il colloquio, Nicodemo più tardi non fu vero discepolo di Gesù, quasi a dimostrare esatte le parole allora udite che «il soffio di Dio soffia dove vuole». Tuttavia a Gesù egli rimase benevolo fin dopo la crocifissione: nel Sinedrio oserà spendere una parola in favore di Gesù (Giov., 7, 50-51), e anche più spenderà materialmente per acquistare cento libbre d’aromi onde curare la salma di lui (Giov., 19, 39). Non era un generoso di animo, ma era almeno un generoso di borsa; se non fu un Pietro, non fu neppure un Giuda.
Il libro usato è «Vita di Gesù Cristo» - Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941, dell’Abate Giuseppe Ricciotti. Fine.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, sempre attingendo alla sobria, erudita e preziosa «Vita di Gesù Cristo» dell’Abate Giuseppe Ricciotti - riposi in pace! - oggi parleremo de «I mercanti del Tempio».
•§ 286. Dal battesimo di Gesù erano trascorsi pochi mesi: ormai era vicina la Pasqua del nuovo anno che, secondo le nostre preferenze giustificate a suo luogo (§ 176), era l’anno 28 dell’Era Volgare. Per questa Pasqua Gesù aveva deciso di compiere il pellegrinaggio (§ 74), perciò partì da Cafarnao alla volta di Gerusalemme. Giunto nella capitale e recatosi al Tempio, egli si trovò davanti alla solita scena che avveniva colà più che mai in occasione delle grandi feste. L’atrio esterno del Tempio era diventato una stalla appestata dal fetore del letame, e risonava del muggito dei bovi, del belato delle pecore, del pigolar dei colombi, e soprattutto delle alte grida dei mercanti e dei cambiavalute istallatisi per ogni dove (§ 48); da quell’atrio si poteva solo remotamente udire una debole eco dei canti liturgici che s’innalzavano al di dentro e intravedere un debole chiarore della lontana luminaria sacra. Altri segni religiosi non apparivano in quel vasto recinto, che si sarebbe detto una fiera di bestiame e un convegno di truffatori, piuttosto che l’anticamera della casa ove abitava l’immateriale Dio d’Israele. Gesù era stato certamente testimone di tale scena altre volte nei suoi precedenti pellegrinaggi a Gerusalemme, ma allora la sua vita pubblica non era ancora cominciata; adesso invece la sua missione doveva svolgersi in pieno, ed egli doveva agire come avente autorità (Matteo, 7, 29; Marco, 1, 22) anche per dimostrare la sua missione. Riunite perciò delle corde a mazzo, si dette a percuotere bestie e uomini, rovesciò tavoli di cambiavalute, sparpagliò a terra mucchietti di monete, scacciò via tutti liberando il sacro recinto: Fuori di qua! Non fate la casa del Padre mio casa di traffico! (Giov., 2, 16). - Non sta scritto «La casa mia casa di preghiera sarà chiamata per tutte le genti»? (Isaia, 56, 7). Voi invece l’avete ridotta a spelonca di ladroni (Marco, 11, 17). Già sei secoli prima il profeta Geremia aveva visto il Tempio ridotto a spelonca di ladroni (Ger., 7, 11); ma i sacerdoti e i magistrati sacri contemporanei a Gesù dovevano pensare che la voce di Geremia era troppo lontana, mentre troppo vicino era il vantaggio che l’amministrazione del Tempio ricavava da tutto quel mercanteggiare perché fosse conveniente farlo cessare. E Gesù lo fece cessare a suon di flagelli.
• § 287. In teoria non c’era nulla da eccepire, come ben vedevano gli stessi Farisei; ma in pratica si poteva sempre domandare a Gesù perché aveva compiuto egli personalmente quell’atto di autorità, e non aveva invece invitato a compierlo i magistrati che avevano la direzione del Tempio. Chi aveva dato a lui l’autorità di far ciò? Anzi, più ampiamente, perché mai egli piovuto giù dalla Galilea aveva preso, come appariva dalle sue prime azioni, un atteggiamento del tutto indipendente dalle autorità costituite e molto simile a quello di Giovanni il Battista? Gli si avvicinarono pertanto alcuni Giudei, certamente insigni, e gli dissero: «Quale segno ci mostri che fai ciò (legittimamente)?». Rispose Gesù e disse loro: «Demolite questo santuario, e in tre giorni lo farò sorgere!». Dissero pertanto i Giudei: «In quarantasei anni fu costruito questo santuario, e tu in tre giorni lo farai sorgere?». Già vedemmo che questa risposta dei Giudei contiene un’indicazione molto importante per stabilire la cronologia della vita di Gesù (§ 176); ma la stessa risposta mostra anche che quegli interlocutori non avevano capito a che cosa alludesse Gesù, e con essi certamente anche l’Evangelista testimonio che narra questo fatto. I Giudei avevano chiesto un segno ossia un miracolo: ciò era troppo, perché l’azione di Gesù si giustificava da se stessa, tanto più che i magistrati del Tempio avevano trascurato d’intervenire per far cessare quella profanazione come sarebbe stato loro dovere. Ad ogni modo, essendo stata chiamata in causa la missione di Gesù, egli ne offre una prova vera e reale ma che sarà compresa soltanto dopo molti mesi, mentre al presente non appagherà affatto la curiosità maligna degli interroganti. Il santuario a cui alludono le parole di Gesù è il suo stesso corpo; quando i Giudei avranno disfatto quel santuario vivente, egli lo farà sorgere di nuovo entro tre giorni. Pronunziando queste parole, può darsi che Gesù abbia anche accennato a se stesso con un gesto; comunque fosse, tutti gli ascoltatori pur non comprendendo la risposta se ne ricordarono più tardi, i Giudei per accusare Gesù (§ 565), i suoi discepoli per credere in lui riconoscendo nella sua resurrezione il segno offerto agli interroganti (Giov., 2, 22). [Nota: Già accennammo alla divergenza cronologica fra Giovanni ed i Sinottici: il primo narra la cacciata dei venditori dal Tempio al principio della vita pubblica, i secondi la narrano alla fine (§ 163). Molti studiosi, stimando impossibile un accordo fra le due narrazioni, hanno creduto trattarsi di due fatti diversi, cioè che Gesù abbia cacciato due volte i venditori dal Tempio. A nostro avviso il fatto è unico, e accadde al principio della vita pubblica come fa espressamente rilevare Giovanni, da accurato cronologo qual è. Se i Sinottici trasportano quest’unico fatto al termine della vita pubblica, vi sono indotti da motivi di analogia d’argomento ma specialmente dalla circostanza che essi, nella loro esposizione sommaria e assai spesso non cronologica, narrano esplicitamente di una sola permanenza di Gesù a Gerusalemme (in luogo delle almeno quattro permanenze narrate da Giovanni) e perciò non potevano ricollegare la scena della cacciata se non con l’unica permanenza narrata]. Sebbene i maligni non fossero stati appagati da Gesù nella loro richiesta del segno, tuttavia già in quella sua prima permanenza pasquale in Gerusalemme, molti credettero nel nome di lui, vedendo i segni di lui che faceva (Giov., 2, 23). Ma più che fede di cuore, era fede di cervello, mentre Gesù cercava assai più quella che questa; perciò anche non affidava se stesso a loro, perché egli conosceva tutti (Giov., 2, 24), mentre agli incolti ma generosi discepoli della Galilea egli si era affidato. Ad ogni modo anche la fede di cervello è preparazione ed invito a quella di cuore, e appunto qui l’Evangelista “spirituale” fa assistere ad un colloquio tra uno che aveva già fede di cervello e Gesù che invece lo solleva in tutt’altra sfera: pare di assistere ad una scena di un pulcino sollevato sopra le nubi dall’aquila, ed è scena prediletta dell’Evangelista “spirituale” che la riprodurrà in altre occasioni. (§ 294). Il libro usato è «Vita di Gesù Cristo» - Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941, dell’Abate Giuseppe Ricciotti. Fine.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, Vi ricordiamo di leggere sul nostro sito il nuovo Regolamento sul trattamento dei dati personali. Il link da usare è il seguente: cliccare qui. Il dotto Abate Ricciotti oggi ci parla delle nozze di Cana.
• § 281. Il colloquio con Nathanael è un nuovo punto di partenza per la cronologia dell’evangelista San Giovanni; egli fa sapere che «il terzo giorno dopo quel colloquio si fecero nozze in Cana della Galilea, ed era la madre di Gesù colà; e fu invitato anche Gesù, e i suoi discepoli, alle nozze» (Giov., 2, 1-2). Poiché, come abbiamo visto, Nathanael era appunto di Cana, è verosimile che egli stesso abbia invitato Gesù e i suoi discepoli Andrea, Pietro, Giovanni e Filippo alle nozze, le quali saranno state di qualche parente o amico di Nathanael stesso; tuttavia dalle parole di Giovanni sembra risultare chiaramente che era la madre di Gesù colà anche prima dell’arrivo del figlio, e ciò induce a congetturare che pure tra Maria e uno degli sposi esistesse qualche legame: come parente o amica, ella si sarà recata là qualche giorno prima per aiutare le donne di casa nei preparativi, specialmente della sposa, ch’erano lunghi. Non hanno invece alcuna verosimiglianza certi almanaccamenti tardivi che vedono nello sposo o Nathanael stesso, l’evangelista Giovanni, o altri. La Cana visitata comunemente oggi in Palestina è Kefr Kenna, che seguendo la strada maestra sta circa a 10 chilometri a nord-est di Nazareth sul percorso verso Tiberiade e Cafarnao, mentre ai tempi di Gesù la distanza fra questa Cana e Nazareth era 3 o 4 chilometri più breve. Ma anticamente esisteva un’altra Cana ridotta oggi a un campo di ruderi, Kirbet Qana, a 14 chilometri a nord di Nazareth. Si disputa fra gli archeologi quale di questi due luoghi sia la Cana del IV Vangelo; in favore di ambedue i luoghi esistono ragioni non spregevoli, sebbene non decisive, e le stesse relazioni scritte degli antichi visitatori sono applicate in favore dell’uno o dell’altro. La questione dunque è tuttora incerta, e d’altra parte non è cosa indispensabile risolverla. Le nozze di Cana furono i nissū’īn del cerimoniale giudaico (§ 231). La festa che li accompagnava era certamente la più solenne di tutta la vita per la gente di basso e medio grado sociale, e poteva durare anche più giorni. La sposa usciva dalle mani delle parenti e delle amiche tutta agghindata pomposamente, con una corona in testa, imbellettata in viso, con gli occhi splendenti di collirio, con i capelli e le unghie dipinti, carica di collane, braccialetti e altri monili per lo più falsi o presi in prestito. Lo sposo, incoronato anch’esso e circondato dagli «amici dello sposo», andava sul far della sera a rilevare la sposa dalla casa di lei, per condurla alla propria; la sposa lo attendeva circondata dalle sue amiche, munite di lampade ed acclamanti al giungere dello sposo. Dalla casa della sposa a quella dello sposo si procedeva in corteo, a cui prendeva parte tutto il paese, con luminarie, suoni, canti, danze e grida festose. Tanta era l’autorità morale di siffatti cortei, che perfino i rabbini interrompevano le lezioni nelle scuole della Legge ed uscivano con i loro discepoli a festeggiare gli sposi. A casa dello sposo si teneva il pranzo, con canti e discorsi augurali, i quali talvolta non erano immuni da allusioni ardite, specialmente quando il pranzo era inoltrato e la comitiva era tutta più o meno brilla. Si beveva infatti senza parsimonia, si tracannava cordialmente, essendone tanto rara l’occasione per gente che tutto l’anno faceva vita grama e stentata. E si bevevano vini speciali, messi in serbo da gran tempo e custoditi appunto per quella festa; ancora oggi si possono scorgere in un oscuro angolo di qualche casa araba file di misteriose giarre, e il padrone di casa dirà con compunzione grave che non devono toccarsi perché è vino per nozze. Del resto nelle sacre Scritture ebraiche si leggeva che il vino letifica il cuore dell’uomo, e quella gente voleva obbedire alle Scritture almeno nella letizia nuziale.
• § 282. A tale festa così cordiale, così umana anche nelle sue debolezze, volle partecipare Gesù, come certamente pure Maria avrà contribuito al pomposo rivestimento della sposa. Quando Gesù era ancora ragazzo a Nazareth, sua madre gli avrà più volte narrato che un po’ di festicciuola era stata fatta anche quando si erano celebrati i nissū’īn per lei, ed ella era entrata in casa di Giuseppe (§ 239). Allora era sorta una nuova famiglia, che Gesù aveva onorata e santificata con un’obbedienza trentennale; adesso, ch’egli sta per uscire da questa famiglia, quasi si volge addietro con rimpianto e vuole onorare e santificarne il principio morale costitutivo. Per questa ragione Gesù, il nato da vergine e che morirà vergine, interviene a nozze al termine della sua vita privata e al cominciare di quella pubblica. Anzi, la cominciò con un miracolo tale che, mentre dimostrava la potenza di lui, direttamente servì a rendere sempre più liete e festose quelle nozze. Accortamente San Giovanni (2, 11), dopo aver raccontato il miracolo, conclude osservando che quello di Cana fu l’inizio dei «segni» miracolosi di Gesù. A Cana Gesù ritrovò sua madre dopo circa due mesi d’assenza. Era stata forse la prima lunga assenza di lui dalla casa paterna; essendo già morto Giuseppe, la bottega in quel tempo era rimasta inoperosa e Maria senza compagnia. In quella prima solitudine, più che mai, ella avrà ripensato a lui, alla sua nascita e alla sua preannunziata missione, intravedendo che questa stava per cominciare: e avrà fatto ciò, mentre doveva schermirsi dalle domande delle indiscrete donne del paese, o anche dai frizzi degli acrimoniosi parenti (§ 264), che avranno voluto sapere perché Gesù l’avesse lasciata sola, e dove fosse andato, e a quale scopo, e quando sarebbe tornato. Adesso, a Cana, ella se lo rivedeva davanti, già chiamato Rabbi, considerato come un maestro e circondato da alcuni fervorosi discepoli: indubbiamente la previsione fatta nella sua solitudine stava per avverarsi. Ma, anche davanti al Rabbi, Maria rimase sempre madre, quale si era mostrata davanti al ragazzo dodicenne disputante nel Tempio. Da buona madre di famiglia Maria, durante quel pranzo di nozze, avrà sorvegliato insieme con le altre donne che tutto procedesse regolarmente, e le vivande e ogni cosa fossero pronte. Senonché sul finire del pranzo - o perché si erano fatti male i calcoli, o perché erano sopraggiunti convitati imprevisti - venne a mancare proprio il principale, il vino. Le massaie che amministravano ne furono costernate. Era il disonore per la famiglia che ospitava; i convitati non avrebbero risparmiato proteste e scherni, e la festa sarebbe finita bruscamente e ignominiosamente, come quando a teatro in una scena decisiva viene a mancare la luce.
• § 283. Maria s’avvide subito della mancanza, e previde la vergogna degli ospitanti; tuttavia non ne fu costernata come le altre donne. Al suo spirito la presenza del suo figlio Rabbi diceva tante cose che non diceva agli altri; soprattutto ella ricollegava quella presenza con la previsione da lei fatta nella sua solitudine di Nazareth. Non era forse giunta l’ora di lui? Dominata da questi pensieri Maria, fra lo smarrimento generale a mala pena dissimulato, dice sommessamente a Gesù: «Non hanno vino». E dice a lei Gesù: «Che cosa (è) a me e a te, donna? Non ancora è giunta l’ora mia» (Giov., 2, 3-4). Gesù pronunziò queste parole in aramaico, e secondo questa lingua esse vanno interpretate. In primo luogo donna era un appellativo di rispetto, circa come l’appellativo (ma)donna nel Trecento italiano. Un figlio chiamava ordinariamente madre la donna che lo aveva generato, ma in circostanze particolari poteva chiamarla per maggior riverenza donna. E donna chiamerà nuovamente Gesù sua madre dall’alto della croce (Giov., 19, 26); ma anche prima, secondo un aneddoto rabbinico, un mendicante giudeo aveva chiamato donna la moglie del grande Hillel, come Augusto aveva chiamato donna Cleopatra, e così in altri casi. Più tipica è l’altra espressione che cosa (è) a me e a te...?, è certamente traduzione della frase fondamentale ebraica mah lī wal (āk) che ricorre più volte nella Bibbia. Ora, il significato di questa frase era precisato nell’uso molto più dalle circostanze del discorso, dal tono della voce, del gesto, ecc., che dal semplice valore delle parole; tutte le lingue hanno di tali frasi idiomatiche in cui le parole sono rimaste un semplice pretesto per esprimere un pensiero, e che verbalmente non si possono tradurre in altra lingua. Nel caso nostro una parafrasi, che tenga qualche conto anche delle parole ebraiche, potrebbe essere questa: Che (motivo fa fare) a me e a te (questo discorso)?; il che, indipendentemente dalle parole, equivale all’espressione italiana: Perché mi fai questo discorso? Era insomma una frase ellittica con la quale si ricercava la recondita ragione per cui tra due persone avveniva un discorso, un fatto, e simili. Con questa risposta Gesù declinava l’invito fattogli da Maria, e ne adduceva come ragione il fatto che ancora non era giunta l’ora sua. Dunque in quelle tre sole parole di Maria non hanno vino (seppure furono dette quelle tre sole) era nascosto l’invito a compiere un miracolo, e la mira dell’invito era nettamente designata dalle circostanze esterne ma soprattutto dai pensieri interni e dal volto materno di colei che invitava. Gesù, che si rende ben conto di tutto, rifiuta, come già nel Tempio aveva rifiutato di subordinare la sua presenza nella casa del Padre celeste a quella nella sua famiglia terrena (§ 262): ancora non è giunta l’ora di dimostrare con miracoli l’autorità della propria missione, poiché il precursore Giovanni sta ancora svolgendo la sua. Tuttavia il dialogo fra Maria e Gesù non è finito; anzi le sue più importanti parole non furono mai pronunziate da labbro, ma solo trasmesse da sguardo a sguardo. Come già nel Tempio Gesù dopo il rifiuto aveva obbedito lasciando subito la casa del Padre celeste, così dopo questo nuovo rifiuto accede senz’altro all’invito di Maria. La madre, nel dialogo muto seguito al dialogo parlato, viene assicurata che il figlio acconsente; perciò senza perdere tempo si volge agli inservienti e dice loro: Fate tutto ciò che vi dirà!
• § 284. Nell’atrio di quella casa erano sei grandi pile destinate alle abluzioni delle mani e delle stoviglie prescritte dal giudaismo: perciò le pile erano di pietra, perché secondo i rabbini la pietra non contraeva impurità come la terracotta. Ed erano pile grandi, contenendo ciascuna due o tre volte la normale «misura» giudaica, la quale si aggirava sui 39 litri; dunque, tutte insieme avevano una capacità di circa 600 litri. Naturalmente il pranzo era lungo, i convitati erano molti, e quindi tutta quell’acqua necessaria era stata in gran parte consumata e le pile erano quasi vuote. Gesù allora dette ordine di riempire totalmente le pile; gl’inservienti corsero al pozzo o alla cisterna vicina, e in pochi viaggi le pile furono colme. Non c’era altro da fare; e dice a quelli: «Attingete adesso, e portate al direttore di mensa». E quelli portarono (Giov., 2, 8). Tutto si era svolto in pochi minuti, anche prima che il direttore di mensa notasse lo smarrimento delle donne e s’avvedesse che non c’era più vino; la discretezza di Maria aveva impedito anche il dilagare dello scandalo familiare. Quando il direttore di mensa si vide davanti una nuova specie di vino, e l’ebbe assaggiata com’era suo ufficio, rimase strabiliato, tanto che dimenticò anche il sussiego della sua carica e parlò con la schiettezza del buon popolano. Avvicinatosi allo sposo, gli dice: «Ogni uomo passa prima il vino buono, e quando sono brilli quello peggiore; tu (invece) hai serbato il vino buono fin qui!» (Giov., 2, 10). Le parole del direttore di mensa non alludono a qualche uso corrente, che non ci è attestato da nessun documento antico; vogliono essere piuttosto un complimento spiritoso, che fa notare quanto fosse inaspettata sul finire del pranzo quell’ambrosia e in quella quantità. Ma, a quelle parole, lo sposo probabilmente guardò ben bene in faccia il direttore di mensa, domandandosi se proprio lui non fosse il più brillo di tutti: egli, lo sposo, non si era mai sognato di riserbare per la fine del pranzo quella sorpresa del vino migliore. Alcune poche interrogazioni rivolte agli inservienti e alle donne indirizzarono le ricerche su Maria e poi su Gesù, e tutto fu spiegato. Così questo primo miracolo, dice San Giovanni, «Gesù manifestò la sua gloria e credettero in lui i suoi discepoli». Ciò non meraviglia, se si pensa all’entusiasmo che già avevano per Gesù i suoi pochi discepoli. Ma quale sarà stata l’impressione prodotta sui commensali dal miracolo? Dissipati i fumi del convito e dimenticato il sapore di quel misterioso vino, avranno essi ripensato al significato morale dell’avvenimento?
• § 285. Dopo la festicciuola e il miracolo Gesù si recò a Cafarnao, «egli e la madre di lui e i fratelli e discepoli di lui, e colà rimasero non molti giorni» (Giovanni, 2, 12). Questa permanenza a Cafarnao fu breve, perché Gesù aveva deciso di recarsi a Gerusalemme per l’imminente Pasqua; ma fin da allora Cafarnao servì a Gesù come abituale dimora in Galilea, divenendo sua patria adottiva invece di Nazareth. Dalla sua famiglia egli già si era staccato, ed all’istituzione familiare aveva anche dedicato in omaggio il suo primo miracolo: adesso si staccava anche dall’umilissimo suo paese, trasferendosi in luogo più opportuno per la sua missione che cominciava. Cafarnao era sulla riva nord-occidentale del lago di Tiberiade non lontano dallo sbocco del Giordano nel lago. Situata a 13 chilometri a nord della città di Tiberiade e a circa 30 a oriente di Nazareth, era presso i confini fra il territorio di Erode Antipa e quello di Filippo; perciò era fornita anche d’un ufficio di dogana, ed era luogo di transito. Sul lago aveva un piccolo porto conveniente per i pescatori. La vita religiosa vi doveva essere intensa e non molto disturbata dall’ellenismo insediato poco sopra; suo presidio ivi era, come sempre, l’edificio della sinagoga oggi fortunatamente conservato e ritornato alla luce, sebbene nella precisa forma in cui è stato ritrovato sembri appartenere a tempi posteriori a quelli di Gesù. Il suo nome Kephar Nahūm, «villaggio di Nahum», proveniva da un personaggio Nahum a noi ignoto; in tempi molto posteriori si venerò ivi la tomba di un rabbino Tanhum, il cui nome fu poi deformato in Tell Hūm, che è l’odierno nome del luogo. A imitazione di Gesù, man mano verranno a stabilirsi a Cafarnao anche i suoi primi discepoli oriundi della vicina Bethsaida, quali Simone Pietro e Andrea. Quanto a Simone Pietro, è probabile che già avesse a Cafarnao legami di parentela; se egli, genero generoso, alberga ivi in casa sua la propria suocera (§ 300), non è arrischiato supporre che la moglie di lui fosse appunto di Cafarnao. Più tardi poi, per designare Cafarnao, si finirà per chiamarla senz’altro «la città propria» di Gesù (Matteo, 9, 1), sebbene lo stesso documento poco appresso designi Nazareth ancora come «la patria di lui» (Matteo, 13, 54). Il libro usato è «Vita di Gesù Cristo» - Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941, dell’Abate Giuseppe Ricciotti: riposi in pace! Fine.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, Vi abbiamo già comunicato tramite e-mail che l’Associazione Sursum Corda ha perfezionato il proprio organigramma in ottemperanza al nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679). Ci sembra opportuno informarVi per iscritto anche mediante il nostro Settimanale, ben sapendo che non tutti hanno una connessione ad internet o una particolare dimestichezza con i prodotti digitali. Nella nostra nuova e perfezionata politica sul trattamento dei dati (leggibile qui) esprimiamo chiaramente: 1) Fondamenti di liceità del trattamento; 2) Informative sulla trasparenza, anche sull’uso dei cookie, sulle interazioni con i social network e con tutti i terzi coinvolti per garantire la navigazione sempre agevole e la massima diffusione dei nostri contenuti; 3) Diritti degli interessati quali accesso, cancellazione-oblio, limitazione del trattamento, opposizione, portabilità dei dati; 4) Titolare e responsabile incaricato del trattamento; 5) Approccio basato sul rischio del trattamento e misure di accountability di titolare e responsabile (valutazione di impatto, registro dei trattamenti, misure di sicurezza finalizzate a tutelare i dati personali, nomina di RDP e DPO); 6) Eventuali trasferimenti internazionali di dati. Sursum Corda non effettua attività di profilazione, né cede i dati a terzi. DPO è il Presidente dell’Associazione che, negli ultimi giorni, ha frequentato due corsi specifici al fine di coniugare le competenze informatiche col nuovo Regolamento europeo, per garantire massima trasparenza, comunicazione agevole e sicurezza nella gestione dei dati degli utenti. Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Sursum Corda con sede in Pignola (PZ) alla C.da Piancardillo, snc. Anche il nostro sito è stato perfezionato per offrire agli iscritti la massima interattività nella gestione dei propri dati , dei cookie e per facilitare la comunicazione tempestiva sia col Titolare del trattamento che col DPO. DPO sta per Data Protection Officer ed è la persona che tecnicamente deve adottare tutte quelle misure finalizzate a rendere la protezione e la gestione dei dati ancora più sicura ed effettiva. Crediamo di aver fatto un ottimo lavoro per la sicurezza di tutti noi e per la buona causa della nostra Associazione. Fatta questa comunicazione dovuta di tipo tecnico e burocratico, veniamo all’argomento del giorno. L’Abate Ricciotti - pace all’anima sua! - ci parla di «Giovanni declinante e Gesù ascendente» e dei primi passi in Galilea.
• Giovanni declinante e Gesù ascendente. § 277. Nel frattempo Giovanni il Battista continuava il suo ministero, e tanto più continuavano a vigilarlo i potentati di Gerusalemme (§ 269). Ma, insomma, chi era quel solitario indipendente, né Fariseo né Sadduceo, né Zelota né romanofilo, né Esseno né Erodiano, che amministrava un battesimo non incluso nel cerimoniale giudaico e predicava un «cambiamento di mente» (§ 266) non contemplato dalla casuistica degli Scribi? Pazienza poi se fosse rimasto solitario nel suo deserto, tutt’al più con un gramo codazzo di discepoli appresso; costui invece si trascinava appresso le folle, e correvano a lui da Gerusalemme e dalla Giudea non meno che dalla lontana Galilea. Indubbiamente quell’uomo era una forza morale di prim’ordine, e coloro che in Gerusalemme tenevano in mano le briglie del giudaismo non potevano lasciarlo ancora sbrigliato. O con loro, o contro di loro. Dichiarasse una buona volta apertamente chi era e che cosa voleva! Per sapere questo si ricorse, naturalmente, a una commissione. Siccome poi lo scopo interessava più o meno tutti, così si scelse una commissione mista in cui entrarono sia sacerdoti e Leviti, cioè in maggioranza Sadducei, sia autentici Farisei, e tutti insieme da Gerusalemme si recarono a Bethania d’oltre il Giordano (§ 269), ove in quel tempo s’intratteneva Giovanni. La commissione si presenta, non come accusatrice, ma solo come investigatrice; essa rappresenta i maggiorenti e i benpensanti del giudaismo che hanno diritto di sapere, quindi domanda a Giovanni: Tu chi sei? (Giovanni, I, 19). Circa quattro secoli e mezzo prima, dai maggiorenti e benpensanti di Atene era stata rivolta l’identica domanda a Socrate: Tu, insomma, chi sei? (Arriano, Epitteto, III, 1, 22). Ma la domanda dei Gerosolimitani, pur nella sua imprecisione, mirava ad uno scopo ben preciso; poiché le grandi folle che accorrevano a Giovanni si chiedevano sempre più insistentemente se egli fosse il Messia, la commissione voleva investigare che cosa pensasse su ciò Giovanni stesso. Ma Giovanni confessò e non negò, e confessò: Io non sono il Cristo (Messia) (Giovanni, I, 20). Quelli replicarono: Sei Elia, che tutti aspettano come precursore del Messia? Sei il profeta, quello pari a Mosè che dovrà apparire ai tempi messianici? - A ogni domanda Giovanni risponde: No! - Ma dunque chi sei, insistono i commissari, perché dovremo pur riportare una risposta a Gerusalemme! - Io sono la voce di chi grida nel deserto: «Raddrizzate la via del Signore», come dice il profeta Isaia (Isaia, 40, 3). La risposta non soddisfece i commissari, specialmente i Farisei. Perciò questi replicarono: Ma allora, se tu non sei né il Cristo né Elia né il profeta, perché battezzi? - E allora Giovanni ripeté a loro l’annunzio già dato alle folle: egli battezzava in acqua ma in mezzo a loro stava uno ch’essi non conoscevano, che veniva dopo di lui, e del quale egli non era degno di sciogliere il legaccio dei calzari.
• § 278 Il giorno appresso a questo incontro, avendo finito la sua quadragesima, Gesù venne di nuovo a Giovanni presso il fiume. Giovanni lo scorse tra la folla e additandolo ai propri discepoli esclamò: Guarda! L’agnello d’Iddio, quello che toglie il peccato del mondo! Questi è colui del quale io dissi «Dopo di me viene un uomo che avanti a me è stato (promosso), perché prima di me era»; e dopo aver alluso all’apparizione avvenuta al battesimo di Gesù, concluse: E io ho veduto e ho attestato che questi è il figlio d’iddio (Giov., I, 29... 34). La metafora di Giovanni, che chiamava Gesù l’agnello d’iddio, faceva insieme tornare alla mente degli uditori giudei i veri agnelli che erano sacrificati nel Tempio di Gerusalemme ogni giorno, e soprattutto alla Pasqua: a qualche uditore più versato nelle Scritture poteva anche ricordare che, in esse, il futuro Messia era stato contemplato come un agnello portato a scannare per i delitti altrui (Isaia, 53, 7 e 4), e che pure altri profeti vi erano stati rassomigliati a quel mite animale destinato ordinariamente a vittima (Geremia, 11, 19) Il collegamento fra i due concetti di agnello-vittima e di figlio di Dio sarà sfuggito probabilmente a quasi tutti gli uditori, ma a Giovanni doveva stare molto a cuore, tanto che vi ritornò sopra il giorno appresso. Il giorno seguente (questa precisione cronologica è dell’accurato Evangelista non sinottico: Giov., 1, 35; cfr. § 163), mentre Giovanni s’intratteneva con due soli discepoli, vide nuovamente Gesù che passava lì presso, e additandolo esclamò ancora: Guarda! L’agnello d’Iddio! I due discepoli, colpiti dalla frase e dalla sua insistenza, discostatisi da Giovanni si misero a seguire Gesù che si allontanava. Scortili Gesù, domandò loro: Che cercate? - Quelli risposero: Rabbi, ove dimori? - E Gesù a loro: Venite e vedrete. - S’accompagnarono infatti con lui alla sua dimora, la quale, a causa della molta gente accorsa a Giovanni, poteva essere una di quelle capanne per guardiani di campi usate ancora oggi nella vallata di Gerico. Erano circa le quattro del pomeriggio. I due discepoli di Giovanni rimasero così dominati dalla potenza dello sconosciuto Rabbi, che s’intrattennero con lui il resto di quel giorno e certo anche la notte seguente. I due erano scesi giù dalla Galilea: uno era Andrea, fratello di Simone Pietro: l’altro è innominato, ma ciò basta in questa narrazione a farlo riconoscere come se fosse anch’egli nominato. È l’evangelista Giovanni, il testimone che può narrare questi fatti con tanta precisione di giorni e di ore; è l’adolescente neppur ventenne destinato a diventare il discepolo che Gesù amava (§ 155), e che in quel primo giorno in cui incontrò Gesù avrebbe potuto scrivere nel libro di sua vita, con veracità ben più alta che l’Alighieri il giorno che incontrò Beatrice, Incipit vita nova. Dopo quella prima permanenza con Gesù, il fervido Andrea volle accomunare nella propria letizia suo fratello Simone. Rintracciatolo, gli dice: Sai? Abbiamo trovato il Messia! - Lo accompagna quindi a Gesù. Gesù lo guarda, e poi gli dice: Tu sei Simone figlio di Giovanni; tu però ti chiamerai Kepha. In aramaico kepha significa «roccia», ma come nome personale non appare usato nell’Antico Testamento e neppure ai tempi di Gesù; a sentirsi rivolgere quelle inaspettate parole è molto probabile che Simone non ne capisse nulla, o tutt’al più giudicasse che l’ignoto Rabbi con la sua mente correva appresso a idee tutte sue personali (§ 397).
• In Galilea. § 279. Nel giorno ancora seguente, come ci dice l’Evangelista testimone dei fatti, Gesù volle ritornare in Galilea; il congiungimento spirituale fra la sua missione e quella del precursore era compiuto, e nulla più lo riteneva per ora in Giudea. Questo primo ritorno in Galilea non è ricordato dai Sinottici; i quali parlano soltanto del secondo ritorno, quello avvenuto dopo l’imprigionamento del precursore (§ 298). L’evangelista Giovanni, come al solito, supplisce alla loro omissione; non si trattiene però a descrivere il viaggio (mentre descriverà il viaggio del secondo ritorno omesso dagli altri; § 293), e passa a parlare di Gesù già tornato in Galilea. Ivi perciò avvennero i fatti successivi. Insieme con Gesù dovettero tornare in Galilea i tre discepoli ch’erano passati a lui dalla sequela del precursore, e ch’erano di Bethsaida sui confini della Galilea (§ 19), cioè i due fratelli Andrea e Simone Pietro e l’innominato Giovanni. Giunti lassù, i tre fervorosi non mancarono certamente di raccontare a familiari ed amici quanto sapevano sul conto di Gesù e di additarlo con entusiasmo in Bethsaida, che pare fosse la prima sosta dopo il viaggio. Fra queste accoglienze Gesù incontra uno del paese, certo Filippo, e gli dice: Viemmi appresso! - Non si trattava di una sequela di poche ore, ma abituale, e Filippo che già doveva essere entusiasmato dai racconti dei tre compaesani accettò con fervore. Anzi, a sua volta, cominciò a parlare ad altri dell’ammirato Rabbi; ma qui invece incontrò una gelida accoglienza. Trovatosi con un suo amico, Nathanael, gli confidò tutto vibrante di gioia: Sai? Abbiamo trovato colui di cui parlano Mosè e i Profeti! È Gesù figlio di Giuseppe, quello di: Nazareth! - Nathanael doveva essere un uomo molto calmo e posato; per di più era di Cana (Giovanni, 21, 2) vicina a Nazareth, e quindi conosceva bene la patria del decantato Rabbi. A sentire che costui veniva fuori da quel miserabile ammasso di tuguri, rispose spregiosamente: Da Nazareth ci può esser qualcosa di buono? (§ 228). La sfiduciante risposta non raffreddò il fervore di Filippo, che ricorse alle prove di fatto. Vieni e vedi! replicò egli; e Nathanael - come già Giulio Cesare - venne, vide, ma invece di vincere rimase vinto.
• § 280. Appena Gesù scorse il diffidente che si avvicinava esclamò: Guarda! Uno davvero Israelita, in cui non è inganno! (§ 251). La lode era certamente meritata, e una prova ne può essere la diffidenza stessa mostrata da Nathanael al primo annunzio ch’era stato trovato il Messia; fra tanti esaltati o ciarlatani che andavano in giro additando in sé o in altri il Messia, un Israelita sincero aveva ogni diritto di diffidare. Perciò l’Israelita richiese: Donde mi conosci? - Rispose Gesù e gli disse: Prima che Filippo ti chiamasse, mentre eri sotto il fico, ti vidi! (Giovanni, 1, 48). Era una vecchia tradizione in Palestina di avere vicino alla propria casetta un denso albero di fico, per passare sotto quell’ombra ore riposate e serene (cfr. I [III] Re, 4, 25; Michea, 4, 4; Zacharia, 3, 10); ai tempi di Gesù i rabbini vi s’intrattenevano volentieri per studiare indisturbati la Legge. Se dunque Gesù dice qui a Nathanael di averlo scorto sotto l’ombroso ritiro, non annunzia una scoperta materialmente straordinaria; ma la sorpresa dovette essere straordinaria spiritualmente, in quanto cioè i pensieri che Nathanael rivolgeva in mente là in quel suo ritiro dovevano avere qualche relazione con l’imminente incontro. Pensava egli forse al vero Messia, avendo udito le strane voci che correvano in paese a proposito di Gesù testé giunto? Domandava egli in cuor suo a Dio un «segno» in proposito, come lo aveva domandato Zacharia (§ 227)? Non siamo in grado di rispondere con precisione; tuttavia è chiaro che Nathanael trovò perfettamente vera la parola rivoltagli: Gesù l’aveva veramente visto nell’interno dei suoi pensieri, più che nella situazione della sua persona. Il retto Israelita rimase sgomento, e l’uomo calmo e posato fu invaso a un tratto da fervore: Rabbi, tu sei il figlio d’iddio! Tu sei re d’israele! Nathanael dunque concordava adesso con Filippo nel riconoscere Gesù come Messia. Era un generoso, ma forse anche troppo. Gesù infatti gli rispose: Perché ti dissi che ti vidi sotto il fico, credi? Cose maggiori di queste vedrai; volgendosi poi anche a Filippo e forse ad altri presenti continuò: in verità, in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli d’iddio ascendenti e discendenti sul figlio dell’uomo! L’allusione si riferisce al sogno di Giacobbe (Israele), che vide gli angeli ascendere e discendere lungo la misteriosa scala (Genesi, 28, 12); analoga a quella scala che collegava la terra col cielo, sarà la missione di Gesù della quale saranno testimoni quei suoi primi discepoli, discendenti da Giacobbe e davvero israeliti. Questo Nathanael non è mai nominato dai Sinottici, ma solo da Giovanni; al contrario i Sinottici nominano fra gli Apostoli un Bartolomeo, che non è mai nominato da Giovanni. È molto probabile che, come avveniva spesso a quei tempi, la stessa persona avesse i due nomi di Nathanael e di Bartolomeo, tanto più che nelle liste degli Apostoli Bartolomeo è nominato di solito insieme con Filippo, cioè proprio l’amico di Nathanael. Il libro usato è «Vita di Gesù Cristo» - Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941, dell’Abate Giuseppe Ricciotti. Fine.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, il giorno 18 maggio 2018 abbiamo donato ai carcerati di Potenza numero 10 copie del libro di Padre J. B. Lemius «Catechismo sul Modernismo». Ci siamo altresì impegnati nel consegnare, la prossima settimana, al cappellano del carcere una copia del «Catechismo di San Pio X» commentato dal Padre Dragone, prezioso volume utile alle istruzioni catechetiche di vero cattolicesimo. Nei giorni 12 e 13 maggio molti di noi hanno avuto la grazia - e la volontà - di partecipare al pellegrinaggio Osimo-Loreto 2018. È stato un momento di preghiera, di devozione e di formazione che reputiamo indispensabile, dunque ne consigliamo la partecipazione annuale a tutti gli Associati. Un’ultima comunicazione di servizio. Si avvicina il periodo di compilazione della dichiarazione dei redditi: è possibile destinare il 5x1000 a Sursum Corda inserendo nell’apposita casella il codice: 01944030764. Veniamo alla formazione. L’Abate Giuseppe Ricciotti - pace all’anima sua! - oggi ci parla di: «Deserto e tentazioni».
• § 271. Compiendo su di sé il rito del suo precursore, Gesù si ricollegava all’operosità di lui ed iniziava la propria. Ma ogni grande impresa è preceduta da una preparazione prossima, oltre a quella remota, e Gesù accettò anche questa comune norma e premise al suo ministero pubblico un periodo di preparazione. Il periodo durò quaranta giorni. Quaranta, infatti, è un numero tipico nell’Antico Testamento, e riferito a giorni o ad anni ricorre in molti casi biblici: i più analoghi al nostro sono quello di Mosè, che stette sul monte Sinai alla presenza di Jahvè 40 giorni e 40 notti: pane non mangiò e acqua non bevve (Esodo, 34, 28), e l’altro di Elia che dopo aver mangiato il cibo apportatogli dall’angelo camminò per la forza di quel cibo 40 giorni e 40 notti fino in Horeb, monte di Dio (I [III] Re, 19, 8). Di Gesù è narrato che, dopo il suo battesimo, fu condotto su nel deserto dallo Spirito per essere tentato dal diavolo; e avendo digiunato 40 giorni e 40 notti, dopo ebbe fame (Matteo, 4, 1-2). Non è da pensare che questo di Gesù fosse l’ordinario digiuno giudaico rinnovato per 40 giorni di seguito: il digiuno giudaico obbligava fino al tramonto del sole, ma al calare della sera si prendeva cibo (come ancora oggi presso i musulmani nel Ramadan), mentre il digiuno di Gesù è ininterrotto per 40 giorni e 40 notti, appunto come quelli di Mosè e di Elia. È evidente che il fatto è presentato come assolutamente soprannaturale. Inoltre, l’informatore dal quale la catechesi primitiva ha saputo il fatto non può essere stato altri che Gesù. In quei 40 giorni infatti egli rimase senza alcun testimonio; era con le fiere come dice Marco (1, 13), il quale riassume in poche parole questo periodo quadragesimale esposto più ampiamente dagli altri due Sinottici. Perciò la scarsezza di precisione, e soprattutto il carattere soprannaturale dei singoli episodi, rendono questa quadragesima arduissima a spiegarsi, molto più di altre pagine evangeliche su cui oggi tanto si discute; ma le pagine oggi tanto discusse passeranno certamente in seconda linea quando un certo spiritualismo - fosse anche non cristiano - avrà sostituito il greve positivismo imperante oggi sugli studiosi, al contrario la quadragesima del deserto rimarrà per qualunque tempo e per qualunque mentalità un libro chiuso di cui è dato leggere in tralice solo poche parole. Tuttavia il titolo del libro, ossia il suo contenuto generico, è ben leggibile; e fu esattamente decifrato appunto dalla catechesi primitiva, la quale ammoni: Non abbiamo un sommo sacerdote incapace di compatire alle infermità nostre, bensì uno tentato in tutte le cose a somiglianza (nostra), senza peccato (Ebrei, 4, 15; cfr. 2, 17-18). In altre parole per la catechesi primitiva il significato, generico ma genuino, della quadragesima nel deserto fu che Gesù permise di esser tentato per compiere la somiglianza con i suoi seguaci, esposti egualmente a tentazione, e per dare ad essi un esempio e un conforto nelle loro infermità: la quale interpretazione, oltre tutto il resto, corrisponde ad una ben fondata norma psicologica. Questo, il titolo del chiuso libro come fu letto dai primi diffusori della buona novella: la lettura dei suoi tre capitoli fu lasciata alle possibilità e all’abilità dei singoli.
• § 272. Il luogo ove Gesù passò questa quadragesima è, secondo una tradizione attestata nel secolo VII ma risalente forse al IV, il monte chiamato oggi dagli Arabi «della Quarantena» (Gebel Qarantal) e la cui cima ai tempi dei Maccabei era chiamata Dūq («osservatorio»); quella cima, su cui stava il fortilizio ove fu assassinato Simone, ultimo dei Maccabei, s’eleva circa 500 metri sulla vallata del Giordano, e tutto il monte chiude verso occidente questa vallata sovrastante a Gerico; il luogo è sempre stato più o meno deserto, e solo dal secolo V le grotte che s’aprono numerose lungo le pendici del monte servirono da stabile dimora a monaci bizantini. Se dunque Gesù fu battezzato nel Giordano circa all’altezza di Gerico - com’è probabile (§ 269) - il cammino dal luogo di battesimo a quello del ritiro fu di pochi chilometri. Quoties inter homines fui, minor homo redii, esclamerà a Roma alcuni anni più tardi un filosofo la cui pratica non s’accordava con la teoria. Gesù, alla vigilia di entrare fra gli uomini, sta lontano totalmente da essi per 40 giorni, quasi per fare ampia provvista di quella umanità di cui gli uomini erano privi e ch’egli avrebbe diffuso tra loro. Le condizioni straordinarie, anche fisicamente, in cui Gesù passò quei 40 giorni, sembrano potersi intravedere dalle parole dei due Evangelisti, secondo le quali egli ebbe fame dopo quei giorni (Matteo, 4, 2) ossia finiti che furono quelli (Luca, 4, 2). In precedenza, dunque, non sentì egli lo stimolo della fame? Passò egli forse la quadragesima in condizioni di estasi così alta ed astratta, che i procedimenti organici della vita fisica erano quasi sospesi? Sono domande, queste, a cui lo storico non ha elementi da rispondere, e lascerà liberamente il campo, più che al teologo, al mistico.
• § 273. Avvertita la fame dopo i 40 giorni, si presenta a lui il tentatore, chiamato soltanto Satana (§ 78) da Marco, soltanto diavolo da Luca, con ambedue i termini nella narrazione di Matteo. La riassuntiva narrazione di Marco non specifica le singole tentazioni, come del resto non fa alcun accenno neppure al digiuno; negli altri due Sinottici le tentazioni sono tre, ma enumerate secondo una serie differente: la serie seguita da Matteo sembra preferibile. Il tentatore gli disse: Se figlio sei d’Iddio, di’ che questi sassi diventino pani! - Ma egli rispondendo disse: Sta scritto «Non di pane solo vivrà l’uomo, ma d’ogni parola uscente per la bocca di Dio» (Matteo, 4, 3-4). Il passo citato sta in Deuteronomio, 8, 3, e la citazione è fatta da Matteo conforme al greco dei Settanta; ma Gesù citò certamente conforme all’originale ebraico, il quale suona «Non di pane solo vive l’uomo; ma di tutto ciò che esce dalla bocca di Jahvè vive l’uomo». Queste ultime parole si riferiscono alla manna, menzionata ivi poco prima, ch’era stata prodotta per ordine della bocca di Jahvè onde nutrire gli Ebrei nel deserto. Il tentatore aveva sfidato Gesù ad impiegare il potere taumaturgico, ch’egli aveva come figlio di Dio, per ottenere uno scopo raggiungibile con mezzi non taumaturgici; Gesù risponde che il pane necessario può essere ottenuto, oltreché per i soliti mezzi umani, anche per predisposizione divina come nel caso della manna, senza impiegare sconsideratamente poteri taumaturgici per istigazione altrui. La mira del tentatore, che aveva voluto esplorare se Gesù fosse ed avesse coscienza d’esser figlio di Dio, era fallita; la sua istigazione ad operare un miracolo superfluo era rimasta inefficace; la cura del sostentamento materiale, a cui il tentatore aveva subordinato il potere taumaturgico, era invece subordinata da Gesù alla provvidenza di Dio.
• § 274. La seconda tentazione, come anche la terza, si svolgono in una sfera tutta sovrumana. Allora il diavolo lo prende seco (conducendolo) nella santa città e lo collocò sopra il pinnacolo del tempio, e gli dice: Se figlio sei d’Iddio, gettati giù; sta scritto infatti «Agli angeli di lui darà ordine riguardo a te, e sulle mani ti solleveranno affinché mai tu urti contro un sasso il piede tuo». Disse a lui Gesù: Sta scritto pur anche «Non tenterai il Signore, il Dio tuo» (Matteo, 4, 5-7). La città santa, com’è chiamata ancor oggi dagli Arabi (el Quds), è Gerusalemme, nominata esplicitamente nel parallelo Luca; il pinnacolo del tempio - non del santuario - era l’angolo dove il «portico di Salomone» si congiungeva col «portico regio» (§ 48), che sovrastava altissimo alla valle del Cedron. Il diavolo invita dunque Gesù ad una prova messianica: se egli è il figlio di Dio, ne sarà una splendida dimostrazione davanti al popolo affollato negli atrii del Tempio quella di gettarsi nel vuoto, giacché gli angeli accorreranno a sostenere il lanciato Messia, si che tocchi terra dolcemente come foglia staccatasi da un albero e che cali cullata da un venticello. Sotto l’aspetto storico si riscontra che l’opinione del diavolo non era solitaria, bensì condivisa da molti Giudei contemporanei. Un ventennio più tardi, sotto il procuratore Antonio Felice (anni 52-60), i taumaturghi messianici pullularono come fungaia e ne fu uccisa dai Romani una gran moltitudine; così dice Flavio Giuseppe (Guerra giud., Il, 259 segg.), il quale ricorda in particolare che un falso profeta egiziano, raccolti migliaia di seguaci sul Monte degli Olivi, aveva promesso che di là sarebbe entrato nella sottostante Gerusalemme sbaragliando i Romani, certo in virtù di qualche strabiliante aiuto celestiale. In sostanza, l’egiziano seguiva il consiglio dato dal diavolo a Gesù, con la sola differenza che il gran giuoco di prestigio messianico sarebbe avvenuto nel lato orientale della valle del Cedron, invece che sul lato occidentale dov’era il pinnacolo del Tempio. Come aveva fatto Gesù nella tentazione precedente, anche il diavolo questa volta cita la Scrittura, cioè il Salmo 91 (ebr.), 11-12. Ma, come osserva ironicamente San Girolamo, il diavolo qui si dimostra cattivo esegeta, perché il Salmo promette la protezione divina a chi si comporti da pio ed osservante, non già a chi provochi arrogantemente Dio. La nuova citazione di Gesù, presa dal Deuteronomio, 6, 16, rettifica il contorcimento scritturistico del diavolo. In che maniera avvennero questa tentazione e quella seguente, in maniera reale ed oggettiva o soltanto in suggestione e visione soggettiva? Dal Medioevo si cominciò a credere che tutto avvenisse in visione, perché si giudicò indegno del Cristo che fosse trasportato dal diavolo qua o là e rimanesse anche limitatamente in potere di lui. Gli antichi Padri, tuttavia, non trovarono in ciò alcuna difficoltà, e interpretarono comunemente i fatti come reali ed oggettivi. Con i Padri, inoltre, sembra che abbia pensato anche Luca, allorché chiudendo il racconto di tutte e tre le tentazioni accenna velatamente ai fatti della passione di Gesù come a nuovi assalti del diavolo (§ 276): e la passione fu costituita indubbiamente da fatti reali ed oggettivi.
• § 275. Nuovamente il diavolo lo prende seco (conducendolo) in un monte elevato assai, e gli mostra tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: Queste cose ti darò tutte quante, se caduto (ai miei piedi) mi adori! - Allora gli dice Gesù: Vattene, Satana! Sta scritto infatti «(Il) Signore il Dio tuo adorerai, e a lui solo renderai culto» (Matteo, 4, 8-10). A questa relazione Luca (4, 5-8) aggiunge alcuni particolari: cioè, che la visione di tutti i regni del mondo avvenne in un punto di tempo o come diremmo noi «in un batter d’occhio»; inoltre, che il diavolo mostrando la possanza dei regni e la loro gloria dichiarò perché a me è stata concessa e a chi voglio la do. In quest’ultima dichiarazione il padre della menzogna mentiva forse meno dell’ordinario; ad ogni modo il millantato credito era evidente, poiché nella sacra Scrittura era stato affermato molte volte che tutti i regni della terra appartenevano, non già al diavolo, ma a Jahvè Dio d’Israele (Isaia, 37, 16; II Cronache, 20, 6; ecc.) e insieme al suo Messia (Daniele, 2, 44; Salmo 72 ebr., 8-11; ecc.). È notevole però che in questa terza tentazione, narrata come seconda da Luca, il diavolo non ripete la proposizione condizionale di sfida se figlio sei d’iddio, con cui aveva cominciato le altre due volte; si era egli forse convinto del contrario, ovvero in quest’ultimo e più violento assalto giudicò inutile quella formula dubitativa? Non ne sappiamo nulla, come nulla sappiamo del monte elevato assai su cui avvenne la visione dei regni e che da Luca non è neppur ricordato; pensare al Tabor o al Nebo, come fecero alcuni commentatori del passato, è da inesperti della Palestina perché quei due monti sono d’altezza modesta - il Tabor di 562 metri sul Mediterraneo, e il Nebo di 835 metri - e chi è salito su quelle due cime sa benissimo che il panorama non s’estende neppure a tutta la Palestina; ma anche se fosse stato il Monte Bianco o un altro anche più elevato non si sarebbero certamente scorti tutti i regni del mondo per visione naturale. Fu dunque una visione, avvenuta sì in cima all’ignoto monte, ma ottenuta con mezzi preternaturali a noi ignoti. Al tentato, il diavolo richiede l’omaggio che si usava con i monarchi della terra e col Dio del cielo, quello di prostrarsi a terra adorando: è l’atto di chi si ritiene moralmente più basso dell’adorato, e ne accetta la superiorità su di sé. Alla proposta Gesù risponde citando la Scrittura, cioè Deuteronomio, 6, 13, che giace nel contesto da cui è tolta la prima parte dello Shema (§ 66); tuttavia il passo citato suona nell’originale ebraico alquanto diversamente da come è allegato nei due Sinottici, cioè Jahvè Dio tuo temerai, e lui servirai, sebbene il senso dell’allegazione evangelica sia implicito nell’originale ebraico.
• § 276. Tutte e tre le tentazioni mostrano una chiara relazione con l’ufficio messianico di Gesù, al quale contrastano. La prima lo vorrebbe indurre ad un messianismo comodo ed agiato; la seconda, ad un messianismo raccomandato a vuote esibizioni taumaturgiche; la terza, ad un messianismo che si esaurisca nella gloria politica. Come Gesù ha superato adesso queste tre tentazioni, così nella sua operosità successiva continuerà a contraddire ai principii su cui esse si fondano. Dopo la terza tentazione Matteo aggiunge che il diavolo, quasi per eseguire il comando di Gesù «Vattene, Satana!», effettivamente si partì da lui, ed ecco che gli angeli si fecero dappresso e ministravano a lui (Matteo, 4, 11). Luca non accenna agli angeli, ma offre una particolarità riguardo alla partenza del diavolo, il quale si allontanò da Lui fino a tempo (opportuno) (Luca, 4, 13). Non c’è da ingannarsi su questo tempo (opportuno): è la futura passione di Gesù, allorché egli esclamerà rivolto alla turba di Giuda questa è l’ora vostra e la potestà della tenebra (Luca, 22, 53), e allorché Satana entrerà nell’interno di Giuda (ivi, 3) e vaglierà gli Apostoli come grano (ivi, 31). In quell’occasione Gesù dirà agli Apostoli di pregare per non entrare in tentazione (ivi, 40), ed egli stesso, entrato nella suprema angoscia, pregherà più intensamente (ivi, 44); ora appunto in quell’occasione Luca, che non ha ricordato gli angeli ministranti a lui dopo le tre tentazioni, parlerà dell’angelo disceso dal cielo per confortarlo (ivi, 43). La passione dunque, nel pensiero di Luca, fu il tempo (opportuno) riservatosi da Satana per muovere il più violento e l’ultimo assalto. Il libro usato è «Vita di Gesù Cristo» - Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941, dell’Abate Giuseppe Ricciotti. Fine.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, le seguenti preghiere che oggi abbiamo pubblicato e condiviso sono del compianto dom Prosper Guéranger: - Preghiera a San Gregorio di Nazianzo; - Preghiera a San Stanislao, Vescovo e Martire; - Preghiera a San Giovanni alla Porta Latina. Preghiamo per l’anima di questo grande, indimenticabile e prezioso liturgista. Il Ricciotti finalmente inizia a parlarci della vita pubblica di Gesù. Oggi studieremo: «Giovanni il Battista e il Battesimo di Gesù». Il libro che andiamo ad usare è «Vita di Gesù Cristo» - Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941, dell’Abate Giuseppe Ricciotti: riposi in pace!
• § 265. La narrazione di Luca è stata fin qui ripartita parallelamente fra Giovanni il Battista e Gesù; l’Evangelista ha terminato lasciandoli ambedue ragazzi, l’uno nel deserto e l’altro a Nazareth, e si è congedato da loro col dire sia dell’uno che dell’altro che crescevano e s’afforzavano (§ § 237, 260). Trascorso questo trentennio di penombra, Giovanni compare in pubblico e poco dopo gli tiene dietro Gesù, quasi per riprodurre la breve distanza di tempo che ha separato le loro nascite; precursore o battistrada è stato preannunziato Giovanni, e tale deve egli essere molto più per l’operosità pubblica che per la silenziosa nascita. Con la comparsa di Giovanni cominciava l’argomento ordinario della primitiva catechesi cristiana (§ 113); perciò in questo nuovo periodo della narrazione s’affiancano a Luca tutti gli altri Evangelisti, compresi il brevissimo Marco e il non sinottico Giovanni. Nella sua lunga permanenza in luoghi deserti Giovanni aveva menato vita solitaria ed austera; se egli comparve in pubblico vestito di peli di cammello con una cintura di pelle intorno ai suoi fianchi, e mangiando locuste e miele selvatico (Marco, 1, 6), questo tenore di vita era certamente quello da lui già seguito nei suoi lunghi anni di solitudine. Del resto, cibo e vestito di quel genere erano abituali a chi menava allora vita eremitica per un principio ascetico, come ancora oggi i beduini palestinesi intessono ordinariamente i loro mantelli di peli di cammello e in mancanza di meglio mangiano locuste, mettendole talvolta anche in serbo dopo averle seccate. Circa 25 anni dopo la comparsa di Giovanni, Flavio Giuseppe per un ideale ascetico rimase tre anni presso un solitario di nome Bano o Banno, il quale viveva nel deserto, servendosi di vestimento (fornito) da alberi e nutrendosi di cibarie nate spontaneamente (Vita, 11). Eremiti di questo genere non dovevano essere molto rari, specialmente nella solitudine ad oriente di Gerusalemme e lungo il Giordano; nulla tuttavia c’induce a ritenere che fossero affiliati agli Esseni, ché anzi la vita cenobitica ch’era di prescrizione per gli Esseni (§ 44) escluderebbe di per se stessa la vita eremitica di questi solitari. Quando giunse l’anno decimoquinto di Tiberio (§175), la parola di Dio fu su Giovanni figlio di Zacharia nel deserto (Luca, 3, 2). Comincia la sua missione di preparare la strada all’imminente Messia, ed egli inizia questa missione proclamando: Pentitevi, poiché si e’ avvicinato il regno dei cieli! (Marco, 3, 2). Dopo questo annunzio generico, egli scende al particolare: in primo luogo esige da coloro che accorrono a lui due riti, cioè una lavanda materiale e inoltre l’aperta confessione dei peccati commessi; in secondo luogo, scorgendo fra coloro che accorrono molti Farisei e Sadducei, li accoglie con queste parole: Razza di vipere! Chi vi ha insegnato a sfuggire all’ira imminente? Fate, dunque, frutto degno della penitenza! E non crediate di dire dentro di voi:”Per padre abbiamo Abramo”; giacché vi dico che iddio può da queste pietre suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi: dunque, ogni albero che non fa frutto è tagliato via e gettato nel fuoco (Matteo, 3, 7-10).
• § 266. Predicatori di tipo messianico ce ne furono molti, prima e dopo Giovanni, ma tutti d’altra indole. Subito dopo la morte di Erode il Grande si erano fatti avanti dapprima in Perea un Simone, che aveva dato fuoco alla reggia di Gerico e si era proclamato re; poi in Giudea un pastore di nome Athronges, che aveva impiantato un regolare governo; quindi in Galilea un Giuda figlio d’Ezechia, che si era impadronito per prima cosa del deposito d’armi a Sefforis; in seguito venne Giuda il Galileo, che iniziò la corrente degli Zeloti (§ 43); più tardi ancora vennero Teuda, e il predicatore egiziano, e gli altri accennati da Flavio Giuseppe, e certamente anche altri più numerosi sebbene non menzionati distintamente. Ma costoro seguivano altri metodi: tutti indistintamente affermavano che i figli d’Abramo erano il primo popolo della terra, e per assicurare loro l’effettiva supremazia politica mettevano mano alle armi; molti si presentavano come re effettivi; altri asserivano di far miracoli, o almeno li promettevano; qualcuno faceva man bassa sulle proprietà altrui ed esponeva la vita altrui, ben di rado la propria: assolutamente nessuno pensava a rendere i suoi seguaci moralmente migliori. Giovanni batteva la strada precisamente opposta. Affermava che figli d’Abramo potevano saltare su anche dalle pietre; non prometteva dominii e supremazie; non toccava né invocava armi; non s’occupava di politica; non faceva miracoli; era povero e nudo: ma in compenso tutta la sua predicazione si riassumeva in un ammonimento morale: È imminente il regno di Dio, perciò cambiate maniera di pensare! Infatti, la prima parola del suo proclama, Pentitevi!... significava appunto questo: Cambiate maniera di pensare! In greco è cambiate di mente; in ebraico si usava il verbo shub, che significa ritornare addietro da una falsa strada per rimettersi su quella buona: ma in ambedue le lingue il significato concettuale è il medesimo, quello di operare una trasformazione totale nell’interno dell’uomo. Ora, poiché un profondo sentimento interno si manifesta spontaneamente anche all’esterno, e un atto materiale esterno può essere una raffigurazione dimostrativa dell’atto spirituale interno: perciò Giovanni, a coloro che «cambiavano maniera di pensare», richiedeva come manifestazione esterna di questo cambiamento che confessassero i peccati commessi, e come raffigurazione dimostrativa che ricevessero una lavanda materiale.
• § 267. Già in altre religioni antiche il pubblico riconoscimento delle proprie colpe e l’abluzione corporale facevano parte di riti speciali, per la semplice ragione che il primo corrisponde ad una naturale inclinazione dell’animo umano allorché comprenda d’aver agito male, e la seconda è il simbolo più spontaneo e più facile della mondezza spirituale. Lo stesso giudaismo praticava i due riti in varie occasioni: ad esempio, nel giorno dell’Espiazione o Kippur (§77), il sommo sacerdote li praticava ambedue insieme, giacché confessava le colpe di tutto il popolo (Levitico, 16, 21) e compiva su di sé una particolare abluzione (IVI, 16, 24). Giovanni, dunque, non usciva dal gran quadro del giudaismo; ma la sua novità consisteva in questo, che i suoi due riti erano chiesti come preparazione al regno di Dio da lui annunziato ormai come imminente. Era dunque un regno che mirava soprattutto allo spirito come appunto vi miravano quei due riti, e un regno che differiva totalmente da quelli annunziati dagli altri predicatori messianici. Costoro badavano soltanto a denaro, ad armi, ad angeli che calassero dal cielo con le spade in pugno a sbaragliare i Romani, a dominio politico d’Israele sui pagani, e a simili cose molto facili e molto vecchie; al contrario, il regno annunziato da Giovanni era molto difficile e molto nuovo. Se non era del tutto nuovo l’insegnamento di Giovanni, ciò avveniva perché esso si ricollegava direttamente con l’antico insegnamento degli autentici profeti d’Israele; già essi avevano insistito molto più sulle opere di giustizia che sulle cerimonie liturgiche (Isaia, 1, 11 segg.), molto più sulla circoncisione del cuore e dell’udito che su quella della carne (Geremia, 4, 4; 6, 10), inoltrandosi molto più sulla strada dello spirito che su quella delle formalità rituali: e precisamente su quella strada dello spirito, troppo abbandonata dal giudaismo contemporaneo, adesso s’inoltrava nuovamente Giovanni. Gli antichi vessilli d’Israele, i profeti, erano scomparsi da molto tempo; già da qualche secolo era risonato il lamento: I nostri vessilli più non vediamo; non c’è più profeta, non c’è fra noi chi sappia alcunché (Salmo 74 ebr., 9). Adesso si levava su Giovanni, come ultimo e conclusivo profeta. Dirà infatti più tardi Gesù: La legge e i Profeti, fino a Giovanni; da allora del regno d’Iddio si dà la buona novella (Luca, 16, 16).
• § 268. Alla predicazione di Giovanni accorsero moltissimi dalla Giudea e da Gerusalemme; anche Flavio Giuseppe conferma la grande autorità ch’egli acquistò sulle folle (Antichità giud., XVIII, 116-119). I suoi discepoli diretti e stabili menavano vita assai austera (Luca, 5, 33), ma verso l’altra gente che accorreva egli si mostrava molto condiscendente e remissivo: né ai pubblicani né ai soldati imponeva d’abbandonare il loro mestiere, ma si limitava a comandare ai primi di non commettere estorsioni e ai secondi di non commettere violenze. Questo atteggiamento così mite d’un uomo così austero spiacque a quei Farisei e Sadducei che accorsero insieme con la folla, e che perciò s’attirarono da Giovanni la non mite invettiva riportata sopra (§ 265); ma alla loro volta essi, specialmente i Farisei e gli Scribi, si vendicarono più tardi richiamando in dubbio o negando apertamente la legittimità della missione di Giovanni (Luca, 7, 29-30; cfr. 20, 1-8). Nonostante questi ostacoli, la corrente iniziata da Giovanni fu potentissima. Molti discepoli di Giovanni seguirono più tardi Gesù, e di costoro conosciamo nominatamente Andrea e Pietro, Giacomo e Giovanni; altri invece rimasero attaccati alla persona del precursore, più che allo spirito del suo insegnamento, e si mantennero appartati sulla soglia del cristianesimo anche dopo la morte di Giovanni e di Gesù (cfr. Atti, 18, 25; 19, 3-4): non mancarono poi manifestazioni di gelosia da parte di taluni discepoli di Giovanni verso Gesù, mentre ambedue erano ancora in vita (Giovanni, 3, 26).
• § 269. Giovanni s’intratteneva per lo più lungo il Giordano, in quel tratto di fiume ch’è più accessibile a chi venga da Gerusalemme, cioè poco sopra al suo sbocco nel Mar Morto ivi era comodità di praticare la cerimonia dell’abluzione nell’acqua del fiume. Tuttavia alcune volte si trasferiva altrove, probabilmente quando per abbondanti piogge le rive del fiume erano sdrucciolevoli e fangose o la corrente era pericolosa; sceglieva allora altri luoghi forniti d’acqua, di cui sono nominati occasionalmente due, Bethania di là dal Giordano che era appunto un’ampia e tranquilla insenatura fatta dal fiume (§ 162), e Ainon presso Salim che è stato riconosciuto in un luogo 12 chilometri a sud di Beisan (Scitopoli) fin dal IV secolo (Eusebio, Onomasticon, pag. 40). Frattanto le folle che accorrevano a Giovanni crescevano, e tra loro aveva anche cominciato a circolare la domanda se non fosse proprio egli il Messia tanto atteso: la profonda differenza morale tra lui e gli altri banditori del regno messianico aveva impressionato tutti. Ma Giovanni tagliò corto a quella dubbiosa speranza con una dichiarazione ben netta e precisa. No, egli non era il grande venturo; egli praticava l’immersione - il greco «battesimo» - soltanto in acqua, ma dietro a lui sarebbe venuto uno ben più potente di lui che avrebbe praticato l’immersione in Spirito santo e fuoco. Questo venturo sarebbe stato anche un vagliatore: col ventilabro alla mano avrebbe egli mondato la sua aia, separando e raccogliendo il grano nel suo granaio, e gettando invece la pula nel fuoco. Parole rivoluzionarie, queste, all’orecchio degli Scribi e dei Farisei. L’aia, evidentemente, era l’eletta nazione d’Israele; ma chi era il grano e chi la pula? Se il buon grano erano i discepoli dei rabbini osservanti delle «tradizioni» e la pula erano tutti gli altri, s’andava d’accordo con Giovanni; ma quel singolare predicatore dava ben poche garanzie di pensare così, non foss’altro per la benignità stessa con cui trattava i pubblicani e i soldati, che invece dovevano essere respinti come appartenenti al sozzo e impuro «popolo della terra» (§ 40). Basta: non rimaneva che aspettare quel grande venturo preannunziato da Giovanni, e frattanto vigilare su questo suo precursore.
• § 270. Un giorno, insieme con la folla, si presentò anche Gesù; veniva da Nazareth, certamente insieme con altri Galilei perché anche in Galilea si doveva esser diffusa la fama di Giovanni e l’entusiasmo per lui. Era mescolato fra gli altri penitenti, uno fra i tanti: nessuno lo conosceva, neppure Giovanni suo parente. Più tardi, riferendosi a questo giorno del primo incontro, Giovanni attestò di Gesù: Io non lo conoscevo; ma Chi m’inviò a battezzare in acqua, Colui mi disse:”Su chi tu veda lo Spirito discendente e fermantesi su lui, egli è il battezzante in Spirito santo” (Giovanni, 1, 33). Questa ignoranza per la persona di Gesù non sorprenderà chi abbia presenti le vicende di Giovanni: già da ragazzo egli si era allontanato dalla casa paterna per darsi al deserto (§ 237), e nulla ci dice ch’egli sia rientrato talvolta tra i suoi familiari nel ventennio circa di sua solitudine. Nel frattempo i suoi già vecchi genitori dovevano esser morti ambedue, ma ambedue e specialmente la madre gli erano spiritualrnente presenti anche nella solitudine. Per qual ragione, del resto, si era egli ritirato nel deserto, se non per le straordinarie cose che gli avevano narrato della sua nascita i genitori e specialmente la madre? Egli era un uomo che aveva avuto fede, e viveva totalmente della sua fede. Perciò anche non si era curato di conoscere materialmente quel misterioso figlio di Maria nato sei mesi dopo di lui; lo conosceva frattanto spiritualmente, e per il resto aveva fede che a suo tempo Iddio glielo avrebbe fatto conoscere anche materialmente. Ma un certo presentimento l’aveva; quando scorse Gesù tra la folla che si preparava al battesimo, la voce dello Spirito e anche quella del sangue gli fecero divinare, in quell’uno fra i tanti, il Messia e il suo parente, sebbene ancora non avesse visto su lui il segno prestabilito (Matteo, 3, 14-15). Vinta la prudente riluttanza di Giovanni, Gesù fu da lui battezzato, e allora la divinazione si tramutò in certezza. Avvenne infatti il segno di riconoscimento. Gesù in apparenza di penitente, ma senza confessare alcun peccato, era sceso in acqua: ed ecco che quando ne risalì, s’aprì il cielo al di sopra, lo Spirito in forma di colomba discese su lui e si udì dall’alto una voce: Tu sei il figlio mio diletto; in te mi compiacqui (Marco, 1, 11). La manifestazione celeste fa ripensare all’altra sulla grotta di Bethlehem (§ 247): il Messia là iniziava la sua vita fisica, qua il suo ministero; là è dato un annunzio a pecorai, qua è dato un segno al precursore innocente e un annunzio a peccatori pentiti. Ma, come avvenne per l’annunzio di Beth-lehem, anche questo delle rive del Giordano ebbe un’efficacia assai limitata quanto al tempo e quanto al numero dei destinatari. Pochi mesi appresso, due discepoli di Giovanni verranno inviati dal loro stesso maestro a domandare a Gesù se egli era proprio l’atteso Messia (§ 339). Fine.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, dopo aver dimorato in Egitto, finalmente la Sacra Famiglia si reca a Nazareth. Il libro che andiamo ad usare è «Vita di Gesù Cristo» - Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941, dell’Abate Giuseppe Ricciotti: riposi in pace!
• § 259. Rientrato che fu in Palestina, Giuseppe apprese che Archelao figlio di Erode (detto il Grande, ndR) era al governo della Giudea, e perciò di Gerusalemme e di Beth-lehem: ciò l’indusse a non far più ritorno alla precedente dimora, per la pessima fama che aveva il nuovo monarca (§ 14), rinunziando così al progetto - se realmente era stato fatto (§ 241) - di stabilirsi a Beth-lehem, luogo originario del casato di David. Nella sua perplessità egli ricevette un’altra rivelazione onirica, in conseguenza della quale ritornò a Nazareth, ove non governava Archelao ma Antipa (§§ 13, 15). Matteo chiude la narrazione dicendo che l’insediamento a Nazareth avvenne affinché s’adempisse il detto per mezzo dei profeti «Nazoreo sarà chiamato» (2, 23). Queste precise parole non si ritrovano in nessuno scritto profetico della Bibbia odierna: supporre che ne riportino qualche tratto che sia andato perduto più tardi, è un’ipotesi arbitraria, come sarebbe contro ogni verosimiglianza supporre che provengano da qualche sconosciuto Apocrifo. Molto più fondata è l’opinione di San Girolamo, benché soltanto negativa, il quale fa notare che Matteo citando i «profeti» al plurale, mostra d’aver preso dalle Scritture non le parole ma il senso; Matteo, cioè, non intenderebbe allegare un determinato passo bensì un concetto, né si riferisce a precise parole bensì ad un pensiero. Troviamo, difatti, che simili citazioni concettuali erano già state impiegate nell’Antico Testamento, come saranno ancora usate dai rabbini successivi. Ma qual è il senso o concetto a cui si riferisce Matteo? La questione non ha ancora ricevuto una risposta sicura, e si riconnette in parte con la questione filologica della doppia forma Nazoreo e Nazareno. Ma, comunque si risolva la questione filologica, nel nostro caso si poté alludere a un determinato concetto anche soltanto mediante una somiglianza o assonanza verbale, come egualmente si era già fatto nell’Antico Testamento soprattutto per nomi di persona o di luogo. Ammessa questa elasticità di relazione, si presenta come possibile più d’una allusione. In primo luogo quella a Isaia, 11, 1, ove del futuro Messia si dice: «Uscirà un virgulto dal tronco di Isai (Jesse, padre di David) e un germoglio dalle sue radici fiorirà»; poiché germoglio è in ebraico neser, Matteo vi può aver visto un richiamo verbale al nome di Nazareth (§ 228), tanto più che anche la tradizione rabbinica riferiva al futuro Messia il passo di Isaia. Può darsi anche, almeno in maniera concomitante e secondaria, si sia pensato allo stato del nazir, cioè di colui che era «nazireo» per consacrazione della sua persona a Dio; è vero che in ebraico nazir è scritto con una lettera differente (N Z R) da quelle del nome di Nazareth (N S R), ma per questi riavvicinamenti onomastico-simbolici bastava una certa corrispondenza empirica o assonanza, come era bastata in casi simili dell’Antico Testamento (Genesi, 11, 9; 17, 5; Esodo, 2, 10): e forse più distintamente si è visto un simbolo prefigurativo del Messia in Sansone, salvatore del suo popolo e chiamato «nazir» di Dio fin dalla sua fanciullezza, come si legge nel libro dei Giudici, 13, 5, che appartiene appunto ai «profeti anteriori» della Bibbia ebraica. [Stiamo adattando alcuni caratteri ed omettendo le lunghe note, ndR]. Quale di queste possibilità, e di molte altre proposte dagli studiosi antichi e moderni, corrisponda alla realtà non è dato di sapere.
• § 260. Quando Giuseppe venne di nuovo a stabilirsi a Nazareth, cioè nell’anno 750 di Roma inoltrato, il bambino Gesù aveva circa due anni di età (§ 173). Da questo tempo fino all’inizio della sua vita pubblica (§ 175) corrono più di 30 anni, che costituiscono la sua vita nascosta. Di così lungo periodo non ci sono comunicate notizie, salvo due, di cui una riguarda un fatto permanente e l’altra un episodio solitario. Ambedue le notizie, com’era da aspettarsi, sono comunicate da Luca, lo storico che attinge le sue informazioni dai ricordi personali della Madre di Gesù. In primo luogo l’evangelista medico, dimostrando quasi un occhio clinico spirituale, afferma una prima volta che, giunti i tre a Nazareth, «il bambino cresceva e s’afforzava pieno di sapienza, e grazia di Dio era su lui» (Luca, 2, 40); poco dopo, come per far notare che questo era un fatto permanente, ripete una seconda volta che, all’età di 12 anni, «Gesù progrediva nella sapienza e statura e grazia presso Dio ed uomini» (2, 52). C’era dunque in Gesù uno sviluppo ed un accrescimento, e non soltanto esteriore davanti agli uomini, ma anche interiore davanti a Dio. Come egli cresceva fisicamente e si sviluppavano le sue facoltà sensitive e intellettive, così crescevano le sue cognizioni sperimentali, ed egli man mano diventava fanciullo, ragazzo, giovane, uomo maturo, fisicamente ed intellettualmente. Gli antichi Doceti negarono la realtà di questo sviluppo e lo considerarono solo apparente e fittizio, perché sembrava loro incompatibile con la divinità del Cristo; ma appunto San Cirillo d’Alessandria, l’implacabile avversario di Nestorio e strenuo assertore dell’unità di Cristo (Quod unus sit Christus, in Migne, Patr. Gr., 75, 1332), sostiene che in Gesù le leggi della natura umana conservarono tutto il loro valore, compresa quella dello sviluppo progressivo fisico ed intellettuale.
• § 261. L’altra notizia comunicata da Luca è l’episodio dello smarrimento e ritrovamento di Gesù a Gerusalemme. I genitori di Gesù - così li chiama semplicemente Luca (2, 41), - si recavano ogni anno a Gerusalemme in occasione della Pasqua, come faceva ogni buon Israelita per questa principale tra le «feste di pellegrinaggio» (§ 74). Secondo le prescrizioni legali Maria, come donna, non era obbligata a questo viaggio, e neppure Gesù prima del suoi 30 anni; tuttavia molte donne accompagnavano spontaneamente i loro mariti, e quanto ai figli i padri più osservanti li conducevano seco anche prima dei 13 anni: i rabbini della scuola di Shammai esigevano che si portasse al Tempio il bambino che potesse reggersi a cavalcioni sulla spalla del padre, mentre quelli della scuola di Hillel restringevano l’obbligo al bambino che potesse salire i gradini del Tempio sorretto dalla mano del padre. Ad ogni modo, a cavalcioni o a piedi, molti bambini e moltissimi ragazzi facevano il pellegrinaggio della Pasqua, accrescendo sempre più la fiumana di gente che vi accorreva (§ 74). Certamente Gesù vi fu condotto anche nella sua fanciullezza, ma quando vi andò che aveva 12 anni avvenne l’episodio narrato da Luca. Il pellegrinaggio, se muoveva da luoghi piuttosto lontani come Nazareth, si compieva a gruppi di parenti ed amici, formando piccole carovane che viaggiavano e pernottavano insieme nelle soste lungo il cammino. Da Nazareth a Gerusalemme le soste di pernottamento dovevano essere tre (o quattro), perché la strada s’aggirava sui 120 chilometri (oggi 140); a Gerusalemme si giungeva uno o due giorni prima del 14 Nisan (§ 74) e si rimaneva o fino a tutto il 15 o anche per l’intera ottava, cioè fino a tutto il 21 con cui terminavano le solennità pasquali. Quell’anno, quando si fu alla partenza di ritorno, il ragazzo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Non vedendolo presso di sé, i due non avevano motivo di sospettare che fosse rimasto in città. La carovana in Oriente ha una disciplina singolare, non militaresca, non rigida, per cui ognuno s’attiene genericamente ai tempi di partenza e d’arrivo, e per il resto rimane libero di sé; lungo il cammino la comitiva si divide e suddivide in tanti gruppi che procedono a una certa distanza fra loro, che si accrescono od assottigliano a beneplacito dei viandanti, e solo alla sera, giunti alla sosta di pernottamento, tutti si ritrovano insieme. Un qualsiasi ragazzo di 12 anni, ch’era quasi sui iuris presso i Giudei, partecipava a siffatta elasticità di disciplina carovaniera al pari e anche più d’un uomo maturo, perché, mentre sapeva benissimo come regolarsi, aveva anche in suo favore la vivacità dell’età sua. Cosicché, lungo la prima giornata di cammino, i genitori credettero che Gesù si fosse unito a qualche gruppo della carovana diverso dal loro; ma quando si giunse alla prima sosta di pernottamento, cercatolo invano nei vari gruppi riuniti insieme, s’avvidero che mancava.
• § 262. Affannati, i due fecero ritorno a Gerusalemme, e la giornata seguente allo smarrimento fu da essi consumata parte nel viaggio e parte nelle prime ricerche in città. Ma le ricerche rimasero vane, e perciò furono proseguite nel terzo giorno; allora «lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori e ascoltandoli e interrogandoli; stupefatti erano tutti che l’ascoltavano, per l’intelligenza e le risposte di lui. E vedendolo (i genitori) furono colpiti, e gli disse sua madre: “Figlio, perché facesti a noi così? Ecco, tuo padre ed io addolorati ti cercavamo!”. E disse loro: “Perché mi cercavate? Non sapevate che nella (casa) del Padre mio è necessario ch’io sia?”. Ed essi non capirono la parola che pronunziò loro» (Luca, 2, 46-50). Alla fine di quello stesso secolo Flavio Giuseppe, scrivendo la sua biografia (Vita, 9), racconterà che quando egli aveva 14 anni, cioè verso il 52 dopo Cr., era già famoso in Gerusalemme per la sua perizia nella Legge, e che i sommi sacerdoti ed altre insigni persone della città si radunavano abitualmente in casa sua per consultarlo su questioni difficili. Chi narra questo fatto risulta un millantatore e un blagueur [gradasso, fanfarone, smargiasso, spaccone, ndR] da molti luoghi dei suoi scritti, e quindi con pieno diritto si potrà negare fede a ciò che egli qui racconta: tuttavia un piccolo nocciolo di verità ci può essere, in quanto cioè, essendo egli d’ingegno svegliato, avrà per caso sostenuto una volta tanto una specie di disputa con alcuni Dottori della Legge riunitisi per altre ragioni a casa sua. I rabbini infatti accettavano nelle loro scuole fanciulletti già di sei anni: «da sei anni in su noi accettiamo (il bambino, e per mezzo della Legge) lo ingrassiamo come un bove» (Baba bathra, 21 a); e naturalmente con i bambini o ragazzi che apparivano più perspicaci e intelligenti essi erano più premurosi, non disdegnando d’entrare in discussioni con loro come da pari a pari. Ma la scena di Luca è tutta diversa da quella di Flavio Giuseppe. Gesù è nel Tempio, in uno dei suoi atrii dove abitualmente s’adunavano i Dottori a discutere (§ 48); egli non detta sentenze come il futuro liberto di Vespasiano, bensì si uniforma al metodo accademico dei rabbini che consisteva in ascoltare, rivolgere domande di schiarimento e procedere per ordine, in modo da far progredire il risolvimento della questione mediante il contributo di tutti i partecipanti. Ma il contributo di quello sconosciuto ragazzo era così straordinario, per aggiustatezza di domande e perspicacia d’osservazioni, che primi ne stupivano i sottili giuristi di Gerusalemme. Ne stupirono anche Maria e Giuseppe, che certamente assistettero a parte di una disputa aspettandone la fine: tuttavia lo stupore di questi due fu diverso da quello dei Dottori, essendo la meraviglia di chi sa molte cose ma non ne ha ancora previste tutte le conseguenze e specialmente non ha ancora riscontrato tali conseguenze tradotte in atto. La madre, nella sua addolorata esclamazione, parla giustamente da madre. Il figlio, nella sua risposta, le risponde più da figlio di un Padre celeste che di una madre terrestre: se egli ha abbandonato momentaneamente la sua famiglia umana, è stato per l’unica ragione capace di indurlo a tale abbandono, quella di essere nella spirituale casa del Padre celeste. La risposta di Gesù riassume tutta la sua vita futura. Luca, che scrive post eventum, interpreta bene in questo senso la risposta di Gesù, e non la riferisce già al materiale Tempio di Gerusalemme come sonava la parola. Ma il sottile storico aggiunge subito che i genitori, a cui Gesù rispondeva, «non capirono la parola che pronunziò loro». Non la capirono, benché già sapessero tante cose di Gesù, per la stessa ragione per cui stupirono al ritrovarlo fra i Dottori: non prevedevano cioè tutte le conseguenze delle cose che già sapevano. E chi poté mai confessare questa antica incomprensione della risposta di Gesù se non Maria stessa, quando ne parlava post eventum allorché suo figlio era morto e risorto? Perciò Luca anche qui ripete la sua preziosa allusione: «La madre di lui serbava tutte le parole nel suo cuore» (2, 51). Che è quanto indicare, con riguardosa discrezione, la fonte delle notizie (§§ 142, 248).
• § 263. Per tutti i 30 anni passati da Gesù a Nazareth non sappiamo altro: tornato lassù dopo l’episodio del Tempio, egli «era sottoposto ad essi» (2, 15), a Giuseppe e a Maria. Penetrare nell’arcano di quei 30 anni sarebbe certamente vivo desiderio di ogni mente eletta, ma chi s’introdurrà in quel santuario senza un’autorevole guida? Le nostre guide ufficiali si sono fermate al di fuori, limitandosi a dirci che là dentro Gesù era sottoposto ad essi. Quel re messianico ch’era nato in una reggia le cui caratteristiche erano state la purità e la povertà, seguitava le tradizioni di quella sua prima corte. Adesso la stalla era stata sostituita parte da una bottega da carpentiere e parte da una casettaccia mezzo scavata nella collina; la purità si era conservata nelle stesse forme e persone di prima; la povertà aveva preso l’aspetto di necessità di lavorare, e a suo fianco e a sua conferma era apparsa la soggezione volontaria. In quei 30 anni, in giro per il mondo, avvenivano cose grosse. A Roma si riapriva il tempio di Giano, essendo finito il periodo del toto orbe in pace composito (§ 225); in Giudea Archelao partiva per l’esilio, e i procuratori romani prendevano il suo posto; Augusto in età di 76 anni cessava di essere il padrone di questo mondo, e subito dopo per decreto del Senato diventava un dio dell’altro mondo; Germanico dopo le vittorie sui Barbari del Settentrione moriva in Oriente; a Roma spadroneggiava Seiano, mentre da Capri vigilava su lui Tiberio pronto a spacciarlo. Nel frattempo, a Nazareth, Gesù era come se non esistesse. Simile esteriormente in tutto ai suoi coetanei, prima bambini, poi ragazzi, infine giovani, egli dapprima saltellò sulle ginocchia della madre, poi le prestò i suoi piccoli servigi, quindi assistette Giuseppe nella bottega, più tardi cominciò a leggere e a scrivere, recitò lo Shema (§ 66) e le altre preghiere abituali, frequentò la sinagoga; da giovane maturo si sarà interessato di campi e vigne, di lavori che Giuseppe man mano eseguiva dentro Nazareth e nei suoi ameni dintorni, di questioni sulla Legge giudaica, di Farisei e di Sadducei, di avvenimenti politici della Palestina e dell’estero. All’apparenza, i suoi giorni passavano semplicemente così. Il suo idioma usuale era l’aramaico, pronunziato con quell’accento particolare ai Galilei che li faceva riconoscere appena cominciavano a parlare. Ma la Galilea, periferica qual era ed in continue relazioni con circostanti popolazioni ellenistiche, esigeva quasi necessariamente un certo impiego del greco; è probabile che Gesù si servisse talvolta anche del greco, e anche più probabile che facesse altrettanto dell’ebraico.
• § 264. Gesù aveva anche dei parenti come sua madre aveva una «sorella» (Giovanni, 19, 25), così egli aveva «fratelli» e «sorelle» più volte ricordati dagli Evangelisti (e anche da Paolo, I Cor., 9, 5). Di quattro di questi «fratelli» ci è trasmesso anche il nome, e si chiamavano Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda (Matteo, 13, 55; Marco, 6, 3); le sue «sorelle» non sono nominate, ma dovevano esser parecchie giacché si parla di «tutte... le sorelle di lui» (Matteo, 13, 56). La designazione di questo ampio stuolo parentale corrisponde bene ai costumi d’Oriente, ove i legami di sangue sono perseguiti anche nelle loro lontane e tenui ramificazioni, cosicché i collaterali più vicini sono designati genericamente come «fratelli» e «sorelle», pur essendo soltanto cugini di vario grado; già nella Bibbia ebraica i nomi «fratello», «sorella», designano spesso parenti di grado molto più lontano che il fratello o la sorella carnali, tanto più che nell’ebraico antico non si ritrova un preciso vocabolo per indicare esclusivamente il cugino. Cugini, dunque, erano i «fratelli» e le «sorelle» di Gesù. Ora, questa numerosa parentela non era tutta favorevole a lui. Nel pieno della sua operosità pubblica ci viene comunicato che «neppure i fratelli di lui credevano in lui» (Giovanni, 7, 5); né si può credere che questa avversione, o alienazione che fosse, si formasse per la prima volta quando Gesù iniziò la sua operosità pubblica. Doveva essere piuttosto la manifestazione aperta di un vecchio sentimento, che nel cuore di cotesti consanguinei covava già al tempo della vita nascosta di Nazareth. Di questo rancore domestico è comunicata da Gesù stesso una ragione, ma è generica: «Non è profeta inonorato se non nella patria di lui e nei parenti di lui e nella casa di lui» (Marco, 6, 4). Ad ogni modo, a fianco a cotesti astiosi parenti ve ne furono di fedelissimi che gli si mantennero uniti usque ad mortem et ultra, e che certamente lo avevano circondato della loro benevolenza fin da quand’era oscuro ragazzo e giovane a Nazareth. Primi fra tutti Maria e Giuseppe; quindi «Giacomo, il fratello del Signore» (Galati, 1, 19), cioè Giacomo il Minore, e poi anche altri (Atti, 1, 14), di cui forse taluni ripulitisi con l’andar del tempo dalla loro antica ruggine. Dopo i fatti dell’infanzia di Gesù non si trova più alcuna menzione di Giuseppe, né la figura di lui s’intravede minimamente durante la vita pubblica. Tanto induce a credere che il padre legale di Gesù morisse durante i 30 anni di vita nascosta del figlio; se egli fosse stato superstite a quei 30 anni, come Maria, qualche accenno se ne sarebbe facilmente conservato nell’antica catechesi e quindi anche nei Vangeli che da essa dipendono. Di lui rimase ufficialmente soltanto l’appellativo paterno, ch’egli lasciò insieme col mestiere al suo figlio legale: «Non è costui il figlio del carpentiere?» (Matteo, 13, 55); «Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria...?» (Marco, 6, 3). Fine.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, nel giorno in cui l’innocente Alfie Evans, avendo ricevuto il Battesimo della Chiesa Cattolica, è passato alla gloria eterna, ci è sembrata cosa opportuna proporre allo studio «La strage degli innocenti» e «La dimora in Egitto». Il libro che andiamo ad usare è «Vita di Gesù Cristo» - Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941, dell’Abate Giuseppe Ricciotti: riposi in pace!
• § 256. Intanto Erode aspettava il ritorno dei Magi. Ma, come i giorni passavano e nessuno compariva, dovette sospettare che il suo piano non era stato abbastanza astuto, e che invece di temere le beffe dei Gerosolimitani e di fare assegnamento sull’inconscia cooperazione dei Magi, avrebbe fatto meglio a spedire con loro quattro dei suoi scherani che lo liberassero subito da ogni apprensione. Quando l’incertezza divenne certezza, l’uomo ritrovò se stesso e, in uno di quegli scoppi d’ira che precedevano abitualmente i suoi ordini di stragi, prese una decisione tipicamente erodiana: inviò l’ordine di uccidere tutti i bambini minori di due anni che si trovavano a Bethlehem e nel territorio da essa dipendente. Nel fissare questo termine di due anni egli si era basato su ciò che gli avevano detto i Magi riguardo al tempo dell’apparizione della stella, e partendo di là aveva fatto i suoi calcoli con molta abbondanza per esser sicuro che questa volta il bambino non gli sfuggisse (§173). E invece il bambino gli sfuggì; perché il neonato di Beth-lehem, anche se non aveva a suo servizio la polizia segreta di Erode, aveva attorno a sé quei cortigiani celestiali che già avevano prestato servizio per la prima volta la notte della sua nascita. Prima che arrivassero gli scherani di Erode, un angelo apparve in sogno a Giuseppe e gli disse «Alzati! Prendi con te il bambino e la madre di lui e fuggi in Egitto, e sta’ là fino a che te lo dica (io); giacché Erode sta per cercare il bambino per farlo perire» (Matteo, 2, 13). L’ordine non ammetteva indugi. In quella notte stessa Giuseppe si mise in viaggio, per la strada opposta a quella di Gerusalemme, alla volta dell’Egitto: questa regione in cui la famiglia di Abramo era diventata nazione, e che lungo i secoli era stata sempre un luogo di scampo per i discendenti di Abramo insediati in Palestina, ricoverava adesso quel «primo e ultimo» fra i discendenti di Abramo. Nel tempo che i tre fuggiaschi, accompagnati forse dal solito asinello, si fermavano a Hebron o a Beersheva per fare qualche provvista onde affrontare il deserto, si stava eseguendo a Beth-lehem l’ordine di Erode. I bambini da due anni in giù vi furono tutti scannati.
• § 257. Quante saranno state le vittime? Partendo da un dato abbastanza verosimile, che cioè Beth-lehem col suo territorio potesse contare poco più di 1000 abitanti, se ne conclude che circa 30 erano i bambini nati ivi ogni anno; quindi, in due anni, erano circa 60. Ma poiché i due sessi a un dipresso si equilibrano per numerosità ed Erode non aveva alcun motivo di far morire le femmine, gli esposti alla sua crudeltà furono soltanto una metà di neonati, cioè i 30 maschi. Tuttavia anche questa cifra probabilmente è troppo elevata, perché la mortalità infantile in Oriente è molto alta e buon numero di neonati non giunge ai due anni. Quindi le vittime saranno state circa da 20 a 25. La bestialissima strage, come già vedemmo (§ 10), è di un valore storico incontestabile accordandosi perfettamente col carattere morale di Erode. Ma anche a Roma, se realmente Augusto ne fu informato come vorrebbe Macrobio nel passo già citato (§ 9), la notizia non dovette fare molta impressione, perché anche a Roma circolavano voci di un fatto simile riguardante Augusto stesso. Narra Svetonio (August., 94) che, pochi mesi prima della nascita di Augusto, avvenne a Roma un portento il quale fu interpretato come preannunzio che stesse per nascere un re al popolo romano; il Senato, composto di tenaci repubblicani, ne fu spaventato, e per scongiurare la sventura d’una monarchia ordinò che nessun bambino nato in quell’anno fosse allevato e cresciuto: tuttavia quelli fra i senatori che avevano la moglie gravida, allentarono in quell’occasione la propria tenacia repubblicana, per il motivo quod ad se quisque spem traheret, e si adoperarono affinché l’ordine del Senato non passasse agli atti. Ora, sul carattere storico di questo episodio si potrà legittimamente dubitare: ma il fatto che a Roma circolasse tale voce raccolta da Svetonio, fa comprendere che se nell’Urbe arrivò la notizia della strage di Beth-lehem sarà stata accolta con sghignazzamenti, quasicché il vecchio monarca avesse ammazzato niente più che una ventina di pulci. La realtà storica è questa: e non si poteva certo pretendere che i Quiriti, per una ventina di piccoli barbari scannati, si commovessero più che per centinaia dei loro propri figli che avevano corso un somigliante pericolo. Pochi mesi dopo la strage di Beth-lehem, l’aguzzino incoronato che l’aveva ordinata, già ridotto da qualche tempo ad un ammasso di carni putrefatte, morì roso alle pudende (Organi genitali esterni, ndR) dai vermi (cfr. Guerra giud., I, 656 segg.). Tuttavia la vera finezza della nemesi storica, più che nella sua morte, si ritrova nella sua sepoltura: essa ebbe luogo all’Herodium dalla cui cima si vedeva il posto della grotta ov’era nato il suo temuto rivale e quello dov’erano stati sepolti i lattanti scannati. L’esser sepolto lì fu la sua vera inferia, non già quella celebratasi con tanta suntuosità e poi descritta con tanta ammirazione da Flavio Giuseppe (Guerra giud., I, 670-678). Oggi, esplorando con lo sguardo dall’alto dell’Herodium, non si scorgono che ruderi e desolazione di morte. Soltanto in direzione di Beth-lehem si vedono segni di vita.
• La dimora in Egitto. § 258. Frattanto i tre fuggiaschi di Beth-lehem s’erano inoltrati nel deserto. Passo passo col loro asinello, studiandosi di seguire le piste carovaniere meno battute, guardandosi ogni tanto addietro per vedere se arrivava gente armata, s’allontanarono sempre più da ogni consorzio umano e ne rimasero separati almeno per una settimana, quanto dovette durare il viaggio. Scendendo giù da Beth-lehem, essi per far più presto seguirono certamente la comoda strada che passava per Hebron e Beersheva; ma ad un certo punto dovettero piegare a destra per ricongiungersi con l’antica strada carovaniera che, rasentando il Mediterraneo, congiungeva la Palestina con l’Egitto. A Beersheva comincia, oggi come allora, la steppa vuota e squallida, ma con suolo ancora compatto; più in giù invece, avvicinandosi ancora al delta del Nilo, s’estende il classico deserto, il «mare di sabbia», ove non si trova né un cespuglio né un filo d’erba né un sasso: nulla, se non sabbia. A sentire i vangeli apocrifi la traversata di questa regione sarebbe stata per i tre fuggiaschi un viaggio trionfale, perché le bestie feroci sarebbero corse ad accucciarsi mansuete ai piedi di Gesù e i palmizi avrebbero abbassato spontanei i loro rami per far cogliere i datteri; ma in realtà il viaggio dovette essere durissimo ed estenuante, soprattutto per la mancanza d’acqua. Nel 55 av. Cr. la stessa traversata era stata fatta dagli ufficiali romani di Gabinio che di viaggi faticosi s’intendevano, e che tuttavia temevano quella traversata più della stessa guerra che li aspettava in Egitto (Plutarco, Antonio, 3); nel 70 dopo Cr. fu fatta in senso inverso dall’esercito di Tito, che saliva dall’Egitto per espugnare Gerusalemme, ma con tutta l’assistenza degli accurati servizi militari romani (cfr. Guerra giud., IV, 658-663); un esercito che, in tempi recenti, ha compiuto la traversata è stato quello degli Inglesi che durante la prima guerra mondiale sono risaliti dall’Egitto in Palestina, ma essi oltre al resto stabilivano una permanente conduttura d’acqua man mano che s’avanzavano, portando così l’acqua del Nilo per oltre 150 chilometri fino ad el-Arish, l’antica Rhinocolura. I tre profughi, invece, dovettero trascinarsi faticosamente di giorno sulle sabbie mobili e nell’arsura spossante, passar la notte stesi a terra, e fare assegnamento solo su quel poco d’acqua e di cibo che si portavano appresso: ciò per una buona settimana. Per farsi un’idea di tali traversate l’europeo odierno deve aver passato notti insonni allo scoperto nella desolata Idumea (il Negeb della Bibbia), e di giorno deve aver intravisto attraverso la nebulosità sabbiosa sospesa sul deserto di el-Arish passarsi dappresso un gruppetto di pochi uomini, accompagnati da un asinello carico di provviste o anche di una donna con un bambino al petto, e tutti pensosi e taciturni come per fatale rassegnazione allontanarsi nella solitudine verso un’ignota mèta; chi ha fatto tali esperienze e tali incontri in quel deserto ha visto, più che scene di colore locale, documenti storici riguardanti il viaggio dei tre profughi di Beth-lehem. A Rhinocolura la minaccia di Erode svanì, perché là erano i confini fra il regno di Erode e l’Egitto romano. Da Rhinocolura a Pelusio il viaggio fu, se non meno faticoso, più calmo. A Pelusio, passaggio abituale per chi entrava in Egitto, si ritrovarono esseri umani e comodità di vita, e più che mai in questa occasione l’oro offerto dai Magi dovette apparire provvidenziale e rendere eccellenti servizi. Né del luogo né del tempo della permanenza in Egitto ci sono date notizie da Matteo (molte, come al solito, dagli Apocrifi e da tardive leggende); tuttavia riguardo al tempo possiamo ritenere con sicurezza che fu breve. Se Gesù è nato sullo scorcio dell’anno 748 di Roma (§173), la fuga in Egitto non poté avvenire che dopo qualche mese, cioè dopo i 40 giorni della purificazione di Maria aumentati dell’interstizio fra la purificazione e l’arrivo dei Magi; poiché questo interstizio poté essere sia di qualche settimana sia di qualche mese, convenzionalmente si potrà assegnare la fuga alla primavera o all’estate dell’anno 749. I fuggiaschi pertanto stavano da alcuni mesi in Egitto, quando vi giunse la notizia della morte di Erode avvenuta nel marzo-aprile del 750 (§ 12); e allora nuovamente un angelo apparve in sogno a Giuseppe, ordinandogli di fare ritorno col bambino e la madre nella terra d’Israele (Matteo, 2, 20). Il comando fu eseguito subito, e i profughi tornarono in patria. Fine.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, per questa settimana riposeremo dagli studi biblici (degni di tal nome) dell’erudito Abate Giuseppe Ricciotti - Requiem æternam! - e dedicheremo le nostre attenzioni al «Catechismo sul Modernismo». La nostra piccola casa editrice Sursum Corda nel mese di maggio, a Dio piacendo, inizierà a distribuire agli Associati, ai Sostenitori ed in generale a tutti i benefattori, la riedizione, minuziosamente curata in proprio, del dimenticato ma utilissimo «Catechismo sul Modernismo» di Padre Jean Baptiste Lemius (1851–1938). Il libro sarà edito con codice ISBN 978-88-900747-8-3, in formato A5, di 186 pagine, stampato su pregevole carta avoriata 90 grammi. Il libro conterrà, oltre al sommario, anche l’indice degli articoli, ovvero delle 510 domande. I caratteri di stampa, come sempre nelle nostre pubblicazioni, saranno grandi e di lettura agevole per chi ha problemi di vista. Anche questo libro verrà distribuito gratuitamente ad alcuni carcerati ed ai veri poveri che ne faranno richiesta. Confidiamo nella preghiera di tutti e nel sostegno soprattutto degli Associati. Ricordiamo altresì che le nostre pubblicazioni non hanno scopo di lucro e non vengono vendute nelle librerie.
• Cenni sull’Autore. Il Padre Jean Baptiste Lemius nacque il 23 maggio del 1851 da Francis Lemius, un poliziotto originario della Lorena, e Jeanne Marie Begarry o Begery. Terzo di cinque figli: Marie, Francis, Jean Baptiste, Louis e Joseph, quest’ultimo fu redattore di parte dell’Enciclica Pascendi contro il Modernismo. Visse l’infanzia a Montfort-en-Chalosse, a 18 chilometri da Dax, all’ombra dei Pirenei. Nel 1862, a 11 anni, entrò nel seminario minore di Aire-sur-l’Adour, unendosi al fratello Francis. A Pasqua del 1871 iniziò di nuovo il noviziato, interrotto nel 1870 dalla guerra franco-prussiana, a Notre-Dame-de-l’Osier. Quindi svolse il suo scolasticato ad Autun, dove venne ordinato Sacerdote il 16 giugno 1876. Il 4 novembre 1880, insieme ad altri 70 Oblati di Maria Immacolata, fu costretto a lasciare lo scolasticato, mentre la polizia rivoluzionaria -al soldo dei cosiddetti “democratici” e “liberi pensatori” (evidentemente né liberi e né pensatori) - irrompeva con le asce a causa delle leggi contro gli Ordini religiosi. Trovò ospitalità a Dublino in Irlanda. A partire dal 1881 fu incaricato di predicare missioni parrocchiali. Nel 1890 fu inviato a Pontmain come Superiore. Di aspetto robusto e di dottrina integrale, seppe subito conquistare la fiducia del popolo. A Saint-Pierre de Cholet, durante la Quaresima del 1889, riempì le tre navate della chiesa ed il piazzale antistante sol posizionando una piccola statua del Sacro Cuore sull’altare: devozione che divulgò fino alla morte. Nel 1883 fu nominato Superiore degli Oblati nella Basilica del Sacro Cuore a Montmartre. Trovò sostegno spirituale e finanziario presso Papa Leone XIII, quindi portò a termine i lavori della Basilica, che egli definiva «rifugio dei poveri», con i quali pregava quotidianamente il Rosario, prima di offrir loro del cibo. Nel 1901 subì una nuova persecuzione e, con le Monache di Montmartre, riuscì a comprare un convento a Tyburn (Londra), luogo di gloriosi Martiri, dove condivisero «prove amare». Fino al 1905 lavorò incessantemente per fondare gli Oblati di Maria Immacolata e per diffondere la devozione al Sacro Cuore a Dinant in Belgio. Ebbe grande talento per scrivere catechismi e per illustrare questioni teologiche ai laici. Fra i suoi lavori memorabili ricordiamo la spiegazione dell’Enciclica Humanum Genus di Papa Leone XIII, contro la Massoneria (1884); successivamente presentò ai semplici l’Enciclica Pascendi dominici gregis di Papa San Pio X, contro il Modernismo (1907). Morì a Talence il 22 luglio 1938, all’età di 87 anni. Si stima che nel solo 1901 predicò ad oltre 140.000 uomini, senza contare i fedeli di Montmartre. Fu davvero l’apostolo del Sacro Cuore in Francia, in Inghilterra (specialmente attraverso le Suore) ed in Belgio. Purtroppo non siamo riusciti a reperire una sua foto. Preghiamo per l’anima di Padre Jean Baptiste Lemius! (Cenni biografici tratti soprattutto dal sito in lingua inglese www.omiworld.org - Si ringrazia don F. Ricossa per la segnalazione)
• Breve presentazione del libro. Il Modernismo è «sintesi di tutte le eresie». È un «sistema di vaneggiamenti» che «spalanca la via all’ateismo». La prima ed immediata causa del Modernismo sta «nell’aberramento dell’intelletto». Quali sue cause remote o morali riconosciamo «la curiosità non saggiamente frenata e la superbia». I modernisti, inoltre, «devono i loro inganni ed orpelli alla totale ignoranza della filosofia scolastica». Per «trarre in inganno gli animi» essi usano una «doppia tattica». Deridono, disprezzano ed emarginano i sapienti; infine si dedicano con zelo, apertamente o dietro sofismi, alla «lotta accanita contro la Religione di Gesù Cristo». Tuttavia i modernisti sanno essere anche adulatori ed attenti al rispetto umano. Essi agitano i loro «consigli di distruzione dentro la Chiesa», il pericolo si appiatta «quasi nelle vene stesse e nelle viscere di lei». L’indizio «più manifesto» per riconoscere un modernista è la «smania di novità». Il modernista «va contro il Magistero, contro la Tradizione, contro la storia». I veri cattolici «sono fatti segno dai modernisti di somma malevolenza e di livore». In questo volume il Padre Jean Baptiste Lemius (1851 - 1938), usando la Pascendi dominici gregis di Papa San Pio X, illustra ai semplici il Modernismo, ne evidenzia i pericoli ed indica i rimedi. Un Catechismo sul Modernismo composto da 510 articoli nella forma di domanda e risposta, introdotto dal Card. Merry del Val, benedetto dal Pontefice e dalla Santa Chiesa. Si tratta di un antidoto necessario per sopravvivere alle tante «cattedre di pestilenza che inculcano le loro dottrine demolitrici nelle chiese, nei congressi, nei libri, nella società». Nel XX° secolo la gran parte dei protagonisti del Modernismo, molti già condannati dalla Chiesa, furono sorprendentemente elevati a “padri” e “dottori” in seno alla rivoluzione del Vaticano Secondo.
• Dalla lettera introduttiva del Card. Merry del Val. Illustrissimo Signore, un alto encomio oltre che l’espressione del più vivo gradimento io godo porgere alla S. V. Illma in nome del Sommo Pontefice (San Pio X, ndR), dopo la consegna che io ho fatta a Sua Santità dello splendido opuscolo di V. S. portante il titolo «Catéchisme sur le Modernisme d’après l’Encyclique Pascendi dominici gregis». L’indole del Pontificio documento ed il genere degli errori in esso condannati, poteva forse rendere alquanto malagevole la subita e completa intelligenza di tutte le più minute parti dell’importantissima Enciclica alle classi meno colte ed estranee al movimento delle buone e delle cattive sentenze, o a quelle altre che pur essendo sventuratamente troppo facili a dare adito agli errori, massime quando questi presentino una falsa esteriorità di scientifici, non sono poi così svegliate da comprendere con eguale prontezza la causa del male. Ella pertanto ha fatto opera di insigne utilità quando ha decomposto, secondo il metodo semplice e piano del nostro Catechismo, il documento medesimo, adattandolo per tal modo anche alla portala delle meno addestrate intelligenze. Sua Santità si compiace del geniale e proficuo lavoro di V. S., e mentre La loda anche per un altro titolo, per non essersi cioè menomamente discostato dalle parole dell’Enciclica, Le offre l’augurio di vedere largamente diffuso il prodotto del provvido suo studio, e Le imparte di cuore l’Apostolica Benedizione. Mentre La rendo di ciò intesa, La ringrazio alla mia volta della copia di detto opuscolo a me gentilmente destinata e passo a confermarle i sensi di ben distinta stima con cui sono, [Di V. S. Illma, Affm̃o per servirla, R. Card. Merry del Val, Segretario di Stato di S. S., Roma, 14 dicembre 1907].
• Dalla prefazione. Era appena pubblicata l’Enciclica «Pascendi dominici gregis» irradiando di sua luce trionfante il mondo cattolico, e formando l’oggetto di ogni conversazione, sia nel campo sconcertato dei nemici di Santa Chiesa, che tra le file degli amici della verità, commossi e riconoscenti, quando volli far visita ai nuovi ospiti del castello di Poyanne, divenuto, in seguito alle recenti espulsioni, rifugio del Gran Seminario d’Aire-sur-l’Adour. Vi trovai l’abate Lahitton, il distinto professore che da ben quindici anni insegna Teologia dogmatica al giovane clero. Savio progressista, ma ostile ad ogni novità sovversiva, egli ha sempre combattuto energicamente contro la diffusione delle idee moderniste. Era raggiante di gioia. - Che stupenda Enciclica! esclamò in vedermi: l’ha letta? - Se l’ho letta! E quale sacerdote, avendola, potrebbe aspettar l’indomani, per percorrerla da capo a fondo? Ma non basta leggerla; è necessario studiarla. - Certo, mi rispose, poiché è un vero programma di Teologia tracciato in vista delle necessità dei tempi presenti; che anzi tutte le scienze ecclesiastiche vi si trovano spiegate, l’una accanto all’altra, ricevendo ognuna dall’infallibile Vicario di G. C. la parola d’ordine, che deve assicurare i suoi progressi. - È vero, replicai. Noi ci troviamo innanzi ad uno splendido monumento, e ognuno dovrà decomporlo a pezzo a pezzo per poterlo analizzare nei suoi particolari. Ma temo che a molti manchi e tempo e coraggio. - Mi è venuta un’idea, riprese l’egregio professore. - Sarebbe? - Verso la fine dell’anno scolastico feci leggere ai miei cari allievi il suo Catechismo sull’Enciclica di Leone XIII «De Conditione Opificum». Le domande fanno risaltare e facilitano sommamente l’intelligenza delle risposte. Lei dovrebbe fare il Catechismo della nuova Enciclica. - Vi avevo già pensato, ma... - Bisogna farlo. Sarà un servizio reso a tanti sacerdoti, che assorti dalle occupazioni, non avranno tempo d’analizzare il documento pontificio; ai nostri seminaristi, che avranno così un manuale chiaro e preciso degli errori dei modernisti, e delle risposte per confutarle; ai giovani dei nostri circoli di studi, i quali pure debbono esser imbevuti di sane dottrine; a tanti altri... - Va benissimo! ma il tempo... i miei lavori apostolici me ne lasciano ben poco di resto. - E se ci mettessimo all’opera subito? - Lei lo desidera? - Di tutto cuore. E subito aprimmo l’Enciclica. Man mano che si andava innanzi, e che alle domande succedevano risposte chiare, convincenti, vittoriose, sottolineate dalle nostre esclamazioni ammirative, noi comprendevamo tutta l’utilità dell’opera. Sopraggiunto il professore di Filosofia, e letti alcuni fogli: Sono, disse, dei potenti sprazzi di luce, che le loro domande proiettano sulle questioni anche più minute dell’Enciclica pontificia, in modo che nulla può sfuggire all’intelligenza. Anche il venerando Vicario Generale, Direttore del Gran Seminario, rimase ammirato, avendo notato cose sfuggitegli nella prima lettura. Animati da tutto ciò, abbiamo finito l’opera, e l’offriamo a chiunque desidera studiare senza difficoltà ed approfondire questa dottrina tanto opportuna, tanto necessaria a tutte le intelligenze contemporanee. Vogliano i cortesi lettori condividere con me la riconoscenza per il mio eccellente amico Abate Lahitton, il caro collaboratore, col quale passai momenti tanto piacevoli. Pio X dichiara che è tempo oramai di smascherare costoro «per far conoscere alla Chiesa tutta chi siano». Pertanto il presente Catechismo, tolta loro la maschera, mette in evidenza i tratti orridi e ributtanti del Modernismo. Indietro! indietro! [G. B. Lemius, Missionario Oblato di Maria Immacolata].
• Sommario dell’opera. - Lettera introduttiva del Card. Merry del Val, 7; - Prefazione, 9; - Pericolosità del male del Modernismo, 13; - La filosofia religiosa dei modernisti, 19; - Il modernista credente, 39; - Il modernista teologo, 51; - I germi della fede per il modernista, 57; - Il modernista storico e critico, 81; - Il modernista apologeta, 99; - Il modernista riformatore, 111; - Complesso di tutte le eresie. Strada all’ateismo, 117; - Cause del Modernismo. Curiosità e superbia, 125; - Cause del Modernismo. L’ignoranza, 129; - Trucchi dei modernisti nel propagare i loro errori, 131; - Rimedi contro il Modernismo, 141; - Conclusione, 161; - Indice degli articoli con numero di pagina, 163; - Sommario 185; - Sub Tuum praesidium Immaculata!
• Alcune delle 510 semplici domande e risposte.
N° 3. Questi uomini, sudditi dell’errore e che all’errare trascinano, sono più numerosi oggi e che scopo si prefiggono? È da confessare che, in questi ultimi tempi, è cresciuto oltre misura il numero dei nemici della croce di Cristo; che, con arti non certo nuove e piene d’astuzia, si affaticano di rendere vana la virtù vivificatrice della Chiesa e scrollare dai fondamenti, se mai venga loro permesso, lo stesso regno di Gesù Cristo.
N° 5. Dove sono ora i fautori dell’errore? Sono dei nemici dichiarati? Ed a rompere senza più gli indugi ci spinge anzitutto il fatto, che i fautori dell’errore già non sono ormai da ricercarsi fra i nemici dichiarati; ma, ciò che dà somma pena e timore, si celano nel seno stesso della Chiesa, tanto più perniciosi, quanto meno sono in vista.
N° 7. Questi laici cattolici, questi preti, che si spacciano per riformatori della Chiesa, osano essi affrontare l’opera di Gesù Cristo e la persona stessa di N. S. G. C.? Fatta audacemente schiera, si gettano su quanto ha di più santo nell’opera di Cristo, non risparmiando la persona stessa del Redentore divino, che con ardimento sacrilego, rimpiccioliscono fino alla condizione di un puro e semplice uomo.
N° 8. Ma questi uomini saranno stupefatti di essere contati dalla Santi Vergine fra i nemici della Chiesa? Fanno meraviglia costoro perché Noi li annoveriamo fra i nemici della Chiesa; ma non potrà stupirsene chiunque, poste da banda le intenzioni di cui Dio solo è giudice, si faccia ad esaminare le loro dottrine e la loro maniera di parlare e di operare. Per verità non si allontana dal vero chi li ritenga fra i nemici della Chiesa i più dannosi.
N° 9. Perché dite che sono i nemici più dannosi della Santa Chiesa? Perché, come abbiamo già detto, i loro consigli di distruzione non li agitano costoro al di fuori della Chiesa, ma dentro di essa; ond’è che il pericolo si appiatta quasi nelle vene stesse e nelle viscere di lei, con rovina tanto più certa, quanto essi la conoscono più addentro.
N° 21. Per procedere con chiarezza nell’esposizione degli errori del Modernismo, quanti personaggi bisogna considerare nei modernisti? Al fine di procedere con ordine in una materia molto complessa, è da notare immediatamente che ogni modernista sostiene e quasi compendia in sé molteplici personaggi; quelli cioè di filosofo, di credente, di teologo, di storico, di critico, di apologista, di riformatore: e queste parti sono tutte ben da distinguersi una ad una, chi voglia conoscere a dovere il loro sistema e penetrare i princìpi e le conseguenze delle loro dottrine.
N° 40. Qual è la dottrina assurda che deriva da questa filosofia, o per dir meglio, da questi deliri dei modernisti? Di qui, o Venerabili Fratelli, quell’assurdissimo enunciato dei modernisti, che ogni religione, secondo il vario aspetto sotto cui si riguardi, debba dirsi egualmente naturale e soprannaturale.
N° 53. Spiegate con un esempio queste tre leggi dei modernisti? Illustriamo il fatto con un esempio, preso dalla persona di Gesù Cristo. Nella persona di Cristo, dicono, la scienza e la storia non trovano nulla al di là dell’uomo. Dunque, in vigore del primo canone dato dall’agnosticismo, dalla storia di essa deve cancellarsi tutto quanto sa di divino. Più oltre, in conformità del secondo canone, la persona storica di Cristo è stata trasfigurata dalla fede: dunque fa d’uopo spogliarla di tutto ciò che la innalza sopra le condizioni storiche. Per ultimo, la stessa è stata sfigurata dalla fede, secondo quanto insegna il terzo canone: dunque sono da rimuoversi da lei i discorsi, i fatti, tutto quello insomma che non risponde al suo carattere, alla sua condizione ed educazione, al luogo ed al tempo in cui visse.
N° 88. Da quale principio fondamentale i modernisti deducono la necessità della variazione dei dogmi? Fra i capisaldi della loro dottrina vi è ancora questo, tratto dal principio dell’immanenza vitale: che le formule religiose, affinché siano realmente tali e non mere speculazioni dell’intelletto, è necessario che siano vitali e che vivano della stessa vita del sentimento religioso.
N° 94. Qual è il giudizio definitivo da dare sui modernisti in ciò che riguarda la verità dogmatica? Oh! veramente ciechi e conduttori di ciechi, che, gonfi del superbo nome di scienza, vaneggiano fino al punto di pervertire l’eterno concetto di verità ed il genuino sentimento religioso: spacciando un nuovo sistema, col quale, tratti da una sfrontata e sfrenata smania di novità, non cercano la verità ove certamente si trova; e disprezzate le sante ed apostoliche tradizioni, si attaccano a dottrine vuote, futili, incerte, riprovate dalla Chiesa, e con esse, uomini stoltissimi, si credono di puntellare e sostenere la stessa verità.
N° 103. Non vi pare che, con questi principii, i modernisti debbano ammettere la verità di tutte le religioni? È evidente. Posta questa dottrina dell’esperienza unitamente all’altra del simbolismo, ogni religione, sia pur quella degli idolatri, deve ritenersi siccome vera. Perché, infatti, non sarà possibile che tali esperienze s’incontrino in ogni religione? E che si siano di fatto incontrate non pochi lo pretendono. E con qual diritto i modernisti negheranno la verità ad un’esperienza affermata da un islamita?
N° 134. Ed essi che fanno della teologia cattolica? Essi, da parte loro, messa fra i ciarpami la vecchia teologia, si adoperano di porne in voga una nuova, tutta ligia ai deliramenti dei filosofi.
N° 164. Da che deriva il culto secondo loro? Il culto vogliono che risulti da un doppio bisogno; giacché, torniamo ad osservarlo, nel loro sistema tutto va attribuito ad intimi bisogni.
N° 185. Secondo l’idea dei modernisti qual è, insomma, la loro intenzione finale? Fin qui il ragionare dei modernisti; e la conseguenza è che sono tutti protesi a trovare modi per conciliare l’autorità della Chiesa con la libertà dei credenti.
N° 190. Chiedono essi, dunque, la separazione della Chiesa dallo Stato? Sì. Lo Stato deve separarsi dalla Chiesa e, per ugual ragione, il cattolico dal cittadino.
N° 195. Basta alla scuola dei modernisti che lo Stato sia separato dalla Chiesa? Non basta alla scuola modernista che lo Stato sia separato dalla Chiesa. Come la fede, quanto agli elementi fenomenici, deve sottostare alla scienza; così nelle cose temporali la Chiesa deve essere soggetta allo Stato.
N° 202. Ma questa è pura democrazia! È lo stesso che subordinare il potere dottrinale al giudizio del popolo? Infatti, loro dicono: «poiché in fin dei conti il Magistero non nasce che dalle coscienze individuali; ed a bene delle stesse coscienze ha imposto un pubblico officio; ne consegue, di necessità, che debba dipendere dalle medesime coscienze e debba quindi avviarsi a forme democratiche».
N° 209. In che modo arrivano al punto capitale del loro sistema? È loro principio generale che in una religione vivente tutto debba essere mutevole e mutarsi di fatto. Di qui proseguono verso quella che è una delle principali fra le loro dottrine, vogliamo dire all’evoluzione.
N° 300. In che modo i modernisti spiegano ironicamente questo rispetto degli antichi Dottori per i Libri santi? Purtroppo i Dottori nostri, essi blaterano, non attesero allo studio delle Scritture con quei mezzi di cui sarebbero forniti i modernisti!
N° 330. Il dogma almeno sarà per essi irreprensibile? Anzi, con una mal velata voluttà, vanno ripetendo pubblicamente che anche in materia dogmatica ritrovano errori e contraddizioni.
N° 353. Dei più moderati! E che possono dire di più gli altri? Quelli fra costoro, che potremmo chiamare integralisti, pretendono che si debba indicare all’uomo, che ancora non crede, latente in lui lo stesso germe che fu nella coscienza di Cristo e da Cristo trasmesso agli uomini.
N° 355. E queste dottrine dei modernisti a che cosa sono buone? Metodo e dottrine infarciti di errori, atti non a edificare, ma a distruggere, non a fare dei cattolici, ma a trascinare i cattolici nell’eresia, anzi alla distruzione totale di ogni religione!
N° 369. Che riforme più gravi pretendono si debbano fare nel governo della Chiesa? Strepitano a gran voce perché il regime ecclesiastico debba esser rinnovato per ogni verso, ma specialmente per il disciplinare ed il dogmatico. Perciò pretendono che dentro e fuori si debba accordare con la coscienza moderna, che tutta è volta a democrazia; perciò dicono doversi dare nel governo la sua parte al clero inferiore e perfino al laicato e discentrare, Ci si passi la parola, l’autorità troppo riunita e ristretta nel centro.
N° 385. Chiuso ogni varco verso Dio per mezzo dell’agnosticismo, in che modo i modernisti pretendono d’andare a Dio? Con essa, dalla parte dell’intelletto, è chiusa all’uomo ogni via per arrivare a Dio, mentre si pretende di aprirla più acconcia per parte di un certo sentimento e dell’azione.
N° 405. Quali sono i passi di questa caduta dello spirito umano nella negazione di ogni religione? L’errore dei protestanti diede il primo passo in questo sentiero; il secondo è del Modernismo; a breve distanza dovrà seguire l’ateismo.
N° 415. Quale dovrà, dunque, essere il primo dovere dei vescovi riguardo a questi sacerdoti superbi? Perciò, o Venerabili Fratelli, sia questo il primo vostro dovere di resistere a questi uomini superbi, occuparli negli uffici più umili ed oscuri, affinché siano tanto più depressi quanto più essi s’inalberano, e, posti in basso, abbiano minor campo di nuocere.
N° 419. Ignoranti? I modernisti che si credono così sapienti! Sarebbe proprio vero questo? I modernisti, quanti essi sono, che vogliono apparire e farla da dottori nella Chiesa, esaltando a grandi voci la filosofia moderna e schernendo la scolastica, se hanno abbracciato la prima ingannati dai suoi orpelli, lo devono alla totale ignoranza in cui si trovano della seconda, e dal mancare perciò le nozioni per riconoscere la confusione delle idee e ribattere i sofismi.
N° 437. In che modo vanno contro il Magistero? Sia pervertendone sacrilegamente l’origine, la natura, i diritti, sia ricantando liberamente contro esso le calunnie dei nemici.
N° 458. Insomma che cosa li spinge a muovere guerra alle tradizioni antiche? Insomma li punge la vana bramosia che il mondo parli di loro; il che si persuadono che non avverrà, se dicono soltanto quello che sempre e da tutti fu detto.
N° 479. Che dovere incombe ai Vescovi per quel che riguarda gli scritti infetti di Modernismo? È parimenti officio dei Vescovi impedire che gli scritti infetti di Modernismo o ad esso favorevoli si leggano se sono già pubblicati, o, se non lo sono, proibire che si pubblichino.
(Ringraziamo l’Associato Fabio Angius per aver fornito la copia originale del manoscritto e per aver insistito sulla ripubblicazione dello stesso).
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, uniamoci in preghiera contro gli iniqui “esportatori di democrazia” ed imploriamo il Signore degli eserciti affinché cessi, quanto prima, questa ennesima violenta aggressione a nocumento del popolo di Siria. Scrive il Salmista: «Corrupti sunt et abominationes operati sunt; non est qui faciat bonum» - Sono corrotti, fanno cose abominevoli, nessuno fa il bene. - Impreca ancora: «Quid gloriaris in malitia, qui potens es iniquitate? Tota die insidias cogitasti; lingua tua sicut novacula acuta, qui facis dolum. Dilexisti malitiam super benignitatem, mendacium magis quam loqui aequitatem. Dilexisti omnia verba perditionis, lingua dolosa» - Perché ti vanti del male o prepotente nella tua iniquità? Ordisci insidie ogni giorno; la tua lingua è come lama affilata, artefice di inganni. Tu preferisci il male al bene, la menzogna al parlare sincero. Ami ogni parola di rovina, o lingua di impostura. - Finalmente attesta: «Deus destruet te in finem; evellet te et emigrabit te de tabernaculo et radicem tuam de terra viventium» - Dio ti demolirà per sempre, ti spezzerà e ti strapperà dalla tenda e ti sradicherà dalla terra dei viventi. Ciò detto, veniamo all’argomento del giorno: I Magi e la loro dottrina. Il libro che andiamo ad usare è «Vita di Gesù Cristo» - Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941, dell’Abate Giuseppe Ricciotti: riposi in pace!
• § 252. Attorno al neonato Messia, Luca finora ha condotto, oltre ai cortigiani celestiali, soltanto gente umile in funzione di cortigiani terreni, i pecorai della steppa e i due vecchi della città. Su tutti costoro tace Matteo; il quale invece gli conduce dappresso non solo personaggi insigni ma - ciò che può sorprendere nel pio israelita fra i quattro Evangelisti - personaggi precisamente non israeliti e appartenenti agli aborriti. Se questo nuovo episodio fosse stato narrato da Luca, si sarebbe detto ch’era stato introdotto per dimostrare avverato l’annunzio di Simeone riguardo alla rivelazione di genti; ma trattandosi di Matteo, non rimane che da richiamarsi alla realtà dei fatti selezionata diversamente dai diversi narratori. Essendo dunque nato «Gesù, ecco che magi da Oriente si presentarono a Gerusalemme dicendo: Dov’è il nato re dei Giudei? Vedemmo infatti la stella di lui nell’Oriente, e venimmo ad adorano. - Allora, avendo udito (ciò), il re Erode si turbò, e tutta Gerusalemme con lui; e avendo adunato tutti i sommi sacerdoti e gli Scribi del popolo, ricercava da essi dove il Cristo debba nascere. E quelli gli dissero: in Beth-lehem della Giudea; così infatti è stato scritto per mezzo del profeta “tu Beth-lehem, terra di Giuda, non sei in alcun modo la minima fra i duci di Giuda; da te infatti uscirà un duce il quale pascolerà il popolo mio Israele”» (Matteo, 2, 1-6). Gli inaspettati stranieri, dunque, erano magi e venivano da Oriente; questi sono a loro riguardo i soli dati sicuri, ma anche vaghi. Il più vago è Oriente, che geograficamente designa tutte le legioni di là dal Giordano, ove procedendo verso levante s’incontra dapprima l’immenso deserto siro-arabico, quindi la Mesopotamia (Babilonia), e infine la Persia: e infatti nell’Antico Testamento tutte e tre queste regioni sono designate come Oriente, anche la lontanissima Persia (come appare da Isaia, 41, 2, ove si allude al persiano Ciro il Grande). Ma precisamente in Persia, a preferenza delle altre due regioni più prossime, ci conduce il termine magi che è originariamente persiano e strettamente legato alla persona e alla dottrina di Zarathushtra (Zoroastro).
[Dalla nota 1 alla pagina 286. Erodoto afferma che magi era il nome di una tribù della Madia, e può darsi che ai tempi di lui i magi con le loro prerogative e leggi particolari costituissero una casta chiusa e una specie di tribù ; ma il loro nome è certamente assai più antico. Già nelle Gatha ricorre il termine magavan - e nell’Avesta recente il termine mogu (antico persiano magu), quali aggettivazioni del nome maga - «dono», e hanno il significato di «partecipe del dono» ; ora, poiché già nelle Gatha col termine «dono» è designata la dottrina di Zarathustra, evidentemente i « partecipi del dono » cioè i magi sono i fedeli di Zarathushtra, ossia i suoi discepoli. Difatti autori greci antichi e accreditati, quali Xantos, Ermodoro e Aristotile, convengono nel presentare i magi come seguaci di Zarathushtra, e definiscono la loro dottrina una filosofia «chiarissima ed utilissima»: per questi autori il primo mago fu Zarathushtra stesso. Bisogna scendere ad autori posteriori, specialmente a Bolos di Mendes, fondatore della scuola neo-pitagorica e naturalistica di Alessandria, per trovare i magi presentati come astrologi e stregoni, e confusi, perciò, in parte con i Caldei babilonesi ed in parte con i maghi egiziani; tuttavia più tardi, in Babilonia, anche i magi fecero di Zarathushtra un astrologo. Per tutto questo argomento, cfr. G. Messina, Ursprung der Magier und die zarathustrische Religion, Roma 1930; id., I Magi a Betlemme e una predizione di Zoroastro, Roma, 1933; id., Una presunta profezia di Zoroastro sulla venuta del Messia, in Biblica, 1933, pagg. 170-198].
Di Zarathushtra i magi furono originariamente discepoli; ad essi aveva egli affidato la sua dottrina riformatrice delle popolazioni dell’Iran, ed essi ne furono poi i custodi e i trasmettitori. La loro classe appare molto potente fin nei tempi più antichi, già all’epoca dei Medi e ancor più a quella degli Achemenidi: era un «mago» quel Gaumata (il «falso Smerdi») che usurpò il trono achemenide nel 522 av. Cr. durante la campagna di Cambise in Egitto; ma, anche dopo l’uccisione di Gaumata, i magi si mantennero sempre potenti nell’Impero persiano e nei regimi successivi, fin verso il secolo VIII dopo Cr. Nel campo culturale essi si saranno anche occupati del corso degli astri come tutte le persone colte a quei tempi ed in quelle regioni, ma astrologi e fattucchieri certamente non erano: ché anzi, come discepoli di Zarathushtra e fedeli trasmettitori dell’Avesta, essi dovevano essere i naturali nemici delle dottrine astrologiche e mantiche dei Caldei, le quali sono recisamente condannate nell’Avesta.
• § 253. I Magi venuti a Gerusalemme avevano dunque visto una stella in Oriente, avevano compreso ch’era la stella del «re dei Giudei», e perciò si erano messi in viaggio dall’Oriente per venire ad adorarlo. Riguardo alla stella abbiamo già espresso la nostra opinione secondo cui Matteo intende presentarla come un fatto miracoloso, da non potersi identificare con un fenomeno naturale (§ 174) poco appresso egli dirà che, usciti i Magi da Gerusalemme, la stella li precederà a guisa di fiaccola indicatrice della strada e si fermerà proprio sul posto dove stava il bambino ricercato (Matteo, 2, 9). Se del re Mitridate si narrava che alla sua nascita e all’inizio del suo regno era spuntata una cometa (Giustino, Hist., XXXVII, 2), e altrettanto si affermava di Augusto per l’inizio del suo impero (Servio, in Eneide, X, 272), nessuno però aveva mai detto che tali comete avessero indicato ad uomini un dato cammino passo passo, aspettandoli anche nelle soste, e poi rimovendosi, e infine fermandosi definitivamente sopra alla mèta. Stabilito pertanto questo carattere miracoloso, come si spiega che i Magi, veduta la stella, la riconoscono come quella del «re dei Giudei»? Che sapevano in precedenza essi, nella lontana Persia, di un re dei Giudei aspettato come salvatore in Palestina? Il riconoscimento della stella da parte dei Magi è, nella narrazione di Matteo, strettamente legato col carattere della stella: la miracolosa stella miracolosamente si fa riconoscere da essi come segno del neonato. Ma riguardo alle predisposizioni culturali dei Magi, e alla loro possibile conoscenza dell’aspettativa messianica dei Giudei, siamo oggi informati da recenti studi meglio che per l’addietro, e possiamo affermare che in Persia si aspettava per tradizione interna una specie di salvatore e inoltre si sapeva che una analoga aspettativa esisteva in Palestina. Trattiamo di ciò in nota come di questione troppo lunga per discutersi qui, ma troppo importante per esser tralasciata.
[Dalla nota 1 alle pagine 287 e 288. Il sistema teologico dei Magi, quale risulta dall’insieme dell’Avesta, è imperniato sul dualismo e sull’eterna lotta fra il Bene e il Male, fra Ahura-Mazdah il «Saggio Signore» e Anra-Mainyu lo spirito del male: della quale lotta è assai importante per il nostro argomento un tratto particolare, che implica la caratteristica idea del saushyant, il «soccorritore». È un’idea che si trova enunciata già nelle parti più antiche dell’Avesta, le Gatha, ed è specificata sempre più ampiamente nelle parti più recenti e nella letteratura medio-persiana; senonché, mentre da principio il «soccorritore» (uno o più) è un personaggio reale, storico, presente, più tardi la missione del «soccorritore» è assegnata a tre futuri personaggi che nasceranno dal seme di Zarathushtra e la cui attività è inquadrata a periodi ricorrenti; fra i tre il più importante è l’ultimo, chiamato per eccellenza il «soccorritore». Alla base di tale idea sta un concetto ottimista, perché la lotta fra il Bene e il Male terminerà col trionfo del primo, grazie all’intervento del «soccorritore». Nella concezione iranica, le vicende cosmiche ed umane si svolgono in un periodo di 12 millenni, divisi in quattro gruppi di 3.000 anni ciascuno. Nei primi due gruppi tutto è in pace; ma nel terzo gruppo comincia la lotta del Male contro il Bene (periodo mitico), e nel quarto gruppo appare Zarathushtra (periodo storico) che annunzia la dottrina di Ahura-Mazdah, ed egli stesso è il primo «soccorritore» coadiuvato da altri «soccorritori», cioè dai seguaci della stessa dottrina. È da notare, tuttavia, che il termine «soccorritore», saushyant, è un participio futuro. Ora, nell’Avesta recente, questa particolarità temporale fu ampiamente sviluppata, sotto l’influenza di altri concetti, e il termine fu applicato specialmente a un ben determinato personaggio escatologico, su cui insieme si trasportarono precedenti lineamenti mitici. Questo personaggio è Astvat-ereta, progenie di Zarathushtra, la cui missione è già accennata nel suo nome che significa «verità incarnata»; egli sarà il saushyant per eccellenza, perché con la sua opera assicurerà il trionfo finale del Bene sul Male e ricondurrà l’umanità alla sua primitiva condizione felice. Alcuni testi persiani successivi, dopo aver nominato altri due «soccorritori» discendenti di Zarathushtra, presentano il terzo ed ultimo, che sarà egualmente della stirpe di Zarathushtra ma partorito da una fanciulla «senza che alcun uomo le si avvicini» (Teodoro bar Konai). Giunto che sia questo ultimo «soccorritore», avverrà la resurrezione dei morti, il giudizio generale dell’umanità e la restituzione del regno assoluto di Ahura-Mazdah col trionfo del Bene. Siffatti concetti, noti al di fuori anche ai cristiani (specialmente agli scrittori siri geograficamente confinanti con i Persiani), fecero credere ad una profezia di Zarathushtra preannunziante il Messia ebraico. Ma questo ravvicinamento delle due figure, del saushyant persiano e del Messia ebraico, era già stato iniziato in precedenza da scrittori giudei, perché fin dai tempi di Ciro il Grande (morto nel 529 av. Cr.) il giudaismo era stato in contatto diretto con i Persiani. I cosiddetti Oracoli di Istape, un libro di cui ci sono pervenuti solo scarsi frammenti, mostrano chiaramente la tendenza ad intrecciare concetti della Bibbia con idee persiane: la quale tendenza è dovuta, come sembra più probabile, ad uno scrittone giudaico che voleva gettare un ponte di passaggio fra il mondo concettuale giudaico e quello persiano. Storicamente, dunque, è in tutto verosimile che verso l’inizio dell’Era cristiana fosse diffusa nella casta dei magi in Persia la conoscenza dell’aspettativa giudaica di un Re-Messia: che questa aspettativa straniera fosse identificata con l’aspettativa persiana di un saushyant «soccorritore»: e che taluni di loro s’interessassero in una maniera qualsiasi della comparsa di questo gran personaggio. (Per ulteriori notizie e rimandi agli antichi testi valgono gli scritti di G. Messina, citati nella nota precedente)].
Matteo non dice quanti fossero i Magi venuti; la tradizione popolare tardiva li credette più o meno numerosi, da un minimo di due a un massimo di una dozzina, ma con preferenza del numero tre suggerito certamente dai tre doni ch’essi offrirono: di questi tre, già da prima del secolo IX, si seppero anche i nomi, Gaspare, Melchiore e Baldassare.
• § 254. Erano proprio stranieri quei Magi e non sapevano proprio nulla delle condizioni politiche di Gerusalemme, giacché appena entrati si danno a domandare: Dov’è il nato re dei Giudei? Di re dei Giudei non c’era altri che Erode; bastava del resto conoscere un pochino il carattere di costui (§ 9 segg.) per stare sicuri che un suo eventuale competitore, appena si fosse mostrato, avrebbe avuto i giorni e anche le ore contate. Perciò, nell’interesse stesso del bambino ricercato, quella domanda era pericolosa nella sua ingenuità. I primi cittadini interpellati rimasero stupiti, e anche un poco turbati, perché una domanda di quel genere fatta da quegli ignoti personaggi induceva a subodorare tenebrose congiure, le quali si sarebbero portate appresso i soliti sconvolgimenti civili e le stragi di gente sospetta. Passando di bocca in bocca la domanda pervenne a gente della corte, e quindi anche ad Erode. Il vecchio monarca, che per sospetti di congiure aveva già ammazzato due figli e stava per ammazzarne un terzo, non poté non turbarsene; ma capì subito che, se una minaccia c’era, era ben diversa dalle altre. La sua polizia segreta, egregiamente organizzata, lo teneva informato dei minimi fatti che accadevano in città, e in quei giorni non era stato riferito assolutamente nulla di inquietante; d’altra parte dalla lontana Persia non si dirigevano facilmente le fila d’una congiura, nè si sarebbero inviate sul posto persone così inesperte ed ingenue come quei Magi. No, qui doveva esserci sotto qualcosa d’altro genere, qualche ubbìa religiosa [Idea priva di fondamento, che dà preoccupazione o avversione ingiustificata; scrupolo infondato, ndR], molto probabilmente la fisima di quel Re-Messia che i suoi sudditi aspettavano ma che egli non aspettava affatto. Ad ogni modo era bene premunirsi, dapprima informandosi chiaramente in proposito, e poi giocando d’astuzia. Trattandosi di beghe religiose, Erode consultò non l’intero Sinedrio (§ 58), ma quei suoi due gruppi ch’erano più versati in simili faccende, cioè i sommi sacerdoti e gli Scribi del popolo (§§ 41, 50), e propose loro il quesito astratto e generico dove il Cristo (Messia) debba nascere. Egli cioè voleva sapere quale sarebbe stato, secondo le tradizioni giudaiche, il luogo di nascita dell’aspettato Messia: saputo ciò, avrebbe provveduto egli a servirsi di quei semplicioni di Magi per fare i suoi propri conti col neonato re dei Giudei. I consultati risposero che il Messia doveva nascere a Beth-lehem, e citarono a prova il passo di Michea, 5, 1-2, che nel testo ebraico dice: «E tu Beth-lehem Efrata, piccola pur essendo nelle ripartizioni di Giuda, da te per me uscirà (colui che) sarà dominatore in Israele, le cui uscite (origini) dall’antichità, dai giorni eterni. Perciò (Dio) li consegnerà (in potere dei nemici), fino al tempo in cui la partoriente partorirà». Si noterà che questo passo non è riprodotto né integralmente né con queste precise parole dalla risposta dei dottori consultati, qual è riferita da Matteo (§ 252); ad ogni modo c’è l’essenziale, cioè la designazione di Beth-lehem come luogo d’origine del Messia, e in tal senso si esprime anche il Targum allo stesso passo. Questa designazione era dunque tradizionale nel giudaismo di quei tempi. Ottenuta questa risposta, Erode dovette rimanere perplesso. Beth-lehem era un paesucolo qualunque, in cui la sua polizia segreta non gli segnalava assolutamente nulla di sospetto; tuttavia quel complesso di stella, di sconosciuti Magi, e specialmente quell’appellativo di re dei Giudei, mentre da una parte stuzzicavano la sua curiosità, dall’altra disturbavano alquanto la sua tranquillità. Per soddisfare dunque alla prima e provvedere alla seconda, non rimaneva che servirsi degli stessi Magi, in maniera tale da non destare i sospetti né di loro né di altri.
• § 255. Questo piano fu attuato. Erode fece chiamare i Magi di nascosto (Matteo, 2, 7), perché non voleva né apparire troppo credulo dando importanza a gente forse squilibrata, né rinunciare alle sue misure di precauzione. Interrogatili quindi accuratamente sul tempo e modo dell’apparizione della stella, li lasciò andare a Beth-lehem: cercassero bene il neonato, e appena trovatolo ne informassero lui, perché sarebbe venuto anch’egli laggiù ad adorarlo. Mandare appresso a quei buffi orientali un manipolo di soldati con qualche ordine segreto sarebbe stato un provvedimento più sicuro, dispensando il vecchio monarca dall’aspettare la notizia che il bambino era stato trovato: ma lo avrebbe anche esposto alle beffe dei suoi sudditi, giacché in tutta Gerusalemme non si faceva che parlare di quella strana comitiva, pur prevedendosi con certezza che tutto sarebbe finito in una scena da ridere e che quegli orientali sarebbero risultati sognatori esaltati. Ad ogni modo essi, com’erano passati allora per Gerusalemme, così dovevano ripassarci al loro ritorno, e quindi Erode li avrebbe avuti sempre a sua disposizione. I Magi, dopo l’udienza reale, partirono. «Ed ecco la stella, che videro nell’Oriente, li precedeva finché venendo stette sopra dov’era il bambino. Ora vedendo la stella, godettero di gaudio assai grande. E venuti nella casa, videro il bambino con Maria la sua madre, e caduti l’adorarono: e aperti i loro forzieri, gli presentarono doni, oro, incenso e mirra. E ricevuta rivelazione per sogno di non ritornare da Erode, per altra strada si ricondussero alla loro regione» (Matteo, 2, 9-12). La narrazione è ristretta alle sole linee principali ed astrae da tempo e da luogo. Se ne raccoglie tuttavia che i Magi passarono almeno una notte a Beth-lehem, giacché vi ricevettero rivelazione per sogno, e non è escluso che vi rimanessero anche più d’un solo giorno; Si raccoglie pure che la famiglia di Giuseppe, abbandonata la grotta, si era ricoverata in una casa (§ 249). Avviandosi per rendere omaggio a un «re», i Magi avevano preparato donativi come esigeva l’etichetta orientale. La reggia di Erode in Gerusalemme splendeva d’oro, e lungo i suoi ambulacri i bruciaprofumi esalavano vapori d’incenso e di resine odorifere. Altrettanto avveniva in quel suo suntuoso Herodium ove il suo fiero costruttore sarebbe stato sepolto fra pochi mesi e che si elevava a poca distanza da Beth-lehem (§ 12); forse più d’una volta i pastori di là, aggirandosi alle falde della sua collinetta, ne avevano intravisto i riflessi aurei delle sale ed erano stati raggiunti dalle folate di profumo che ne uscivano. Conforme al cerimoniale delle grandi corti i Magi offrirono oro, incenso e quella resina profumata che tutti i Semiti chiamavano mōr, da cui il nostro nome di mirra. Erode stesso largheggiava in donativi con altri monarchi, specialmente se più potenti di lui: ad esempio, proprio in quei giorni, egli nel suo testamento lasciava ad Augusto un legato di ben 1000 o anche 1500 talenti (Guerra giud., I, 646; II, 10; cfr. Antichità giud., XVII, 323), somma altissima anche per quei tempi, che però fu rifiutata signorilmente da Augusto. I Magi certamente non poterono essere munifici quanto Erode, ma in compenso ebbero la gioia di vedere accettati i loro doni e inoltre d’accorgersi ch’erano opportunissimi: se tutti e tre i doni riconoscevano la dignità regale del neonato, specialmente l’oro arrivava come una provvidenza per restaurare le finanze di quella corte, la quale di suo non aveva né un tetto e forse neanche un mezzo siclo, dopo averne lasciati cinque interi al Tempio di Gerusalemme (§ 249). Compiuti gli omaggi, i viaggiatori dopo qualche tempo ripartirono alla volta del loro paese, ma non passarono per Gerusalemme e Gerico, bensì forse per l’altra strada che toccando la fortezza erodiana di Masada costeggiava la spiaggia occidentale del Mar Morto. E di loro non si seppe più nulla. Fine.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, Vi ricordiamo che nei giorni sabato 12 e domenica 13 maggio 2018 si terrà l’edizione XVa del Pellegrinaggio Osimo-Loreto. Per informazioni e prenotazioni potete scrivere alla mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Anche quest’anno saremo presenti come Associazione. Veniamo all’argomento del giorno: «La Purificazione della Vergine Maria» secondo gli studi del dotto Abate Giuseppe Ricciotti - riposi in pace!
• § 249. La dimora dei tre (Gesù Bambino, San Giuseppe e la Vergine Maria, ndR) nella grotta dovette esser breve, forse di pochi giorni soltanto. Man mano che il censimento progrediva, la gente ripartiva e le case si sfollavano: una di esse fu occupata da Giuseppe che vi si trasferì con gli altri due, e fu la casa ove si presentarono alcune settimane dopo i Magi (Matteo, 2, 11). Forse già in questa casa avvenne la circoncisione del neonato, praticata secondo la prescrizione otto giorni dopo la nascita (§ 69), e in tale occasione gli fu imposto il nome di Gesù notificato dall’Angelo sia a Maria sia a Giuseppe (§§ 230, 239). L’angelo infatti aveva detto che il nascituro sarebbe stato chiamato figlio dell’Altissimo; ma di fatto era comparso nel mondo come discendente d’Israele per il casato di David, né dall’Angelo era stata comunicata alcuna istruzione che esimesse questo nuovo Israelita dagli obblighi comuni a tutti gli Israeliti: perciò Giuseppe e Maria compirono tali obblighi a suo riguardo. E li compirono anche riguardo a se stessi. La Legge ebraica prescriveva che la donna dopo il parto fosse considerata impura, e rimanesse segregata 40 giorni se aveva fatto maschio, e 80 se femmina, dopo di che doveva presentarsi al Tempio per purificarsi legalmente, e farvi un’offerta: che per i poveri era limitata a due tortore o due piccioni. Se poi il bambino era primogenito, esso di legge apparteneva al Dio Jahvè, come tutti i primogeniti degli animali domestici e le primizie dei campi; perciò i suoi genitori dovevano riscattarlo pagando al Tempio, in cambio del primogenito, cinque sicli. Non era obbligo portare materialmente il neonato primogenito al Tempio per presentarlo a Dio, ma di solito le giovani madri lo portavano per invocare su lui le benedizioni celesti. Ambedue queste usanze furono seguite riguardo a Gesù: dopo 40 giorni Maria si recò al Tempio per la propria purificazione, offrendo ciò ch’era prescritto per i poveri, e portò con sé Gesù per presentarlo a Dio, pagando i cinque sicli. Se i due piccioni o tortore per la purificazione valevano ben poco, i cinque sicli per il riscatto del primogenito furono assai gravi per la povertà dei due coniugi; infatti cinque sicli d’argento, che equivalevano a un poco più di 20 lire nostre in oro, era quanto un artigiano come Giuseppe avrebbe guadagnato a mala pena con una ventina di giornate di lavoro, mentre poi in quei giorni a Bethlehem egli avrà potuto poco o nulla lavorare: tuttavia alla spesa straordinaria ma prevista si sarà fatto fronte con qualche risparmiuccio che i due si saranno portati appresso da Nazareth come scorta. Quel gruppetto di tre persone che entravano nel Tempio di Gerusalemme non era fatto per attirare su di sé gli sguardi della gente, che stava là a oziare o a sentire le dissertazioni dei maestri farisei o a commerciare nell’«atrio dei gentili» (§ 48): erano tante le madri le quali ogni giorno venivano là a purificarsi dopo il parto e a presentare i loro primogeniti, che quel gruppetto di tre persone non meritava davvero uno sguardo particolare. Ma proprio quel giorno c’era qualcuno, là nell’atrio, che aveva uno sguardo differente dagli altri e poteva scorgere ciò che gli altri non scorgevano; era un uomo di Gerusalemme, di nome Simeone, e quest’uomo (era) giusto e timorato, aspettava la consolazione d’Israele e Spirito santo era su lui; e gli era stato rivelato dallo Spirito santo che non avrebbe visto morte prima che avesse visto il Cristo del Signore (Luca, 2, 25-26).
• § 250. Il nome Simeone era comunissimo fra i Giudei di quel tempo: e qui si dice di lui soltanto ch’era uomo giusto e timorato, e tutt’al più dalle parole ch’egli pronunzierà si può argomentare che era ben avanti negli anni; nulla però induce a credere che egli fosse sacerdote, e tanto meno il sommo sacerdote come vorrebbe un Apocrifo. L’uguaglianza poi del nome non basta per identificarlo, come taluni hanno suggerito, con Rabban Simeon figlio del grande Hillel e padre del Gamaliel maestro di San Paolo, mentre contro questa identificazione stanno gravi difficoltà cronologiche. Questo laico era dunque un privato qualunque che si teneva a parte dai grandi avvenimenti dei politicanti di Gerusalemme, viveva tra le sue opere di giustizia e di timor di Dio come i pecorai di Beth-lehem vivevano tra le loro pecore, e come quelli aspettava la consolazione d’Israele, cioè il promesso Messia: e nella stessa guisa che i pecorai furono avvisati dall’Angelo, così Simeone era stato preavvisato dallo Spirito santo che la sua amorosa aspettativa sarebbe stata appagata. Cosicché quel giorno egli venne nello Spirito al tempio; e mentre i genitori introducevano il bambino Gesù per far con lui secondo il consueto della legge, egli lo ricevette sulle braccia, e benedisse Iddio e disse: Ora dimetti lo schiavo tuo, o Padrone, - secondo la tua parola - in pace! Perché videro gli occhi miei la tua salvezza, che preparasti al cospetto di tutti i popoli: luce a rivelazione di genti, e gloria del tuo popolo d’Israele (Luca, 2, 27-32). La salvezza che appagava l’aspettativa di costui era rappresentata da quell’infante di quaranta giorni, che esteriormente non aveva niente di straordinario: e fin qui si poteva lasciar correre. Ma se lì presso ci fosse stato un Fariseo, di quelli più genuini e più tipici, non avrebbe potuto reprimere il suo sdegno a udire quelle parole, secondo cui il Messia (chiunque fosse) avrebbe operato la salvezza per tutti i popoli e sarebbe stato una rivelazione di genti, cioè di quelle genti pagane che non facevano parte dell’eletta nazione d’Israele. Siffatte affermazioni erano scandalose e sovversive! È vero che in fondo si aggiungeva che lo stesso Messia sarebbe stato la gloria del popolo d’Israele; ma questa aggiunta finale rappresentava un compenso troppo scarso, era un misero piatto di lenticchie con cui si pretendeva compensare una spirituale primogenitura - o meglio unigenitura - perduta. Il futuro Messia, invece, doveva apparire in Israele e per Israele soltanto, e le altre genti, tutt’al più sarebbero stati ammessi come umili sudditi e discepoli d’Israele nei trionfali tempi del Messia; equiparare Israele e le genti agli effetti della salvezza messianica era un’eresia e una rivoluzione! Il genuino e tipico Fariseo avrebbe avuto ragione, come Fariseo: infatti il vaticinante Simeone non avrebbe potuto appoggiare la sua affermazione su nessuna sentenza dei grandi maestri farisei. Tuttavia, risalendo più su di costoro, l’avrebbe appoggiata su sentenze di Dio stesso, il quale nella Scrittura sacra aveva proclamato al futuro Messia: Metterò te qual patto di popolo, quale luce di genti (Isaia, 42, 6); e aveva confermato poco appresso: metterò te quale luce di genti, per esser la mia salvezza fino all’estremità della terra (Isaia, 49, 6). Il nazionalismo escludente aveva fatto dimenticare la parola di Dio, ma Simeone passava sopra al particolarismo geloso dei Farisei e rievocava il decreto universalistico di Dio. Fatto ciò e contemplato il Messia, il vecchio non desiderava altro, e poteva partire per il viaggio senza ritorno. Tuttavia alle sue parole perfino il padre di lui (del bambino) e la madre erano meravigliati (Luca, 2, 33); onde il contemplativo si rivolse anche ad essi. Ma essi erano in realtà la sola Maria, alla quale perciò egli soggiunse: Ecco, costui è posto a caduta e resurrezione di molti in Israele e a segno contraddetto - e a te stessa trapasserà l’anima una spada - affinché siano rivelati i pensieri da molti cuori (2, 34-35). Dunque, il contemplativo scorge bensì la luce del Messia brillare su tutti i popoli, ma non già fugare tutte le tenebre; in Israele stesso molti procomberanno a causa di quella luce, la quale sarà un segno di contraddizione, un «segno d’immensa invidia - e di pietà profonda, - d’inestinguibile odio - e d’indomato amor». E i colpi vibrati contro quel segno non raggiungeranno solo esso, ma anche la madre di lui, la cui anima sarà trafitta da acuta spada. Forseché, nella salvezza operata da quel bambino, la madre sarebbe stata unita col figlio, e non si sarebbe potuto colpire il figlio senza trapassare insieme la madre?
• § 251. Amante dei quadretti abbinati, San Luca soggiunge immediatamente all’episodio di Simeone quello di Anna (2, 36-38). Egli la chiama profetessa, com’erano state altre donne nell’antico Israele. Ancora un settantennio più tardi Flavio Giuseppe presenterà se stesso come conoscitore di eventi futuri (Guerra giud., III, 351-353, 400 segg.), ed a Roma Svetonio lo prenderà sul serio e gli darà ragione (Vespasian., 5): ma Giuseppe era tutt’altro che il «profeta», che l’antico nābī’ ebreo, «uomo di Dio» il quale viveva e moriva per la sua fede. La profetessa Anna invece era veramente donna di Dio: rimasta vedova dopo sette anni di matrimonio, aveva passato la sua vita negli atrii del Tempio fra digiuni e preghiere, raggiungendo l’età di 84 anni. Anch’ella, sopravvenuta in quella stessa ora, rendeva a sua volta lode a Dio, e parlava di lui (del bambino Gesù) a tutti quei che aspettavano la liberazione di Gerusalemme (2, 38). Di questi aspettanti San Luca ha presentato i soli Simeone ed Anna; ma appresso a quei due dovevano stare molti altri, e verso ognuno di loro si sarebbe potuto esclamare: Guarda! Uno davvero Israelita, in cui non è inganno! (Giovanni, 1, 47): tutta gente ignota agli alti ceti sacerdotali, aliena da beghe politiche, ignara di sottigliezze casuistiche, ma che aveva concentrato la sua esistenza in una ansiosissima attesa, quella del Messia promesso da secoli ad Israele. Tuttavia in quei giorni a Gerusalemme erano certamente più numerosi coloro la cui ansiosissima attesa era di conoscere le decisioni dei sommi dottori Hillel e Shammai su una formidabile questione che allora si discuteva, quella di sapere se era lecito o no mangiare un uovo fatto dalla gallina durante il sacro riposo del sabbato (Besah, I, 1; Eddujjōth, IV, 1). Fine.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, oggi dedichiamo l’articolo d’apertura alla nascita del Bambin Gesù, secondo gli studi del dotto Abate Giuseppe Ricciotti: riposi in pace. Cogliamo l’occasione per porgere a tutti Voi i più sinceri auguri in occasione della Santa Pasqua 2018.
• § 240. L’appartenenza di Giuseppe e della sua famiglia al casato di David, che era originario di Beth-lehem, ebbe ben presto una conseguenza nel campo civile in occasione del censimento ordinato da Roma ed eseguito sotto Quirinio. Di questo famoso censimento abbiamo trattato a parte (§ 183 segg.), e perciò qui supponiamo già note le osservazioni fatte. In Oriente l’attaccamento al proprio luogo d’origine era, ed è tutt’ora, tenace. Presso gli Ebrei una tribù si divideva in grandi «famiglie», le famiglie si suddividevano in casati «paterni» e i casati paterni si frazionavano man mano in nuovi casati che potevano sciamare dall’alveare umano di loro origine e trasferirsi altrove; ma, ovunque andassero, i nuovi raggruppamenti familiari conservavano tenacemente il ricordo dell’alveare originario, sia demograficamente sia geograficamente. Si sapeva, cioè, che il decimo o il ventesimo antenato della propria famiglia era il Tale figlio del Tale, il quale aveva dimorato nella tale borgata, ivi aveva impiantato il suo casato e di là altre discendenze avevano sciamato. La storia degli Arabi è intessuta di nomi quali Banū X, Banū Y, cioè figli di X, figli di Y, come i Banū Quraish a cui appartenne Maometto; e anche oggi non è affatto difficile trovare un arabo, musulmano o cristiano, emigrato in Europa od America, che sappia dire appuntino a quale grande casato egli appartenga e quale regione o borgata sia il centro geografico originario del suo casato. Questo attaccamento al proprio luogo d’origine formava presso i Giudei la base di un censimento, e i Romani nel primo censimento di Quirinio seguirono questa norma locale, sia per le ragioni politiche che già sappiamo (§ 188), sia per frenare in qualche maniera lo spopolamento delle campagne causato dall’inurbanesimo. Perciò, bandito che fu il censimento, su Giuseppe incombé l’obbligo di presentarsi agli ufficiali dell’anagrafe in Beth-lehem, giacché egli era del «casato» e della «famiglia» di David (Luca, 2, 4) la quale era originaria di Beth-lehem.
• § 241. Beth-lehem è oggi una cittadina di circa 20.000 abitanti, situata 9 chilometri a sud di Gerusalemme all’altezza di 770 metri sul mare. Il suo nome era originariamente Beth-Lahamu «casa del (dio) Lahamu», divinità dei Babilonesi venerata anche dai Cananei del posto; sottentrati poi gli Ebrei ai Cananei, il nome finì per essere interpretato nel senso dell’ebraico beth-lehem, «casa del pane». Con l’avvento degli Ebrei in Palestina, s’insediò ivi il casato di Efrata (I Cronache, 2,50-54; 4,4), quindi il luogo fu chiamato sia Efrata sia Beth-lehem (Genesi, 35, 19; Ruth, 1, 2; 4, 11). Ivi, discendendo dal ramo di Isai (Jesse), era nato David (Ruth, 4, 22; I Cron., 2, 13-15). Se Nazareth era d’importanza così scarsa da non essere menzionata da nessun documento antico (§ 228), Beth-lehem a sua volta era un villaggio assai meschino ai tempi di Gesù. Già nel secolo VIII av. Cr. il profeta Michea (5, I ebr.) aveva chiamato Beth-lehem piccola fra le ripartizioni della tribù di Giuda; il villaggio col territorio circostante doveva albergare poco più di 1000 abitanti, in massima parte pastori o poveri contadini. Era però un luogo di passaggio per le carovane che da Gerusalemme scendevano in Egitto: difatti una sosta per carovane, ossia un caravanserraglio vi fu costruita da Chamaam, ch’era forse figlio d’un amico di David (II Samuele, 19, 37 segg.), e perciò fu chiamata «foresteria di Chamaam» (Geremia, 41, 17). Da Nazareth a Beth-lehem sono per la strada odierna 150 chilometri, e ai tempi di Gesù poteva esservi una piccola differenza in meno: era dunque un viaggio di tre o quattro giorni per le carovane d’allora. Non consta con certezza se a presentarsi personalmente in Beth-lehem fosse obbligato soltanto Giuseppe, ovvero pure Maria; ma anche se Maria non era inclusa nella legge, sta di fatto che Giuseppe vi si recò insieme con Maria, la fidanzata di lui, ch’era gravida (Luca, 2, 5 - Le nozze con la coabitazione già erano avvenute, sebbene non ricordate da Luca; ma sembra che intenzionalmente qui Luca impieghi uno a fianco all’altro i due termini fidanzata e gravida per alludere allo stato tuttora virgineo di una donna regolarmente maritata e gestante. L’aggiunta o la sostituzione di moglie - per es. nella Vulgata o nella Siro-sinaitica - sembra dovuta a copisti preoccupati di facilitare il senso). Queste parole possono benissimo valere come delicato accenno ad una almeno delle ragioni per cui venne anche Maria, cioè la vicinanza del parto in cui essa non doveva essere lasciata sola. Ma un’altra ragione - oltre al possibile obbligo di legge - poté essere che i due coniugi pensassero di trasferirsi stabilmente nel luogo originario del casato di David: poiché l’angelo aveva annunziato che Dio avrebbe dato al nascituro il trono di David padre suo (§ 230), quale pensiero più naturale che far ritorno alla patria di David per aspettare ivi l’attuazione dei misteriosi disegni divini? Già da vari secoli il profeta Michea aveva additato appunto la piccola Beth-lehem come luogo di provenienza di colui che avrebbe dominato su Israele (§ 254).
• § 242. Il viaggio dovette essere spossante per Maria, ch’era al nono mese di gravidanza. Le strade della regione, non ancora tracciate e mantenute dai Romani maestri in materia, erano cattive e appena adatte per carovane di cammelli e asini; in quei giorni poi, col subbuglio del censimento, saranno state più frequentate del solito e quindi anche più scomode. I due coniugi, nella migliore delle ipotesi, avranno avuto a loro disposizione un asino, che sarà stato caricato anche delle cibarie e degli oggetti più necessari, uno di quegli asini che ancora oggi in Palestina si vedono precedere una fila di cammelli o seguire un gruppetto di pedoni: i tre o quattro pernottamenti del viaggio saranno stati fatti o in qualche casa amica, o più probabilmente nei luoghi pubblici di sosta sdraiandosi a terra fra gli altri viandanti in mezzo a un cammello ed un asino. Giunti a Bethlehem, le condizioni furono peggiori. Il piccolo villaggio rigurgitava di gente, che si era allogata un po’ dappertutto a cominciare dal caravanserraglio. Questo era forse la vecchia costruzione di Chamaam (§ 241) riattata lungo i secoli; Luca la chiama l’albergo, ma la parola italiana non deve trarre in errore facendo pensare a un’azienda che rassomigli anche lontanamente a una modestissima locanda dei nostri villaggi. Il caravanserraglio d’allora era in sostanza l’odierno khān palestinese (§ 439), cioè un mediocre spazio a cielo scoperto recinto da un muro piuttosto alto e fornito di un’unica porta; internamente, lungo uno o più lati del muro, correva un portico di riparo che per un certo tratto poteva esser chiuso da muretti, e così formava uno stanzone con a fianco qualche altra cameretta più piccola. L’«albergo» era tutto qui; le bestie erano radunate in mezzo, nel cortile a cielo scoperto, e i viandanti si ricoveravano sotto il portico o dentro lo stanzone finché c’era posto, altrimenti s’accampavano fra le bestie: le camerette più piccole, se esistevano, erano riservate a chi poteva permettersi quella comodità pagando. E là, fra quell’ammasso di uomini e di bestie, tutto alla rinfusa si questionava d’affari e si pregava Dio, si cantava e si dormiva, si mangiava e si defecava, si poteva nascere e si poteva morire, tutto fra quel sudiciume e quel lezzo che appestano ancora oggi gli accampamenti di beduini palestinesi in viaggio.
• § 243. Luca ci fa sapere che, quando Giuseppe e Maria giunsero a Bethlehem, non c’era posto per essi nell’albergo (2, 7). Questa frase è più studiata di quanto sembri all’apparenza. Se Luca avesse voluto dire soltanto che il caravanserraglio non poteva contenere più alcuno, gli sarebbe bastato dire che ivi non c’era posto; egli invece aggiunge per essi, non senza riferirsi implicitamente alle loro particolari condizioni, cioè a quelle di Maria nell’imminenza del parto. Potrà sembrare una sottigliezza, ma non è. In Bethlehem Giuseppe avrà avuto senza dubbio conoscenti o anche parenti a cui domandare ospitalità; sia pure che il villaggio era gremito, ma un angoletto per due persone così semplici e dimesse si poteva sempre trovare in Oriente: quando a Gerusalemme affluivano centinaia di migliaia di pellegrini in occasione della Pasqua (§ 74), la capitale rigurgitava non meno che la Bethlehem del censimento, eppure tutti trovavano posto adattandosi. Ma naturalmente, in circostanze di quel genere, diventavano simili a caravanserragli anche le squallide case private, che consistevano di solito in un unico stanzone a pianterreno: tutto vi era in comune, tutto si faceva in pubblico, non c’era riserbo o segretezza di sorta. Perciò si comprende perché Luca specifichi che «non c’era posto per essi»: nell’imminenza del parto, ciò che Maria ricercava era soltanto riserbo e segretezza. E avvenne che, mentre essi erano colà, si compirono i giorni per il parto di lei, e partorì il suo figlio primogenito, e lo infasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia (Luca, 2, 6-7). Qui si parla solo di mangiatoia, ma questo è un indizio ben sicuro alla luce delle costumanze contemporanee. La mangiatoia svela una stalla, e la stalla esige secondo le costumanze d’allora una grotta, una piccola caverna, scavata sul fianco di qualche collinetta nei pressi del villaggio: grotte di questo genere e destinate a questo uso si trovano tuttora in Palestina nei dintorni di gruppi di case. Quella stalla su cui misero gli occhi i due coniugi sarà stata forse occupata parzialmente da bestie, sarà stata tetra e sudicia di letame, ma era alquanto discosta dal villaggio e quindi solitaria e tranquilla; ciò bastava alla futura madre. Perciò, giunti i due a Beth-lehem e vista quell’affluenza di gente, si alloggiarono alla meglio in quella grotta solitaria, in attesa sia di compiere le formalità del censimento, sia del parto che la gestante sentiva imminente. Giuseppe avrà predisposto alla meglio un angolo meno disadatto e meno sudicio, vi avrà preparato un giaciglio di paglia pulita, avrà estratto dalla bisaccia di viaggio le provviste e qualche altra cosa più necessaria disponendole sulla mangiatoia fissata al muro, e tutto fu lì: altre comodità non potevano esigere allora in Palestina quei due viandanti di quel grado sociale, i quali per di più si erano segregati spontaneamente in una grotta da bestie. In conclusione, povertà e purità furono le cause storiche per cui Gesù nacque in una grotta da bestie: la povertà del suo padre legale, che non aveva denaro per affittarsi fra tanti concorrenti una stanza appartata; la purità della sua madre naturale, che volle circondare il suo parto di riverente riserbo.
• § 244. La grotta, fra i luoghi archeologici della vita di Gesù, è quello che ha in suo favore testimonianze più antiche e autorevoli, fuor dei Vangeli. Anche astraendo da vari Apocrifi che ci ricamano attorno molto, nel secolo II Giustino martire, ch’era palestinese di nascita, offre questa preziosa testimonianza: Essendo nato allora il bambino in Bethlehem, poiché Giuseppe non aveva in quel villaggio dove albergare, albergò in una certa grotta dappresso al villaggio e allora, essendo essi colà, Maria partorì il Cristo e lo pose in una mangiatoia, ecc. (Dial. Cum Tryph., 78). Nei primi decenni del secolo III Origene attesta egualmente la grotta e la mangiatoia, e si appella alla tradizione notissima in quei posti e anche presso gli alieni dalla fede (Contra Celsum, 1, 51). Sulla base di questa tradizione Costantino nel 325 ordina che si costruisca sulla grotta la grandiosa basilica (cfr. Eusebio, Vita Constantini, III, 41-43), che nel 333 è ammirata dal pellegrino di Bordeaux e che rispettata nel 614 dai Persiani invasori è tuttora superstite.
• § 245. Venuto alla luce Gesù in questa grotta, Maria l’infasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia. Queste parole del delicato Evangelista medico fanno intendere abbastanza chiaramente che il parto avvenne senza l’usuale assistenza d’altre persone: la madre da se stessa accudisce al neonato, l’infascia e lo ripone sulla mangiatoia. Neppure Giuseppe è nominato. Soltanto le successive narrazioni apocrife s’affanneranno a far venire la levatrice, inviando in giro Giuseppe a cercarla (Protovangelo di Giacomo, 19-20); ma nel racconto di Luca non c’è posto per essa, come già aveva rilevato San Girolamo: Nulla ibi obstetrix, nulla muliercularum sedulitas intercessit; ipsa pannis involvit infantem: ipsa et mater et obstetrix fuit (Adv. Helvidium, 8). Non per nulla la futura madre aveva cercato con cura sì premurosa un luogo solitario e tranquillo. Così dunque Maria partorì il suo figlio primogenito, che l’angelo le aveva preannunziato come erede del trono di David padre suo (§ 230). Senonché il futuro regno del neonato - stando almeno a quelle prime manifestazioni - si prevedeva ben diverso dai regni d’allora, giacché questo erede dinastico aveva per aula regia una stalla, per trono una mangiatoia, per baldacchino le ragnatele pendenti dal soffitto, per nubi d’incenso le esalazioni del letame, per cortigiani due creature umane senza casa. Tuttavia il regno di quell’erede dinastico si annunziava fin d’allora con talune note caratteristiche davvero nuove e del tutto ignote ai regni contemporanei: delle tre persone componenti quella corte stalliera, una rappresentava la verginità, una l’indigenza, tutte e tre l’umiltà e l’innocenza. Esattamente nove chilometri più a settentrione sfolgoreggiava la corte indorata di Erode il Grande, in cui la verginità era parola affatto sconosciuta, l’indigenza era aborrita, l’umiltà e l’innocenza si manifestavano nell’attentare alla vita del proprio padre, nel mettere a morte i propri figli, nell’adulterio, nell’incesto e nella sodomia. Il vero contrasto storico fra le due corti non era tanto fra il letame dell’una e gli ori dell’altra, quanto fra le loro caratteristiche morali.
• § 246. Ad ogni modo al neonato discendente di David spettava bene un omaggio di cortigiani, i quali fossero in condizione sociale non troppo differente da quella di David, già pastore di pecore, e da quella dei due cortigiani fissi che stavano presso al suo trono-mangiatoia; inoltre, poiché l’angelo aveva detto che il neonato sarebbe stato chiamato figlio dell’Altissimo, gli spettava anche più un omaggio di cortigiani dell’Altissimo che si accomunassero in quell’ossequio con i cortigiani bassissimi della terra. Ora, Bethlehem era ed è ancora oggi sui limiti della steppa, ossia di quell’estensione abbandonata e incolta che può essere sfruttata solo a pascolo di greggi. I pochi ovini posseduti dagli abitanti del villaggio erano fatti rientrare durante la notte nelle stalle circostanti, ma i greggi numerosi rimanevano continuamente all’aperto là nella steppa con qualche uomo di guardia: fosse giorno o notte, estate o inverno (§ 174), quelle molte bestie e quei pochi uomini formavano tutta una collettività che viveva della steppa e nella steppa. Pecorai di tal genere riscotevano pessima reputazione presso i Farisei e gli Scribi: in primo luogo la loro stessa vita nomade nella steppa scarseggiante d’acqua li rendeva lerci, fetenti, ignari di tutte le fondamentalissime leggi sulla lavanda delle mani, sulla purità delle stoviglie, sulla scelta dei cibi, e quindi: essi più di chiunque altro costituivano quel «popolo della terra» ch’era degno per i Farisei del più cordiale disprezzo (§ 40); inoltre, passavano per ladri tutti quanti, e si consigliava di non comperare da loro né lana né latte che potevano essere cose refurtive. D’altra parte non si poteva insistere troppo con loro per ricondurli alle osservanze della «tradizione», persuadendoli a lavarsi bene le mani e a sciacquare bene le stoviglie prima di mangiare; erano infatti uomini di nerbo e di fegato, e come non temevano di spaccare col loro bastone la testa al lupo che infastidiva il gregge, così non avrebbero esitato a spaccarla al Fariseo od allo Scriba che avesse infastidito la loro coscienza. Perciò questi esseri abietti e maneschi erano esclusi dai tribunali, e la loro testimonianza - al pari di quella dei ladri e dei rei d’estorsione - non era accettata in giudizio.
• § 247. Senonché, esclusi dalla corte giudiziaria dei Farisei, questi bassissimi pecorai entrano nella corte regale del neonato figlio di David, e vi sono invitati dai celestiali cortigiani dell’Altissimo. C’erano pastori in quella stessa contrada, che dimoravano sul campo e facevano la guardia nella notte sul loro gregge. E un angelo del Signore s’appressò a loro, e la gloria del Signore rifulse attorno a loro, e temettero di gran timore; e l’angelo disse loro: Non temete! Ecco, infatti, vi do la buona novella d’una grande gioia la quale sarà per tutto il popolo, perché fu partorito per voi oggi un salvatore, che è Cristo signore, nel(la) città di David; e segno per voi sia questo: troverete un bambino infasciato e giacente in una mangiatoia. E ad un tratto fu insieme con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodavano Dio e dicevano: Gloria negli altissimi a Dio, e sulla terra pace negli uomini di beneplacito! (Luca, 2, 8-14). Questa scena segue immediatamente il racconto della nascita, e senza dubbio è intenzione del narratore far intendere che tra i due fatti non intercorse se non qualche ora. Dunque Gesù nacque di notte, come notturna è l’apparizione ai pastori.
• § 248. A costoro, dopo la dovuta lode a Dio nei cieli altissimi, si annunzia soltanto una cosa, la pace sulla terra. Veramente la pace allora c’era (§ 225); ma era una pace transitoria, di pochi anni, che equivalgono a pochi secondi sul grande orologio dell’umanità. Di quei pochi secondi aveva approfittato, come di un’istantanea tregua nella procella, per nascere tra gli uomini il salvatore cioè il Cristo (Messia) signore, e cominciava col fare annunziare dai suoi cortigiani celestiali la pace. Ma la sua era una pace di nuovo conio, sottoposta a una nuova condizione. La pace di quei pochi anni era sottoposta alla condizione dell’impero di Roma; era la pax Romana, garantita da 25 legioni, le quali tuttavia qualche anno dopo si mostrarono insufficienti a Teutoburgo amareggiando gli ultimi anni di Augusto. La nuova pace del Cristo signore era sottoposta alla condizione del beneplacito di Dio: coloro che con le loro opere si rendono degni di quel beneplacito e sui quali esso viene a posarsi (i due fatti si richiamano l’un l’altro) otterranno la nuova pace. Costoro sono gli operanti pace e saranno proclamati beati perché ad essi spetta l’appellativo di figli d’Iddio (§ 321). Dalla mirabile apparizione dell’angelo e dalle sue parole i pastori compresero ch’era nato il Messia. Erano uomini rozzi, sì, che non sapevano nulla dell’immensa dottrina dei Farisei; ma, da Israeliti semplici e d’antico stampo, sapevano del Messia promesso dai profeti al loro popolo, e ne avranno spesso parlato durante le lunghe veglie di guardia al gregge. L’angelo, adesso, ne aveva dato anche il segno, un bambino infasciato e giacente su una mangiatoia; forse avrà anche indicato la direzione da prendere per giungere alla grotta. Quei pecorai continuarono cosi a ritrovarsi nel loro ambiente: nelle grotte, se potevano, si rifugiavano anch’essi quand’era gran pioggia o gran freddo; forse più d’uno aveva ricoverato la propria moglie sopra parto egualmente in una grotta, e aveva deposto il suo neonato egualmente dentro una mangiatoia. E adesso sentivano, da chi non poteva ingannare, che pure il Messia si trovava nelle stesse loro condizioni. Andarono quindi verso di lui frettolosi, dice Luca (2, 16), di quella fretta cioè ch’è mossa da familiarità gioiosa: mentre forse con la lentezza appesantita da perplessità ritrosa si sarebbero avviati verso la corte di Erode, se là fosse nato il Messia. Giunsero alla grotta. Trovarono Maria, Giuseppe e il neonato. Ammirarono. Essendo poveri di denaro ma signori di spirito non chiesero nulla, e ritornarono senz’altro alle loro pecore: soltanto sentirono un gran bisogno di lodare Dio e di far sapere ad altri del posto quanto era accaduto. Prima di terminare, l’accorto Luca ammonisce: Maria però conservava tutte queste parole convolgendole nel suo cuore. Già sappiamo che ciò è una delicata allusione alla fonte delle notizie (§142). Fine.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, sempre utilizzando la preziosa «Vita di Gesù Cristo» dell’Abate Giuseppe Ricciotti - riposi in pace -, oggi studieremo brevemente la «Nascita di Giovanni il Battista» e la figura di «San Giuseppe sposo di Maria».
• § 235. Narrati i due episodi paralleli, Luca subito appresso mette in contatto fra loro le due protagoniste. Maria, a cui era stato addotto come prova ciò ch’era avvenuto ad Elisabetta, andò a visitare la sua parente, sia per felicitarsi con lei, sia perché le parole dell’Angelo avevano lasciato chiaramente intravedere che particolari legami avrebbero congiunto i due nascituri come già avevano congiunto le due madri. Per recarsi da Nazareth alla «regione montagnosa» della Giudea (§ 226) il viaggio non era breve: supponendo che la città di Zacharia fosse realmente Ain-Karim, vi s’impiegavano circa tre giorni di carovana. Forse Maria già aveva fatto quel viaggio recandosi a Gerusalemme per le «feste di pellegrinaggio» (§ 74), e in qualche occasione aveva anche visitato la sua parente soggiornando alquanto presso di lei. Ma subito dopo l’annunciazione vi si recò con sollecitudine, entrò inaspettata in casa di Zacharia e salutò Elisabetta. A quell’incontro le due madri furono oggetto di particolari illuminazioni divine. A Zacharia l’Angelo aveva preannunziato che il suo figlio nascituro sarebbe stato ripieno di Spirito santo ancor nel seno di sua madre; costei a sua volta, racchiusasi nel suo riserbo equivalente alla mutolezza di Zacharia, credeva forse che il suo stato di gestante non fosse noto ad alcuno, come a lei non era certamente noto lo stato di gestante di Maria. Ma l’arrivo di Maria fece improvvisa luce su tutto. «E avvenne che, appena Elisabetta udì il saluto di Maria, sobbalzò l’infante nel seno di lei: ed Elisabetta fu ripiena di Spirito santo, e gridando ad alta voce disse: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo! E donde a me questo, che venisse la madre del mio Signore a me? Ecco infatti, appena la voce del tuo saluto fu nelle mie orecchie, sobbalzò in esultanza l’infante nel seno mio! E beata colei la quale credette che vi sarà adempimento alle cose dette a lei da parte del Signore!”» (Luca, I, 41-45). Prima di quell’incontro molte delle cose avvenute erano chiare alle due donne in misura diversa fra loro, ma non poche altre cose rimanevano ancora velate in una misteriosa penombra: quell’incontro fu come una subitanea aurora che getti la sua vivida luce tutt’intorno e faccia riconoscere nitidamente il paesaggio. Era il paesaggio dei disegni di Dio. Elisabetta si trovava conosciuta dentro al suo riserbo, conosceva a sua volta il segreto di Maria, e riconosceva in lei la madre del suo Signore.
• § 236. In Oriente la gioia porta facilmente al canto e all’improvvisazione poetica. Avevano improvvisato anticamente, in occasioni solenni, Maria sorella di Mosè, Debora la profetessa, Anna madre di Samuele, i cui carmi erano conservati nelle Scritture sacre e noti certamente a Maria; e anche fra i Semiti odierni non di rado la donna diventa declamatrice davanti a gioie o a dolori grandi, ed esprime i propri sentimenti in accenni brevi ma incisivi, retti da un vago ritmo più che da rigoroso metro, ispirantisi ordinariamente a temi tradizionali con un’impronta più o meno personale. E in quell’ora di giubilo pure Maria si mostrò poetessa; ispirandosi fra altre Scritture soprattutto al carme di Anna (II Samuele, 2, 1 segg.), ella declamò il suo Magnificat (Luca, I, 46-55): «Magnifica l’anima mia il Signore, ed esulta lo spirito mio sul Dio salvatore mio, poiché rimirò sulla bassezza della schiava sua. Ecco, invero, da ora mi chiameranno beata tutte le generazioni, poiché fece a me cose grandi il Possente, e santo (è) il nome suo. E la misericordia di lui di età in età per quei che lo temono. Operò potenza col braccio suo, disperse orgogliosi nel pensamento del cuor loro. Tirò giù potenti dai troni, e in alto mise bassi; affamati riempì di beni, e ricchi rimandò vuoti. Soccorse Israele servo suo, rammentandosi di misericordia: conforme parlò ai padri nostri, ad Abramo ed alla sua stirpe in eterno». [Alcuni autori - come Loisy, Harnack e Burkitt - attribuiscono il Magnificat a Santa Elisabetta. Si tratta di una fantasiosa stranezza istigata dall’amore di novità, ndR]. L’originale di questo carme fu certamente in semitico, e in realtà sono state proposte varie ritraduzioni (molto facili del resto) dall’odierno testo greco in ebraico. Le reminiscenze letterarie bibliche vi sono insistenti. Ma più insistente ancora è, nel campo psicologico, il contrasto tra bassezza e grandezza, tra tapinità [meschinità, ndR] esaltata e orgoglio depresso, tra fame saziata e sazietà affamata: Maria scorge in se stessa soltanto bassezza da schiava, ma trova anche che il braccio potente di Dio ha sollevato la piccolezza di lei collocandola sul trono, compiendo in lei cose grandi, tanto ch’ella prevede che la chiameranno beata in tutte le generazioni. Si poteva immaginare una predizione più «inverosimile» di questa? Era circa l’anno 6 av. Cr., e una fanciulla di neppur 15 anni, sprovvista di beni di fortuna e d’ogni altro titolo sociale, sconosciuta ai suoi connazionali e dimorante in un villaggio egualmente ad essi sconosciuto, proclamava fiduciosamente che la chiameranno beata tutte le generazioni. C’era da prenderla in parola quella fanciulla vaticinante, con la sicurezza assoluta di vederla smentita fin dalla prima generazione! Oggi sono passati venti secoli, e il confronto fra la predizione e la realtà si può fare. Ormai la storia ha tutto l’agio di riscontrare se Maria ha previsto giusto, e se realmente l’umanità oggi esalti lei più che Erode il Grande allora arbitro della Palestina, e più che Caio Giulio Cesare Ottaviano Augusto allora arbitro del mondo.
• § 237. Presso Elisabetta Maria rimase tre mesi, cioè fino al tempo del parto della ospitante, e poi tornò a Nazareth: non risulta con certezza se era ancora in casa di Zacharia al tempo del parto, essendovi ragioni pro e contro. A suo tempo Elisabetta partorì un figlio, e sparsasi la notizia del caso straordinario, parenti e vicini vennero a congratularsi con lei. L’ottavo giorno dalla nascita, come era prescrizione (§ 69), si doveva circoncidere il neonato e imporgli il nome; ma, su quest’ultimo punto, sorse dissenso. Di solito s’imponeva il nome del nonno, per continuare l’onomastica di famiglia e nello stesso tempo evitare confusioni col padre; ma in quel caso straordinario, con un padre muto e vecchio quanto un nonno, si poteva ben fare un’eccezione all’usanza e continuare l’onomastica di famiglia imponendo al figlio il nome del padre. Tutti infatti sostenevano che il bambino doveva chiamarsi Zacharia; la madre, invece, sosteneva che doveva chiamarsi Giovanni, ed ella ne sapeva ben la ragione (§ 226). Ma gli zelanti amici non si spiegavano quella stranezza, tanto più che nessuno nel casato di Zacharia si chiamava Giovanni. Sulla decisione della madre poteva prevalere solo quella del padre: quindi gli zelanti si rivolsero al padre. Ma egli era muto, e forse anche sordo, e perciò solo a mezzo di gesti gli fecero comprendere la loro domanda. Il muto allora chiese una tavoletta cerata, di quelle usate per brevi scritture, e vi scrisse sopra: «Giovanni è il suo nome». Il nome era fissato, e tutti rimasero meravigliati. Ma, ormai, anche il segno di prova e di purificazione dato dall’angelo a Zacharia, cioè la sua mutolezza, non aveva più ragione di essere, perché tutto si era adempiuto, e la futura sorte del neonato era stata delineata bastevolmente dalle varie circostanze della sua nascita. Quindi, subito dopo fissato il nome del figlio (Luca, I, 64), Zacharia riacquistò la favella e parlò benedicendo Dio. Tutti gli astanti, stupiti, previdero grandi cose riguardo al bambino, e Zacharia fu riempito di Spirito santo e profetò dicendo: «Benedetto il Signore, Iddio d’Israele, ecc». È il cantico Benedictus (Luca, I, 68-79), usitatissimo nella liturgia cristiana, che esalta l’adempimento delle promesse di salvezza fatte da Dio ad Israele, e vede nel neonato il precursore di questo adempimento, essendo egli colui che andrà innanzi al Signore a preparare le vie di lui. Il salvatore dunque era imminente, essendo già comparso il suo battistrada. Se il mondo potente d’allora, in Israele e fuori d’Israele, non sapeva ancora nulla né dell’uno né dell’altro, ciò non aveva importanza, perché le vie del salvatore e del suo battistrada non erano le vie del mondo, e non già i potenti andava Dio scegliendo per attuare il suo piano di salvezza, bensì gli ignoti, gli appartati, gli umili, quali erano Zacharia, Elisabetta, Maria. Una sola cosa aveva accettato Dio dal mondo dei potenti d’allora, quasi condizione indispensabile al piano di salvezza, cioè la pace: e allora nel mondo regnava la pace, sotto l’autorità di Roma. Prima di lasciare la narrazione del neonato Giovanni per riprendere quella di Maria, Luca fa un anticipo cronologico comunicando sommariamente che «il bambino cresceva e s’afforzava di spirito e stava nei deserti fino al giorno della sua manifestazione ad Israele» (Luca, I, 80). I deserti a cui qui si allude, e in cui Giovanni si sarà trasferito quand’era giovanetto già maturo, erano probabilmente le regioni a sud-est di Gerusalemme note come il deserto della Giudea (cfr. Matteo, III, 1).
Giuseppe sposo di Maria
• § 238. Finora il nostro informatore è stato Luca, ma a questo punto è necessario anche ascoltare Matteo, che narra lo stesso fatto del concepimento di Gesù molto più stringatamente, non senza però aggiungervi qualche elemento nuovo. Nella narrazione di Matteo figura in primo piano Giuseppe, che invece nella narrazione di Luca era stato appena nominato: ora, come riguardo a Luca argomentiamo a buon diritto che la principale informatrice sia stata Maria stessa o immediatamente o per il tramite di San Giovanni (§ 142), così riguardo a Matteo possiamo ragionevolmente supporre che per questo argomento egli sia ricorso a informatori della Galilea, già in relazioni particolari con Giuseppe, quale poteva essere ad esempio Giacomo il “fratello” di Gesù. Per Matteo, Maria è fidanzata di Giuseppe e prima che coabitino (§ 231) diviene gravida; circa la soprannaturalità del concepimento Giuseppe non è preavvisato, ma solo s’avvede del fatto già compiuto (Matteo, I, 18). Questa scoperta non poté avvenire se non dopo il ritorno di Maria dalla visita a Elisabetta, cioè fra il quarto e il quinto mese di gravidanza; tornata ella a Nazareth, da cui era partita subito dopo l’Annunciazione, le sue condizioni fisiche furono ben presto rilevate da Giuseppe che ne ignorava i precedenti. Ora «Giuseppe, suo marito, essendo giusto e non volendo esporla, deliberò di dimetterla segretamente» (Matteo, I,19). Dopo ciò che già sappiamo circa le condizioni giuridiche dei fidanzati-coniugi presso i Giudei (§ 231), i termini sono chiari: Giuseppe, come legittimo marito, avrebbe potuto dimettere Maria consegnandole la scritta di divorzio, il quale provvedimento avrebbe avuto per conseguenza di esporre la ripudiata alla pubblica disistima; ma, per evitare ciò, Giuseppe pensa di dimetterla segretamente, e prende questa deliberazione essendo (egli) giusto. Di tutto il periodo, quest’ultima frase è la più importante e la vera chiave di spiegazione. In un caso di quel genere un Giudeo retto e onesto, che fosse stato convinto della colpevolezza della donna, le avrebbe consegnato senz’altro la scritta di divorzio, stimandosi non solo in diritto, ma forse anche in dovere, di agire così, poiché una silenziosa e inerte tolleranza poteva sembrare approvazione e complicità. Giuseppe invece, appunto essendo giusto, non agisce così; dunque, egli era convinto dell’innocenza di Maria, e per conseguenza giudicò procedimento iniquo sottoporla al disonore di un divorzio pubblico. D’altra parte come poteva Giuseppe spiegare lo stato attuale di Maria? Avrà egli pensato ad una violenza patita da lei incolpevolmente durante i tre mesi d’assenza? Il silenzio programmatico di Maria su quel punto - silenzio spontaneo presso una riservata fanciulla in quelle condizioni - poteva ben suscitare un sospetto di questo genere. Oppure, avvicinandosi anche più alla realtà, Giuseppe intravide nell’accaduto alcunché di soprannaturale, di divino? Noi non sappiamo, perché Matteo non dice nulla al riguardo: solo che dalla deliberazione di Giuseppe, di rompere il suo legame con Maria segretamente cioè senza danneggiare la fama di lei, concludiamo che agì sia da persona convinta dell’innocenza di Maria, sia da giusto.
• § 239. La perplessità di Giuseppe non fu lunga. Quando però egli ebbe preso questa deliberazione, ecco che un Angelo del Signore gli comparve in sogno, dicendo: «Giuseppe figlio di David, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, poiché il generato in lei è da Spirito santo; partorirà poi un figlio, e lo chiamerai col nome di Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai loro peccati» (Matteo, I, 20-21). Il sogno era stato un mezzo non infrequente nell’Antico Testamento con cui Dio aveva comunicato i Suoi voleri agli uomini; Matteo, l’Evangelista più interessato per l’Antico Testamento (§§ 125, 234), ricorda varie comunicazioni divine per mezzo di sogni (oltre questa, cfr. Matteo, II, 12. 13. 19.22; 27, 19) che non sono ricordate dagli altri Evangelisti. Il nome di Gesù da imporsi al nascituro era già stato comunicato alla madre (§ 230): qui si aggiunge il motivo di questa imposizione, salverà, ecc., fondata sul significato etimologico del nome stesso. Dopo questa dichiarazione imperativa dell’Angelo, Giuseppe prese in casa sua Maria. Si saranno celebrate le cerimonie solite in simili nozze; parenti ed amici saranno accorsi per la meschina festicciuola esteriore, ma rimasero certamente ignari dell’arcano segreto che si celava in seno a quella nuova famiglia. E Giuseppe, l’uomo della tribù di Giuda e del casato di David, il carpentiere di mestiere, fu capo legale di quella famiglia. Fine.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, il lungo articolo d’apertura di oggi si intitola «Toto orbe in pace composito». Il nostro Evento - rivendicano le cronache la Liturgia - avviene in un’ era di pace. Studieremo anche «L’annunzio a Zacharia» e «L’annunzio a Maria». Il libro utilizzato è: «Vita di Gesù Cristo» - Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941 - dell’erudito Abate Giuseppe Ricciotti: riposi in pace. La «Vita di Gesù Cristo» del Ricciotti si contrappone sin da subito agli innumerevoli studi di falsa scienza che i modernisti, insieme con i protestanti, pubblicarono e continuano a pubblicare a vilipendio e bestemmia della Santa Persona di Nostro Signore Gesù Cristo. Il precursore degli attuali divulgatori di menzogne e turpitudini, purtroppo tanti anche in ambito nominalmente cattolico, fu Alfredo Loisy e, proprio contro gli scritti di costui, il Ricciotti dedica particolari approfondimenti.
• «Toto orbe in pace composito». § 225. Gli ultimi anni avanti l’Era Volgare l’Impero romano, ossia l’orbis terrarum, fu in pace. Nell’anno 15 av. Cr. Tiberio e Druso, figliastri di Augusto, avevano sottomesso la Rezia, la Vindelicia e il Norico, fra le Alpi e il Danubio; nel 13 i Dalmati e i Pannoni erano stati ridotti all’obbedienza mediante una spedizione iniziata da Agrippa, genero d’Augusto, e terminata da Tiberio; dal 12 in poi Druso aveva diretto le operazioni guerresche contro i Germani, stabilendo saldamente il dominio di Roma lungo il Reno. Dall’anno 8 av. Cr. comincia un periodo di pace, che non sarà più turbata se non dopo l’Era Volgare con le nuove sollevazioni dei Germani, Dalmati e Pannoni, culminate con la disfatta di Quintilio Varo a Teutoburgo (9 d. Cr.). A Roma, l’Ara Pacis Augustae era stata inaugurata già nel gennaio del 9 av. Cr.; il tempio di Giano, che era stato chiuso due sole volte da Augusto, fu da lui chiuso per la terza volta appunto nell’8 av. Cr., essendo toto orbe in pace composito, come proclama ogni anno la Chiesa in occasione della nascita di Gesù. Augusto, autore di questa pax romana, aveva raggiunto la vetta della sua piramide di gloria, trovandosi in quel periodo per cui non avrebbe dovuto mai morire. Si disse infatti di Augusto che, per il bene di Roma, avrebbe dovuto o non mai nascere o non mai morire: il periodo anteriore al suo dominio assoluto sarebbe quello per cui non avrebbe dovuto mai nascere, e il periodo in cui egli rimase unico padrone del mondo sarebbe quello per cui non avrebbe dovuto morire. E a tale padrone del mondo, appunto in questo secondo periodo, erano riserbati onori fino allora sconosciuti nell’Impero: gli si dedicavano templi e città intere, era proclamato di stirpe non già umana ma divina, egli era il nuovo Giove, era il Giove Salvatore, era l’astro che sorge sul mondo. Non risulta invece che, fra tanti eccelsi titoli, fosse dato ad Augusto quello di principe di pace, che pure non era da lui immeritato nel suo secondo periodo. Ma sette secoli prima un profeta ebreo aveva ben impiegato questo titolo, e insieme con altri che ricordano quelli d’Augusto lo aveva attribuito, precisamente come ultimo e conclusivo titolo, al futuro Messia: «Ci è nato un pargolo, ci fu largito un figlio: fu posto l’impero sull’omero suo. Suo nome sarà “Ammirabile”, “Consigliere”, “Dio”, “Forte”, “Padre sempiterno”, “Principe di pace”» (Isaia, 9, 5). È vero che in ebraico l’espressione «principe di pace» ha un significato più ampio del latino princeps pacis, perché in ebraico «pace» (shalom) designa il «benessere», la «felicità» perfetta; tuttavia il futuro Messia, essendo stato previsto come «principe», non avrebbe mancato di apportare nel suo regno, insieme con la «felicità», anche la pax nel senso latino di esclusione della guerra, giacché ov’è guerra non è pax e tanto meno «felicità».
«L’annunzio a Zacharia»
• § 226. Si era pertanto in tempo di pace, sotto l’imperatore Augusto, ai giorni di Erode re della Giudea (Luca, 1, 5), e correva l’anno 747 di Roma (7 av. Cr.). Viveva allora un sacerdote del Tempio di Gerusalemme, di nome Zacharia, ch’era ammogliato con una donna di stirpe sacerdotale di nome Elisabetta, ed abitava nella «regione montagnosa» di Giuda (Giudea); la città ove egli dimorava è innominata, ma una tradizione risalente fin verso il secolo V la identifica con l’odierna Ain-Karim (S. Giovanni in Montana), a circa 7 chilometri a sud-ovest di Gerusalemme. I due coniugi erano avanzati in età ambedue, e non avevano ricevuto la prima e più gioconda benedizione di un focolare ebraico, cioè la figliolanza: nella loro solitudine s’attristavano, e consci di aver sempre menato una vita tutta dedicata ai grandi principii della religiosità ebraica si chiedevano perché mai Dio li avesse lasciati privi di quella consolazione. Ora, essendo giunto il turno di servizio al Tempio per la classe a cui apparteneva Zacharia, che era l’ottava classe presieduta da Abia (§ 54), egli dalla sua dimora rurale si trasferì a Gerusalemme; essendosi poi fatta l’assegnazione dei singoli uffici per mezzo delle sorti, a Zacharia toccò l’onorevole incarico di offrire l’incenso sull’altare dei profumi, il che avveniva due volte il giorno nel sacrifizio mattutino e in quello vespertino. L’altare dei profumi era collocato nel «santo» (§ 47) ove potevano entrare soltanto i sacerdoti, mentre i laici restavano fuori seguendo da lontano con lo sguardo le cerimonie del sacerdote che entrava e usciva dal «santuario». Entrato pertanto Zacharia, «tutta la moltitudine del popolo stava pregando al di fuori all’ora dell’incenso; ma apparve a lui un angelo del Signore, stante ritto a destra dell’altare dell’incenso. E si turbò Zacharia al vederlo, e timore cadde su lui. Ma l’angelo gli disse: Non temere, Zacharia, perché la tua preghiera fu esaudita, e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio, e tu gli metterai nome Giovanni (Luca, 1, 10-13). Per gli Ebrei più che per gli altri popoli il nomen era un omen, un presagio: nel nostro caso Giovanni, significava Jahvè (Dio d’Israele) fu misericordioso. L’angelo infatti proseguì assicurando lo sbigottito Zacharia che, per quella nascita, il padre e molti altri godrebbero: il fanciullo sarebbe un grande al cospetto di Dio, si asterrebbe dal vino e da ogni bevanda inebriante, sarebbe ripieno di Spirito santo ancor nel seno di sua madre, richiamerebbe molti Israeliti al loro Dio, anzi sarebbe un precursore che con lo spirito e la possanza di Elia incederebbe avanti a Dio stesso per preparare al Signore una degna accoglienza da parte del popolo ben disposto.
• § 227. L’annunzio dell’angelo oltrepassava tutte le previsioni umane. Dal vino e dalle bevande inebrianti si astenevano coloro che facevano voto di «nazireato», ma di solito era un voto temporaneo e non perpetuo: lo Spirito santo secondo le Scritture sacre aveva riempito alcuni profeti o altri personaggi in occasioni speciali, ma del solo Geremia si leggeva ch’era stato destinato da Dio a un’alta missione già nel seno di sua madre; un precursore dell’atteso Messia era stato predetto anticamente dal profeta Malachia (Mal., 3, 1; 4, 5-6) e tutti ritenevano che questo battistrada spirituale sarebbe stato il profeta Elia già salito al cielo su un carro di fuoco, ma il celestiale profeta non avrebbe potuto rinascere quale figlio di Zacharia né trasfondere in altri il suo spirito e la sua possanza. Per queste considerazioni al primo sbigottimento successe in Zacharia una differente sospensione d’animo. «E Zacharia disse all’angelo: A che (segno) conoscerò (vero) questo? Io infatti sono anziano e mia moglie è avanzata nei suoi giorni. - E l’angelo rispondendo gli disse: lo sono Gabriele che sto alla presenza d’Iddio (§ 78), e fui inviato per parlarti e dirti questa buona novella. Ecco però che sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che avverranno queste cose, perché non credesti alle mie parole che si adempiranno a tempo loro» (Luca, 1, 18-20). La punizione, se pur fu tale, serviva da nuova prova della straordinaria promessa; come già negli antichi tempi Abramo, Mosè, e altri personaggi avevano chiesto e ricevuto da Dio qualche «segno» a conferma di promesse divine, così Zacharia ne aveva chiesto uno e lo riceveva di tal genere sulla propria persona che fosse anche una purificazione spirituale. I tempi nuovi, già da antico promessi ad Israele, cominciavano; e il loro annunzio era stato dato inaspettatamente, ma durante la liturgia perenne d’Israele e in un periodo di pace per il mondo intero. Frattanto il popolo fuori del «santuario» attendeva che uscisse il sacerdote, per intonare l’inno che accompagnava il sacrificio da compiersi sull’altare degli olocausti, e si meravigliava dello straordinario indugio. Finalmente Zacharia ricomparve sulla soglia, ma non pronunziò la solita benedizione sul popolo «né poteva parlare a quelli, e conobbero che aveva contemplato una visione nel santuario; egli poi faceva dei gesti, e rimase muto» (Luca, 1, 22). La mutolezza di Zacharia probabilmente impedì che il popolo risapesse il preciso oggetto della visione e le promesse comunicate al veggente; si parlò genericamente d’apparizione, come doveva parlarsene spesso in quel tempo o a ragione o a torto. Terminata la settimana di servizio al Tempio, il muto Zacharia ritornò alla sua città. Poco dopo «sua moglie Elisabetta divenne gravida, e si tenne nascosta per cinque mesi, dicendo: Così il Signore ha agito con me ai giorni in cui volse lo sguardo a toglier via l’obbrobrio mio di tra gli uomini» (Luca, 1, 24-25). L’obbrobrio era la sterilità deprecatissima dagli Ebrei; e ciò è sufficiente a dimostrare che il riserbo in cui si tenne Elisabetta nei primi cinque mesi non era per nascondere la gravidanza, che l’avrebbe invece onorata presso la gente, bensì per ragioni più alte; al sesto mese, infatti, la sua condizione sarà rivelata a un’altra donna a cui servirà da prova di disegni divini. I quali intanto si venivano attuando senza alcuno strepitio, fra il riserbo di Elisabetta e la mutolezza di Zacharia. A questo episodio l’evangelista Luca, che vuol procedere con ordinamento (§§ 114, 140) e predilige le narrazioni abbinate, soggiunge immediatamente un altro episodio che ha parecchi tratti somiglianti al precedente, ma nello stesso tempo segna un grande progresso nell’attuazione dei disegni divini: all’annunzio e concepimento del precursore segue l’annunzio e il concepimento dello stesso Messia Gesù.
«L’annunzio a Maria»
• § 228. Per il nuovo episodio la scena è portata lontano da Gerusalemme e dal suo Tempio, e collocata nella Palestina settentrionale, in Galilea. Ivi, a 140 chilometri da Gerusalemme per la strada odierna, sorge Nazareth, oggi amena cittadina che conta circa 25.000 abitanti, ma che ai tempi di Gesù doveva essere tutt’altro che amena e niente più che trascurabile villaggio. Di Nazareth non si trova alcuna menzione né nell’Antico Testamento, né in Flavio Giuseppe, né nel Talmud; i Vangeli, che soli ne parlano, riportano anche il giudizio sprezzante dato da un uomo di quei dintorni: «Da Nazareth ci può esser qualcosa di buono?» (Giovanni, 1, 46). Tuttavia l’insediamento umano vi doveva essere molto antico; recenti investigazioni archeologiche, fatte attorno al santuario locale dell’Annunciazione, hanno riportato in luce numerose grotte aperte artificialmente nel pendio della collina; le quali, se più rozze e spoglie, servivano da depositi di vettovaglie, se invece erano più comode e vi era stata aggiunta sul davanti qualche elementare costruzione servivano anche da abitazioni. La Nazareth dei tempi di Gesù doveva restringersi alla parte orientale dell’odierna cittadina, quella che guarda dall’alto verso la vallata di Esdrelon. Siccome, poi, nella Palestina antica un insediamento umano appare provocato sempre da una sorgente d’acqua, anche a Nazareth non mancava una fonte; è quella chiamata oggi «Fontana della Madonna» attorno a cui gli Apocrifi lavorano parecchio di fantasia, ma che ai tempi di Gesù doveva essere forse il solo richiamo verso il villaggio per le assetate carovane che passavano lungo i dintorni. Forse la sua posizione alta rispetto alla pianura orientale aveva procurato a quell’accolta di stamberghe semi-trogloditiche il nome di Nasrath, Nasrah [abbiamo adeguato i caratteri usati, ndR] col significato originario di «guardiana», «custodiente» (più che di «fiore» o «germoglio»). Ora, in uno degli abituri di Nazareth viveva «una vergine fidanzata ad un uomo di nome Giuseppe, del casato di David, e il nome della vergine (era) Maria» (Luca, 1, 27). Al casato di David apparteneva, oltre a Giuseppe, anche Maria: né deve far meraviglia di trovare discendenti di un casato anticamente così glorioso confinati in un villaggio così meschino e anche così lontano dalla culla del casato, che era Beth-lehem; già da secoli la stirpe di David viveva una vita oscura ed appartata, e neppure al tempo del risorgimento nazionale sotto i Maccabei essa si era segnalata per benemerenze speciali; questa vita da semplici privati aveva favorito anche l’allontanamento dei discendenti del casato dal centro originario, molti dei quali erano andati a stabilirsi nei vari luoghi della Palestina ove i loro interessi li chiamavano, senza però dimenticare i propri legami col luogo d’origine.
• § 229. Il nome Maria, in ebraico Mirjam, era assai frequente ai tempi di Gesù, mentre nell’antica storia ebraica appare portato soltanto dalla sorella di Mosè: il suo significato è del tutto incerto, nonostante le moltissime interpretazioni (più d’una sessantina) che se ne sono proposte; del resto sembra che ai tempi di Gesù la pronunzia ebraica originaria fosse stata mutata in quella di Marjam, con introduzione d’un nuovo significato. Della famiglia di Maria nulla dicono i Vangeli canonici, mentre gli Apocrifi dicono anche troppe cose: solo incidentalmente è ricordata una sua «sorella» (Giovanni, 19, 25). D’altra parte ci vien detto che «Elisabetta era parente di Maria» (Luca, 1, 36); ma questa parentela, di cui non si può precisare il grado, era certamente il risultato di un precedente matrimonio fra estranei, perché Elisabetta era di stirpe sacerdotale (§ 226) e quindi apparteneva alla tribù di Levi, mentre Maria, essendo del casato di David, apparteneva alla tribù di Giuda: forse Elisabetta discendeva da padre Levita e da madre del casato di David.
• § 230. Ora, il sesto mese della gravidanza di Elisabetta (Luca, 1, 26), lo stesso angelo Gabriele che aveva preannunziato quel concepimento, fu da Dio inviato a Nazareth da Maria, «ed entrato da lei disse: Salve, piena di grazia! il Signore (è) con te! Ma ella a quel discorso si turbò, e andava ragionando seco che genere di saluto fosse questo» (Luca, 1, 28-29). Come nel precedente episodio di Zacharia, abbiamo anche qui l’apparizione inaspettata e il turbamento di chi la contempla; ma questa volta il turbamento è prodotto, non dalla visione in sé, bensì dalle grandiose parole udite ch’erano stimate sproporzionate alla destinataria. Era dunque il turbamento dello spirito ch’è umile ed ha coscienza della propria bassezza (Luca, 1, 48): non era il turbamento che raggiungesse lo spavento, perché anche in presenza dell’apparizione Maria andava ragionando seco. Secondo l’apocrifo Protovangelo di Giacomo (§ 97) l’apparizione sarebbe avvenuta presso la fontana di Nazareth, mentre Maria si preparava ad attingere acqua; è infatti inclinazione degli Apocrifi far accadere i fatti in palese, ma la narrazione evangelica mostra che il nuovo episodio accadde in segreto, perché l’angelo parlò a Maria «entrato da lei», cioè in sua casa, ch’era certamente una delle umilissime del villaggio. E l’angelo le disse: «Non temere, Maria! Trovasti infatti grazia presso iddio. Ed ecco concepirai in seno e partorirai un figlio, e lo chiamerai col nome di Gesù. Costui sarò grande, e figlio dell’Altissimo sarà chiamato; e il Signore Iddio darò a lui il trono di David padre suo, e regnerà sul casato di Giacobbe per i secoli e il suo regno non avrò fine» (Luca, 1, 30-33). Questo annunzio, sebbene solennissimo, è stato in qualche maniera preparato dal grandioso saluto dell’angelo stesso; chi è piena di grazia ed ha il Signore con sé trova la spiegazione di queste sue prerogative nei fatti presentati dall’annunzio: il quale poi si riferisce direttamente al Messia, ed usa concetti messianici dell’Antico Testamento (cfr. II Samuele, 7, 16; Salmo ebr. 89, 30.37; Isaia, 9, 6; Michea, 4, 7; Daniele, 7, 14; ecc;). Lo stesso nome da imporsi al nascituro è preannunziato, come il nome del figlio di Zacharia: infatti Gesù, in ebraico Jeshu (forma abbreviata di Jehoshua [ibid.] ossia «Giosuè»), significa Jahvè salvò, quindi l’ufficio del nascituro sarà quello di operare una salvezza da parte del Dio Jahvè. In conclusione, l’angelo ha annunziato a Maria che diverrà madre del futuro Messia. L’annunziata non discute il messaggio, né imita Zacharia nel chiedere una prova dimostrativa: prende bensì a considerare la maniera meno onorifica per lei in cui poteva avvenire quella sua maternità, ch’era la maniera del concepimento naturale comune a tutti gli uomini, non escluso il figlio di Zacharia tuttora in gestazione. Contro questa maniera Maria ha una sua obiezione, ch’ella presenta come domanda di schiarimento: «Disse però Maria all’angelo: Come sarò ciò, poiché non conosco uomo?» È la frase eufemistica, usuale in ebraico, per alludere alla causa del concepimento avvenuto in una donna secondo le leggi naturali. Per valutare il significato di questa frase in quanto pronunziata da Maria bisogna aver presente ciò che Luca poco prima ha detto di lei, cioè che era «una vergine fidanzata ad un uomo di nome Giuseppe» (§ 228).
• § 231. Presso i Giudei il matrimonio legale si compiva, dopo alcune trattative preparatorie, con due procedimenti successivi, che erano il fidanzamento e le nozze. Il fidanzamento non era, come presso di noi oggi, la semplice promessa di futuro matrimonio, bensì era il perfetto contratto legale di matrimonio, ossia il vero matrimonium ratum: quindi la donna fidanzata era già moglie, poteva ricevere la scritta di divorzio dal suo fidanzato-marito, alla morte di costui diventava regolarmente vedova, e in caso d’infedeltà era punita come vera adultera conforme alla norma del Deuteronomio, 22, 23-24; questo stato giuridico è riassunto con esattezza da Filone quando afferma che presso i Giudei, contemporanei di lui e di Gesù, il fidanzamento vale quanto il matrimonio (De special. leg., III, 12). Compiuto questo fidanzamento-matrimonio, i due fidanzati-coniugi restavano nelle rispettive famiglie ancora per qualche tempo, che di solito si protraeva fino a un anno se la fidanzata era una vergine e fino a un mese se era una vedova: questo tempo era impiegato nei preparativi per la nuova casa e per l’arredo familiare. Fra i due fidanzati-coniugi non avrebbero dovuto avvenire, a rigore, relazioni matrimoniali; ma in realtà queste avvenivano comunemente, come attesta la tradizione rabbinica (Ketuboth, I, 5; Jebamoth, IV, 10; babli Ketuboth, 12 a; ecc.), la quale informa anche che tale disordine si riscontrava nella Giudea ma non nella Galilea. Le nozze avvenivano quand’era trascorso il tempo suddetto, e consistevano nell’introduzione solenne della sposa in casa dello sposo: cominciava allora la coabitazione pubblica, e con ciò le formalità legali del matrimonio erano compiute. Generalmente il fidanzamento di una vergine avveniva quando essa era in età fra i 12 e i 13 anni, ma talvolta anche alquanto prima: quindi le nozze, in conseguenza di quanto si è visto sopra, cadevano di solito fra i 13 e i 14 anni. Tale era probabilmente l’età di Maria all’apparizione dell’angelo. L’uomo si fidanzava fra i 18 e i 24, e perciò questa doveva essere l’età di Giuseppe. Concludendo, sappiamo da Luca che Maria era una vergine in questa condizione di fidanzata; inoltre, da Matteo, 1, 18, apprendiamo che ella divenne gravida prima che andasse a coabitare con Giuseppe, cioè prima delle nozze giudaiche. Alla luce di queste notizie, quale significato hanno le sue parole rivolte all’angelo: «Come sarò ciò, poiché non conosco uomo».
• § 232. Prese isolatamente in se stesse, non possono avere che uno di questi due sensi: o richiamare alla memoria la nota legge di natura per cui ogni figlio presuppone un padre; oppure esprimere per il futuro il proposito di non sottoporsi a questa legge e quindi di rinunziare alla figliolanza. Un terzo senso, per quanto ci si pensi, non è dato scoprirlo. Ora, in bocca a Maria, fidanzata giudea, le parole in questione non possono avere il primo di questi due sensi, perché sarebbero state di una puerilità sconcertante, tale da costituire un vero non-senso; a chi avesse espresso un pensiero di tal genere, se era una fidanzata giudea, era facile replicare: «Ciò che non è avvenuto fino ad oggi, può avvenire regolarmente domani». È quindi inevitabile il secondo senso, nel quale il verbo «non conosco» non si riferisce soltanto alle condizioni presenti ma si estende anche alle future, esprimendo cioè un proposito per l’avvenire: tutte le lingue, infatti, conoscono questo impiego del presente esteso al futuro, tanto più se tra presente e futuro non cade interruzione e se si tratta di uno stato sociale (non mi sposo; non mi fo prete, avvocato, ecc.). Se Maria non fosse stata una fidanzata-coniuge le sue parole, un po’ forzatamente, avrebbero potuto interpretarsi come un implicito desiderio di avere un compagno nella propria vita: ma nel caso effettivo di Maria il compagno già c’era, legittimo e regolare; quindi, se l’annunzio dell’angelo avesse dovuto avverarsi in maniera naturale, non esisteva alcun ostacolo. E invece l’ostacolo esisteva: era rappresentato da quel «non conosco», che valeva come un proposito per il futuro, e che giustificava pienamente la domanda «come sarò ciò?». L’unanime tradizione cristiana, che ha interpretato in tal senso il non conosco, ha battuto una strada che è certamente la più agevole e facile ma anche l’unica ragionevole e logica. Se però Maria aveva fatto il proposito di rimaner vergine, perché aveva in precedenza acconsentito a contrarre il giudaico fidanzamento-matrimonio? Su questo punto i Vangeli non offrono spiegazioni, ma se ne possono trovare riportandosi alle usanze giudaiche contemporanee. Certamente nell’antico ebraismo lo stato celibe o nubile non era affatto apprezzato, e la principale preoccupazione familiare era la figliolanza e più numerosa possibile: la mancanza di figli era reputata una maledizione di Dio (Deuteronomio, 7, 14). Si conoscono soltanto, fra gli uomini, l’antico caso del profeta Geremia rimasto celibe per dedicarsi totalmente alla sua missione di profeta (Geremia, 16, 2 segg.), e ai tempi di Gesù il caso degli Esseni che contraevano matrimonio o eccezionalmente o forse mai (§ 44). Quanto alle donne, non si saprebbe che caso citare; la donna senza marito e senza figli era per gli Ebrei un essere lugubre. Allorché San Paolo incidentalmente ci fa sapere che c’erano padri i quali reputavano indecoroso d’avere in casa figlie da marito tuttora nubili (I Corinti, 7, 36) non fa che confermare quanto già aveva detto il Siracida, secondo cui un padre non riesce a prendere sonno la notte perché ripensa a sua figlia che si fa anziana senza trovar marito (Ecclesiastico, 42, 9), e quanto più tardi diranno le fonti rabbiniche, secondo cui bisogna sposare la propria figlia appena in età da marito. La donna senza marito era per gli Ebrei come una persona umana senza testa, perché «l’uomo è la testa della donna» (Efesii, 5, 23): e come pensavano in questa maniera gli Ebrei e in genere gli altri Semiti antichi, così pensano ancora oggi gli Arabi, fra cui vige il proverbio che per una ragazza non c’è che un solo corteo, o quello nuziale o quello funebre.
• § 233. Cedendo dunque a questa tirannica usanza comune, Maria si era fidanzata; ma il suo stesso proposito, così fiduciosamente obiettato all’angelo, illumina di riflesso anche la disposizione del suo fidanzato Giuseppe, il quale non sarebbe mai stato accettato come fidanzato se non avesse deciso di rispettare il proposito di Maria: la disposizione di Giuseppe, poi, trova un bel parallelo storico nel celibato degli Esseni testé ricordato. Più in là di questo i Vangeli non dicono; ma come il proposito di Maria risulta nitidamente dalle sue parole, così le altre conseguenze risultano da una conoscenza anche superficiale delle usanze contemporanee. È quanto già aveva scorto Sant’Agostino, con la sua abituale perspicacia, quando scriveva: «Ciò indicano le parole con cui Maria rispose all’angelo che le annunziava un figlio: “Come” disse “sarà ciò, poiché non conosco uomo?”. Il che certamente non avrebbe detto, se già dapprima non avesse fatto voto di sé come vergine a Dio. Ma poiché le costumanze degli Israeliti ancora non ammettevano ciò, ella si sposò con un uomo giusto, il quale avrebbe, non già tolto via con violenza, bensì custodito contro i violenti, ciò di cui ella già aveva fatto voto» (De sancta virginitate, 4). Alla segreta intenzione delle parole di Maria si riferisce l’angelo nella sua replica. E rispondendo l’angelo le disse: «Spirito santo sopravverrà su te, e potenza d’Altissimo adombrerà su te; perciò anche il nato (sarà) santo, sarà chiamato figlio di Dio» (Luca, 1, 35). La questione proposta da Maria «Come sarà ciò...?» è risolta, e insieme il suo proposito è salvadaguardato: la potenza di Dio scenderà direttamente su Maria, e come anticamente nel deserto la gloria di Jahvè si posava a guisa di nuvola sul tabernacolo ebraico adombrandolo (Esodo, 40, 34-35), così adombrerà questo tabernacolo vivente di vergine, e il figlio che da lei nascerà non avrà altro padre che Dio. Questo figlio avvererà in sé l’appellativo di figlio di Dio in maniera perfetta, mentre ad altri personaggi dell’Antico Testamento lo stesso appellativo era stato applicato in maniera incompiuta. Il Messia non avrebbe potuto esser chiamato «figlio» se non da Dio che gli dava dall’eternità la natura divina, e dalla vergine sua madre che gli dava natura umana: nessun’altra creatura umana l’avrebbe chiamato, a rigore di termine, con quel nome. Oramai la proposta dell’angelo è pienamente presentata; Maria che, pur non dubitando, ha chiesto uno schiarimento, lo ha ottenuto. Non manca che l’assenso di lei, perché tutto si compia. Ma il parallelismo, e anche l’intreccio, di questo episodio con quello precedente di Zacharia continua ancora: come l’annunzio, così una prova del nuovo annunzio è data egualmente a Maria che non l’aveva richiesta. Perciò l’angelo continuò: «Ed ecco Elisabetta, la parente tua, anch’essa ha concepito un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese (di gravidanza) per lei ch’è chiamata sterile; poiché non è impossibile presso Iddio qualunque cosa» (Luca, 1, 36-37).
• § 234. Alla non richiesta prova Maria non replica, ma risponde soltanto: «Ecco la schiava del Signore: avvenga a me secondo la tua parola!» (Luca, 1, 38). L’abitatrice del tugurio di Nazareth, benché eletta ad esser madre del Messia, ha tuttora perfetta coscienza della sua bassezza (§ 230) e perciò si chiama, non già ministra o cooperatrice di Dio, bensì una schiava, cioè una di quelle miserabili creature ch’erano al livello più basso della società umana; solo dopo ciò ella dà il suo assenso alla proposta dell’angelo. E allora il Verbo diventò carne (Giovanni, 1, 14), ossia l’umanità numerò tra i suoi figli il Messia. Già sette secoli prima, il profeta Isaia aveva preannunziato uno straordinario segno divino con queste parole: «Ecco, la vergine è gravida e partoriente un figlio, ed ella lo chiamerà col nome di “Immanu’El” (Con-noi-Dio)» (Isaia, 7, 14). Matteo, premuroso di far rilevare l’avveramento delle antiche profezie messianiche (§ 125), cita questa profezia di Isaia come adempiutasi in Gesù e nella sua madre (Matteo, 1, 22-23). Al contrario per la tradizione giudaica la profezia di Isaia rimase un libro chiuso con sette sigilli, e negli scritti rabbinici non esiste il più lontano accenno alla partenogenesi del Messia. Fine.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Comunicato numero 103. I razionalisti e la vita di Gesù (Ultima parte)
- Comunicato numero 102. I razionalisti e la vita di Gesù (Quinta parte)
- Comunicato numero 101. I razionalisti e la vita di Gesù (Quarta parte)
- Comunicato numero 100. I razionalisti e la vita di Gesù (Terza parte)
- Quote: rinnovo tessera e nuove iscrizioni anno 2018
- Comunicato numero 99. I razionalisti e la vita di Gesù (Seconda parte)
- Comunicato numero 98. I razionalisti e la vita di Gesù (Prima parte)
- Comunicato numero 97. L’aspetto fisico di Gesù
- Comunicato numero 96. Il censimento di Quirinio
- Comunicato numero 95. Data della morte di Gesù
























![[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1](/images/stories/virtuemart/product/resized/[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1_0x130.jpg)