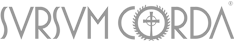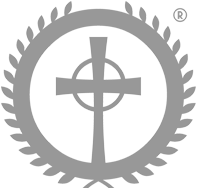Stimati Associati e gentili Sostenitori, abbiamo caricato sul nostro canale Youtube il prezioso video: «Abate Giuseppe Ricciotti sull’eutanasia: il suicidio commissionato». Segue la trascrizione dell’intervento: «Suicida è il malato che, essendo disperato della sua salute, vuole morire. Omicida è il medico che accetta quasi la commissione del malato disperato e acconsente di ucciderlo. Abbiamo, cioè, un suicidio commissionato. Questo è lecito? Questo è accettabile da una morale seria? No, perché la vita è un deposito che noi abbiamo e che non abbiamo creato da noi stessi. La vita, in altre parole, è un posto di battaglia che noi riceviamo da un alto Capitano e non possiamo in nessuna maniera abbandonare questo posto di battaglia, anche se è doloroso, anche se è faticoso».
Stimati Associati e gentili Sostenitori, abbiamo caricato sul nostro canale Youtube il prezioso video: «Abate Giuseppe Ricciotti sull’eutanasia: il suicidio commissionato». Segue la trascrizione dell’intervento: «Suicida è il malato che, essendo disperato della sua salute, vuole morire. Omicida è il medico che accetta quasi la commissione del malato disperato e acconsente di ucciderlo. Abbiamo, cioè, un suicidio commissionato. Questo è lecito? Questo è accettabile da una morale seria? No, perché la vita è un deposito che noi abbiamo e che non abbiamo creato da noi stessi. La vita, in altre parole, è un posto di battaglia che noi riceviamo da un alto Capitano e non possiamo in nessuna maniera abbandonare questo posto di battaglia, anche se è doloroso, anche se è faticoso».
• Veniamo, adesso, agli odierni argomenti di studio della Sacra Scrittura: «Il giudice iniquo. Il fariseo e il pubblicano». § 477. Il precedente dialogo [sulla Parusia] ebbe uno strascico. Come prospettiva terrena, il dialogo aveva pronunziato parole di colore oscuro, che avevano lasciato prevedere, oltre alla sofferenza suprema ed alla riprovazione del maestro, anche quei giorni di distretta e di calamità in cui i discepoli avrebbero desiderato invano di vedere uno solo dei giorni trionfali del figlio dell’uomo. Ma, se in quei giorni di prova i discepoli avessero pregato, non sarebbero stati esauditi? La prova non sarebbe stata abbreviata? Iddio non avrebbe reso giustizia ai suoi eletti, facendo un piccolo anticipo al trionfo finale del figlio dell’uomo? Si, certamente; e Gesù espresse questo insegnamento con una parabola molto simile a quella dell’amico importuno (§ 443) e riportata dal solo San Luca (18, 18) appunto dopo il precedente dialogo: «Diceva poi loro una parabola riguardo alla necessità che essi pregassero sempre e non si stancassero». C’era in una città un giudice che non aveva né timor di Dio né riguardo per uomini. Nella stessa città c’era anche una povera vedova che, come di solito le vedove nell’antichità, riceveva continui soprusi da un tale. La vedova ricorreva ogni tanto dal giudice racccomandandosi: «Rendimi giustizia del mio persecutore!». - Per un pezzo il giudice non se lo dette per intesa, ma alla fine, seccato per l’insistenza della donna, fece tra sé questo ragionamento: «Se pur non temo Iddio né ho riguardo per uomo, tuttavia per il fastidio che mi dà questa donna le renderò giustizia, affinché non venga alla fine a rompermi la testa». - Finita qui la parabola, Gesù soggiunse: «Udiste che cosa dice il giudice iniquo? E Iddio forse non farà giustizia dei suoi eletti che gridano a lui di giorno e di notte ed è lento a loro riguardo? Vi dico che farà giustizia di essi con celerità!. Senonché il figlio dell’uomo, venuto (che sia), troverà la fede sulla terra?». Quest’ultima proposizione non mostra una chiara connessione logica con ciò che precede, e non senza fondamento si è pensato che essa sia un detto staccato di Gesù proveniente da altro discorso. La proposizione sembra aver presenti i tempi in cui i discepoli desidereranno vedere un solo dei giorni del figlio dell’uomo e non lo vedranno (§ 475); quei tempi saranno così duri e calamitosi che scoteranno la fiducia di moltissimi (cfr. Matteo, 24, 12; Marco, 13, 22), tanto che in tono retorico si può ben domandare se «il figlio dell’uomo... troverà la fede sulla terra». Checché sia del senso e riferimento di questa proposizione, è noto che i cristiani delle prime generazioni fecero un particolare assegnamento su queste promesse. Stretti fra persecuzioni incessanti, essi anelarono di vedere il giorno del figlio dell’uomo, in cui il Cristo trionfatore calasse dalle nubi a rendere loro giustizia: e attesero di vedere questa giustizia con celerità e di contemplare la grande rivelazione del figlio dell’uomo da un giorno all’altro. Ma alla loro ansia furono somministrati correttivi già dagli Apostoli, i quali ammonirono di non perturbarsi «quasicché sia imminente il giorno del Signore» (II Tessalonicesi, 2, 2), e di ricordarsi che «un solo giorno (è) presso il Signore come mille anni, e mille anni come un solo giorno; non ritarda il Signore la promessa» (II Pietro, 3, 8-9). Quei primi cristiani inquadravano la promessa di Gesù nel calendario dell’uomo; gli Apostoli, invece, l’inquadravano nel calendario di Dio.
• § 478. La parabola della vedova, esaudita per la sua insistenza nel pregare, porta ad un’altra riguardante l’indole e le disposizioni spirituali della preghiera: è la parabola, particolare anch’essa a San Luca (18, 9-14), in cui sono attori un Fariseo e un pubblicano, cioè i due estremi della scala su cui erano disposti i valori morali nel giudaismo. La parabola fu indirizzata da Gesù «a taluni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri». Un Fariseo e un pubblicano salgono alla stessa ora nel Tempio di Gerusalemme per pregare. Il Fariseo, nella sua confidente sicurezza di essere giusto, agisce e pensa come tale. S’inoltra egli nell’«atrio degli Israeliti» (§ 47), fino al limite più vicino al «santuario» ove dimora il Dio della sua nazione e della sua setta. Quel Dio è un essere potente: ma per lui, uomo giusto e Fariseo rigoroso, quel Dio ha una predilezione singolare, e quindi egli può trattarlo con una certa familiarità; anzi può trattarlo come un monarca, sì, ma a cui il suddito viene ad elencare una quantità di belle cose fatte in favore di lui. Il Fariseo infatti, messosi là in piedi come pregavano ordinariamente gli Ebrei, comincia il suo elenco: «O Dio, ti ringrazio perché io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, o anche come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana (§ 77); pago la decima di quanto posseggo (§ 36)». La parabola non prosegue nell’elenco; ma questo poté benissimo prolungarsi assai ed enumerare altre elette virtù del Fariseo, come le sciacquature di mani e di stoviglie prima di mangiare, l’astenersi dallo spegnere una lampada in giorno di sabbato, la conoscenza a memoria dei 613 precetti della Torah (§ 30), e tante altre egregie doti dell’inappuntabile Fariseo [il Ricciotti sta facendo del sarcasmo]. In conclusione, Dio è stato beneficato dal Fariseo: l’uomo ha fatto consistere la sua preghiera nell’elencare i benefizi elargiti da lui a Dio, ossia nello sciorinare quelle giustizie umane di cui l’antico profeta aveva sentenziato: «Come panno di mestrui (sono) tutte le nostre giustizie» (Isaia, 64, 5 ebr.). Nel frattempo il pubblicano, conscio del disprezzo decretatogli dai benpensanti del giudaismo e sicuro che lo stesso disprezzo è condiviso da Dio, si è fermato appena all’ingresso dell’atrio, come un mendico mal tollerato; là lontano, senza neppure osare di alzare gli occhi verso il «santuario», egli sta a battersi il petto implorando: «O Dio, sii propizio a me peccatore!». Tutta qui è la preghiera di colui che i rabbini definivano «tanghero» (§ 40), perché egli ha coscienza di non poter donare a Dio nulla di quanto sta donandogli il Fariseo: s’affida quindi alla misericordia di Dio confessandosi peccatore in umiltà profonda: «... io mi rendei Piangendo a quei che volentier perdona. Orribil furon li peccati miei; Ma la bontà infinita ha sì gran braccia, Che prende ciò che si rivolge a lei». (Purgatorio, III, 119-123). Il risultato del contrasto tra questi due uomini fu precisamente la smentita delle loro rispettive coscienze. Concluse infatti Gesù: «Vi dico, questo (il pubblicano) discese giustificato a casa sua a differenza di quello: perché chiunque s’innalza sarà abbassato, mentre chi s’abbassa sarà innalzato». Nessuno meglio di Sant’Agostino ha riassunto in poche linee i punti principali della parabola: «Che cosa (il Fariseo) abbia domandato a Dio, cercalo nelle sue parole: non troverai nulla. Salì per pregare; non volle domandare a Dio, ma lodare se stesso. È poco non domandare a Dio e lodare se stesso: per dippiù, anche insultava chi domandava. Il pubblicano stava lontano, egli tuttavia s’avvicinava a Dio... poco che stesse lontano: neppure alzava gli occhi al cielo... C’è dippiù, si batteva il petto... dicendo: “Signore sii propizio a me peccatore!”. Ecco colui che domanda».

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.




























![[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1](/images/stories/virtuemart/product/resized/[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1_0x130.jpg)