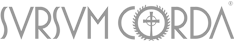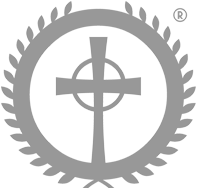Stimati Associati e gentili Sostenitori, sul nostro canale Youtube abbiamo caricato alcuni video, fra i quali una relazione sulla vera umiltà secondo i preziosi studi dell’intramontabile Cornelio ALapide (link per l’ascolto). Se possibile, vi chiediamo altresì di destinare il 5x1000 alla nostra piccola Associazione. È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi (o in allegato ad altri modelli) il nostro codice fiscale - 01944030764 - nell’apposita casellina: «Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale ...». Grazie, Dio Vi benedica! Con questo editoriale diamo inizio allo studio di un altro periodo della vita di Nostro Signore: «Dall’ultima Festa della Dedicazione fino all’ultimo viaggio lungo la Giudea». Il venerando Abate Giuseppe Ricciotti - riposi in pace! - oggi ci parla dell’ultima Festa della Dedicazione.
Stimati Associati e gentili Sostenitori, sul nostro canale Youtube abbiamo caricato alcuni video, fra i quali una relazione sulla vera umiltà secondo i preziosi studi dell’intramontabile Cornelio ALapide (link per l’ascolto). Se possibile, vi chiediamo altresì di destinare il 5x1000 alla nostra piccola Associazione. È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi (o in allegato ad altri modelli) il nostro codice fiscale - 01944030764 - nell’apposita casellina: «Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale ...». Grazie, Dio Vi benedica! Con questo editoriale diamo inizio allo studio di un altro periodo della vita di Nostro Signore: «Dall’ultima Festa della Dedicazione fino all’ultimo viaggio lungo la Giudea». Il venerando Abate Giuseppe Ricciotti - riposi in pace! - oggi ci parla dell’ultima Festa della Dedicazione.
• § 460. Nella precedente operosità di Gesù furono consumati circa due mesi e mezzo, cioè l’intervallo di tempo che separava la Festa dei Tabernacoli (§ 416) da quella delle Encenie, ossia della Dedicazione del Tempio (§ 77). Poiché San Giovanni (10, 22) dice esplicitamente che a quest’ultima festa Gesù intervenne, viene spontaneo identificare questo intervento con uno dei viaggi minori appena accennati da San Luca (§ 415). Era dunque la fine di dicembre dell’anno 29; interrompendo la sua vaga peregrinazione lungo la Giudea, Gesù si recò nella capitale per continuare ivi il suo ministero durante quella nazionalistica «festa dei lumi». La sua presenza in città fu subito notata le recenti discussioni sulla sua missione e il suo aggirarsi nella circostante Giudea avevano reso il Rabbi galileo oggetto di particolare attenzione e sorveglianza da parte delle supreme autorità del giudaismo. Difatti un giorno dell’ottava festiva, mentre Gesù si intratteneva nel Tempio e insegnava passeggiando nel «portico di Salomone» (§ 48) forse a causa della pioggia - il minuzioso San Giovanni ricorda appunto che era inverno - gli vennero attorno i soliti avversari Giudei e gli dissero: «Fino a quando tieni sospeso l’animo nostro? Se tu sei il Cristo (Messia), diccelo francamente!». La forma di questa dichiarazione è non solo amichevole, ma quasi di raccomandazione e di preghiera: si direbbe che quegli interroganti aspettassero soltanto la franca dichiarazione che Gesù era l’aspettato Messia per darsi anima e corpo a lui. La sostanza dell’interrogazione è invece un’insidia: gli avversari aspettano quella franca dichiarazione soltanto per ritorcerla in accusa contro Gesù e rovinarlo, come mostreranno poi i fatti. Il carattere subdolo dell’interrogazione è rivelato da Gesù, il quale risponde fornendo la sostanza della dichiarazione attesa, ma non nella forma desiderata, giacché dichiara chi egli sia, senza però offrire appiglio all’insidia: «Ve (lo) dissi e non credete: le opere che io faccio nel nome del Padre mio, queste attestano circa me; ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore odono la voce mia, e io le conosco e mi seguono; e io do ad esse vita eterna, e non periranno in eterno e non le rapirà alcuno dalla mia mano. Ciò che il Padre mio mi ha dato è maggiore di tutte le cose, e nessuno può rapir(lo) dalla mano del Padre. (Ora), io e il Padre siamo una sola cosa» (Giovanni, 10, 25-30). Gli interroganti avevano sperato che Gesù rispondesse esplicitamente «io sono il Messia»; Gesù invece ha risposto in sostanza «Che io sia il Messia argomentatelo dalle opere che io faccio», evitando una dichiarazione precisa e netta, come già aveva fatto con gli stessi avversari alla Festa dei Tabernacoli (§ 422). Anche il motivo di questa maniera indiretta di rispondere è il medesimo; considerando serenamente i miracoli di Gesù, tutti potevano concludere che era giunto... il regno d’iddio (§ 444) e che egli era il Messia, mentre questo appello ai miracoli non offriva appiglio a denunzie politiche e a violenze; se invece Gesù si fosse con termini espliciti dichiarato Messia davanti a quegli avversari, avrebbe fornito loro occasione di accusano presso le autorità romane come agitatore politico, o anche di trascendere ad atti di violenza immediata contro di lui.
• § 461. Infatti, appena udite le ultime parole di Gesù, i Giudei presero di nuovo le pietre per lapidarlo; l’Evangelista con l’avverbio «di nuovo» vuol ricordare l’analogo tentativo fatto ai Tabernacoli pochi mesi prima. In quell’occasione Gesù si era proclamato anteriore ad Abramo (§ 423), si era descritto come buon pastore di affezionate pecore (§ 432 segg.), ed aveva anche risaputo del tentativo fatto dai Farisei di «rapire dalla sua mano» una di quelle pecore, cioè il cieco nato scacciato dagli inquisitori, ed espulso conseguentemente dalla sinagoga (§ 430). Qui Gesù va assai più oltre: in linea preliminare afferma che gli avversari non credono in lui perché non sono del numero delle sue pecore, e che queste non possono essere rapite via dalla mano di lui come neppure dalla mano del Padre; infine, rivela la ragione fondamentale di tutto ciò, la quale è che Gesù e il Padre sono una sola cosa. Dunque Gesù, pur non proclamandosi esplicitamente Messia, si proclama addirittura Dio? Così interpretarono le sue parole i Giudei con logica inappuntabile, e lo dichiararono apertamente. Vedendoli infatti raccogliere le pietre, Gesù domandò loro: «Molte opere buone vi mostrai (fatte per autorità ricevuta) dal Padre; per quale opera fra esse mi lapidate?». Gli risposero i Giudei: «Per opera buona non ti lapidiamo, ma per bestemmia, e perché, essendo tu uomo, fai te stesso Dio!». Il furore per la lapidazione è momentaneamente calmato: in Oriente sui mercati e nei fondachi, nei luoghi pubblici e nei privati, gli animi si accendono ad un tratto per un nonnulla: si grida, si gesticola, teatralmente, senza conseguenze tragiche. Così avvenne quella volta, e i minacciosi ascoltarono le spiegazioni di Gesù, che disse: «Eppure nella vostra Legge sta scritto quel passo: “Io dissi - Siete Dei -” (cfr. Salmo 82, 6 ebr.). Se dunque Dio stesso, rivolgendosi agli uomini li chiama Dei, e fa ciò nella sacra Scrittura la cui testimonianza è irrefragabile; perché accusate di bestemmia me per aver detto che sono figlio di Dio, se il Padre stesso mi ha santificato e inviato nel mondo? Ad ogni modo, guardate le mie opere: se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete; ma se le faccio, lasciatevi convincere da esse, e allora conoscerete che in me (è) il Padre e io (sono) nel Padre» (Giovanni, 10, 34-38). Nel passo della Scrittura addotto a prova, il termine «Dei» è usato in senso improprio, perché si riferisce ai giudici umani, che rappresentano l’autorità di Dio nei tribunali. La prova tuttavia era efficace come argomento ad hominem, per ridurre al silenzio gli avversari di Gesù rispettosi della sacra Scrittura: se la Scrittura stessa chiamava «Dei» gli uomini, i Giudei non potevano accusarlo di bestemmia avendo egli maggior ragione per attribuirsi quel termine. Anche qui Gesù non scese a particolari, che avrebbero gettato altra esca sul fuoco; tuttavia, riferendosi alla frase incriminata secondo cui egli e il Padre erano una cosa sola, precisò dichiarando «In me (è) il Padre e io (sono) nel Padre». Lungi dall’essere un’attenuazione, questa spiegazione era una conferma della frase. Anche questa volta i Giudei capirono perfettamente, e il fuoco che era appena sopito divampò nuovamente: Cercavano pertanto di nuovo di afferrarlo; ma (egli) uscì fuori dalle loro mani. Quei Giudei erano molto intelligenti: capirono subito e perfettamente ciò che gli Ariani, tre secoli più tardi, non vollero capire, cioè che dalle parole di Gesù risulta indubbiamente che egli si è dichiarato eguale in tutto al Padre. I critici radicali odierni sono intelligenti quanto quegli antichi Giudei, e forse anche più: capiscono anch’essi perfettamente che dalle parole di Gesù risulta una dichiarazione di eguaglianza al Padre, ma parecchi di essi - tanto per non essere da meno degli antichi Ariani - assicurano che Gesù non pronunziò mai quelle parole, le quali sarebbero un’esposizione teorica del dogma cristiano dovuta all’autore del IV Vangelo. [L’Abate Ricciotti si riferisce ad una delle tante e deliranti elucubrazioni dei modernisti in campo biblico ed esegetico. D’altronde riconoscendo la divinità di Nostro Signore, non solo ipocritamente a parole ma ragionevolmente e nei fatti, sarebbe impossibile professare la turpe apostasia dell’ecumenismo: insieme di eresie, infedeltà e menzogne che, al contrario, i modernisti spacciano per cattolicesimo - Qui è possibile ascoltare una relazione dettagliata sull’ecumenismo, ndR] Le prove “storiche” di questa spiegazione sono tutte nell’assicurazione di chi la propone, e nella solita “impossibilità” che Gesù abbia pronunziato quelle parole. Ritorna insomma l’identico procedimento già seguito a proposito dell’episodio di Cesarea di Filippo (§ 398): giacché in sostanza quella critica demolitrice, se è povera e nuda di argomenti storici, è anche monotona e uniforme nei suoi procedimenti dialettici.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.






























![[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1](/images/stories/virtuemart/product/resized/[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1_0x130.jpg)