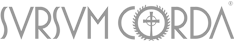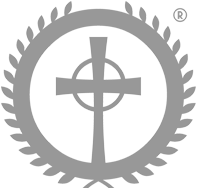Comunicati e Note
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, oggi studieremo, con l’Abate Ricciotti («Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941), il capitolo: «Sadducei, Farisei, Scribi ed altri gruppi giudaici» all’epoca di Gesù.
• § 28. Ai tempi di Gesù i Sadducei ed i Farisei formavano, dentro il popolo giudaico, i suoi due principali raggruppamenti. I quali però non erano delle «sette» nel senso rigoroso della parola, perché non erano staccati dalla compagine morale della nazione; neppure erano confraternite religiose come gli Esseni (§ 44), quantunque i loro principii fondamentali fossero religiosi; e nemmeno mostravano quale prima nota caratteristica un dato atteggiamento politico come gli Erodiani (§ 45), sebbene avessero grande importanza anche nel campo politico e sociale. Erano invece due correnti o tendenze che partivano ambedue da principii solenni nella nazione giudaica, pur essendo fra loro in assoluto contrasto. Esaminandole contemporaneamente, il loro stesso contrasto giova a definirle con precisione. Si crede di solito che i Farisei rappresentassero la corrente conservatrice, e i Sadducei quella liberale e innovatrice: ciò potrà esser vero nel campo pratico, ma in quello giuridico-religioso la designazione dovrebb’essere inversa, perché i Sadducei dal loro punto di vista si presentavano quali conservatori del vero patrimonio morale del giudaismo, e respingevano come innovazioni le dottrine particolari ai Farisei. Le due correnti, infatti, sorsero dal diverso atteggiamento che i vari ceti della nazione presero di fronte all’ellenismo, quando questo venne in urto col giudaismo, cioè dall’epoca dei Maccabei (167 av. Cr.) in poi.
• § 29. L’insurrezione dei Maccabei, diretta contro la politica ellenizzatrice dei monarchi Seleucidi, fu sostenuta specialmente da quei popolani di basso ceto, cordialmente avversi a istituzioni straniere, che si chiamarono gli Asidei - «pii»; al contrario, in seno alla nazione stessa, si mostrarono favorevoli all’ellenismo parecchi altri Giudei ch’erano rimasti abbarbagliati dallo splendore di quella civiltà straniera, ed appartenevano specialmente a classi sacerdotali e facoltose. Rimasta però vincitrice l’insurrezione nazionale-religiosa, gli aristocratici fautori dell’ellenismo entro la nazione giudaica scomparvero o tacquero. Tuttavia poco dopo, stabilitasi la dinastia nazionale degli Asmonei discendenti dai Maccabei, le due correnti ricomparvero apertamente, sebbene con provenienza alquanto mutata; avvenne, cioè, che proprio quei sovrani Asmonei che dovevano il loro trono ai popolani Asidei, si mettessero in contrasto con questi, e si appoggiassero invece sulle classi sacerdotali ed aristocratiche. La ragione del mutamento è chiara. L’ellenismo premeva dall’esterno così gravemente sullo Stato giudaico ricostituito, che i governanti Asmonei non potevano praticamente evitare ogni relazione politica con esso, né impedire numerose infiltrazioni di quella civiltà pagana nei loro territori; senonché quelle relazioni ed infiltrazioni parvero sconfitte politiche e soprattutto apostasie religiose agli Asidei, che perciò si alienarono man mano dai già favoriti Asmonei e divennero ad essi ostili. Passando all’opposizione, essi si chiamarono i «Separati»: in ebraico Perushim, in aramaico Perishajja, donde Farisei (abbiamo fatto un adattamento dei caratteri, ndR). I loro avversari, in maggioranza di stirpe sacerdotale, si chiamarono Sadducei, dal nome di Sadoq antico capostipite d’un insigne casato sacerdotale.
• § 30. Ma da chi, o da che cosa, i Farisei si consideravano «separati»? Il criterio della loro separazione era soprattutto nazionale-religioso, e solo conseguentemente civile e politico: essi si tenevano separati da tutto ciò che non era giudaico e che per tal ragione era anche irreligioso ed impuro, giacché giudaismo, religione e purità legale erano concetti che praticamente non si potevano staccare l’uno dall’altro. Ma qui sorgeva il contrasto, anche dottrinale, con i Sadducei: qual era la vera norma fondamentale del giudaismo? Quale il supremo e inappellabile statuto che doveva governare la nazione eletta? A questa domanda i Sadducei rispondevano che era la Torah, cioè la «Legge» per eccellenza, la «Legge scritta» consegnata da Mosè alla nazione come statuto fondamentale e unico. I Farisei, invece, rispondevano che la Torah, la «Legge scritta», era soltanto una parte, e neppure la principale, dello statuto nazionale-religioso: insieme con essa, e più ampia di essa, esisteva la «Legge orale», costituita dagl’innumerevoli precetti della «tradizione». Questa Legge orale era costituita da un materiale immenso: essa comprendeva, oltre ad elementi narrativi e di altro genere, anche tutto un elaborato sistema di precetti pratici, che si estendeva alle più svariate azioni della vita civile e religiosa, ed andava perciò dalle complicate norme per i sacrifizi del culto fino alla lavanda delle stoviglie prima dei pasti, dalla minuziosa procedura dei pubblici tribunali fino a decidere se era lecito o no mangiare un frutto caduto spontaneamente dall’albero durante il riposo del sabbato. Tutta questa congerie di credenze e di costumanze tradizionali non aveva quasi mai un vero collegamento con la Torah scritta; ma i Farisei scoprivano spesso siffatto collegamento sottoponendo a un’esegesi arbitraria il testo della Torah: e anche quando non ricorrevano a tale metodo, si richiamavano al loro principio fondamentale che Dio aveva dato a Mosè sul Sinai la Torah scritta contenente solo 613 precetti, e inoltre la Legge orale molto più ampia ma non meno obbligatoria.
• § 31. Anzi, anche più obbligatoria. Troviamo infatti che con l’andare del tempo, man mano che i dottori della Legge o Scribi elaboravano sistematicamente l’immenso materiale della tradizione, questo veniva ad assumere un’importanza pratica, se non teoretica, maggiore della Torah scritta. Nel Talmud, che è in sostanza la tradizione codificata, sono contenute sentenze come queste: «Maggior forza hanno le parole degli Scribi che le parole della Torah; perciò anche è peggior cosa andar contro alle parole degli Scribi che alle parole della Torah» (Sanhedrin, XI, 3); infatti «le parole della Torah contengono cose proibite e cose permesse; precetti leggieri e precetti gravi: ma le parole degli Scribi sono tutte gravi» (Berakoth pal., I, 3 b). È chiaro che, stabilito questo principio fondamentale, i Farisei erano in regola, e potevano legiferare quanto volevano estraendo ogni decisione dalla loro Legge orale. Ma appunto questo principio era respinto dai Sadducei, i quali non riconoscevano altro che la Legge scritta, la Torah, non accettando punto la Legge orale e la «tradizione» dei Farisei. Codeste cose - dicevano i Sadducei - erano tutte innovazioni, tutte deformazioni dell’antico e semplice spirito ebraico; essi, i Sadducei, erano i fedeli custodi di quello spirito, i veri «conservatori», e perciò si opponevano agli arbitrari ed interessati sofismi messi fuori da quei modernisti di Farisei. La risposta dei Sadducei era abile senza dubbio; tanto più che con quella parvenza di conservatorismo si evitavano legalmente i carichi pesanti (Matteo, 23, 4) imposti dai Farisei, e si lasciava una porta aperta per intendersi con l’ellenismo e la civiltà greco-romana. Perciò i Sadducei si appoggiarono sui ceti della nobiltà e di governo, che necessariamente dovevano mantenere relazioni con la civiltà straniera; i Farisei, al contrario, si appoggiarono sulla plebe, avversa a tutto ciò ch’era forestiero ed invece attaccatissima a quelle costumanze tradizionali da cui i Farisei estraevano la loro Legge orale. Di qui anche il paradosso per cui i Sadducei erano giuridicamente conservatori ma praticamente lassisti; i Farisei invece apparivano come innovatori riguardo alla Torah scritta, mentre la loro innovazione voleva essere una salvaguardia ed una protezione dell’antico.
• § 32. Le due correnti di Farisei e di Sadducei compaiono per la prima volta, già ben definite ed in contrasto, al tempo del primo degli Asmonei, Giovanni Ircano (134-104 av. Cr.), ch’era anche figlio di Simone ultimo dei Maccabei: benché tale, egli era già in aperta ostilità con i Farisei. L’ostilità divenne furibonda sotto Alessandro Janneo (103-76 av. Cr.), e fra monarca e Farisei si ebbe una guerra di sei anni che fece cinquantamila vittime (Antichità giud., XIII, 376). Al contrario, sotto il regno di Alessandra Salome (76-67 av. Cr.) i Farisei ebbero il loro periodo d’oro, poiché la regina lasciò fare ogni cosa ai Farisei, e comandò che anche il popolo obbedisse a loro...; ella quindi aveva il nome di regina, ma i Farisei avevano il potere (Ivi, 408). Seguirono, naturalmente, le intemperanze della vittoria: gli sconfitti Sadducei, che avevano avuto fino allora la maggioranza nel consiglio del gran Sinedrio, vi rimasero per allora in minoranza esigua; gli antichi avversari dei Farisei o furono messi a morte o presero la via dell’esilio; si arrivò al punto che l’intero paese stava quieto, fatta eccezione dei Farisei (Ivi, 410). Appunto da questo tempo in poi il giudaismo fu sempre improntato dalle dottrine farisaiche. Una certa reazione da parte dei Sadducei si ebbe sotto Aristobulo II, per cui essi parteggiavano, mentre per il suo rivale fratello Ircano II parteggiavano i Farisei: ma in seguito la massa del popolo divenne dominio quasi assoluto dei Farisei, i quali contavano taluni seguaci anche fra i bassi ceti sacerdotali; cosicché, negli ultimi tempi prima del 70, i Sadducei restrinsero la loro autorità al Tempio ed alle grandi famiglie sacerdotali o facoltose accentrate attorno ad esso.
• § 33. Con la catastrofe dell’anno 70 i Sadducei scomparvero dalla storia, e naturalmente il giudaismo posteriore, dominato totalmente dai Farisei, conservò un pessimo ricordo dei Sadducei. Ecco come, sul finire del secolo I dopo Cr., si giudicavano i grandi casati sacerdotali che negli ultimi tempi prima della catastrofe erano stati più famosi: «Guai a me dal casato di Boeto, guai a me dal loro scudiscio! Guai a me dal casato di Cantharos, guai a me dal loro calamo! Guai a me dal casato di Anna, guai a me dal loro sibilo! Guai a me dal casato d’Ismael figlio di Fiabi, guai a me dal loro pugno! Sommi sacerdoti sono essi, tesorieri i loro figli; magistrati del Tempio i loro suoceri, i loro servi vengono con mazze a randellarci!». E questo documento (Tosefta Menahoth, XIII, 21; Pesahim, 57 a, Bar.) non è solitario nei testi rabbinici: inoltre violenze e rapine compiute dall’alto sacerdozio a danno del clero inferiore sono ricordate anche da Flavio Giuseppe (Antichità giud., XX, 179-181).
• § 34. Quanto alle dottrine delle due correnti, ecco come si esprime il loro più antico storico, Flavio Giuseppe: «(I Farisei) hanno fama d’interpretare con accuratezza le leggi e dirigono la setta principale; attribuiscono ogni cosa al Destino ed a Dio, (ritenendo che) l’operare giustamente o no dipende in massima parte dall’uomo, ma il Destino coopera in ciascuna (azione); ogni anima è incorruttibile, ma soltanto quelle dei malvagi sono punite con un castigo eterno. I Sadducei invece, che sono il secondo gruppo, sopprimono assolutamente il Destino, e pongono Dio fuori (della possibilità) di fare alcunché di male o (anche solo) di scorgerlo; essi dicono che è in potere dell’uomo la scelta del bene e del male, e che secondo la decisione di ciascuno avviene la sopravvivenza dell’anima, come pure la punizione e i premi giù nell’Ade. I Farisei sono affezionati fra loro, e promuovono il buon accordo con la comunità; i Sadducei invece sono piuttosto rudi per abitudine anche tra loro, e nelle relazioni con i (loro) simili sono scortesi come con gli stranieri» (Guerra giud., II, 162-166; anche Antichità giud., XIII, 171-173; 288-298; XVII, 41-45; XVIII, 11-17). Si vedono chiaramente, in questi due sistemi di dottrine, le conseguenze del criterio principale che divideva i Sadducei dai Farisei. I primi accettavano la sola Legge scritta: e poiché in essa non trovavano chiaramente formulata una dottrina sulla resurrezione o sull’oltretomba, negavano questi punti; secondo Atti, 23, 8, essi non ammettevano neanche l’esistenza degli angeli e degli spiriti. Quanto al Destino che i Sadducei negavano secondo Flavio Giuseppe, è da vedersi piuttosto la Provvidenza o la Grazia divina. In sostanza, i Sadducei filosoficamente si rassomigliavano agli Epicurei e teologicamente ai Pelagiani. Nel campo pratico la rudezza, attribuita loro dallo storico, doveva essere effetto della loro arroganza aristocratica; ma ci si dice pure che essi, nei giudizi forensi, erano rigorosissimi a differenza dei Farisei che inclinavano alla mitezza.
• § 35. I Farisei estraevano dalla «tradizione» le dottrine respinte dai Sadducei; e poiché lo studio della Legge, specialmente di quella orale, era il dovere più stretto e l’occupazione più nobile per ogni Giudeo, essi si dedicavano totalmente a questo studio. Fu detto, fra l’altro, che è maggiore lo studio della Torah che la costruzione del Tempio (Megillah, 16 b), anzi che è maggiore della venerazione per il padre e per la madre (Ivi), e che l’uomo non deve ritrarsi dalla casa di studio (della Legge) e allontanarsi dalle parole della Torah neppure all’ora della morte (Shabbath, 83 b); inoltre la Torah è maggiore del sacerdozio e della regalità, perché la regalità esige 30 requisiti, il sacerdozio 24, mentre la Torah si acquista con 48, e segue l’enumerazione dei 48 requisiti (Pirqe Aboth, VI, 5-6). Né è da credere che queste norme rimanessero lettera morta perché moltissimi sono gli esempi di Farisei che consacrarono tutta la loro vita allo studio della Legge trascurando ogni altra occupazione, salvo forse l’esercizio di un mestiere manuale per poche ore al giorno, tanto per procurarsi da vivere. Cotesti studiosi della Legge erano consci della loro grandezza: la Legge infatti era l’armamentario da cui doveva estrarsi ogni norma per la vita pubblica e privata, religiosa e civile; quindi essi, custodi di quell’armamentario, erano dappiù del sacerdozio e della regalità. In una nazione ove la massa del popolo accettava pienamente l’idea teocratica, siffatto ragionamento era perfetto; e perciò i Farisei sentivano che la loro forza poggiava, non sulle classi aristocratiche o dell’alto sacerdozio o della corte, bensì sulla massa del popolo.
• § 36. Lo studio farisaico della Legge verteva su tre argomenti principali, che erano il riposo del sabbato (§ 70), il pagamento delle decime e la purità rituale (§ 72): ma, oltre a questi, moltissimi altri argomenti formavano oggetto di lunghe investigazioni. Il metodo di studio si basava in primo luogo sulla conoscenza delle sentenze già emanate dalla «tradizione», e secondariamente sull’applicazione estensiva e sull’ulteriore sviluppo di esse. Il contenuto del Talmud, che fissò in iscritto ciò che per secoli avevano trasmesso a memoria i dottori della Legge, non è in massima parte che una raccolta di tali sentenze (§ 87). Era evidente, in siffatto metodo, il pericolo del formalismo e della casistica, infarciti di sottigliezze ma privi di spirito; e nel pericolo si cadde in massima parte. Chi si trasferisca nell’ambiente storico d’allora, non rimarrà tanto meravigliato di trovare un trattato del Talmud intitolato dai Nidi degli uccelli, e un altro dai Vasi, e un altro dai Picciuoli delle frutta, e altri ancora da argomenti meno decorosi e puliti (§ 72); si domanderà piuttosto su quale impalcatura spirituale poggiava tutto questo immenso scenario giuridico che sembrerebbe campato in aria. L’impalcatura, in realtà, esisteva: era costituita dal sedimento che nell’animo della nazione aveva depositato la predicazione degli antichi profeti, tutta di altissima moralità e di intima religiosità, la quale nei secoli passati era risonata fra il popolo ed anche allora era riecheggiata dalle Scritture sacre lette nelle sinagoghe. Ma troppo poco si badava allora al valore spirituale di quella predicazione, e invece troppi gingillamenti si facevano attorno alla materialità della sua applicazione. Il profluvio dell’ispirazione divina finiva nella morta gora della casistica umana: alla sorgente d’acque vive si preferivano cisterne screpolate che non serbano acqua, come già aveva detto Geremia (2, 13), il quale però aveva anche gridato il rimprovero (8, 8): Come potete dire: «Sapienti noi siamo, e la Torah di Jahvè è con noi? Ecco, invero, a menzogna l’ha ridotta lo stilo menzognero degli scribi!».
• § 37. Sarebbe falso ed ingiusto dire che tutta l’elaborazione della Legge compiuta dai Farisei fosse menzogna: ma moltissimo ciarpame era certamente. In un mare di futilità e di pedanterie erano contenute vere perle preziose, che rappresentavano l’eredità dello spirituale insegnamento profetico: ma troppa sproporzione correva tra l’ampiezza del mare e la scarsità delle perle, tra lo smisurato scenario giuridico e l’esigua impalcatura spirituale, cosicché l’utile restava affogato fra tanto disutile. Ad esempio, sentenza senza dubbio sublime è quella attribuita al celebre Hillel, anteriore a Gesù di pochi anni, il quale ad un pagano, che gli aveva chiesto d’insegnargli tutta la Legge nel breve tempo che fosse riuscito a reggersi su un piede solo, rispose: «Ciò che non desideri per te, non fare al prossimo tuo. Questa è tutta la Legge; il Testo è solo commento. Va’ e impara» (Shabbath, 31 a). Ma sta di fatto che il commento, qui collocato giustamente in seconda linea, in pratica passava in prima linea, e faceva dimenticare la Legge stessa. [Nota bene: Una conferma dell’importanza di questa distinzione è offerta dai vari estratti del Talmud, che dotti israeliti moderni hanno pubblicato recentemente. Questi estratti o riassunti sono tutti esattissimi, senza un errore di citazione o di traduzione: ma storicamente parlando sono falsi per deficienza, perché non danno affatto un’idea adeguata del complesso. Il Talmud ivi presentato è un Talmud del secolo xx, selezionato, cribrato, diminuito almeno di 90 parti su 100, e proprio di quelle 90 parti che rappresentano il Talmud casuistico e storicamente più vero. E se oggi le 10 parti che si offrono sono le più apprezzate, perché moralmente più nobili e più universalmente umane, è lecito credere che in questo apprezzamento c’entri per qualche cosa il cristianesimo; ma non è affatto certo che, anche ai tempi in cui il Talmud era in elaborazione, le stesse 10 parti fossero le più apprezzate da ogni classe del giudaismo, a preferenza delle altre 90 più tipiche e caratteristiche. Assai più agevole, per chi avesse la deplorevole intenzione di denigrare il Talmud, sarebbe farne estratti da quelle 90 parti su cui oggi si sorvola : ma anche in questi casi si farebbero estratti letterariamente veri e storicamente falsi]. Peggio ancora: talvolta il commento contraddiceva alla Legge. È noto che Gesù in un determinato caso rimproverò ai Farisei: «Trasgredite il precetto d’Iddio per la tradizione vostra» (Matteo, 15, 3, 6; Marco, 7, 9); estendendosi poi dal caso singolo all’abitudine generale, aggiunse: «E cose simili di tal genere fate molte» (Marco, 7, 13). Le prove di queste trasgressioni si troverebbero facilmente negli antichi scritti rabbinici; ma è importante rilevare come, appunto riguardo allo studio della Legge, fu sentenziato: «Un pagano che si occupa dello studio della Torah è degno di morte» (Sanhedrin, 59 a), ciò che non era né nella lettera né nello spirito della Legge, ma solo nella gelosia nazionalistica dei Farisei considerata come elemento di «tradizione».
• § 38. Anche riguardo alla condotta pratica dei Farisei non si potrebbe dare un giudizio valevole per tutti. Oltre a maestri veramente insigni, quali Hillel, Gamaliel il Vecchio (cfr. Atti, 5, 34 segg.) che fu maestro di S. Paolo (Atti, 22, 3), e altri, non erano pochi gli onesti ed i sinceri anche fra le persone oscure. Anche da parte cristiana troviamo Gesù in relazioni amichevoli con Farisei, quali Simone, Nicodemo, Giuseppe di Arimatea; perfino S. Paolo, mentre proclama l’abolizione della Legge ebraica, si afferma Ebreo da Ebrei, secondo la Legge Fariseo (Filipp., 3, 5). Tuttavia le invettive più severe di Gesù sono dirette appunto contro i Farisei, non già contro i Sadducei, come appunto nei Farisei egli trovò gli oppositori più tenaci alla sua missione. Il cap. 23 di Matteo è tutto una formale accusa di Gesù contro i Farisei, con allegazione di fatti ben precisi (§ 518). Ma se ciò non sorprende da parte di Gesù, è storicamente importante trovare che accuse simili sono rivolte ai Farisei anche da parte rabbinica. Il Talmud enumera sette tipi diversi di Fariseo che denomina con i precisi termini seguenti il «Fariseo-Sichem», ossia chi è Fariseo per vantaggi materiali (allude al fatto di Sichem, narrato in Genesi, 34); il « Fariseo-niqpi», cioè quatto-quatto, che con la maniera stentata di camminare fa mostra affettata di umiltà; il «Fariseo-salasso», che si procura frequenti emorragie battendo la testa contro i muri, per non guardare donne; il «Fariseo-pestello», che cammina tutto curvo nella persona da sembrare un pestello nel mortaio; il «Fariseo-qual-è-il-mio-dovere-perch’io-lo-faccia?”, cioè colui che non già si esibisce pronto a compiere tutti i suoi doveri, bensì afferma di non poterne compiere altri essendo già occupatissimo; il «Fariseo-per-amore», che opera per amore interessato della mercede, non già per devozione verso Dio; il «Fariseo-per-timore», che opera per timor di Dio, ossia per vero sentimento religioso (Sotah, 22 b, Bar.). Dei sette tipi, dunque, solamente l’ultimo merita lode, e certamente ogni tipo era rappresentato da numerosi individui. Questo elenco, tuttavia, per quanto sarcastico, non è violento. Invece già verso il 10 dopo Cr., cioè prima ancora che Gesù pronunziasse le sue invettive contro i Farisei, poté essere scritto da un anonimo Fariseo il seguente passo, la cui violenza (severità, ndR) non è certo inferiore a quella usata da Gesù: «Sorgeranno su essi (sugli Israeliti) uomini perversi ed empi, che si proclameranno giusti. Essi ecciteranno lo sdegno dei loro amici perché saranno uomini menzogneri, viventi solo per piacere a se stessi, camuffati in tutte le guise, banchettanti volentieri ad ogni ora del giorno e tracannando con la gola... ai poveri (?) divorando i beni, asserendo d’agire per compassione... repellenti, litigiosi, ingannatori, nascondendosi per non lasciarsi conoscere, empi, colmi di delitto e d’iniquità, ripetenti da mane a sera: “Vogliamo aver gozzoviglie ed opulenza, mangiare e bere... ed atteggiarci a principi!”. Le mani e i cuori loro tratteranno cose impure, la bocca loro proferirà cose superbe, eppure diranno: “Non mi toccare, ché tu mi rendi impuro!”» (Assunzione di Mosè, VII, 3-10). Assai probabilmente il disilluso Fariseo che dipinge questo quadro impiega tinte più scure del giusto; ma l’amarezza d’animo, che gli fa scegliere queste tinte, doveva ben essere stata cagionata da fatti reali. Ad ogni modo le invettive di Gesù si riferivano alla condotta pratica dei Farisei più che alle loro dottrine, almeno considerate genericamente; sono chiare in tal senso le sue parole: «Sulla cattedra di Mosè si sedettero gli Scribi ed i Farisei. Perciò, tutte quante le cose che vi dicano, fate ed osservate, ma conforme alle opere loro non fate» (Matteo, 23, 2-3).
• § 39. Quanto alla numerosità dei Farisei, da un passo di Flavio Giuseppe (Antichità giud., XIII, 383) sembra risultare che si aggirassero sugli 8000 ai tempi del re Alessandro Janneo: circa un secolo più tardi, sotto Erode il Grande, si parla di più che 6000 (Ivi, XVII, 42) che dovrebbero essere tutti i Farisei d’allora. Ma probabilmente queste cifre non sono esatte, come spesso avviene in Flavio Giuseppe, e dovranno essere alquanto aumentate. Provenienti dalle varie classi sociali, e in piccola parte anche da quella sacerdotale meno alta, i Farisei erano stretti fra loro con vincoli ben saldi, che miravano al grande scopo di osservare la purità legale e mantenersi «separati» (§ 29) dall’impuro. Tra loro si chiamavano haberim, cioè etimologicamente «collegati», e l’associazione era una haberuth ossia «colleganza». I membri dell’associazione, poveri o ricchi che fossero, dovevano essere di un rigore minuziosissimo nell’osservare i tre gruppi principali di precetti, cioè il riposo del sabbato, le norme di purità legale e le leggi del culto (decime, ecc.): chi poi aveva anche una cultura sufficiente per discutere su questioni legali, era un hakam, cioè un «dotto», mentre chi non l’aveva era un privato qualsiasi, chiamato hedjot (Abbiamo fatto un adattamento dei caratteri, ndR).
Prosegue la prossima settimana ...

Testo ed immagini tratti da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti, 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, abbiamo usato i primi 60 comunicati di Sursum Corda per un’infarinatura apologetica e per iniziare a formarci dottrinalmente su argomenti di particolare attualità, poi altri 10 li abbiamo dedicati ai Comandamenti, infine gli ultimi 6 ad una Breve storia della Religione scritta da Papa san Pio X. Il numero 61 è contro la vanagloria, tratto da Cornelio Alapide. Finalmente è giunto il momento di approfondire la vita di Gesù Cristo. Lo faremo con l’Abate Giuseppe Ricciotti che, negli anni ‘40, contrappone il suo verace lavoro a quelli «dello Strauss, del Renan, del Loisy e di tanti altri (che) ricevettero le loro particolari coloriture soprattutto dallo stato d’animo del rispettivo autore». Dunque una meticolosa e scientifica Vita di Gesù Cristo che l’Autore redige «uscito dal presente e raccolto nel passato, uscito dal sangue (dalla carne) e raccolto nel Vangelo». Evangelicamente impassibile, opera storico-documentaria che «ricerca il fatto antico e non la teoria moderna, la sodezza del documento e non la friabilità d’una sua interpretazione in voga». La Vita di Gesù Cristo che l’Abate Ricciotti contrappone a quelle scritte dai «demolitori, (i quali) rifiutano di abdicare e rimangono tenacemente attaccati ai loro metodi», che tuttavia egli definisce del tutto «superati». Iniziamo a studiare, pertanto, la Vita di Gesù Cristo «costruttrice e non distruttrice». Dio abbia in gloria l’Abate Giuseppe Ricciotti anche per questa e per altre sue opere immortali. Per il momento omettiamo i punti dal § 1 al § 45.
• Tempio e sacerdozio all’epoca di Gesù. § 46. Il giudaismo, conservando anche sotto la dominazione di Roma il suo ordinamento teocratico-nazionale, continuò ad avere il suo centro spirituale in Gerusalemme: ivi, infatti, stava l’unico Tempio eretto legittimamente a Jahvè, il Dio della Nazione, ed in quel Tempio ministrava la gerarchia sacerdotale ch’era al vertice dell’ordinamento teocratico. La nazionalità giudaica implicava la religione giudaica: la religione richiedeva il Tempio di Gerusalemme: il Tempio esigeva il sacerdozio. Non solo da tutta la Palestina, ma anche dalle regioni vicine e lontane su cui si era riversata mediante la Diaspora la nazione di Jahvè, si guardava a Gerusalemme ed al sommo sacerdote, come al luogo più santo e all’uomo più vicino a Dio. Il Tempio frequentato da Gesù fu quello di Erode il Grande. Era dunque, materialmente, il terzo Tempio; il primo infatti, quello costruito da Salomone, era stato distrutto da Nabucodonosor quando aveva espugnato Gerusalemme nel 586 avanti Cristo; il secondo, ricostruito dai reduci dell’esilio babilonese ed inaugurato nel 515 avanti Cristo, era durato fino a Erode; costui lo aveva demolito totalmente per costruire il terzo. Tuttavia i rabbini chiamavano «secondo tempio» anche quello di Erode, considerandolo moralmente tutt’uno col Tempio costruito dai reduci dell’esilio. Erode cominciò i lavori del Tempio l’anno 180 del suo regno, cioè nel 20-19 avanti Cristo; già da prima, per dimostrare al popolo le sue serie intenzioni, egli aveva accumulato materiali in quantità enorme, aveva impegnato diecimila operai che lavorassero alle parti esterne, e aveva fatto imparare l’arte muraria a mille sacerdoti che lavorassero nelle parti interne del Tempio inaccessibili ai laici secondo la Legge ebraica. I lavori per le parti interne, costituenti il vero «santuario», durarono un anno e mezzo; quelli per le parti esterne, costituenti gli amplissimi atrii, durarono otto anni: durante i lavori il servizio liturgico non vi fu mai interrotto, perché man mano che si demoliva una parte dell’edificio interno si procedeva subito alla sua ricostruzione. Dopo nove anni e mezzo dall’inizio dei lavori, Erode celebrò la dedicazione del ricostruito Tempio nell’anniversario della sua salita al trono; tuttavia, come avviene d’ordinario nelle grandi costruzioni, i lavori di rifinitura si prolungarono ancora per molti anni (cfr. Giovanni, 2, 20) e non terminarono del tutto se non ai tempi del procuratore Albino (anni 62-64), cioè poco prima che il Tempio fosse distrutto dai Romani.
• § 47. Nel Tempio di Erode il “santuario” interno era in tutto analogo a quello del Tempio di Salomone, ma con elevazione maggiore; al contrario, le costruzioni esterne che circondavano il ”santuario” furono ampliate grandemente. Poiché l’antico Tempio sorgeva sulla collina orientale della città, il piano superiore della collina fu dilatato quasi del doppio per mezzo di costruzioni compiute ai suoi fianchi: sullo spazio così ottenuto sorsero tre portici o atrii, ch’erano uno più elevato dell’altro, procedendo dalla periferia verso il “santuario” interno. Il primo e più periferico era accessibile a chiunque, e perciò era chiamato “atrio dei gentili”, potendo essere frequentato anche dai pagani; ma, procedendo verso l’interno, ad un certo punto quest’atrio era sbarrato da una balaustra di pietra che segnava il limite accessibile ai pagani: iscrizioni greche e latine, ivi apposte, ricordavano a costoro la proibizione di passare oltre sotto pena di morte (una di queste iscrizioni, in greco, fu ritrovata nel 1871). Oltrepassata la balaustra e saliti più in là alcuni gradini, si entrava nell’“atrio interno”, protetto da grossissimi muri e suddiviso in due parti: la parte più esterna era detta “atrio delle donne”, perché fin lì potevano penetrare le donne israelite, e la più interna era detta “atrio degli Israeliti”, accessibile ai soli uomini. Procedendo e salendo ancora, veniva l’“atrio dei sacerdoti”, ove stava l’altare degli olocausti a cielo scoperto; infine, dopo altri gradini, si giungeva al vero “santuario”. Il “santuario” aveva sul davanti un vestibolo, ed internamente era diviso in due parti. Quella anteriore era chiamata il “santo”, e conteneva l’altare d’oro per i profumi, la mensa per i pani della proposizione e il candelabro d’oro a sette bracci. La parte posteriore era il “santo dei santi”, perché considerata dimora del Dio d’Israele e quindi il luogo “santissimo” di tutta la terra. Ivi, nel Tempio di Salomone, era stata l’Arca dell’Alleanza; ma, distrutta questa, il “santo dei santi” del nuovo Tempio rimase una stanza misteriosamente oscura e vuota. Pompeo Magno, che vi penetrò nel 63 avanti Cristo, vi trovò nulla intus deum effigie vacuam sedem et inania arcana (Tacito, Hist., v, 9). Nel “santo dei santi” entrava soltanto il sommo sacerdote un solo giorno all’anno, nella ricorrenza del Kippur o Espiazione (§ 77); secondo una tradizione rabbinica il sommo sacerdote entrato colà, deponeva il turibolo su una pietra alta tre dita che ricordava il posto ove anticamente era stata l’Arca.
• § 48. L’”atrio dei gentili” era fiancheggiato, ad oriente ed a mezzogiorno, da due famosi portici. L’orientale, che guardava dall’alto sopra il torrente Cedron, era chiamato comunemente ma senza ragione archeologica “portico di Salomone” (Giovanni, 10, 23; Atti, 3, 11; 5, 12); il meridionale, chiamato ”portico regio”, toccava con i suoi due capi la valle del Cedron ad oriente, e la valle del Tyropeon ad occidente. Questo “portico regio” era costruzione veramente insigne, degna di stare a fianco delle più famose di Atene e di Roma, ma mostrava carattere totalmente greco e non aveva nulla di ebraico: era formato da centosessantadue grandi colonne sormontate da finissimi capitelli corinti e disposte in quadruplice fila in modo da costituire una triplice navata. L’“atrio dei gentili” era il gran luogo di convegno per chi abitava o si trovava di passaggio a Gerusalemme. I pagani vi andavano per trattare i loro affari, come nelle loro città sarebbero andati al foro; i Giudei vi si recavano per udire famosi dottori della Legge, che circondati dai loro discepoli tenevano scuola o disputavano fra loro, e più genericamente vi erano attirati dalle mille curiosità del luogo frequentatissimo e dalle notizie d’ogni sorta che vi si potevano raccogliere. Specialmente in occasione delle grandi feste ebraiche l’“atrio dei gentili” diventava un pubblico mercato. I venditori, istallatisi sotto i portici o nel piazzale scoperto, offrivano ai pellegrini giunti dalla Palestina e dall’estero buoi, pecore, ed ogni altra cosa necessaria per i sacrifizi liturgici, mentre i cambiavalute tenevano esposti su banchetti improvvisati i vari tipi di monete palestinesi, pronti a cambiarle con moneta straniera ai pellegrini venuti dall’estero. Soltanto dopo aver oltrepassato quest’inferno di clamore e di fetore, si giungeva al purgatorio, ove al solo Israelita era lecito purgarsi dei suoi peccati davanti a Dio, nel silenzio e nella preghiera.
• § 49. All’angolo nord-ovest del Tempio, e congiunta con esso, s’alzava la fortezza Antonia, anch’essa costruita totalmente da Erode sul posto d’una precedente torre. La grandiosa potenza di questa costruzione fu dimostrata all’atto pratico nella guerra contro Roma, allorché Tito trovò in essa un enorme ostacolo alla conquista del Tempio e della città; Flavio Giuseppe, che ne dà una minuta descrizione, termina con queste importanti notizie archeologiche: Dalle parti ove (la fortezza) si ricongiungeva con i portici del Tempio, aveva in ambedue i lati delle scale per le quali discendevano le guardie - giacché in essa risiedeva sempre una schiera di Romani - e si distribuivano con le armi lungo i portici durante le festività, vigilando che il popolo non tramasse innovazioni. Infatti, alla città sovrastava, come presidio, il Tempio, e al Tempio (sovrastava) l’Antonia; ma in questa stavano le guarnigioni di tutti e tre (i luoghi: città, Tempio ed Antonia) (Guerra giud., v, 243-245). Per questo motivo pratico come anche per la sua vicinanza al Tempio, l’Antonia serviva spesso al procuratore romano - come già accennammo (§ 21) - per il disbrigo d’affari di governo, specialmente se richiedevano un diretto contatto con masse di popolo: in tali casi il palazzo reale di Erode, più lontano dal Tempio e più aristocratico, si prestava meno bene.
• § 50. Nel Tempio dominava il sacerdozio levitico, che aveva a capo il sommo sacerdote: perciò, in forza dell’ordinamento teocratico, il sommo sacerdote era anche il capo di tutta la nazione giudaica, e riuniva in sé la suprema autorità religiosa e anche quella civile. Così era in teoria: ma in pratica, specialmente ai tempi di Gesù, il potere effettivo del sommo sacerdote era assai minore. Gli Asmonei, discendenti dei Maccabei, erano stati nello stesso tempo sommi sacerdoti e re, attuando nuovamente l’antichissimo ideale d’Israele, pur non discendendo essi dalla stirpe di David; ma privati gli Asmonei del trono, i sommi sacerdoti furono eletti, quasi sempre, tra i membri di talune famiglie sacerdotali che avevano particolare influenza e costituivano dentro al ceto sacerdotale una casta d’aristocratici privilegiati. Inoltre il sommo sacerdote era eletto a vita, e solo eccezionalmente nei tempi antichi era stato deposto; ma dai tempi di Erode il Grande l’eccezione era diventata invece un uso comune, e ben raramente i sommi sacerdoti, morivano in carica. Dagli inizi di Erode il Grande fino alla morte di Gesù, che sono circa 65 anni, si contarono una quindicina di sommi sacerdoti, di cui parecchi rimasero in carica un anno e anche meno. I deposti, insieme con gli altri membri delle loro privilegiate famiglie, costituirono quella classe che i Vangeli e Flavio Giuseppe chiamano dei “sommi sacerdoti”. Se questa instabilità noceva molto alla carica del sommo sacerdote, anche più noceva alla sua dignità l’accaparramento che le suaccennate famiglie avevano fatto sia di quell’ufficio sia delle altre cariche più lucrose del Tempio. In occasione delle elezioni pare che abitualmente corresse denaro, ed un detto rabbinico mette appunto in relazione l’instabilità dell’ufficio con la sua venalità: Siccome sommi sacerdoti compravano il loro ufficio, così i loro giorni furono diminuiti (Levit. Rabba, 120 c; cfr. Joma pal., 1, 38 c).
• § 51. Eletto che fosse, il sommo sacerdote era il primo ministro del culto e il capo di tutti i servizi del Tempio. A lui personalmente spettava di celebrare soltanto la liturgia nel giorno del Kippur o Espiazione (§ 77), ma talvolta officiava anche in altre feste più solenni, ad esempio nella Pasqua. Nel campo civile il sommo sacerdote agiva specialmente come capo del Sinedrio (§ 58), la cui presidenza gli spettava di diritto. Ma, qui soprattutto, il suo potere effettivo diminuì dopo la scomparsa degli Asmonei: il loro successore, Erode il Grande, accennava con la sua spada il cammino che il capo del Sinedrio doveva seguire; i procuratori romani non furono così brutali, ma sorvegliavano attentamente la sua condotta e rivedevano le sue decisioni più importanti, anche per fargli comprendere che se egli portava ancora l’infula pontificale non aveva più la corona regale. Anzi gli stessi indumenti pontificali del sommo sacerdote erano custoditi nella fortezza Antonia per una disposizione che risaliva a Erode il Grande o era forse anteriore, e che fu mantenuta in seguito anche dai procuratori: di là erano tolti in occasione delle principali festività, per esservi subito appresso restituiti; tuttavia nell’anno 36, dopo la destituzione di Ponzio Pilato, i Romani rinunziarono a questo diritto, odioso alla sensibilità religiosa dei Giudei. In linea di fatto, poi, il credito morale dei sommi sacerdoti, se non proprio la loro autorità ufficiale, si era molto abbassato ai tempi di Gesù anche per la ragione che essi appartenevano sempre alla corrente dei Sadducei: questa aristocratica corrente non solo era invisa al popolo, ma il suo indirizzo dottrinale era esplicitamente combattuto dai popolari Farisei, e quindi dagli Scribi che appartenevano in massima parte alla corrente dei Farisei. Ora, sulla cattedra di Mosè avrebbe dovuto assidersi il sommo sacerdote, come supremo moderatore ed interprete della Legge teocratica: e questa norma era stata sancita espressamente anche dal pagano Giulio Cesare in favore del sommo sacerdote (in Antichità giud., xiv, 195). Ma in realtà sulla cattedra di Mosè si sedettero gli Scribi ed i Farisei (Matteo, 23, 2), i quali, in altre parole, eressero una controcattedra di fronte a quella del sommo sacerdote e distolsero dal suo seguito le masse popolari, lasciandogli soltanto i suoi interessati Sadducei.
• § 52. I sommi sacerdoti che entrano direttamente nella storia di Gesù sono due, Anna e Caifa. Il nome Anna, grecizzato in Anano da Flavio Giuseppe, era una abbreviazione dell’ebraico Hananjah, ossia Anania. Flavio Giuseppe (Antichità giud., xx, 198) presenta quest’uomo come felicissimo per due ragioni, perché egli stesso tenne il sommo sacerdozio per lunghissimo tempo e perché in quella dignità ebbe come successori ben cinque figli; ma avrebbe potuto aggiungere che, oltre ai cinque figli, ebbe per successore nella sua carica anche un genero, cioè Giuseppe detto Caifa, così sarebbe risultato anche meglio il pratico monopolio che del sommo sacerdozio avevano fatto le influenti famiglie cui già accennammo (§§ 33, 50). Stando a Flavio Giuseppe, Anna fu eletto da Quirinio subito dopo la destituzione del tetrarca Archelao, cioè nel 6 dopo Cristo; ma non è improbabile che lo storico giudeo prenda qui un abbaglio (come gli accade sovente altrove), e che Anna diventasse sommo sacerdote anche prima, perché fu deposto certamente dal procuratore Valerio Grato nell’anno 15, cosicché avrebbe pontificato solo nove anni, che non è un lunghissimo (tempo) come egli stesso dice. Checché sia di ciò, anche dopo la sua deposizione Anna conservò grandissima autorità, perché i pontificati dei cinque figli e del genero furono regolati, segretamente o anche palesemente, sempre da lui. I figli pontificarono negli anni qui appresso indicati, ma non si sa se Anna fosse ancora in vita durante il pontificato dell’ultimo figlio a lui omonimo: Eleazaro, nell’anno l6-17; Jonathan, nell’anno 36-37; Teofilo, negli anni 37-41; Mattia, nell’anno 42-43; Anano (Anna), nell’anno 61. Costui fu ucciso nel 67, durante la guerra contro Roma, dagli insorti antiromani. L’immediato predecessore di Jonathan figlio di Anna fu il genero dello stesso Anna, cioè detto Qajapha (Caifa): quest’ultimo nome è di significato incerto. Caifa fu eletto nell’anno 18 da Valerio Grato, lo stesso procuratore che aveva deposto suo suocero, e rimase in carica fino al 36: era dunque sommo sacerdote allorché Gesù fu condannato ed ucciso, sebbene in tale occasione la realtà del potere fosse esercitata più dal suocero che da lui.
• § 53. Sotto l’alta direzione del sommo sacerdote ministravano nel Tempio i discendenti della tribù di Levi, che rimanevano distinti nelle due antiche categorie di sacerdoti e di semplici Leviti: i sacerdoti compievano le funzioni liturgiche ordinarie, sia quelle di culto pubblico ufficiale, sia quelle richieste dalla pietà dei singoli fedeli; i semplici Leviti coadiuvavano i sacerdoti nella preparazione ed esecuzione delle funzioni, e generalmente erano incaricati dei servizi secondari del Tempio. I Leviti non sacerdoti erano dunque il clero inferiore, e fuori del Tempio non avevano particolare importanza nella vita sociale e culturale della nazione. Il loro stato economico, che secondo gli antichi statuti si basava sulla rendita delle decime, non era florido, sia perché le decime erano spesso aleatorie, sia perché ai Leviti ne andava quella parte che si degnavano di lasciar loro i sacerdoti, non senza le eventuali rapine che già ricordammo (§ 33).
• § 54. I sacerdoti erano raggruppati in 24 classi, le quali s’avvicendavano ogni settimana nel ministero del Tempio. Ciascuna classe aveva a capo un sacerdote da cui prendeva il nome, e i suoi dipendenti erano designati alle singole incombenze del ministero per mezzo delle sorti (cfr. Luca, 1, 5-9). I più dei sacerdoti dimoravano in Gerusalemme stessa o nei suoi immediati dintorni; ma taluni risiedevano in borgate piuttosto distanti, ove ritornavano terminata che fosse la loro muta di servizio in Gerusalemme: altrettanto facevano i semplici Leviti (cfr. Luca, 1, 23; 10, 31-32). L’ufficio proprio ai sacerdoti era quello liturgico. Conoscere esattamente i requisiti necessari in un animale da offrirsi in sacrifizio, la misura di una data libazione sacra, i riti preparatori ed esecutivi di certe oblazioni, le prescrizioni da osservarsi in determinate funzioni, ed in genere tutte le norme scritte o tradizionali riguardanti la materialità della liturgia, costituiva la scienza di cui andava fiero il sacerdote. Nella società teocratica egli eseguiva con esattezza quelle uccisioni d’animali, quegli spargimenti di sangui, quei bruciamenti d’incensi, che Dio stesso aveva prescritti e richiesti: con ciò il sacerdote aveva compiuto il suo ufficio, rendendosi benemerito verso la società più d’ogni altra persona, perché con quei sangui e con quegli incensi aveva placato Dio e ne aveva assicurato la protezione sulla collettività. La partecipazione dello spirito alla materialità del rito era stata bensì oggetto della predicazione degli antichi profeti, ma di fatto entrava ben poco nelle attribuzioni della “professione” esercitata dal sacerdote ebraico. Alle discussioni in voga fra Scribi e Farisei, la maggior parte dei sacerdoti restava aliena. Per il “professionista” sacro esisteva la Legge scritta, quella da cui i suoi privilegi sacri erano garantiti, e cercare più in là sarebbe stato perdita di tempo; ché se qualche raro sacerdote prendeva parte a tali discussioni, era solo per impugnare e respingere quanto andavano affermando quei petulanti e plebei di Farisei, verso i quali non nutriva che altezzoso disprezzo. E questa attitudine d’aristocratica superiorità era mantenuta tanto più da quei sacerdoti che, dopo il sommo sacerdote, occupavano gli uffici più alti del Tempio, come quelli di capitano del tempio (Atti, 4, 1; 5, 24-26), di tesoriere, ed altri onorifici e lucrosi; già udimmo da fonte rabbinica che tali uffici erano accaparrati abitualmente da membri delle “famiglie di sommi sacerdoti”.
• § 55. Sarebbe certamente falso credere che questa combriccola parentale, formatasi sul vertice, fosse degna rappresentante di tutti coloro che stavano più in basso, o anche che i discendenti di Levi fossero indistintamente ottusi mestieranti di liturgia, privi di religiosità vera: al contrario, soprattutto fra il basso clero costituito dai Leviti e anche fra i sacerdoti di famiglie meno cospicue e meno urbanizzate, dovevano essere numerosi gli spiriti profondamente religiosi, che segretamente ripensavano agli antichi benefizi fatti da Dio ad Israele ed aspettavano ansiosamente quelli promessi per il futuro. Per citare un solo esempio, da una di queste famiglie rurali di sacerdoti era stato iniziato nel 166 avanti Cristo il risorgimento nazionale dei Maccabei, che aveva richiamato a nuova vita il giudaismo in forza di principii nazionali-religiosi. Ad ogni modo, questa porzione buona e sana del levitismo era - come avviene sempre - la meno vistosa e rumorosa, la meno atta a far parlare di sé nelle ordinarie vicende della vita sociale : gli occhi del popolo erano attirati, invece, da quei fastosi ed altezzosi sacerdoti che spadroneggiavano nel Tempio e che si spartivano la direzione degli affari pubblici col procuratore romano, col quale s’intendevano abbastanza bene; codesti pezzi grossi della finanza e della politica - se non della religione - erano agli occhi della plebe il sacerdozio pratico, i discendenti effettivi di Levi e di Eli.
• § 56. Era quindi naturale che la plebe non li amasse. Una tradizione rabbinica riferisce che una volta il popolo esasperato urlasse nell’atrio del Tempio: Uscite via di qua, uscite via di qua, figli di Eli! Avete insozzato la casa del nostro Dio! (Sukkah, pal., iv, 54 d). I figli di Eli erano i legittimi sacerdoti di Dio Jahvè, che dal popolo non erano dunque graditi; ma saranno stati essi graditi dal loro stesso Dio Jahvè? A questo proposito abbiamo notizia di un fatto straordinario, che merita di essere ricordato sia per il singolare momento storico in cui sarebbe avvenuto, sia perché la sua notizia è trasmessa concordemente dal giudeo Flavio Giuseppe e dal pagano Cornelio Tacito. Narra lo storico giudeo che, in uno degli ultimi anni prima della catastrofe nazionale e dell’incendio del Tempio, nella festa che si chiama Pentecoste, essendo giunti i sacerdoti nel tempio interno - com’era loro costume per gli uffici liturgici - affermarono che dapprima avevano avvertito una scossa ed un colpo, e poi una voce collettiva “Noi ce ne partiamo di qua”. Colui che abitava in permanenza nel Tempio di Gerusalemme e in quel momento se ne partiva, era Jahvè, Dio d’Israele, che qui parla in prima persona plurale (come già in Genesi, 1, 26, allorché crea l’umanità). In questa stessa maniera intende il fatto anche lo storico pagano. Accettando come vero questo fatto, bisognerebbe concludere che, non avendo i figli di Eli abbandonato il Tempio alle grida del popolo esasperato, Dio stesso lo abbandonò lasciando ai sacerdoti un Tempio che era ormai vuoto di Dio. E allora quel Tempio crollò per sempre.

Testo ed immagini tratti da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti, 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, stiamo usando il «Catechismo maggiore» di Papa san Pio X, «Brevi cenni di Storia ecclesiastica». Prima di iniziare faccio presente che i numeri 74, 75 e 76 del nostro SVRSVM CORDA® saranno pubblicati in versione ridotta, ossia di 4 e non di 8 pagine. A Dio piacendo, dal numero 77 - del 10 settembre 2017 - riprenderemo con l’abituale formato. Inizio della citazione.
• Le persecuzioni ed i martiri. Ma la fede cristiana doveva passare per durissime prove, acciò fosse manifesto che essa veniva da Dio, e da Lui solo era sostenuta. Nei tre primi secoli di sua esistenza, ossia per il corso di 300 anni, molte terribili persecuzioni infierirono contro i seguaci di Gesù Cristo, per comando degli imperatori romani. Non era continua la guerra intimata ai cristiani ma a certi intervalli ripigliavasi; ed allora essi erano cercati a rendere ragione della loro fede, loro era ingiunto di offrire incenso agli idoli, e, ricusando erano sottoposti a tutti gli sfregi, le pene e i tormenti, che 1’umana malizia possa escogitare, infino alla morte. Essi non irritavano punto i loro nemici; si radunavano per le loro divozioni e per assistere al divino Sacrifizio per lo più in luoghi sotterranei, oscuri e deserti, che tuttora esistono a Roma ed altrove, detti cemeteri o catacombe; ma non riuscivano ad evitare i pericoli di morte. E un numero grandissimo di essi, collo spargimento del loro sangue, resero testimonianza alla fede di Gesù Cristo, per affermare la quale erano morti gli Apostoli ed i loro imitatori. Perciò diconsi martiri, che appunto vuol dire testimoni. La Chiesa riconosceva queste care vittime della fede, raccoglieva i loro cadaveri, li componeva nei santi luoghi di dormizione, e li ammetteva all’onore degli altari.
• Costantino e la pace della Chiesa. La Chiesa non ebbe solida pace che sotto l’imperatore Costantino, il quale, riuscito vincitore dei suoi nemici, favorito ed incoraggiato da una celeste visione, emanò editti, pei quali ciascuno restava libero di ascriversi alla religione cristiana; i cristiani rientravano in possesso dei beni, che loro erano stati confiscati; nessuno poteva inquietarli per ragione della loro fede; né dovevano più essere esclusi dalle cariche od impieghi dello Stato; essi potevano fabbricare chiese; e l’imperatore talora ne sosteneva la spesa. Allora tutti quanti i confessori della fede, che erano in carcere, furono prosciolti; i cristiani cominciarono a celebrare con pubblico splendore le loro adunanze, e gl’infedeli stessi sentivansi attratti a magnificare il vero Dio. Costantino, superato l’ultimo suo competitore, restò solo padrone del mondo romano, e la Croce di Gesù Cristo videsi sfolgorare nel vessillo dell’impero. Egli divise poscia l’impero in orientale ed occidentale, facendo di Bisanzio sul Bosforo una nuova capitale, che abbellì e chiamò Costantinopoli (a. d. C. 330). Questa metropoli diventò ben presto una Roma novella, per l’autorità imperiale che vi risiedeva. Allora lo spirito di orgoglio e di novità si impadronì di alcuni ecclesiastici, ivi costituiti in alta dignità; i quali ambirono di primeggiare sul Papa e su tutta la Chiesa di Gesù Cristo. Da ciò nacquero gravissimi sconcerti per parecchi secoli, e finalmente il disastroso scisma, per cui l’Oriente separossi dall’Occidente (Sec. IX) sottraendosi in gran parte dalla divina autorità del Pontefice Romano, che è il successore di san Pietro, Vicario di Gesù Cristo.
• Le eresie ed i concili. Mentre usciva vittoriosa della guerra esterna del paganesimo, e vinceva la prova delle sue feroci persecuzioni, la Chiesa di Gesù Cristo, assalita da nemici interni, già combatteva una guerra intestina ben più terribile. Guerra lunga e dolorosa che, ingaggiata e tenuta accesa da cattivi cristiani, suoi figli degeneri, non ha veduto ancora il suo termine; ma dalla quale la Chiesa uscirà trionfante secondo la infallibile parola del suo divin Fondatore al primo suo Vicario in terra, l’apostolo Pietro: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte dell’inferno non prevarranno contro di lei». (san Matteo XVI, 18.). Già dai tempi apostolici erano sorti uomini perversi, che per lucro e per ambizione turbavano e corrompevano nel popolo la purità della fede con turpi errori. A questi si opposero gli Apostoli colla predicazione, cogli scritti, e colle infallibili sentenze del primo concilio che essi celebrarono in Gerusalemme. D’allora in poi, lo spirito delle tenebre non cessò dai suoi velenosi attacchi contro la Chiesa e contro le divine verità delle quali ella è custode indefettibile; e suscitandole contro sempre nuove eresie, attentò man mano a tutti i dogmi della cristiana religione. Fra le altre, vanno tristamente famose le eresie: di Sabellio, che impugnò il dogma della Santissima Trinità; di Manete, che negò l’Unità di Dio, ed ammise nell’uomo due anime; di Ario, che non volle riconoscere la Divinità di Nostro Signore Gesù Cristo; di Nestorio, che negò a Maria Santissima la sua eccelsa qualità di Madre di Dio, e distinse in Gesù Cristo due persone; di Eutiche, il quale in Gesù Cristo non ammise che una sola natura; di Macedonio, che combatté la divinità dello Spirito Santo; di Pelagio, che intaccò il dogma del peccato originale e della necessità della grazia; degli Iconoclasti, che ripudiarono il culto delle Sacre Immagini e delle Reliquie dei Santi; di Berengario, che disdisse la presenza reale di Nostro Signore Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento; di Giovanni Hus, che negò il primato di san Pietro e del Romano Pontefice; e finalmente la grande eresia del Protestantesimo (sec. XVI), prodotta e divulgata principalmente da Lutero e da Calvino. Questi novatori, col respingere la Tradizione divina riducendo tutta la rivelazione alla Sacra Scrittura, e col sottrarre la Sacra Scrittura medesima al legittimo Magistero della Chiesa, per darla insensatamente alla libera interpretazione dello spirito privato di ciascheduno, demolirono tutti i fondamenti della fede, esposero i Libri Santi alla profanazione della presunzione e dell’ignoranza, ed aprirono l’adito a tutti gli errori. Il protestantesimo o religione riformata, come orgogliosamente la chiamarono i suoi fondatori, è la somma di tutte le eresie, che furono prima di esso, che sono state dopo, e che potranno nascere ancora a fare strage delle anime. Con una lotta, che dura senza tregua da 20 secoli, la Chiesa cattolica non cessò di difendere il sacro deposito della verità che Iddio le ha affidato, e di proteggere i fedeli contro il veleno delle eretiche dottrine. Ad imitazione degli Apostoli, ogni volta che lo ha richiesto il pubblico bisogno, la Chiesa radunata in concilio ecumenico o generale, ha definito con limpida chiarezza la verità cattolica; l’ha proposta qual domma di fede ai suoi figli; ed ha respinto dal suo seno gli eretici, colpendoli di scomunica e condannandone gli errori. Il concilio ecumenico o generale, è un augusto consesso a cui sono, dal Romano Pontefice, chiamati tutti i Vescovi dell’universo, ed altri prelati della Chiesa, e che è presieduto dal Papa medesimo, ora in persona, ora per mezzo dei suoi Legati. A tale consesso, che rappresenta tutta la Chiesa docente, è promessa l’assistenza dello Spirito Santo; e le sue decisioni in materia di fede e di costumi, dopo la conferma del Sommo Pontefice, sono sicure ed infallibili come la parola di Dio. Il concilio che condannò il protestantesimo è stato il Sacro Concilio di Trento, così denominato dalla città, dove tenne sua sede. Colpito da questa condanna il protestantesimo vide svilupparsi i germi di dissoluzione che portava nel suo viziato organismo: le dissenzioni lo lacerarono, si moltiplicarono le sétte, che dividendosi e suddividendosi lo ridussero in frammenti. Al presente il nome di protestantesimo non significa più una credenza uniforme e diffusa, ma nasconde la più mostruosa congerie di errori privati ed individuali, raccoglie tutte le eresie, e rappresenta tutte le forme di ribellione contro la santa Chiesa cattolica. Lo spirito protestante tuttavia, cioè lo spirito di sconfinata libertà e di opposizione ad ogni autorità, non lasciò di diffondersi; e molti uomini sorsero che gonfiati da una scienza vana e superba, ovvero dominati dall’ambizione e dall’interesse non dubitarono di creare o dar favore a teorie sovvertitrici della fede, della morale, e di ogni autorità divina ed umana. Il Sommo Pontefice Pio IX, dopo di avere in un Sillabo, condannato molte delle più essenziali proposizioni di questi temerari cristiani, per portare la scure alla radice del male aveva convocato in Roma un nuovo concilio ecumenico. Questo aveva felicemente incominciato l’opera sua illustre e benefica nelle prime sessioni tenute nella basilica di San Pietro in Vaticano (onde ebbe il nome di Concilio Vaticano), quando nel 1870 per le vicende dei tempi dovette sospendere le sue sedute. Giova sperare che, quietata la burrasca la quale agita momentaneamente la Chiesa, il Romano Pontefice potrà ripigliare e condurre a termine l’opera provvidenziale del santo concilio; e che sconfitti gli errori, i quali ora travagliano 1a Chiesa e la società civile, sarà dato presto di vedere la verità cattolica brillare di nuova luce ed illuminare il mondo dei suoi eterni splendori.
• Accenni e direzioni per lo studio della religione nella storia della Chiesa. Qui ha termine il nostro sunto, perché non è possibile di seguire passo a passo le vicende della Chiesa complicate cogli avvenimenti politici, senza dir cose meno adatte alla comune intelligenza, e fallire lo scopo di queste pagine. Il fedele di buona volontà si provveda di un buon compendio di storia ecclesiastica di autore cattolico. - E in ciò fare si valga del consiglio del suo parroco o di un dotto confessore. - Legga con ispirito di semplicità ed umiltà cristiana, e vedrà la Chiesa sua madre risplendere dei caratteri di cui Nostro Signore Gesù Cristo ha insignita la sola vera Chiesa da lui fondata; che sono di essere Una, Santa, Cattolica ed Apostolica.
• Una. - L’unità della Chiesa vedrà risplendere nell’esercizio continuato della fede, della speranza e della carità. Vedrà in 20 secoli di vita sempre giovane e fiorente, che conta la Chiesa, tante generazioni, tanta moltitudine di uomini, diversi d’indole, di nazione, di linguaggio, riuniti in una società, governata sempre da una medesima e perpetua Gerarchia, professare le stesse credenze, confortarsi delle stesse speranze, partecipare alle comuni preghiere, agli stessi sacramenti, sotto la direzione dei legittimi Pastori. Vedrà la gerarchia ecclesiastica formata da tante migliaia di Vescovi e di Sacerdoti, tenersi stretta in vincolo di unità nella comunione e nell’ubbidienza del Romano Pontefice, che ne è il capo divinamente istituito, ed attingere da lui i divini insegnamenti, per comunicarli al popolo con perfetta unità di dottrina. Onde mai tanta meraviglia d’unione? Dalla presenza, dall’assistenza di Gesù Cristo che aveva detto agli Apostoli: «ecco che io sono con voi sino alla consumazione dei secoli».
• Santa. - Il fedele che leggerà con cuor retto la storia ecclesiastica, vedrà risplendere la santità della Chiesa, non solo nella santità essenziale del suo Capo invisibile Gesù Cristo; nella santità dei sacramenti, della dottrina, delle corporazioni religiose, di moltissimi dei suoi membri; ma ancora nella abbondanza dei doni celesti, dei sacri carismi, delle profezie e dei miracoli, con cui il Signore (negandoli a tutte le altre società religiose), fa risplendere in faccia al mondo la dote della santità di cui va esclusivamente fregiata la Sua unica Chiesa. Chi legge con animo retto la storia ecclesiastica, è colpito di meraviglia nel contemplare la visibile azione della Provvidenza divina, la quale comunica alla Chiesa la santità e la vita; e veglia alla sua conservazione. È dessa che fin dai primi secoli suscitava quei grandi uomini, gloria immortale del cristianesimo, che, ripieni di sapienza e di virtù sovrumana, combatterono vittoriosamente le eresie e gli errori a misura che insorsero: Santi Padri e Dottori che brilleranno come stelle, giusta la frase scritturale, nella perpetua eternità; del cui unanime ed universale consenso si valse sempre la Chiesa, a riconoscere la Tradizione e il senso delle Sante Scritture. E colpisce parimenti il sorgere provvidenziale, a tempo e luogo opportuno, di quegli Ordini Regolari, di quelle Religiose Famiglie, approvate e benedette dalla Chiesa, nelle quali, fin dal quarto secolo fioriva la vita cristiana ed aspiravasi alla perfezione evangelica, praticando i divini consigli nei santi voti di castità, povertà ed obbedienza. Appare dalla storia che queste Religiose Famiglie, nel corso dei secoli, andarono sempre e vanno tuttora succedendosi e rinnovandosi con uno scopo sempre adatto alla diversità dei tempi e dei bisogni di essi: o la preghiera, o l’insegnamento, o l’esercizio del ministero apostolico, o il compimento svariato e molteplice delle opere di carità. Esse vanno soggette, come la santa madre Chiesa, a persecuzioni furiose, che sovente e per qualche tempo le opprimono. Ma siccome tali istituti appartengono all’essenza della Chiesa per l’attuazione dei consigli evangelici, perciò non possono del tutto perire. Ed è provato che la tribolazione li purifica e li ringiovanisce: e, rinascendo altrove, si moltiplicano e producono più abbondanti frutti, restando sempre una sorgente inesausta della santità della Chiesa.
• Cattolica. - Leggerà con rammarico il fedele che pur troppo, nel corso dei secoli, grandi moltitudini di cristiani, talora intiere nazioni, furono miseramente staccate dall’unità della Chiesa; ma vedrà pure che, successivamente, ad altre genti, ad altre nazioni mandava Iddio la luce del Vangelo per mezzo di uomini apostolici, incaricati appunto da Lui, come lo furono gli Apostoli, di guidare a salvezza le anime. - E si consolerà nel riconoscere che un tale apostolato degnasi il Signore di affidare nel nostro secolo a centinaia e migliaia di sacerdoti, di religiosi d’ogni ordine, di vergini consacrate a Lui, che sui battelli a vapore e sulle vie ferrate percorrono le terre e i mari dell’antico e del nuovo mondo, per dilatare il regno di Gesù Cristo. Imperocché sarebbe un errore il prestar fede alle vanterie degli increduli: che il cattolicismo vada estinguendosi nel mondo, quasi che gli uomini più non si curino che del progresso delle scienze e delle arti. Invece dalle statistiche risulta chiaramente che il numero complessivo dei cattolici, nelle cinque parti del mondo, non ostante persecuzioni e difficoltà d’ogni sorta, si accresce ogni anno; ed è da sperare che, continuando a facilitarsi i mezzi di comunicazione, e prestando favore Iddio, ornai non saravvi più terra accessibile ove non siavi in una modesta chiesa, attorno ad un povero missionario, un gruppo di cristiani congiunti di mente e di cuore coi fratelli di tutto il mondo, e per mezzo di Vescovi o di Vicari apostolici legittimamente mandati dalla Sede Romana, legati alla medesima in unità di fede e di comunione. - È ciò che chiamasi cattolicità della Chiesa. Essa sola può dirsi cattolica ossia universale, cioè d’ogni tempo e d’ogni luogo.
• Apostolica. - Vedrà il fedele, nel percorrere la storia ecclesiastica, succedersi, fra incredibili difficoltà, tanti Romani Pontefici, tutti nella persona di Pietro rivestiti delle stesse prerogative date a lui da Gesti Cristo, diffondere la giurisdizione ai successori anche degli altri Apostoli, dei quali nessuno erasi mai separato da Pietro siccome ora nessuno potrebbe separarsi dalla Sede Romana, senza cessare di appartenere alla Chiesa, che perciò è realmente e dicesi apostolica. Nella storia ecclesiastica, il fedele imparerà a conoscere ed evitare i nemici della Chiesa e della sua fede. Nel corso dei secoli s’incontrerà in associazioni o società tenebrose e segrete, le quali sotto vario nome si andarono formando, non già per glorificare Iddio eterno, onnipotente e buono, ma per abbattere il suo culto e sostituirvi (cosa incredibile, ma vera) il culto del demonio. Né si meraviglierà che i legittimi successori di san Pietro, sopra il quale Gesù Cristo fondò la sua Chiesa, siano stati, o siano al presente ancora, agli eretici ed agli increduli, oggetto d’odio, di scherno e di avversione, dovendo essi più da vicino rassomigliare al divino maestro, che disse: «se perseguitarono me, perseguiteranno voi pure». Ma la verità, che si vedrà risultare dalla storia, è questa: che i primi Papi per vari secoli furono giustamente innalzati agli onori degli altari, avendo molti versato il sangue per la fede; che quasi tutti gli altri splendettero per egregie doti di sapienza e di virtù, sempre intenti ad istruire, a difendere e santificare il popolo cristiano, sempre pronti, come i loro predecessori, a dare la vita per rendere testimonianza alla parola di Dio. Che importa (dacché sgraziatamente vi fu tra i dodici un apostolo malvagio), che importa se pochissimi fra tanti fossero stati meno degni di salire su quella suprema Sede, dove ogni macchia appare gravissima? Dio lo permise per far conoscere la sua potenza nel sostenere la Chiesa, mantenendo un uomo infallibile nel suo insegnamento, benché fallibile col suo personale operare. Fine.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, stiamo usando il «Catechismo maggiore» di Papa san Pio X, «Sunto di storia del Nuovo Testamento». Prima di iniziare faccio presente che i numeri 74, 75 e 76 del nostro SVRSVM CORDA® saranno pubblicati in versione ridotta, ossia di 4 e non di 8 pagine. A Dio piacendo, dal numero 77 - del 10 settembre 2017 - riprenderemo con l’abituale formato. Inizio della citazione.
• Mirabili effetti della parola e della potenza del Redentore. Ordinariamente dopo i suoi discorsi, gli erano presentati infermi d’ogni specie, muti, sordi, storpi, ciechi, lebbrosi, ed Egli a tutti ridonava la sanità. Non solo nelle sinagoghe andava Egli spargendo le sue grazie ed i suoi benefizi; ma in qualunque luogo si trovasse, presentandosene l’occasione, veniva in soccorso degli infelici, che in gran numero gli erano condotti da ogni parte della Palestina e dei paesi circonvicini, essendosi anche in tutta la Siria sparsa la fama dei suoi miracoli. Specialmente gli ossessi dal demonio, di cui v’era non piccolo numero in quel tempo, ed Egli li liberava dagli spiriti maligni, i quali uscivano gridando: «tu sei il Cristo, il Figliuol di Dio!». Due volte con pochi pani miracolosamente moltiplicati, sfamò le turbe che lo avevano seguito nel deserto; sulle porte della città di Naim, risuscitò il figlio di una vedova, che era portato alla sepoltura, e, qualche tempo prima della sua passione, risuscitò Lazzaro, morto da quattro giorni e fetente nel sepolcro. È infinito il numero dei miracoli, anche strepitosissimi, che fece nei tre anni della sua predicazione per dimostrare che Egli parlava per comando di Dio, che era il Messia aspettato dai Patriarchi e predetto dai Profeti, che era il Figliuolo di Dio stesso; e tale si manifestò nella sua Trasfigurazione per lo splendore della sua gloria e per la voce del Padre che lo proclamava suo Figliuolo diletto. Alla vista di tali miracoli parecchi si convertivano e lo seguitavano, molti poi lo acclamavano, cercando talora di farlo re.
• Guerra aperta contro Gesù. Questi trionfi di Gesù fin da principio eccitarono la gelosia degli scribi, dei farisei, dei prìncipi, dei sacerdoti e dei capi del popolo, la quale si accrebbe a dismisura, quando Egli si diede a smascherare la loro ipocrisia od a rimproverarli dei loro vizi. Essi perciò non tardarono a perseguitarlo ed a denigrarlo, dicendolo perfino indemoniato, ed a cercare il modo di sorprenderlo in parole, sia per screditarlo dinanzi al popolo, sia per accusarlo presso il governatore romano. La loro invidia aumentò sempre più quando, in seguito alla risurrezione di Lazzaro si moltiplicò grandemente il numero dei giudei, che credevano in Lui. Allora tennero un consiglio per ucciderlo; ed il pontefice Caifa finì per dire: «è necessario che un uomo muoia per il popolo, e non perisca tutta la gente»: pronunziando colle sue parole una profezia senza saperlo; imperocché appunto per la morte di Gesù sarebbe salvato il mondo.
• Causa di odio estremo e tradimento di Giuda. Finalmente il loro odio giunse al colmo quando, essendo vicina la Pasqua, (ed era la quarta che Egli faceva a Gerusalemme, dopo che aveva cominciata la sua predicazione) essendo la città ripiena di forestieri venuti da ogni parte per la festa, Gesù, seduto sopra un asinello, entrò trionfante ed acclamato dal popolo, che gli era uscito incontro portando rami di palma e d’ulivo, mentre alcuni stendevano le loro vestimenta sopra la strada, ed altri tagliavano ramoscelli dagli alberi e li spargevano per la via. Allora gli anziani del popolo, i prìncipi dei sacerdoti e gli scribi si congregarono nella casa del pontefice Caifa, e stabilirono insieme di pigliare Gesù con inganno e di soppiatto, per timore che le turbe facessero tumulto. L’occasione non si fece aspettare. Giuda Iscariota, uno dei dodici Apostoli, invasato dal demonio dell’avarizia, si offrì a dare il suo divin Maestro nelle mani dei suoi nemici, per trenta monete di argento.
• Ultima cena di Gesù Cristo e istituzione del sacramento dell’Eucaristia. Era il dì, in cui si doveva sacrificare e mangiare l’agnello pasquale. Giunta l’ora assegnata, Gesù venne al luogo dove Pietro e Giovanni, mandati da lui, avevano apparecchiato ogni cosa per la cena, e si posero a tavola. Si è durante quell’ ultima cena che Gesù diede agli uomini la più gran prova del suo amore per loro, coll’istituire il sacramento dell’Eucaristia.
• Passione di N. S. Gesù Cristo. Finita la cena, il divin Salvatore, accompagnato dai suoi Apostoli, uscì dalla città, e per via dicendo loro le più tenere cose e loro dando i più sublimi insegnamenti, andò, secondo il solito, nell’orto di Getsemani, dove pensando alla sua prossima passione, pregando ed offrendosi all’Eterno suo Padre, sudò vivo sangue e da un Angelo fu confortato. Venne Giuda, il traditore a capo di una squadra di sgherri armati di bastoni e di spade, e diede a Gesù un bacio, che era il segno convenuto per farlo conoscere. Gesù abbandonato dagli Apostoli, che erano per paura fuggiti, fu tosto afferrato e legato da quei manigoldi, e con ogni sorta di maltrattamenti da loro trascinato prima ad un principe dei sacerdoti, chiamato Anna, e poscia a Caifa pontefice, il quale nella stessa notte radunò il gran sinedrio, che proclamò Gesù reo di morte. Scioltasi la radunanza dei giudici, Gesù venne consegnato agli sgherri, dai quali, in quella notte, fu vilipeso ed oltraggiato con barbari trattamenti. Si fu anche in quella notte dolorosa che Pietro amareggiò il cuore di Gesù, negandolo tre volte. Guardato però da Gesù tornò in sé, e pianse il suo peccato tutta la vita. Venuto il giorno, e radunatosi nuovamente il Sinedrio, Gesù fu condotto al preside romano, Ponzio Pilato, al quale a voce di popolo si domandò che lo condannasse a morte. Pilato, avendo riconosciuta l’innocenza di Gesù e la perfidia dei giudei, cercò di salvarlo; e dovendo in occasione della Pasqua, liberare un malfattore, lasciò al popolo la scelta tra Gesù e Barabba. Il popolo scelse Barabba. Poscia, sentendo Pilato che Gesù era galileo, lo mandò ad Erode Antipa da cui fu disprezzato, trattato da pazzo e poi rimandato, vestito per scherno con una veste bianca. Finalmente lo fece flagellare dai manigoldi, i quali, dopo averlo ridotto tutto una piaga, con insulto atroce gli posero in capo una corona di spine, sulle spalle uno straccio di porpora, in mano una canna, e schernirono salutandolo re. Ma tutto ciò non essendo bastato ad acquietare il furore dei suoi nemici e della plebe tumultuante, Pilato lo condannò alla crocifissione. Allora Gesù dovette sottoporre le sue spalle ad un duro tronco di croce e trascinarlo fino al Calvario, dove denudato, abbeverato di fiele e mirra, inchiodato alla croce ed innalzato fra due ladroni, in mezzo ad un mare di spasimi e di tormenti, dopo tre ore di penosissima agonia, spirò pregando per i suoi crocifissori, che non cessarono perciò dall’inferocire. Anche morto, ebbe il cuore trapassato da un fiero colpo di lancia. Nessuna mente umana può immaginare, nessuna lingua può esprimere quanto Gesù dovette soffrire e nella notte del suo arresto, e nei diversi viaggi dall’uno all’altro tribunale, e nella flagellazione, e nella coronazione di spine, e nella crocifissione, e finalmente nella lunga agonia!... Solo l’amore che ne fu causa, può ridestarne una pallida immagine nei cuori riconoscenti. Maria santissima assistette con sovrumana fortezza alla morte del suo divin Figlio; e unì lo strazio del suo cuore ai dolori di Lui, per la redenzione del genere umano. Come nella vita, così nella morte il Padre celeste fece risplendere la divinità di Gesù Cristo; mentre era in croce, il sole si oscurò e si coprì la terra di densissime tenebre; al suo spirare, la terra traballò con spaventoso terremoto; il velo del tempio si lacerò, da capo a fondo, e parecchi morti, usciti dai sepolcri, si videro in Gerusalemme ed apparvero a molti.
• Sepoltura di Gesù, sua Risurrezione e sua Ascensione al Cielo. Gesù fu crocifisso e morì in giorno di venerdì e nella stessa sera, prima del calare del sole deposto dalla croce fu sepolto in un sepolcro nuovo, a cui si posero i sigilli e le guardie, per timore che i suoi discepoli potessero involarlo. All’alba del giorno successivo al sabato, si sentì un gran terremoto; Gesù era risuscitato, ed uscito glorioso e trionfante dal sepolcro. Egli, dopo essere comparso alla Maddalena, comparve agli Apostoli, per confortarli e consolarli; ed alcuni Santi Padri pensano che prima Egli apparisse alla santissima Madre sua. Quaranta giorni stette ancora Gesù sulla terra dopo la sua risurrezione, in diverse apparizioni mostrandosi ai suoi discepoli e conversando con essi. Così rassicurava con miracolosi modi gli Apostoli, confermavali nella fede, comunicava loro altissime cose e dava loro gli ultimi avvertimenti: finché, nel quarantesimo giorno, li radunò sul monte Oliveto, e dopo averli benedetti, alla loro presenza, visibilmente si alzò da terra ed ascese al cielo.
• Discesa dello Spirito Santo. - Predicazione degli Apostoli. Gli Apostoli, seguendo gli avvisi del loro divin Maestro, tosto si ritirarono nel cenacolo di Gerusalemme, e là per dieci giorni aspettarono, pregando, lo Spirito Santo, che Gesù aveva loro promesso, e che discese su di loro in forma di tante lingue di fuoco la mattina del giorno decimo, detto Pentecoste. Essi allora, mutati in altri uomini, cominciarono ad un tratto a parlare diverse lingue, secondoché lo Spirito stesso dava ad essi di favellare. A mirare tale spettacolo accorsero le genti d’ogni nazione, adunate in quei giorni a Gerusalemme; e, ad un discorso fatto da san Pietro sulle profezie avveratesi nella persona di Gesù Cristo e sui miracoli operati da lui, tremila persone si convertirono. Alcuni giorni dopo, lo stesso Pietro, seco unito l’apostolo Giovanni, dopo una miracolosa guarigione d’uno storpio dalla nascita, parlando a quella moltitudine di giudei, altri cinquemila ne attirò alla fede. Né solo in Gerusalemme, ma in tutta la Giudea, predicando gli Apostoli, il numero dei credenti andava crescendo. Ma tosto i seniori del popolo ed i prìncipi dei sacerdoti cominciarono a perseguitare gli Apostoli, e chiamatili e rimproveratili acerbamente, intimarono loro di non più parlare di Gesù. Questi rispondevano: «Noi non possiamo tacere quello che abbiamo veduto ed udito; giudicate voi stessi se ci sia lecito obbedire agli uomini, disobbedendo a Dio», ma quelli li imprigionarono maltrattandoli; fecero morire il diacono santo Stefano sotto una tempesta di sassi: e gli Apostoli lieti di esser fatti degni di patire per Gesù Cristo, ne prendevano coraggio a predicare, e sempre maggiore era il numero dei convertiti.
• L’apostolo Paolo. Il più celebre dei convertiti al Vangelo fu Saulo, detto poscia Paolo, nativo di Tarso, il quale prima furioso nemico e persecutore dei cristiani, colpito dalla divina potenza, diventò un vaso di elezione, il più zelante ed operoso degli Apostoli. Sono incredibili i viaggi, le fatiche e le tribolazioni di questo prodigio della grazia, per far conoscere il nome e la dottrina di Gesù Cristo fra i gentili: onde viene chiamato Dottore delle genti. Predicando la fede, non già coll’apparato della sapienza umana, ma nella virtù di Dio, che confermavala coi miracoli, convertiva i popoli sebbene fosse sempre accusato dai nemici della Croce di Cristo. Tali accuse lo portarono provvidenzialmente a Roma, ove poté predicare anch’egli il Vangelo ai giudei ivi residenti, ed ai pagani. Dopo altre peregrinazioni vi ritornò, ed ivi coronando l’apostolica sua vita col martirio, ebbe tagliata la testa sotto il medesimo Imperatore Nerone, sotto cui san Pietro vi fu crocifisso. Ci restano di lui 14 epistole, scritte la maggior parte alle varie chiese da lui fondate, e sono esse un altro segno dell’apostolica missione datagli da Gesù Cristo, avendo egli scritto, come osserva sant’Agostino, con tale estensione, lucidezza, profondità ed unzione che rivelano lo spirito di Dio.
• Dispersione degli Apostoli per tutto il mondo. Dopo aver predicato il Vangelo nella Giudea, giusta il comando di Gesù, gli Apostoli si separarono, ed andarono a predicarlo per tutto il mondo. San Pietro, capo del Collegio apostolico, andò in Antiochia. Si è in questa che i credenti in Gesù Cristo cominciarono a chiamarsi Cristiani. Da Antiochia san Pietro venne a Roma, dove fissò la sua sede, senza più trasportarla in altro luogo. Esso fu Vescovo di Roma, e nella stessa città finì la sua vita, come sopra si accennò, con un glorioso martirio sotto Nerone. I successori di san Pietro nella Sede romana ereditarono la suprema podestà, che il Signore aveva a lui data di Maestro infallibile della Chiesa, di fonte di tutta la giurisdizione e di protettore e difensore di tutti i cristiani. Essi perciò giustamente si chiamano col nome di Papi, che vuol dire Padri, e si sono succeduti senza interruzione sulla cattedra di Pietro sino ai nostri giorni. Tutti gli Apostoli concordi ed unanimi, in comunione con Pietro, predicavano dappertutto la stessa fede; e gli uomini si convertivano ed abbandonavano l’idolatria, sicché in breve il mondo si riempì di cristiani, al governo dei quali gli Apostoli stessi ponevano i Vescovi, a continuare il loro ministero. Prosegue ...
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, stiamo usando il «Catechismo maggiore» di Papa san Pio X, «Sunto di storia del Nuovo Testamento». Prima di iniziare faccio presente che i numeri 74, 75 e 76 del nostro SVRSVM CORDA® saranno pubblicati in versione ridotta, ossia di 4 e non di 8 pagine. A Dio piacendo, dal numero 77 - del 10 settembre 2017 - riprenderemo con l’abituale formato. Inizio della citazione.
• Annunciazione della Vergine Maria. Durante il regno di Erode, detto il grande, viveva in Nazaret, piccola città della Galilea, una santissima Vergine di nome Maria, sposata a Giuseppe, che il Vangelo chiama uomo giusto. Sebbene entrambi fossero discendenti dai re di Giuda, e quindi della famiglia di Davidde, tuttavia erano poveri, e guadagnavansi il vitto col lavoro. A questa Vergine fu mandato da Dio l’arcangelo Gabriele, il quale la salutò piena di grazia, e le annunciò che Ella sarebbe divenuta madre del Redentore del mondo. Alla vista ed alle parole dell’Angelo turbossi in prima Maria; ma poi, da lui rassicurata, rispose: «Ecco l’ancella del Signore, si faccia di me secondo la tua parola». In quello stesso momento il Figliuol di Dio, per opera dello Spirito Santo, s’incarnò nel seno purissimo di Lei, e restando vero Dio, cominciò ad essere vero uomo. Così ebbe principio la redenzione del genere umano.
• Visita a santa Elisabetta e nascita di san Giovanni Battista. Nel colloquio coll’Arcangelo, Maria aveva inteso che sua cugina Elisabetta, moglie ad un sacerdote, chiamato Zaccaria, doveva, sebbene avanzata in età, avere un figlio. Con santa sollecitudine andò Maria a trovare la cugina sulle montagne della Giudea, per congratularsi con lei, e sopratutto per servirla, come fece per tre mesi, quale umile ancella. Si fu in quell’occasione che Maria, rispondendo al saluto della cugina che, ispirata dallo Spirito Santo la salutava Madre di Dio, uscì in quel sublime cantico - Magnificat - che sovente canta la Chiesa. Il figlio di Elisabetta fu Giovanni Battista, il santo precursore del Messia.
• Nascita di Gesù Cristo e circostanze di quel grandissimo avvenimento. In quel tempo venne pubblicato un editto, per cui l’imperatore Cesare Augusto ordinava che dovesse farsi il censimento di tutte le persone soggette all’impero romano, e che quindi tutti dovessero andare a farsi registrare ciascuno nella città da cui traeva origine. Maria, e Giuseppe, per essere della casa e famiglia di Davidde, dovettero andare nella città di Betlemme, ove Davidde aveva avuto i natali; ma non vi essendo più luogo per loro negli alberghi a cagione della grande moltitudine venuta a dare il nome, si ripararono in una specie di spelonca, che serviva da stalla, non lungi dalla città. Fu là che, in sulla mezzanotte, il Figliuolo di Dio, fattosi uomo per salvare gli uomini, nacque da Maria Vergine, la quale lo involse in poveri panni e lo collocò a giacere nel presepio, ossia nella mangiatoia degli animali. In quella notte stessa un Angelo comparve ad alcuni pastori, che vegliavano in quei contorni alla custodia del gregge, e loro annunziò che era nato il Salvatore del mondo. I pastori accorsero stupefatti alla stalla, trovarono il Santo Bambino e per primi lo adorarono.
• Obbedienza di Gesù e della santissima Madre sua alla legge. L’ottavo giorno dopo la nascita, per ubbidire alla legge, il Bambino fu circonciso, e gli fu imposto il nome di Gesù, così come aveva indicato l’Angelo a Maria, quando le aveva annunziato il mistero dell’incarnazione. Ed ancora in ossequio alla legge, Maria, benché non vi fosse obbligata, nel quarantesimo giorno si presentò con Gesù nel tempio, per la cerimonia della purificazione; offrendo per sé il sacrifizio delle povere donne, un paio di tortore o di colombelle; e per Gesù il prezzo del riscatto. V’era nel tempio un santo vecchio di nome Simeone, il quale aveva avuto rivelazione dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di vedere il Cristo del Signore. Egli si recò in braccio il divin Fanciullo, e riconoscendolo per suo Redentore, pieno di giubilo lo benedisse e lo salutò con quel tenero cantico - Nunc dimittis - che la Chiesa canta sul fine dell’ufficio di ciascun giorno. In quell’ora stessa sopravvenne una piissima e vecchia vedova, la quale vedendo il divin Bambino ne giubilò nel suo cuore, e in seguito parlava di esso a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Israele.
• I Magi. Qualche tempo dopo la nascita di Gesù entrarono in Gerusalemme tre Magi, ossia Sapienti, venuti dall’Oriente, domandando dove era nato il Re dei Giudei. Stando nel loro paese avevano osservato una stella straordinaria, e dalla medesima, secondo un’antica profezia nota nell’Oriente, avevano conosciuto che doveva esser nato nella Giudea l’Aspettato dalle genti; ispirati da Dio, seguendo il cammino indicato dalla stella, erano venuti ad adorarlo. Regnava allora in Gerusalemme Erode, detto il grande, uomo ambizioso e crudele. Questi alle parole dei Magi turbossi molto; s’informò dai prìncipi dei sacerdoti in qual luogo doveva nascere il Messia e, saputo che il luogo indicato dai Profeti era Betlemme, vi mandò i Magi raccomandando loro di ritornare prontamente da lui, simulando di voler anch’egli portarsi ad adorare il nato Bambino. I Magi partirono; e tosto la stella (scomparsa sopra Gerusalemme) riapparve ad essi, guidandoli alla dimora del Divino Infante in Betlemme, sopra la quale si fermò. Essi vi entrarono, e trovato il Bambino con Maria sua Madre, si prostrarono, l’adorarono, ed aperti i loro tesori, gli offrirono oro, incenso e mirra, riconoscendolo come re, come Dio, e come uomo mortale. Nella notte poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, per altra via ritornarono nel loro paese.
• Strage degli innocenti e fuga in Egitto. Erode aspettò inutilmente i Magi; vedendosi deluso, adirossi moltissimo, e nella barbara sua astuzia sperando di colpire anche Gesù, mandò ad uccidere tutti i fanciulli dai due anni in giù, che si trovavano in Betlemme e nei suoi dintorni. Antecedentemente però un Angelo era apparso in sogno a Giuseppe, per avvisarnelo e per ordinargli di fuggire in Egitto. Giuseppe immediatamente ubbidì: e con Maria e Gesù andò in Egitto, dove stette fino alla morte di Erode; dopo la quale avvisato nuovamente dall’Angelo, ritornò, non a Betlemme nella Giudea, ma a Nazaret nella Galilea.
• Disputa di Gesù nel tempio. Quando Gesù giunse all’età di dodici anni, fu condotto dai parenti a Gerusalemme per le feste di Pasqua, che duravano sette giorni. Finite le feste, secondo l’uso, Maria con le donne e Giuseppe con gli uomini, se ne partirono per Nazaret. I fanciulli erano ammessi a viaggiare tanto cogli uomini, quanto colle donne. Riunitisi dopo un giorno di cammino Maria e Giuseppe s’accorsero che Gesù non era né coll’uno né coll’altra. Dopo averlo cercato invano fra i congiunti ed i conoscenti, afflitti rifecero tosto la strada di Gerusalemme e, trovatolo il terzo giorno nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, in atto di interrogarli e di ascoltarli, la Madre dolcemente chiesegli, perché si fosse fatto cercare così. - La risposta ch’Egli diede fu la prima dichiarazione della sua divinità: E perché mi cercavate? Non sapevate voi che nelle cose, che riguardano il padre mio, fa d’uopo che io mi trovi? Dopo ciò egli se ne ritornò con loro a Nazaret; e da questo punto fino all’età di trent’anni il Vangelo più non ci riferisce alcun fatto particolare di lui, ma compendia tutta la storia di quel tempo in queste parole: «Gesù viveva nell’obbedienza di Maria e di Giuseppe, e cresceva in età, in sapienza ed in grazia appresso Dio ed appresso gli uomini». Per questo fatto, che Gesù passò in Nazaret il tempo della sua vita privata, Egli fu poi chiamato: Gesù Nazareno.
• Battesimo di Gesù e suo digiuno nel deserto. Giovanni, figlio di Zaccaria e di Elisabetta, destinato da Dio, come fu detto, ad essere il precursore del Messia, ed a preparare gli ebrei a riceverlo, si era ritirato nel deserto a far vita penitente. Venuta l’ora di dar principio alla sua missione, Giovanni, vestito di pelle di cammello con ai lombi una cintura di cuoio, uscì sulle sponde del fiume Giordano, e si diede a predicare ed a battezzare. Egli gridava: «fate penitenza, imperciocchè il regno de’ cieli è vicino». Un giorno fra la moltitudine gli si presentò pure Gesù, il quale, essendo giunto all’età di trent’anni, doveva cominciare a manifestarsi al mondo. In sulle prime Giovanni, che lo riconobbe, voleva ritirarsi, ma poi vinto dal comando di Gesù, lo battezzò. Ed ecco che, appena uscito Gesù dall’acqua si aprirono i cieli, lo Spirito Santo, in figura di colomba, discese Su di lui, e s’udì una voce che diceva: «questi è il mio Figliuolo diletto». Ricevuto il battesimo, Gesù fu dallo stesso Spirito Santo condotto nel deserto, dove passò quaranta giorni e quaranta notti a vegliare, digiunare e pregare. In quell’occasione egli volle essere in varie guise tentato dal demonio, per insegnare a noi a vincere le tentazioni.
• Primi discepoli di Gesù e suo primo miracolo. Dopo tale preparazione Gesù per dare principio alla sua vita pubblica, ritornò nei pressi del fiume Giordano, dove Giovanni continuava a predicare; questi, vedendolo venire esclamò: «Ecco l’Agnello di Dio, ecco Colui che toglie i peccati del mondo». Questa ed altre testimonianze a favore di Gesù, ripetute ancora il giorno dopo, determinarono due discepoli di Giovanni a seguire il divino Maestro, che in quel giorno li trattenne seco. Uno di questi di nome Andrea, abbattutosi in un suo fratello chiamato Simone, lo menò a Gesù, il quale, riguardatolo in faccia, gli disse: «tu sei Simone figlio di Giona; d’ora innanzi sarai chiamato Pietro». E questi furono i primi suoi discepoli. Molti altri ancora, o da lui invitati, come Giacomo, Giovanni, Filippo, Matteo, o mossi dalle sue parole, si diedero a seguirlo. In sul principio essi non si fermavano continuamente con lui, ma dopo aver ascoltato i suoi discorsi, ritornavano alle loro famiglie ed alle loro occupazioni: solamente qualche tempo dopo lasciarono tutto, per non più abbandonarlo. Con alcuni di essi fu un giorno invitato ad una festa di nozze in Cana di Galilea, alla qual festa era pure stata invitata Maria sua madre. Si è in tale occasione che, per intercessione della sua Santissima madre Maria, cambiò una gran quantità di acqua in squisitissimo vino. E questo fu il primo miracolo di Gesù, per cui egli manifestò la propria gloria e confermò nella fede i suoi discepoli.
• Elezione dei dodici Apostoli. Fra questi discepoli Egli ne scelse poi dodici, che chiamò Apostoli, perché fossero sempre con lui, e per mandarli a predicare; e furono, Simone cui dato aveva il nome di Pietro, e suo fratello Andrea, Giacomo e Giovanni figliuoli di Zebedeo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Giuda Taddeo, Simone Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. A capo dei medesimi apostoli Gesù Cristo elesse Simone, ossia Pietro, che doveva essere poi il suo Vicario in terra.
• Predicazione di Gesù. Accompagnato dagli Apostoli, e talora da loro preceduto, per tre anni continui percorse più volte tutta la Giudea e la Galilea, predicando il suo Vangelo e confortando le sue parole con un numero infinito di miracoli. Per lo più nei sabati entrava nelle sinagoghe ed insegnava, sebbene, presentandosene l’occasione e l’opportunità, non sdegnasse di dare in qualunque luogo i suoi ammaestramenti. Leggiamo infatti che le turbe lo seguivano, ed egli predicava non solo nelle case, sulle piazze, ma ancora all’aperta campagna, sui monti, nei deserti, in riva al mare, e persino dal mare, salendo sulla navicella di Pietro.
• Il celebre discorso delle otto beatitudini è chiamato appunto il discorso del monte, dal luogo dove lo pronunziò. Coll’esempio predicava non meno che colle parole. I discepoli, ammirati delle sue lunghe orazioni, lo supplicarono un giorno che insegnasse a pregare anche a loro: e Gesù loro insegnò la sublime orazione del Pater noster. Gesù nei suoi insegnamenti, per varie ragioni, tra le quali fu anche quella di adattarsi alla capacità della maggior parte dei suoi uditori, ed all’indole dei popoli orientali, si serviva ben sovente di parabole, ossia similitudini. Sono semplici e sublimi quelle del figliuol prodigo, del samaritano, del buon pastore, dei dieci talenti, delle dieci vergini, del ricco epulone, del fattore infedele, del servo che non vuol perdonare, dei vignaiuoli, dei convitati alle nozze, del grano di senapa, della semente, del fariseo e del pubblicano, degli operai, della zizzania ed altre notissime ai buoni cristiani, che assistono alla spiegazione del santo Vangelo, che si fa alla domenica nelle loro parrocchie. Prosegue ...
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, andiamo avanti nel breve studio di storia della nostra gloriosa e santa Religione. Stiamo usando, per irrefutabile verità, il «Catechismo maggiore» di Papa san Pio X, «Sunto di storia dell’Antico Testamento». Inizio della citazione.
• Passato il mar Rosso, gli ebrei entrarono nel deserto, ed in brevissimo tempo avrebbero potuto giungere alla terra promessa, la Palestina, se fossero stati obbedienti alla divina legge ed ai comandi di Mosè loro condottiero; ma, avendo prevaricato ed essendosi ribellati più volte, Iddio li trattenne nel deserto 40 anni, lasciandovi perire tutti quelli che erano usciti dall’Egitto, eccettuati due soli: Caleb e Giosuè. In tutto questo tempo Iddio provvide al loro nutrimento con una specie di brina in bianchi e minuti granellini, chiamata manna, che ogni notte ricopriva la terra e veniva raccolta al mattino. Però nella notte precedente al sabato, il qual giorno era festivo per gli ebrei, la manna non cadeva: perciò se ne raccoglieva il doppio la mattina del venerdì. - Alla bevanda Iddio provvedeva coll’acqua, la quale sovente scaturì miracolosamente dalle rupi, percosse dalla verga di Mosè. Una gran nuvola poi, che di giorno li difendeva dai raggi del sole, e di notte, cambiandosi in colonna di fuoco, li illuminava e loro mostrava la via, li accompagnò per tutto quel viaggio.
• I dieci comandamenti della legge di Dio. Il terzo mese, dopo l’uscita dall’Egitto gli ebrei pervennero alle falde del monte Sinai. Fu là che, tra le folgori e i tuoni, Iddio parlò, e promulgò la Sua legge in dieci comandamenti, scritti su due tavole di pietra, che consegnò a Mosè, sulla vetta del monte. Ma quando ne discese, dopo 40 giorni di colloquio col Signore, Mosè trovò il popolo, che, caduto nell’idolatria, adorava un vitello d’oro. Compreso di santo zelo per tanta ingratitudine e tanta empietà, spezzò le tavole della legge, ridusse in polvere il vitello, e punì di morte i principali istigatori del grave peccato. Risalito poscia sul monte, implorò il perdono dal Signore, ricevette altre tavole della legge, e quando discese fu meravigliato il popolo di vedere com’egli avesse due raggi di luce in fronte, che rendevano la sua faccia splendente e gloriosa.
• Il Tabernacolo e l’Arca. Quivi appiè del Sinai Mosè, per comando di Dio e secondo le di lui prescrizioni, fabbricò il Tabernacolo e l’Arca. Il Tabernacolo era una gran tenda a guisa di tempio, che s’innalzava in mezzo agli accampamenti, quando gli Ebrei si fermavano. L’Arca era poi una cassa di legno preziosissimo, coperto entro e fuori di purissimo oro, in cui furono poscia collocate le tavole della legge, un vaso della manna del deserto e la verga fiorita di Aronne. Molte volte gli ebrei nel deserto, mormorando contro Mosè e contro il Signore, si attirarono gravi castighi. Fra questi è da notarsi quello dei serpenti velenosi, dai quali morsicati, molti perirono; molti poi, pentiti, si salvarono rimirando un serpente di bronzo, che, innalzato da Mosè sopra un’asta, dava immagine di croce. La virtù di questo emblema era simbolo delle virtù che avrebbe avuto la santa Croce di guarire le piaghe del peccato.
• Giosuè e l’entrata nella terra promessa. Dopo averli trattenuti per 40 anni nel deserto, Iddio introdusse gli ebrei nella terra promessa. Mosè la vide da lungi, ma non vi entrò: Giosuè gli succedette nel governo del popolo. Preceduti dall’Arca, passarono il fiume Giordano le cui acque si erano fermate per lasciare libero il passo nel letto del fiume: presero la città di Gerico, soggiogarono nella terra di Canaan i popoli che l’abitavano, e la divisero in dodici parti, quante erano le loro tribù. Così Iddio per mezzo del suo popolo castigò i gravissimi delitti di quelle genti. Queste tribù pigliarono il nome da Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Isacar, Zabulon, Dan, Neftali, Gad, Aser, Beniamino, figli di Giacobbe, e da Efraim e Manasse, figli di Giuseppe. La tribù di Levi però non ebbe territorio; Iddio la chiamò all’uffizio sacerdotale, e volle tenerle luogo Egli stesso di porzione e di eredità. Dalla tribù di Giuda, secondo aveva profetizzato Giacobbe morente, nacque poi il Redentore del mondo.
• Giobbe. In quei tempi viveva un principe nell’Idumea, ricchissimo e giusto, di nome Giobbe, il quale temeva Iddio e si guardava dal mal fare. Volendo il Signore farne un modello di pazienza nelle miserie più grandi della vita, permise che Satana lo tentasse con inaudite tribolazioni. In pochi giorni gli furono rapite le sue immense possessioni, la morte lo privò della numerosa sua famiglia, ed egli stesso fu colpito in tutto il corpo da un’ulcere maligna. Giobbe sbattuto da tante disgrazie non peccò d’impazienza; si gettò colla faccia per terra, adorò il Signore disse: «il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». Iddio, in premio della sua rassegnazione, lo benedisse e, ritornatolo in salute, lo prosperò più che prima. Tutto ciò viene luminosamente descritto in uno dei libri santi intitolato Giobbe.
• Gli ebrei sotto i giudici. Gli ebrei, resisi padroni della Palestina sotto la condotta di Giosuè, più non l’abbandonarono, governati secondo la legge di Mosè, o dai seniori del popolo, o dai giudici, e più tardi dai re. I Giudici furono persone (fra cui due donne, Debora e Giaele) suscitate ed elette di tempo in tempo da Dio per liberare gli ebrei, ogni qualvolta essi, in castigo dei loro peccati, erano caduti nella schiavitù dei loro nemici. I due più cospicui giudici furono Sansone e Samuele. Sansone, dotato di una forza straordinaria e meravigliosa, tribolò e danneggiò per molti anni i filistei, potenti nemici di Dio. Tradito poi e perduta la prodigiosa sua forza, usò gli ultimi avanzi di essa per far crollare un tempio dei suoi nemici, sotto cui fu seppellito, con molti di essi. Samuele, ultimo dei giudici, vinti i filistei, per ordine di Dio radunò il popolo che tumultuava e chiedeva un re, ed alla sua presenza elesse e consacrò Saulle, della tribù di Beniamino, a primo re di tutto il popolo ebreo.
• Gli ebrei sotto i re. Molti anni regnò Saulle, ma dopo i due primi per una gravissima disobbedienza, fu rigettato da Dio, e venne unto e consecrato re un giovane, di nome Davidde, della tribù di Giuda, il quale si rese presto illustre uccidendo in singolare combattimento un gigante filisteo chiamato Golia, che insultava il popolo di Dio schierato in battaglia. Saulle, sconfitto dai filistei, si diede la morte. Allora ascese al trono Davidde, il quale regnò sul popolo di Dio per 40 anni. Egli finì di conquistare tutta la Palestina, sconfiggendo gli infedeli, che vi erano rimasti, e specialmente s’impadronì della città di Gerusalemme, che elesse per sua dimora e fece capitale del regno. A Davidde succedette suo figlio Salomone, che fu l’uomo più sapiente che mai sia esistito. Edificò il tempio di Gerusalemme, ed ebbe regno lungo e glorioso. Ma negli ultimi anni della sua vita, per le arti insidiose di donne straniere, cadde nell’idolatria, e da alcuni si teme della sua salute eterna.
• Divisioni del regno. Succedette al re Salomone suo figlio Roboamo. Non avendo costui voluto diminuire il peso durissimo dei tributi imposti dal padre, dieci tribù gli si ribellarono, costituirono re Geroboamo, capo degli insorti, e restarono a Roboamo due sole tribù, quelle di Giuda e di Beniamino. Il popolo ebreo si trovò così diviso in due regni - il regno d’Israele e il regno di Giuda. Questi due regni più non si unirono, ma ciascuno ebbe le proprie vicende.
• Regno d’Israele e sua distruzione. I re d’Israele, in numero di 19, tutti perversi e caduti nell’idolatria, a cui trassero la maggior parte del popolo delle dieci tribù, governarono per 254 anni. Finalmente, in castigo delle enormi scelleratezze commesse, il popolo venne da Salmanasar, re degli Assiri, parte disperso, parte condotto schiavo nell’Assiria; ed il regno d’Israele cadde per non risorgere più (A. a. C. 722). Furono mandati a ripopolare il paese colonie di gentili, ai quali si assodarono in tempi successivi alcuni reduci israeliti e cattivi giudei, e tra tutti formarono poi un popolo, detto samaritano, nemico acerrimo della nazione giudaica. Fra gli israeliti condotti schiavi in Ninive, capitale dell’Assiria, vi fu Tobia, uomo santissimo, di cui ci è restata fra i Libri Santi una storia particolare, atta a farci altamente apprezzare il santo timore di Dio e le disposizioni della Sua Provvidenza.
• Regno di Giuda e schiavitù di Babilonia. I re di Giuda in numero di 20, dei quali alcuni pii e buoni, ed altri pur troppo anche scellerati, regnarono in tutto 388 anni. Ai tempi di Manasse, uno degli ultimi re di Giuda, successe quanto è scritto nel libro, che si intitola da Giuditta, la quale uccidendo Oloferne, capitano generale del re degli Assiri di quel tempo, liberò la città di Betulia e tutta la Giudea. Più tardi un altro re degli Assiri, chiamato Nabucodonosor, pose fine al regno di Giuda; egli s’impadronì di Gerusalemme e la distrusse tutta col tempio di Salomone fin dai fondamenti; fece prigioniero ed acciecò Sedecia, ultimo re, e condusse il popolo schiavo in Babilonia.
• Daniele. Durante la schiavitù di Babilonia visse il profeta Daniele. Scelto insieme con altri giovani ebrei, per essere educato e poscia destinato al servizio personale del re, colla sua virtù si acquistò la stima e l’affezione di Nabucodonosor specialmente dopo di aver al medesimo manifestato ed interpretato un sogno ch’egli aveva avuto e poscia dimenticato. Sebbene amato dal re, Daniele non andò esente dalle persecuzioni de suoi nemici, i quali, accusandolo di disobbedienza agli ordini sovrani, perché adorava il suo Dio, giunsero a cacciarlo in una fossa piena di leoni, dai quali però restò miracolosamente illeso.
• Fine della schiavitù di Babilonia e ritorno degli ebrei nella Giudea. La schiavitù di Babilonia durò 70 anni, dopo i quali i giudei ebbero da Ciro la libertà. Ricondotti in patria da Zorobabele, (A. a. C. 538), fabbricarono Gerusalemme ed il tempio, confortati nell’opera santa da Neemia ministro del re, e da Aggeo profeta. Non tutti però rimpatriarono. Tra quelli che rimasero nella terra straniera vi fu per divina disposizione Ester, la quale, essendo stata scelta dal re Assuero a sua sposa, salvò poi il suo popolo dalla distruzione, a cui era stato condannato dal re ad istigazione del ministro Amanno che odiava Mardocheo, zio della regina. I giudei ritornati a libertà, furono quind’innanzi più fedeli al Signore, vivendo nell’osservanza delle proprie leggi e riconoscendo per capo della nazione il loro sommo sacerdote, sotto una certa tal quale dipendenza ora dai re di Persia, ora dai re di Siria, ora dai re di Egitto, secondo la sorte delle armi. Fra questi re alcuni lasciarono in pace i giudei, ed alcuni altri li perseguitarono per ridurli all’idolatria. Il più crudele e tiranno fu Antioco Epifane, re di Siria, il quale bandì una legge, per cui, pena la morte, tutti i suoi sudditi dovevano abbracciare la religione pagana. Allora molti giudei acconsentirono a quell’empietà, ma molti più stettero forti e si conservarono fedeli a Dio, ed altri molti morirono di glorioso martirio. Così avvenne di un santo vecchio, detto Eleazaro, e di sette fratelli, detti Maccabei, colla loro madre.
• I Maccabei. Sorsero allora alcuni intrepidi sostenitori della religione e dell’indipendenza della patria, contro l’empio e crudele Antioco alla cui testa si pose un sacerdote per nome Mattatia, coi cinque suoi figliuoli, virtuosi e prodi come lui. Prima si ritirò ai monti, e raccolti ancora altri valorosi intorno a sé, discese e sbaragliò gli oppressori. Giuda, soprannominato Maccabeo, figlio di Mattatia, proseguì la guerra incominciata dal padre, e col favore di Dio e coll’aiuto dei suoi fratelli, fondò il breve regno detto dei Maccabei, che per 128 anni governarono la Giudea come pontefici e principi, poi anche come re. Questo gran capitano, chiamato nelle Sante Scritture uomo fortissimo, diede esempio insigne di pietà pei defunti, ed affermò solennemente la fede nel purgatorio, coll’ordinare una grande colletta di danaro da mandarsi in Gerusalemme, affinché si offrissero doni e sacrifizi in suffragio dei caduti nella guerra santa. Egli fu per le molte sue vittorie benedetto dal popolo, e fu il terrore dei suoi nemici. Ma infine sopraffatto da questi, non sostenuto dai suoi, morì da eroe colle armi in pugno, l’anno 161 prima dell’Era cristiana. A Giuda Maccabeo, succedettero un dopo l’altro i suoi fratelli Gionata e Simone, quindi il figlio di costui Giovanni Ircano, il quale tenne un governo savio, glorioso e felice. Ma i figliuoli e discendenti degenerarono dalla virtù dei maggiori, e discordi fra loro s’implicarono in disgraziate contese con potenti vicini; in breve la Giudea, perdute le forze ed il prestigio, a poco a poco cadde sotto il dominio dei romani.
• I romani e fine del regno di Giuda. I romani primieramente la resero tributaria, e poco appresso le imposero un re di nazione straniera, Erode il grande, così chiamato per alcune fortunate imprese, ma non grande certamente in faccia alla storia, la quale non tace i raggiri e le viltà per mezzo di cui assunse il desiato potere; del quale si valse poi a perseguitare la persona adorabile di Gesù Cristo nella sua infanzia. Esternamente fortunato, infelicissimo visse e morì; fine ordinaria dei persecutori. Dopo di lui regnarono, con varia estensione di potere, tre suoi figliuoli e due nipoti; ma fu breve la gloria, poiché il regno fu presto cambiato in provincia dell’impero romano; e in nome di esso fu mandato a reggerla un governatore.
• I Profeti. Iddio, a mantenere il suo popolo nell’osservanza della legge, od a richiamarvelo, e specialmente a preservarlo dall’idolatria, cui era potentemente inclinato, aveva in ogni tempo suscitati uomini straordinari, chiamati Profeti, i quali, da Lui ispirati, preannunciavano i futuri avvenimenti. Alcuni di tali Profeti, come Elia ed Eliseo, non lasciarono scritti: ma di loro e delle loro gesta, restò memoria nella Storia Sacra. Altri sedici lasciarono scritte le loro profezie, che furono conservate fra i Libri Santi. Quattro di questi, Geremia, Daniele, Ezechiele ed Isaia, sono detti maggiori, perché le loro profezie sono più ampie; gli altri dodici sono detti minori, per la ragione contraria. Mandato principale dei Profeti era quello di tener viva la memoria della promessa del Messia, e di preparare la ricognizione di lui. Annunziarono molti secoli prima il tempo preciso della venuta di Lui (di Gesù Cristo), ed anzi diedero una tale descrizione delle circostanze della nascita, della vita, della passione e della morte di Lui (di Gesù Cristo), che, leggendo il complesso delle profezie, i loro autori appaiono storici, più che Profeti.
• Alcune profezie che riguardano il Messia. Ecco alcune delle profezie, che riguardano il tempo della venuta del Messia: Il profeta Daniele sul finire della schiavitù di Babilonia annunziava chiaramente, che il Messia sarebbe comparso, vissuto, rinnegato dai giudei, e da loro ucciso, dopo settanta settimane di anni, e che poco dopo Gerusalemme sarebbe distrutta ed i giudei dispersi, senza più potersi costituire in nazione. I profeti Aggeo e Malachia annunziavano ai giudei che il Messia sarebbe venuto nel secondo tempio, e quindi prima della sua distruzione. Il profeta Isaia, oltre all’aver descritte molte circostanze della nascita e vita del Messia, annunziava che dopo la sua venuta i gentili si sarebbero convertiti. I fatti annunziati da questi e dagli altri profeti ebbero il loro compimento. Cioè si compirono le settanta settimane, fu distrutta Gerusalemme, fu distrutto il secondo tempio, i giudei furono e sono dispersi, ed i gentili si sono convertiti: dunque il Messia deve esser venuto. Più; tutte queste profezie ebbero il loro compimento nella persona di Nostro Signore Gesù Cristo, e solamente in Lui; dunque Egli è stato il vero Messia promesso.
• Annunciazione della Vergine Maria. Durante il regno di Erode, detto il grande, viveva in Nazaret, piccola città della Galilea, una santissima Vergine di nome Maria, sposata a Giuseppe, che il Vangelo chiama uomo giusto. Sebbene entrambi fossero discendenti dai re di Giuda, e quindi della famiglia di Davidde, tuttavia erano poveri, e guadagnavansi il vitto col lavoro. A questa Vergine fu mandato da Dio l’arcangelo Gabriele, il quale la salutò piena di grazia, e le annunciò che Ella sarebbe divenuta madre del Redentore del mondo. Alla vista ed alle parole dell’Angelo turbossi in prima Maria; ma poi, da lui rassicurata, rispose: Ecco l’ancella del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. In quello stesso momento il Figliuol di Dio, per opera dello Spirito Santo, s’incarnò nel seno purissimo di Lei, e restando vero Dio, cominciò ad essere vero uomo. Così ebbe principio la redenzione del genere umano. Prosegue ...
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, proseguiamo nel breve studio di storia della nostra santa Religione. Stiamo usando il «Catechismo maggiore» di Papa san Pio X, «Sunto di storia dell’Antico Testamento». Seguiranno le altre parti - Dio volendolo - nei prossimi numeri. Inizio della citazione.
• Creazione del mondo. In principio Iddio creò il cielo e la terra, con tutto ciò che nel cielo e nella terra si contiene: e sebbene avesse potuto compiere la grand’opera in un solo istante, volle impiegarvi sei periodi di tempo, che la Scrittura Santa chiama giorni. Nel primo giorno disse: sia fatta la luce, e la luce fu; nel secondo fece il firmamento; nel terzo dì separò le acque dalla terra, a cui comandò di produrre erbe, fiori ed ogni sorta di frutti; nel quarto fece il sole, la luna e le stelle; nel quinto dì creò i pesci e gli uccelli; nel sesto creò tutti gli altri animali, e finalmente creò l’uomo. Nel settimo giorno Iddio cessò dal creare, e questo giorno, che chiamò sabato cioè riposo, comandò poi per mezzo di Mosè al popolo ebreo che fosse santificato e consacrato a Lui.
• Creazione dell’uomo e della donna. Iddio creò l’uomo a Sua immagine e somiglianza, e lo fece così: ne formò il corpo di terra; poi gli alitò in faccia, infondendogli un’anima immortale. Iddio diede al primo uomo il nome di Adamo, che vuol dire formato di terra, e lo collocò in un luogo pieno di delizie, chiamato il Paradiso terrestre. Adamo però era solo. Volendo Iddio dargli una compagna e consorte, lo fece cadere in un profondo sonno e, mentre dormiva, gli tolse una costa, e di quella formò la donna, che presentò ad Adamo. Questi l’accolse con grato affetto e la chiamò Eva, che vuoi dire vita, perché sarebbe diventata la madre di tutti i viventi.
• Degli Angeli. Prima dell’uomo che è la creatura più perfetta di tutto il mondo sensibile, Iddio aveva pure creato una moltitudine infinita di altri esseri, di natura più elevata dell’uomo, chiamati Angeli. Gli Angeli, senza forma né figura alcuna sensibile, perché puri spiriti, creati per sussistere senza dover essere uniti a corpo alcuno, erano pure stati fatti da Dio ad immagine Sua, capaci di conoscerLo ed amarLo, e liberi di operare il bene ed il male. Nel tempo della prova, moltissimi di questi spiriti restarono fedeli a Dio, ma molti altri di loro peccarono. Il loro peccato fu di superbia, volendo essere simili a Lui, e da Lui non dipendere. Gli spiriti fedeli, chiamati Angeli buoni, o Spiriti celesti, o semplicemente Angeli, furono premiati coll’eterna felicità in Paradiso. Gli spiriti infedeli, chiamati Diavoli o Demoni, col loro capo detto Lucifero o Satanasso, furono scacciati dal Paradiso e condannati all’Inferno per tutta l’eternità.
• Peccato di Adamo ed Eva, e loro castigo. Iddio aveva posto Adamo ed Eva in uno stato perfetto di innocenza, di grazia e di felicità, esenti perciò dalla morte e da ogni miseria di anima e di corpo. Egli aveva loro permesso, di mangiare di tutti i frutti del Paradiso terrestre, e solamente aveva loro vietato di gustare quelli di un albero, che era in mezzo al Paradiso, e che la Sacra Scrittura chiama l’albero della Scienza del bene e del male. Così fu chiamato, perché per mezzo di esso, in virtù dell’obbedienza, Adamo ed Eva avrebbero avuto bene, cioè aumento di grazia e di felicità; o in pena della disobbedienza sarebbero decaduti dalla loro perfezione essi ed i loro discendenti, ed avrebbero fatto esperienza del male, tanto spirituale, quanto corporale. Iddio voleva che Adamo ed Eva nell’omaggio di questa obbedienza lo riconoscessero per Signore e Padrone. Il demonio, invidioso della loro felicità, tentò Eva, parlandole per mezzo del serpente, ed istigandola a trasgredire il ricevuto comando. Eva spiccò del frutto vietato, ne gustò, indusse Adamo a gustarne egli pure, ed ambedue peccarono. Questo peccato produsse per loro e per tutto il genere umano i più disastrosi effetti. Adamo ed Eva perdettero la grazia santificante, l’amicizia di Dio, ed il diritto al Paradiso: diventarono schiavi del demonio, e meritevoli dell’Inferno. Il Signore pronunziò contro di essi la sentenza di morte: li sbandì da quel luogo di delizie, e li cacciò fuori a guadagnarsi il pane col sudore della loro fronte, fra innumerevoli stenti e fatiche.
• Il peccato di Adamo poi si propagò a tutti i loro discendenti, eccetto Maria Santissima; ed è quello con cui tutti nasciamo, e che si chiamò peccato originale. Il peccato originale macchia l’anima nostra fin dal primo istante di nostra esistenza, ci rende nemici di Dio, schiavi del demonio, esclusi per sempre dal Paradiso, soggetti alla morte ed a tutte le altre miserie.
• Promessa d’un Redentore. Iddio però non abbandonò Adamo e la sua discendenza a tale disgraziatissimo fine. Nella sua infinita misericordia gli promise tosto un Salvatore (il Messia), che sarebbe venuto a liberare il genere umano dalla servitù del demonio e dal peccato, ed a meritargli il Paradiso. Tale promessa Iddio ripeté in seguito, molte altre volte ai Patriarchi ed al popolo ebreo, per mezzo dei Profeti. I figliuoli di Adamo ed i Patriarchi. Adamo ed Eva, dopo che furono scacciati dal Paradiso terrestre, ebbero due figli, cui diedero i nomi di Caino ed Abele. Cresciuti in età, Caino si dedicò all’agricoltura, ed Abele alla pastorizia. Avendo Iddio dimostrato di gradire i sacrifizi di Abele, che pio ed innocente Gli offeriva il meglio del suo gregge, e di sdegnare quelli di Caino, il quale offeriva i frutti della terra, questi, pieno d’ira e d’invidia contro il fratello, lo condusse seco a diporto nei campi, gli si avventò contro e lo uccise. Per consolare Adamo ed Eva della morte di Abele, Iddio diede loro un altro figliuolo, che chiamarono Seth, il quale fu buono e timorato di Dio. Adamo, durante la sua lunga vita di 930 anni, ebbe ancora molti altri figliuoli e figliuole, i quali moltiplicandosi, a poco a poco popolarono la terra. Fra i discendenti di Seth e degli altri figli di Adamo, i vecchi padri di numerosa progenie restavano a capo delle tribù, formate dalle famiglie dei figli e dei nipoti; ne erano prìncipi, giudici e sacerdoti. - La Storia li onora del nome venerando di Patriarchi. - La Provvidenza li dotava di lunghissima vita, affinché insegnassero ai posteri la religione rivelata, e, vigilando sulla tradizione fedele delle divine promesse, perpetuassero la fede nel venturo Messia.
• Il Diluvio. Coll’andar dei secoli, i discendenti di Adamo si pervertirono, e tutta la terra fu piena di vizi e di disonestà. Iddio, per tanta corruzione dapprima minacciò, poi punì il genere umano con un diluvio universale. Allora fece piovere per quaranta giorni e per quaranta notti, fino a tanto che restarono coperte d’acqua le più alte montagne. Tutti quanti gli uomini morirono annegati; non si salvarono che Noè e la sua famiglia. Noè, per ordine ricevuto da Dio, cento anni prima del diluvio, aveva cominciato a fabbricare un’arca, cioè una specie di nave, in cui poi era entrato egli con la sua moglie, coi suoi figliuoli - Sem, Cam e Iafet - con le tre mogli loro, e con quegli animali, che Dio gli aveva indicato.
• La torre di Babele. I discendenti di Noè ben presto si moltiplicarono e crebbero in sì gran numero che, non potendo più stare insieme, dovettero pensare a dividersi. Essi però, prima di separarsi, stabilirono di fabbricare una torre così alta, che arrivasse fino al cielo. L’opera si avanzava a gran passi, quando Iddio, offeso di tanto orgoglio, discese e ne confuse le lingue, per modo che i superbi edificatori, più non intendendosi fra loro, si dovettero disperdere senza compiere l’ambizioso disegno. La torre ebbe il nome di Babele, che vuoi dire confusione.
• Il popolo di Dio. Dopo il diluvio gli uomini non si conservarono per molto tempo fedeli a Dio, ma ricaddero ben presto nelle iniquità di prima, anzi giunsero al punto di perdere la cognizione del vero Dio, e di darsi all’idolatria, vale a dire, di riconoscere e adorare come divinità le cose create. Laonde Iddio per conservare la vera religione sopra la terra, si elesse un popolo e prese a governarlo con speciale provvidenza, preservandolo dalla generale corruzione.
• Esordi del popolo di Dio. Si rinnova con Abramo l’antico patto. A padre e stipite del suo popolo Iddio elesse un uomo della Caldea, chiamato Abramo, discendente dagli antichi Patriarchi per la linea di Eber. Il popolo, che da lui ebbe origine, fu chiamato Popolo Ebreo. Abramo si era conservato giusto in mezzo alla sua gente, datasi al culto degli idoli ed acciò perseverasse nella giustizia, Iddio gli ordinò di uscire dal suo paese e di trasferirsi nel paese di Canaan, detto pure Palestina, promettendogli che l’avrebbe fatto capo di un grande popolo, e che il Messia sarebbe nato dalla sua progenie. In conferma della parola di Dio, Abramo ebbe da Sara sua moglie, sebbene già avanzata in età, un figlio, che chiamò Isacco. Per provare la fedeltà ed obbedienza del Suo servo, Iddio gli ordinò di sacrificarGli questo suo unico figlio, che egli tanto amava, e sul quale riposavano le divine promesse. Abramo però, sicuro di queste promesse, non vacillò nella fede, e, come sta scritto nella Sacra Scrittura, sperò contro la stessa speranza; dispose tutto l’occorrente pel sacrificio, e l’avrebbe compito. Ma un angelo gli trattenne la mano; Iddio poi in premio della sua fedeltà lo benedisse, e gli annunziò che da quel figlio sarebbe venuto il Redentore del mondo. Isacco giunto all’età di quarant’anni, sposò Rebecca, sua cugina, madre poi ad un tempo di due figli, Esaù e Giacobbe. Ad Esaù, come primogenito sarebbe toccata la benedizione paterna; ma il Signore dispose che, per sollecitudine di Rebecca, Isacco benedicesse Giacobbe, al quale, per troppo meschino compenso, Esaù già aveva ceduto il diritto di primogenitura. Giacobbe allora, per sottrarsi all’ira di Esaù, dovette fuggire in Aran da suo zio Labano, che gli diede in ispose due sue figliuole - Lia e Rachele - e dopo venti anni tornò a casa ricchissimo, e con numerosa famiglia. Nel ritorno per via, prima che si riconciliasse col fratello, in una visione, che egli ebbe, gli fu cambiato il nome di Giacobbe in quello d’Israele. Giacobbe fu padre di dodici figliuoli; i due ultimi dei quali, Giuseppe e Beniamino, erano figli di Rachele. Tra i figli di Giacobbe il più savio e costumato era Giuseppe, sopra tutti carissimo al padre. Per questo motivo i fratelli presero ad odiarlo, e l’odio li portò a meditarne prima la morte, e poscia a venderlo a certi mercatanti ismaeliti, che lo condussero in Egitto e lo rivendettero a Putifarre, ministro di Faraone.
• Giacobbe ed i suoi figli in Egitto. Giuseppe in Egitto con la sua virtù si guadagnò subito la stima e l’affezione del suo signore; ma poi, calunniato dalla padrona, venne cacciato in prigione. Ivi stette due anni, cioè fino a tanto che, per aver interpretato al Faraone, ossia re d’Egitto, due sogni e profetizzato che sette anni di abbondanza sarebbero seguiti da sette anni di carestia, fu liberato e creato viceré d’Egitto. Nel tempo dell’abbondanza Giuseppe fece grandi provvisioni, sicché quando la fame cominciò a desolare la terra, l’Egitto rigurgitava di viveri. Da tutte le parti si dovette accorrere colà per comprarvi del grano; Giacobbe fu pure costretto a mandarvi i suoi figliuoli, i quali a prima giunta non riconobbero Giuseppe; riconosciuti però da lui, e dopo che egli loro si manifestò, ebbero l’incarico di condurre in Egitto il padre con tutta la sua famiglia. Giacobbe desideroso di abbracciare il figlio diletto, vi andò, e dal re gli fu assegnata per dimora sua e dei suoi la terra di Gessen. Dopo 17 anni di dimora in Egitto, Giacobbe vicino a morte, radunò intorno a sé i suoi dodici figli, in un con i due figli di Giuseppe, per nome Efraim e Manasse; raccomandò loro di ritornarsene nella terra di Canaan senza però dimenticare le sue ossa in Egitto, li benedisse tutti in particolare, predicendo a Giuda che lo scettro, ossia la sovrana potestà, non sarebbe uscito dalla sua discendenza fino alla venuta del Messia.
• Schiavitù degli Ebrei in Egitto. I discendenti di Giacobbe chiamati ebrei o israeliti, per alcun tempo furono rispettati e tollerati dagli Egiziani. Ma, essendo poi essi cresciuti in grandissimo numero, tanto da formare un gran popolo, da un altro Faraone, che regnò più tardi, vennero oppressi sotto il giogo della più dura schiavitù, e condannati persino a gettare nel fiume Nilo tutti i figli maschi appena nati.
• Liberazione degli ebrei per mezzo di Mosè. Sotto l’orrenda schiavitù d’Egitto, il popolo ebreo sarebbe perito tutto intero, né avrebbe rivedutola terra di Canaan, se Iddio non veniva a strappano prodigiosamente dalle mani dei barbari oppressori. Un bambino ebreo di nome Mosè era stato provvidenzialmente salvato dalle acque del Nilo dalla stessa figlia di Faraone, e da lei fatto istruire ed educare nella reggia di suo padre. Di lui si servì Iddio per liberare il Suo popolo, e adempiere in esso le promesse fatte ad Abramo. A Mosè adunque, fatto adulto, comandò Iddio che, in compagnia di suo fratello Aronne, andasse da Faraone, e gli ordinasse di lasciare partire gli ebrei dall’Egitto. Faraone si rifiutò. - Allora Mosè, per vincere il cuore indurito di lui, armato di una verga, percosse l’Egitto con dieci prodigiosi e terribili castighi, detti poi le Piaghe d’Egitto, ultimo dei quali fu che un Angelo in sulla mezzanotte, incominciando dal figlio del re, uccise tutti i primogeniti egiziani, sia degli uomini che degli animali. La notte in cui avvenne quell’eccidio, gli ebrei per comando di Dio, celebrarono la prima volta la festa di Pasqua, che vuol dire passaggio del Signore. - Questo fu il rito prescritto da Dio: che ogni famiglia uccidesse un agnello senza macchia, e segnasse col sangue di esso la porta di casa, la quale resterebbe così salva nel passaggio dell’Angelo; che ne arrostisse le carni, e poscia le mangiasse in veste da viaggio e col bastone in mano, come gente preparata per la partenza. Quell’agnello era figura dell’Agnello immacolato Gesù, il quale col Suo sangue avrebbe salvato dalla morte eterna tutti gli uomini. Faraone e tutti gli egiziani, alla vista dei loro figli morti, senza più, scongiurarono gli ebrei a mettersi in cammino, e loro diedero tutto l’oro e l’argento ed ogni cosa che domandarono. Gli ebrei partirono, e dopo tre giorni si trovarono alle sponde del mar Rosso.
• Passaggio del mar Rosso. Ben presto Faraone si penti di aver lasciato andare gli ebrei; si pose tosto ad inseguirli col suo esercito, e li raggiunse presso al mare. Mosè, confortato il popolo, che era intimorito alla vista degli egiziani, stese la sua verga sul mare, e le acque si divisero da riva a riva fino al fondo, lasciando una lunga via agli ebrei, che passarono a piede asciutto. Faraone ostinato nella perversità, si cacciò anche esso per quella via; ma, appena fu dentro, giù caddero le acque, e quanti erano, uomini e cavalli, perirono annegati. Prosegue ...
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, è arrivato il momento di studiare brevemente la storia della nostra santa Religione. Per non sbagliare, useremo il «Catechismo maggiore» di Papa san Pio X, partendo dal paragrafo «Principi e nozioni fondamentali». Seguiranno le altre parti - Dio volendolo - nei prossimi numeri. Inizio della citazione.
• Avendo Iddio sapientissimo ordinato tutte le cose da Lui create al fine ultimo di dargli gloria con la manifestazione delle sue divine perfezioni; anche l’uomo, nel mondo visibile principalmente, doveva promuovere ed adempiere questo fine, secondo la propria natura ragionevole, con gli atti liberi della sua volontà, cioè col conoscere Dio, con l’amarlo, col servirlo e così ottenerne quel premio, che Dio gli avrebbe poi dato. Questo vincolo morale, o legge universale, onde l’uomo si trova per natura legato a Dio si dice Religione Naturale.
• Ma avendo Iddio per sua bontà voluto preparare all’uomo un premio molto più grande ed elevato di quanto mai l’uomo potesse pensare e desiderare, volendo cioè metterlo a parte della sua medesima felicità, ne venne di conseguenza che a tanto fine la religione naturale più non bastasse, e perciò Dio stesso avesse ad istruire l’uomo nei suoi Doveri Religiosi. Si comprende quindi che la religione fin dal principio dovette essere, rivelata, ossia svelata da Dio all’uomo.
• Di tatto Dio rivelò la religione ad Adamo ed ai primi Patriarchi, che si succedevano gli uni agli altri, e potevano facilmente tramandarsela; vivendo insieme lunghissima vita; finché Iddio si ebbe formato un popolo, che la custodisse sino alla venuta del Salvatore Gesù Cristo, Verbo di Dio incarnato: il quale non la sciolse, ma la compì, la perfezionò e la confidò in custodia alla Chiesa per tutti i secoli. Tutto ciò è provato dalla storia della religione la quale, può dirsi, si confonde con la storia della umanità. Quindi è chiaro che tutte quelle, che diconsi religioni, fuori dell’unica vera rivelata da Dio, della quale parliamo, sono invenzioni degli uomini e deviazioni dalla Verità, della quale talune conservano una qualche parte, mista però a molte menzogne ed assurdità.
• Quanto poi alle sètte, ossia divisioni, che si fecero dalla santa Chiesa cattolica, apostolica, romana, esse furono sempre suscitate e sostenute o da uomini presuntuosi, che abbandonarono il sentimento della Chiesa universale, per tener dietro volontariamente ed ostinatamente a qualche errore proprio od altrui contro la fede - e sono gli eretici; - oppure da uomini orgogliosi ed avidi di dominio, i quali credendosi più illuminati di santa Chiesa, trascinarono una parte dei figli suoi a scindere, contro la parola di Gesù Cristo, la cattolica unità, separandosi dal Papa e dall’Episcopato unito con Lui, e sono gli scismatici.
• Invece il fedele cristiano cattolico, che inclina la sua ragione alla parola di Dio, predicatagli in nome di santa Chiesa dai legittimi Pastori, e adempie fedelmente la santa divina legge, cammina sicuramente sulla via che lo conduce al suo ultimo fine, e più s’istruisce nella religione, sempre meglio comprende la ragionevolezza della santa fede.
• Questo appunto fu il modo stabilito da Dio per la perpetua tradizione della religione: la successiva continua comunicazione degli uomini fra loro; sicché la verità insegnata dai maggiori si trasmettesse nella stessa guisa ai posteri; e ciò dovette durare anche dopo che una parte della divina legge fu per volere di Dio, in progresso di tempo consegnata in Libri da scrittori ispirati da Lui. Questi libri scritti sotto l’ispirazione di Dio si chiamano: Santa Scrittura, i Libri Sacri o la Sacra Bibbia. Diconsi libri del Vecchio Testamento, quelli che furono scritti prima della venuta di Gesù Cristo; e quelli che furono scritti dopo, chiamansi del Testamento Nuovo.
• Quì Testamento vuol dire Alleanza, Patto fatto da Dio con gli uomini: di salvarli cioè per mezzo di un Redentore promesso, a condizione che prestassero fede alla parola di Lui, ed obbedissero alle sue leggi. L’antico Patto fu stabilito da Dio prima con Adamo e Noè, poi più specialmente con Abramo e con la sua discendenza: esso imponeva la fede nel venturo Redentore o Messia, e l’osservanza della legge, data in principio da Dio, poi promulgata nel popolo suo per mezzo di Mosè.
• Il nuovo Patto, dopo la venuta di Gesù Cristo Redentore e Salvatore nostro, è stabilito da Dio con tutti quelli, che ricevono il segno da Lui stabilito, il Battesimo; e credono in Lui ed osservano la legge, che lo stesso Gesù Cristo venne a perfezionare e compire, predicandola in persona ed insegnandola di sua bocca agli Apostoli. Questi ricevuto il comando dal divino Maestro di predicare dappertutto il santo vangelo, lo predicarono realmente di loro bocca, prima, che fosse scritto, come poi lo fu per divina ispirazione. Ma né tutti, né solo gli Apostoli scrissero, e certamente né gli uni, né gli altri scrissero tutto ciò, che avevano visto e sentito.
• Da quanto ora dicemmo e da quanto accennammo, si comprende l’importanza somma della Tradizione divina, la quale è la stessa parola, da Dio medesimo dichiarata, a viva voce, ai primi suoi ministri, e da quelli passata fino a noi per una continua successione. Anche ad essa perciò giustamente si appoggia la fede come a stabilissimo fondamento.
• Questa Tradizione divina, unitamente alla Sacra Scrittura, cioè tutta insieme la parola di Dio scritta e trasmessa a viva voce, fu confidata da Nostro Signore Gesù Cristo ad un Depositario, pubblico, perpetuo, infallibile: cioè alla santa Chiesa Cattolica ed Apostolica; la quale fondandosi appunto sopra quella divina Tradizione, appoggiandosi all’autorità datale da Dio, ed affidata alla promessale assistenza e direzione dello Spirito Santo, definisce quali libri contengano la divina rivelazione, interpreta le Scritture, e ne fissa il senso ogniqualvolta nasca dubbio circa il medesimo, decide delle cose che riguardano la fede ed i costumi, e giudica inappellabilmente su tutte le questioni, che, riguardo a questi oggetti di suprema importanza, possano comunque far traviare la mente e il cuore dei fedeli credenti.
• Tale giudizio però si avverta, spetta a quella eletta parte della Chiesa che si chiama docente, cioè insegnante, formata in prima dagli Apostoli, e poi dai loro successori, i Vescovi con a capo il Papa, ossia il Romano Pontefice successore di san Pietro. Il Sommo Pontefice dotato da Gesù Cristo della medesima infallibilità, onde è fornita la Chiesa, e che gli è necessaria a conservare l’unità e (purezza) della dottrina, quando parla ex cathedra, ossia come Pastore e Dottore di tutti i cristiani, può fare quegli stessi decreti e portare quegli stessi giudizi nelle cose che riguardano la fede e i costumi, i quali niuno può rifiutare senza scapitar nella fede. Può sempre esercitare la suprema sua potestà in tutto ciò che riguarda eziandio la disciplina e il buon regime della Chiesa; e tutti i fedeli debbono obbedirlo con sincero ossequio della mente e del cuore. Nell’obbedienza a questa suprema autorità della Chiesa e del Sommo Pontefice, per la cui autorità ci si propongono le verità della fede, ci s’ impongono le leggi della Chiesa e ci si comanda tutto ciò che è necessario al buon regime di essa, sta la regola della nostra fede. Prosegue ...
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, studiamo il nono e decimo comandamento insieme: «Non desiderare la casa del prossimo tuo, né la moglie, il servo, la serva, il bue, l’asino e tutto quello che è suo», usando il semplice Catechismo del Santo Concilio di Trento.
• In questi due comandamenti è riposto il modo per osservare gli altri. Si noti, prima di tutto, che in questi due comandamenti, che sono stati dati per ultimi, è quasi riposto il segreto per cui si possono osservare tutti gli altri. Poiché quello che è imposto con queste parole mira a questo: che se uno vuole osservare i suddetti comandi della Legge, deve sopratutto badare a non desiderare disordinatamente. Infatti chi è contento di quel che possiede, non desidera né brama le cose altrui. Egli godrà dei vantaggi degli altri, darà gloria a Dio immortale, lo ringrazierà più che può, onorerà il sabato, cioè godrà di perpetua pace, onorerà i suoi maggiori, infine non offenderà alcuno né con atti né con parole, né in altro modo. Infatti, origine e seme di tutti i mali è la malvagia concupiscenza (1 Tm. 6, 10; Giac. 1, 14 e 4, 1), giacché, chi ne è acceso, cade a precipizio in ogni sorta di turpitudini e di colpe. Premesse queste avvertenze, il Parroco sarà molto diligente nell’esporre quel che segue, ed i fedeli più attentamente lo ascolteranno.
• Quantunque qui noi abbiamo unito due comandamenti, perché, essendone simile l’argomento, tengono la medesima via nell’ammaestrarci, il Parroco tuttavia, nell’esortare e nell’ammonire, potrà trattarli insieme o separatamente, come gli sembrerà più conveniente. Se poi si assumerà il compito di spiegare il Decalogo, mostri quale sia la dissomiglianza tra i due comandamenti e in che cosa una concupiscenza differisca dall’altra; la quale differenza è esposta da sant’Agostino nel libro delle questioni sull’Esodo. L’una di esse mira soltanto a ciò che è utile e a ciò che è vantaggioso; l’altra ha per oggetto le libidini ed i piaceri sessuali. Se dunque uno desidera il podere o la casa d’altri, brama più il lucro o l’utile che il piacere; se invece desidera la moglie altrui, arde non del desiderio dell’utile, ma del piacere.
• Duplice fu la necessità di questi comandamenti: la prima deriva dall’esigenza di spiegare il senso del sesto e settimo comandamento. Perché, quantunque con un certo naturale acume si potesse comprendere che, vietato l’adulterio, era pur proibita la brama di possedere la moglie altrui - giacché se fosse lecito il desiderare, dovrebbe esserlo ugualmente il possedere - tuttavia molti Ebrei, accecati dal peccato, non potevano essere indotti a credere che ciò fosse proibito; anzi, dopo che fu divulgata e conosciuta questa legge divina, molti che si professavano interpreti della Legge, caddero in questo errore, come si può capire dal discorso del Signore, nel Vangelo di san Matteo: «Udiste come fu detto agli antichi: Non fare adulterio. Ma io vi dico...» (Mt 5,27), con quel che segue. Seconda necessità di questi comandamenti è di vietare distintamente ed esplicitamente certe colpe, non vietate esplicitamente nei comandamenti sesto e settimo. Il settimo comandamento, per esempio, proibisce che uno desideri ingiustamente le cose altrui o tenti di prenderle; questo invece vieta che uno possa in qualche modo desiderare le cose altrui, quand’anche potesse ottenerle a buon diritto e secondo la legge, quando dal loro possesso derivasse un danno al prossimo.
• In questi precetti è manifesta la bontà di Dio verso di noi. Siano avvertiti i fedeli, prima di venire alla spiegazione del comandamento, che noi con questa legge non siamo soltanto ammaestrati a frenare le nostre cupidigie, ma anche a conoscere la pietà di Dio verso di noi, che è immensa. Egli infatti, avendoci fornito con i precedenti comandamenti della Legge una specie di difesa, perché nessuno potesse danneggiare noi e le cose nostre, con questo comandamento supplementare volle, sopratutto, provvedere che non ci danneggiassimo con i nostri sfrenati desideri. Il che facilmente ci sarebbe accaduto se fosse stata libera ed intera per noi la possibilità di bramare e desiderare ogni cosa. Col prescriverci, invece, questa legge su ciò che non dobbiamo desiderare, Dio provvide a che gli stimoli delle passioni, dalle quali possiamo più spesso esser incitati verso le cose a noi dannose, repressi in qualche modo dal vigore di questa legge, meno ci assillino. E così, liberati dalla molesta cura delle passioni, possiamo avere più tempo per compiere quei doveri di pietà e di religione, che, in gran numero ed importantissimi, dobbiamo a Dio stesso.
• Né questa norma c’insegna solo questo; ma ci ammonisce pure che la Legge di Dio è di tal fatta che bisogna osservarla non solo col compiere le obbligazioni esterne imposteci dal dovere, ma anche con l’intima adesione dell’animo. E questa è la differenza tra le leggi divine e le umane: queste si contentano dell’osservanza esterna; quelle invece, poiché Dio penetra nell’animo nostro, richiedono vera e sincera castità ed integrità dell’animo stesso. La Legge divina è come uno specchio, in cui vediamo i vizi della nostra natura; perciò l’Apostolo disse: «Non avrei conosciuto la concupiscenza, se la Legge non dicesse: Non desiderare» (Rm. 7, 7). Infatti, poiché la concupiscenza, cioè il fomite del peccato che ebbe origine dal peccato originale, perdura sempre in noi, veniamo a conoscere che siamo nati nel peccato; e perciò, supplichevoli, ci rifugiamo presso Colui che, solo, può togliere le sozzure del peccato.
• Le due parti del comandamento: proibizioni e prescrizioni. Ognuno di questi due comandamenti ha questo in comune con gli altri: da una parte, vieta qualche cosa, dall’altra parte, impone dei doveri da compiere.
• Per quanto riguarda la proibizione, perché nessuno creda che sia peccato la concupiscenza non viziosa, - come è quella dello spirito contro la carne (Gal. 5, 17), o quella che consiste nel chiedere ad ogni momento le divine giustificazioni (Ps. 118, 20), ciò che David desiderava di ricordare, - il Parroco insegni quale sia la concupiscenza che viene colpita dalla prescrizione di questa legge.
• Si ricordi che la concupiscenza è un turbamento ed uno stimolo dell’animo, per opera del quale gli uomini desiderano le cose gradite che non possiedono; ed a quel modo che gli altri appetiti dell’animo non sempre sono cattivi, così questo stimolo della concupiscenza non sempre deve essere riposto tra i vizi. Infatti non è cosa cattiva il desiderare cibo o bevanda, bramare di riscaldarci quando abbiamo freddo, o di rinfrescarci quando abbiamo caldo; anzi questo retto stimolo della concupiscenza è insito nella nostra natura per opera di Dio. Ma per il peccato dei nostri progenitori, accadde che esso, passando i confini segnalati dalla natura, si depravò a tal segno, che spesso è incitato a desiderare le cose, che ripugnano allo spirito e alla ragione.
• Questo stimolo, se moderato e racchiuso nei suoi limiti, spesso procura grandi vantaggi; perché, prima di tutto, fa in modo che noi preghiamo Dio con assiduità e chiediamo supplichevoli a Lui quello che sopratutto desideriamo. L’orazione infatti è la manifestazione del desiderio; e, se mancasse questo retto stimolo della concupiscenza, non ci sarebbero tante preghiere nella Chiesa di Dio. Inoltre ci rende più cari i doni di Dio, perché quanto più fortemente ardiamo del desiderio di una cosa, tanto più cara e gradita ci diviene, quando l’abbiamo ottenuta (onestamente - come Dio vuole, ndR). Lo stesso piacere, poi, che proviamo per la cosa desiderata, ci fa ringraziare Dio con maggiore devozione. Perciò, se qualche volta è lecito desiderare, dobbiamo riconoscere che non è proibito ogni stimolo di concupiscenza; e, quantunque san Paolo abbia detto che la concupiscenza è peccato (Rm. 7, 20), bisogna intendere ciò nel senso in cui parlo Mosè (Ex. 20, 17), del quale riporta la testimonianza; e lo dichiara la parola dello stesso Apostolo, poiché nella Lettera ai Galati chiama questo difetto: concupiscenza della carne. « Camminate, egli dice, nello spirito, e non soddisfate i desideri della carne» (5, 16).
• Dunque lo stimolo del desiderio naturale e moderato, che non esce dai suoi limiti, non è proibito; e molto meno quella spirituale tendenza di una retta mente, da cui siamo stimolati a desiderare ciò che ripugna alla carne. Ad essa infatti ci esortano le sacre Scritture, dicendo: «Desiderate i miei discorsi» (Sap. 6, 12); «Venite a me tutti voi che mi desiderate» (Eccli. 24, 26).
• Pertanto, con questa proibizione, non è vietato del tutto quel desiderio che può condurre tanto al bene che al male; ma la consuetudine della prava cupidigia, chiamata concupiscenza della carne e fomite di peccato, la quale porta con sé il consenso dell’animo, deve essere sempre annoverata tra i vizi. Dunque è vietata soltanto quella libidine di concupiscenza, che l’Apostolo chiama concupiscenza della carne (Gal. 5 ,16. 24), cioè quei moti di concupiscenza che non hanno alcun freno di ragione e non sono racchiusi nei limiti fissati da Dio.
• Questa cupidigia è condannata, sia che desideri il male, come adulteri, ebrietà, omicidi e altre simili colpe nefande, di cui l’Apostolo dice: «Non desideriamo ciò ch’è malvagio, come essi lo desiderarono» (1 Cor. 10, 6); - sia che quanto desideriamo non sia lecito per noi, quantunque le cose desiderate per natura non siano cattive. A questo genere di cose appartiene ciò che Dio, o la Chiesa vietano di possedere; non è infatti lecito desiderare ciò che è in generale proibito di possedere, come lo erano nell’antica Legge, l’oro e l’argento che erano serviti per farne idoli; le quali cose il Signore nel Deuteronomio vietò di desiderare (7, 25).
• Inoltre questa viziosa bramosia è proibita perché le cose che si desiderano sono di altri, come la casa, il servo, l’ancella, il campo, la moglie, il bove, l’asino, e molte altre, che la Legge divina vieta di desiderare appunto perché di altri. Il desiderio di tali cose è cattivo e viene annoverato tra i più gravi peccati, quando l’animo dà il suo consenso. Infatti si ha naturalmente il peccato, quando, dopo l’impulso di malvagie passioni, l’animo si diletta di cose biasimevoli e consente o non ripugna ad esse. Così insegna san Giacomo, allorché mostra l’origine e il progredire del peccato, con queste parole: «Ognuno è tentato, attratto e allettato dalla propria concupiscenza. Quando poi la concupiscenza ha concepito, produce il peccato; e il peccato quando è stato consumato, genera la morte» (1, 14).
• Spiegazione del comandamento. Giacché siamo così messi in guardia dalla Legge che dice: «Non desiderare», queste parole si devono intendere nel senso che dobbiamo tenere lontano il desiderio dalle cose altrui; che la sete di cupidigia per le cose degli altri è immensa e infinita, né mai si sazia. Sta scritto infatti: «L’avaro non si sazierà di denaro» (Eccle. 5, 9); ed anche Isaia dice: «Guai a voi che aggiungete casa a casa e unite campo con campo» (5,8). Ma dalla spiegazione delle singole parole più facilmente capiremo la turpitudine e la gravita di questo peccato.
• Il Parroco insegni che col termine «casa», non s’intende soltanto il luogo che abitiamo, ma tutti i beni ereditari, come si può ricavare dall’usanza e consuetudine degli scrittori sacri. Nell’Esodo sta scritto che alle levatrici furono edificate case da Dio (1 ,21); e la frase qui significa che le loro sostanze furono aumentate ed accresciute da Dio. Da questa interpretazione conosciamo che questa parte del precetto vieta di desiderare avidamente le ricchezze, di invidiare le facoltà, la potenza, la nobiltà altrui, mentre ci è imposto di contentarci del nostro stato, qualunque esso sia, umile o eccelso. Dobbiamo poi intendere che è vietato anche il desiderio della gloria altrui, giacché anche questa ha relazione con la casa.
• Quel che segue poi: «Né il bove né l’asino», mostra che non dobbiamo desiderare non solo le cose importanti, come la casa, la nobiltà e la gloria, quando siano d’altri, ma nemmeno le piccole, comunque siano, animate o inanimate.
• Segue ancora: «Né il servo, né la serva»; e ciò si deve intendere tanto degli schiavi presi in guerra, quanto di tutti i servi, che non dobbiamo desiderare, come ogni altro bene altrui. Quanto agli uomini liberi, che servono di loro volontà, per denaro, per amore e affetto, in nessun modo, né con parole, né con dar loro speranze, promesse, ricompense, si devono corrompere o indurre ad abbandonare coloro ai quali spontaneamente si sono vincolati; anzi, se prima del tempo pattuito per il loro servigio, se ne allontanassero, siano ammoniti, con l’autorità di questo comandamento, a farvi prontamente ritorno.
• Quanto alla menzione che nel comandamento si fa del prossimo, essa mira a dimostrare la colpa di coloro che insistono a desiderare i campi vicini, le case contigue, o altra cosa siffatta, che sia a portata di mano. La vicinanza, infatti, che suole considerarsi come un vincolo d’amicizia, talvolta cambia l’amore in odio, per colpa della cupidigia di possedere. Ma non offendono affatto questo comandamento quelli che desiderano comprare, o comprano a giusto prezzo dai vicini, quanto questi possono vendere. Essi infatti non solo non danneggiano il prossimo, ma lo aiutano grandemente, poiché il denaro gli sarà di maggior comodo e vantaggio di quelle cose che vende.
• Al precetto che vieta di desiderare la roba d’altri, segue l’altro che vieta di desiderare la moglie degli altri; da quest’ultimo veniva proibito non soltanto quella libidine di concupiscenza con cui l’adultero desidera la moglie altrui, ma anche quella per la quale uno desidera sposare la moglie d’altri. Infatti, quand’era permesso il ricorso al libello del ripudio, poteva facilmente avvenire che la donna ripudiata da uno fosse accolta in moglie da un altro. Ma il Signore lo vietò, affinché né i mariti fossero stimolati a lasciare le mogli, né le mogli si mostrassero scontrose e capricciose coi mariti, e così s’imponesse loro quasi una certa necessità di ripudiarle.
• Adesso dunque il peccato è più grave, perché un altro uomo non può sposare una donna ripudiata dal marito, se non dopo la morte di questo; e così chi desidera la moglie altrui, facilmente cadrà da un desiderio all’altro: bramerà infatti o che muoia il marito di lei, o di commettere un adulterio. Lo stesso si dica delle donne, promesse in matrimonio ad un altro; anche queste non è lecito desiderarle, giacché chi cerca di rompere il fidanzamento, viola un santissimo vincolo religioso. A quel modo poi che è somma nefandezza desiderare la donna d’altri, così non si deve in nessun modo desiderare come moglie la donna, consacrata al culto ed alla religione di Dio.
• Se poi uno desiderasse di prendere in moglie una donna maritata, non credendola però tale, disposto però a non desiderarla, se la sapesse maritata a un altro - come accadde al Faraone e ad Abimelech, che desiderarono sposare Sara, credendola nubile e sorella, non già moglie di Abramo (Gn. 12, 11; Gn. 20, 2 segg. ) -, colui che così pensa, non viola questo precetto.
• Rimedi contro la concupiscenza. Perché il Parroco possa indicare i rimedi adatti a togliere questa passione della cupidigia, deve spiegare l’altra parte del comandamento, che consiste in questo: se le ricchezze abbondano, non dobbiamo attaccarvi il cuore, ma essere invece sempre pronti a profonderle per pietà e per amore delle cose divine, volentieri erogandole nel sollevare le miserie dei poveri. Che se poi ci mancano i mezzi, dobbiamo sopportare la povertà con animo sereno e ilare. E così, se saremo liberali nel dare le cose nostre, estingueremo in noi il desiderio delle altrui. Quanto alle lodi della povertà e al disprezzo delle ricchezze, facilmente il Parroco potrà trovare molti argomenti nelle sacre Scritture e nei santi Padri, per esporli al popolo fedele.
• Con questa legge ci viene pure comandato di desiderare con ardente passione e con tutta la forza dell’animo che si compia sopratutto non ciò che desideriamo, ma quel che Dio vuole, secondo le parole nell’Orazione domenicale. E la volontà di Dio è sopratutto questa: che noi in maniera speciale diventiamo santi, conserviamo l’animo sincero, integro e puro da ogni macchia, e ci esercitiamo in quei doveri della mente e dello spirito, che ripugnano ai sensi materiali; cosicché, domati i loro appetiti, teniamo nella vita la retta strada, sotto la guida della ragione e dello spirito, e infine freniamo sopratutto l’impeto violento di quei sensi che offrono materia alla nostra cupidigia e alla libidine.
• Ma ad estinguere questo ardore di desideri giova moltissimo il proporci dinanzi agli occhi i danni che ne derivano. Primo danno è questo: se noi siamo schiavi di tali passioni, nell’anima nostra regna fortissimo il potere del peccato; perciò l’Apostolo ammonisce: «Non regni il peccato nel vostro corpo mortale, in modo che dobbiate ubbidire alle sue concupiscenze» (Rm. 6, 12). Poiché, come resistendo noi alle passioni, cadono a terra le forze del peccato, così, soccombendo ad esse, cacciamo il Signore dal suo regno, ed in suo luogo poniamo il peccato.
• C’è poi il secondo danno: da questo impeto di concupiscenze, come da una fonte, emanano tutti i peccati, come insegna san Giacomo (1, 14). E san Giovanni scrive: «Tutto quello che è nel mondo, è concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e superbia della vita» (1 Gv. 2, 16).
• Il terzo danno consiste in questo: dalle passioni viene oscurato il retto giudizio dell’animo, perché gli uomini accecati dalle tenebre delle passioni, giudicano onesto e bellissimo quanto essi bramano. Infine l’impeto della concupiscenza soffoca la parola di Dio, posta nelle anime da quel grande agricoltore che è Dio. Così infatti sta scritto in san Marco: «Gli altri (chicchi di grano) seminati tra le spine, sono coloro che ascoltano la parola; ma le cure del mondo, l’inganno delle ricchezze e le voglie delle altre cose s’insinuano a soffocare la parola: la quale resta così infruttuosa» (4, 18. 19).
• Chi soprattutto debba esser tenuto lontano dal vizio della concupiscenza. Più di tutti gli altri, sono colpiti da questi vizi della concupiscenza e sono quindi più bisognosi di essere esortati dal Parroco a osservare più diligentemente questo comandamento, quanti si dilettano di giuochi disonesti, o abusano immoderatamente dei giuochi; così pure quei mercanti che desiderano penuria d’ogni cosa e carestia, o sopportano a malincuore che ci siano altri i quali riescono a vendere a più caro prezzo, o a comperare più a buon mercato di loro.
• Peccano allo stesso modo quanti desiderano che gli altri siano nel bisogno, per potere nel commercio guadagnare di più. Così pure peccano quei soldati che bramano la guerra per cupidigia di saccheggio; i medici che desiderano le malattie; i giureconsulti che si augurano abbondanza di cause e di liti; gli artigiani, infine, che, avidi di guadagno, invocano penuria di quanto è necessario alla vita, per trame il maggior lucro possibile. Inoltre, in questo peccano gravemente quanti sono avidi e bramosi di acquistare lode e gloria, sia pure a prezzo di calunnia e danno alla fama altrui; sopra tutto se coloro che desiderano lode e gloria, sono uomini inetti e di nessun valore. Poiché la lode e la fama sono premi del valore e del lavoro, non già dell’ignavia e della nullità.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, studiamo l’ottavo dei comandamenti: «Non dirai contro il prossimo tuo falsa testimonianza», usando il semplice Catechismo del Santo Concilio di Trento.
• Necessità di una frequente spiegazione di questo comandamento. Quanto sia non solo utile, ma anche necessaria un’assidua spiegazione di questo comandamento e un’assidua esortazione a questo dovere, lo ricorda san Giacomo con queste parole: «Se uno non sbaglia nel discorrere, è uomo perfetto»; ed ancora: «La lingua è un piccolo membro, eppur capace di grandi effetti. Ecco qual grande selva incendia un così piccolo fuoco!» (Gc. III, 2, 5), con quel che segue, sempre a questo proposito.
• Siamo ammoniti così di due cose: primo, che molto ampiamente è diffuso questo vizio della lingua, il che è confermato anche dalla sentenza del Profeta: «Ogni uomo è mendace» (Ps. 115, 11); di modo che questo è quasi il solo peccato, che sembra estendersi a tutti gli uomini; secondo, che da esso derivano mali innumerevoli, poiché spesso per colpa d’un maldicente si perdono la ricchezza, la fama, la vita, la salvezza eterna, tanto di colui che è offeso, perché non può sopportare pazientemente le ingiurie e cerca di vendicarle con animo inconsiderato, come di colui che offende, perché, per un inconsulto pudore o spaventato dalla falsa opinione della stima pubblica, non può indursi a dare soddisfazione all’offeso. Perciò bisognerà ammonire i fedeli di ringraziare quanto più possono Iddio di questo salutare comandamento che ordina di non dire falsa testimonianza: comandamento che non solo ci vieta di offendere gli altri, ma con la sua osservanza impedisce anche che siamo offesi dagli altri.
• Le due parti del comandamento. Nella spiegazione di questo comandamento dobbiamo procedere con lo stesso metodo e per la stessa via che usammo per gli altri, distinguendo cioè in esso due leggi: una che proibisce di dire falsa testimonianza; l’altra che comanda di pesare le nostre parole e le nostre azioni con la verità, eliminando ogni simulazione e menzogna. L’Apostolo ammonì gli Efesini di questo dovere con le parole: «Operando la verità nella carità, cresciamo in lui (cioè in Cristo) in ogni cosa» (Efes. 4, 15).
• La prima parte di questo comandamento col nome di falsa testimonianza indica egualmente ciò che si dice in bene o in male di qualcuno, sia in giudizio, sia fuori: tuttavia proibisce specialmente la falsa testimonianza resa in giudizio da chi ha giurato. Infatti il testimone giura nel nome di Dio, perché il discorso di chi fa tale testimonianza, interponendovi il nome divino, ha moltissima credibilità ed importanza. Essendo questa falsa testimonianza pericolosa, è proibita in modo speciale. Infatti neppure il giudice può respingere testimoni che giurino, se non siano esclusi da legittimi motivi o sia manifesta la loro malvagità e perversità, sopratutto dal momento che la Legge divina comanda che per bocca di due o tre testimoni si stabilisca ogni cosa (Dt. 19, 15; Mt. 18, 16).
• Ma perché i fedeli intendano chiaramente il comandamento, sarà loro spiegato che cosa s’intende con la parola prossimo, contro il quale non è in nessun modo lecito di dire falsa testimonianza. Come è esposto dalla dottrina di Cristo Nostro Signore (Lc. 10, 29), è prossimo chiunque ha bisogno dell’opera nostra, sia egli parente od estraneo, concittadino o forestiero, amico o nemico; non è infatti permesso credere lecita la falsa testimonianza contro i nemici, che pure dobbiamo amare per comando di Dio Signor nostro. Anzi, poiché ognuno in certo modo è prossimo a se stesso, non è lecito dire falsa testimonianza contro se stessi; coloro che così fanno, imprimendosi da sé stessi una nota d’ignominia e di turpitudine, offendono sé e la Chiesa, di cui sono membri, a quel modo stesso che i suicidi nuocciono alla collettività dei propri concittadini. Infatti sta scritto in sant’Agostino: «A chi non consideri bene, potrebbe sembrare che non sia proibito essere falso testimonio contro se stesso, giacché nel comandamento fu aggiunto: contro il prossimo tuo. Ma nessuno, dicendo falsa testimonianza contro se stesso, creda di essere immune da questa colpa, poiché chi ama il prossimo deve prendere questa norma dall’amore di se stesso».
• Ma, dal momento che è proibito di danneggiare il prossimo con la falsa testimonianza, nessuno però creda che sia lecito il contrario, cioè procurare, spergiurando, qualche utilità o vantaggio a chi ci sia congiunto per natura, o per religione. Nessuno infatti deve dire menzogne o cose vane, e tanto meno fare uno spergiuro. Perciò sant’Agostino, scrivendo sulla menzogna a Crescenzio, ammonisce, secondo la sentenza dell’Apostolo, che la bugia è da annoverarsi tra le false testimonianze, quand’anche si dica per falsa lode di qualcuno. Infatti, spiegando quel passo paolino che dice: «Noi saremmo falsi testimoni di Dio, giacché abbiamo testimoniato di Dio questo: che egli risuscitò Cristo, che invece non sarebbe risuscitato, se fosse vero che i morti non risorgono» (1 Cor. 15, 15), egli osserva: «L’Apostolo chiama falsa testimonianza il mentire intorno a Cristo ed a tutto ciò che si riferisce a sua lode».
• Spessissimo poi accade che chi favorisce l’uno, osteggi l’altro; e la causa dell’errore si attribuisce certamente al giudice, che talvolta, indotto da falsi testimoni, stabilisce ed è costretto a giudicare contro il diritto, con vera ingiustizia. Accade anche che chi ha vinto in giudizio una causa per la falsa testimonianza di qualcuno e se la passa impunemente, esultando dell’iniqua vittoria, si avvezzi (abitui, ndR) a corrompere e ad usare falsi testimoni, per opera dei quali spera di poter giungere a quel che brama. Ora questo fatto è, prima, una cosa gravissima per il testimone stesso che viene riconosciuto falso e spergiuro da colui stesso che, col suo giuramento, ha soccorso ed aiutato; poi, giacché l’inganno gli riesce come desidera, egli prende ogni giorno maggior pratica ed abitudine all’empietà e all’audacia. Come dunque sono proibite le menzogne, le bugie e gli spergiuri dei testimoni, così tutte queste colpe sono proibite negli accusatori, negli accusati, nei patrocinatori, sostenitori, procuratori ed avvocati; e infine in tutti quelli che costituiscono i tribunali.
• In ultimo, Dio proibisce, non solo in giudizio, ma anche fuori, ogni testimonianza che possa recare ad altri incomodo o danno. Sta scritto, infatti, nel Levitico, dove si ripetono questi comandamenti: «Non farete furto; non mentirete, né alcuno ingannerà il suo prossimo» (XIX, 11). Così nessuno può dubitare che ogni menzogna, proibita con questo comandamento, sia condannata da Dio; e questo molto apertamente lo testimonia David cosi: «Distruggerai tutti quelli che dicono menzogna» (Ps. 5, 7).
• Altri peccati proibiti con questo comandamento. È proibita da questo comandamento non solo la falsa testimonianza, ma anche la detestabile mania ed abitudine di denigrare gli altri. È incredibile quante sciagure gravi, pericolose e cattive, derivino da questa peste. Il vizio di parlare con maldicenza e con offesa degli altri occultamente, spesso è rimproverato dalle divine Scritture: «Con il maldicente, dice David, non mi sedevo a mensa» (Salm. C, 5); e san Giacomo: «Non vogliate denigrarvi a vicenda, o fratelli» (Gc. 4, 11). Né abbondano soltanto i richiami della sacra Scrittura, ma anche gli esempi dai quali è dimostrata la gravità della colpa. Aman accese tanto Assuero contro i Giudei con la falsa accusa di delitti, che questi comandò d’uccidere tutti gli uomini di quel popolo (Ester 13). È piena la Storia sacra di simili esempi, col ricordo dei quali i sacerdoti cercheranno di tener lontani i fedeli da una colpa tanto malvagia.
• Affinché si capisca la gravità di questo peccato con cui si denigrano gli altri, bisogna ricordare che non soltanto coll’usare la calunnia, ma anche con l’accrescere ed amplificare le colpe, si lede la stima di cui gode un uomo. E quando uno commette occultamente un’azione, che, se risaputa, sarebbe nociva alla sua fama, chi la divulga dove, quando, o a chi non sarebbe necessario, a buon diritto è detto denigratore e maldicente. Fra tutte le denigrazioni, nessuna è più grave di quella di denigrare la dottrina cattolica ed i suoi difensori. Cade in codesta colpa chi colma di lodi gli autori di malvagie dottrine e di errori.
• Né sono separati dal numero ed esenti dalla colpa di costoro quelli che, prestando orecchio ai detrattori e maldicenti, non riprendono i calunniatori, ma volentieri li approvano. Infatti, se sia più condannabile il calunniare o l’ascoltare un calunniatore, non si saprebbe dire facilmente, come scrivono san Girolamo e san Bernardo; non ci sarebbe infatti chi calunnia, se non ci fosse chi ascolta il calunniatore.
• Appartengono alla medesima razza quelli che, con le loro arti, separano gli uomini e li spingono l’uno contro l’altro, e si dilettano molto di suscitare discordie, in modo che, rompendo, con finti discorsi, strettissime unioni ed alleanze, inducono uomini amicissimi a perpetue inimicizie e li spingono alle armi. Questa peste, il Signore l’ha in abominio: «Non sarai infamatore né sobillatore in mezzo al popolo» (Lv. 19). Tali erano molti dei consiglieri di Saul, che cercavano di alienare il suo favore da David ed incitare il re contro di lui.
• Commettono infine questo peccato gli uomini lusingatori ed adulatori che, con blandizie e lodi simulate, si insinuano nelle orecchie e nell’animo di coloro di cui ricercano il favore, il denaro e gli onori, «chiamando male il bene e bene il male», come scrive il profeta (Is. 5, 20). David ammonisce di tenere lontani costoro e di cacciarli dalla nostra società con queste parole: «Il giusto mi rimprovererà nella sua misericordia e mi sgriderà; ma l’olio del peccatore non ungerà il mio capo» (Ps. 140, 5). Quantunque, infatti, costoro non sparlino affatto del prossimo, tuttavia gli nuocciono moltissimo, giacché essi, col lodare i suoi peccati, gli offrono una ragione per perseverare nei vizi, finché vive.
• Però in questo genere di vizi è peggiore l’adulazione usata per la calamità e la rovina del prossimo. Così fece Saul, il quale, desiderando gettare David in preda al furore ed al ferro dei Filistei perché fosse ucciso, lo blandiva con queste parole: «Ecco la mia figlia maggiore Merob, te la darò per moglie; sii soltanto guerriero valoroso e combatti le guerre del Signore». Così fecero i Giudei quando, con insidioso discorso, parlarono con Cristo Signore: «Maestro, sappiamo che sei veritiero ed insegni la via del Signore secondo la verità» (Mt. 22, 16; Mc. 12, 14).
• Molto più pericoloso, poi, è il discorso che gli amici, gli affini e i congiunti fanno talvolta per illudere quelli che, colpiti da malattia mortale, sono ormai in punto di morte. Affermano che egli non è in imminente pericolo. Lo consigliano a stare lieto ed allegro, e lo distolgono dalla confessione dei suoi peccati; infine tengono lontano il suo animo da ogni cura e pensiero dei supremi pericoli, nei quali soprattutto si trova.
• Perciò bisogna fuggire ogni sorta di menzogne, ma specialmente quelle dalle quali uno può ricevere grave danno. Colma d’empietà è la menzogna quando si mentisce contro la religione od in cose di religione. Ma Dio si offende gravemente anche con le ingiurie e le calunnie contenute nei libelli chiamati infamanti, e per altri simili oltraggi. Inoltre, cadere nella menzogna scherzosa od ufficiosa, quand’anche nessuno ne abbia danno o vantaggio, è in generale cosa da non farsi, come ammonisce l’Apostolo: «Deponendo la menzogna, dite la verità» (Efes. 4, 25). Infatti, da ciò nasce una grande inclinazione a menzogne più frequenti e più gravi. Dalle menzogne dette per scherzo gli uomini prendono l’abitudine di mentire, in modo che vengono tenuti nella considerazione pubblica come non veritieri; per cui han bisogno di giurare continuamente affinché il loro discorso sia creduto.
• Per finire, nella prima parte di questo comandamento è condannata la simulazione; e non solo le parole dette con simulazione, ma anche le azioni cosiffatte partecipano di questa colpa. Infatti, tanto le parole che le azioni sono indizi e segni di quel che è nell’animo d’ognuno. Perciò il Signore, redarguendo spesso i Farisei, li chiama ipocriti. E ciò basti per la prima parte del comandamento, che riguarda quanto esso proibisce.
• Che cosa comanda il Signore riguardo ai giudizi forensi. Ora esporremo che cosa comandi il Signore nell’altra parte del comandamento. Il contenuto e l’espressione del precetto mirano a questo: che i giudizi forensi si facciano con giustizia e secondo le leggi, che gli uomini quindi non si arroghino, né usurpino tali giudizi; non è lecito infatti giudicare un servo altrui, come scrive l’Apostolo (Rm. 14, 4); affinché non diano la sentenza in una causa loro sconosciuta, come fece il consesso di sacerdoti e scribi, che giudicò santo Stefano (Act. 6, 12; Act. 7); peccato che fu pure commesso dai magistrati di Filippi, ai quali l’Apostolo fece dire: «Dopo averci battuto pubblicamente, senza processo, romani come siamo, ci hanno messo in prigione; e ora ci mandano via di nascosto» (Act. 16, 37). Non condannino gli innocenti, né assolvano i colpevoli; non si lascino smuovere dal denaro, dai favori, dall’odio o dall’amore. Così infatti Mosè ammonisce gli anziani, che egli aveva eletto giudici del popolo: «Giudicate secondo giustizia sia l’imputato cittadino sia forestiero. Non ci sia differenza di persone; ascolterete il piccolo e il grande: non guarderete in faccia a persona, perché giudicare spetta a Dio» (Dt. 1, 16).
• Quanto agli accusati ed ai colpevoli, Dio vuole che confessino la verità, quando sono interrogati secondo la formula giudiziaria. Infatti tale confessione è come una testimonianza ed un riconoscimento della lode e gloria di Dio, secondo le parole di Giosuè, che esortando Achan a confessare il vero, disse: «Figlio mio, dai gloria al Signore Dio d’Israele» (Gios. 7, 19).
• Ma siccome questo comandamento riguarda sopratutto i testimoni, anche di essi il Parroco tratterà con diligenza: poiché il comandamento non solo vieta la falsa testimonianza, ma impone anche di dire la verità. Nelle cose umane, infatti, si fa grandissimo uso di una testimonianza veridica; sono, infatti, innumerevoli le cose che ignoreremmo se non le conoscessimo per attestazione di testimoni. Per cui nulla è così necessario come la verità delle testimonianze in quello che non possiamo sapere da noi, e che tuttavia non dobbiamo ignorare. Intorno a ciò abbiamo la celebre sentenza di sant’Agostino: «Chi nasconde la verità, e chi dice menzogna, sono ambedue colpevoli; il primo perché non vuol giovare ad altri; il secondo perché desidera di nuocere». È lecito tacere talvolta la verità, ma fuori del tribunale; in giudizio, quando il testimonio è interrogato nelle forme rituali dal giudice, deve svelare completamente la verità. Qui tuttavia badino i testimoni a non affermare per vero, quel che non sanno sicuramente, troppo fidandosi della propria memoria.
• Restano i patrocinatori delle cause e gli avvocati, tanto di difesa quanto di accusa. Quelli non facciano mancare l’opera ed il patrocinio loro nelle circostanze necessarie, venendo benignamente in aiuto ai bisognosi; ma non prendano a difendere cause ingiuste, né allunghino le liti con i cavilli, né le alimentino con l’avarizia. La mercede dovuta al loro lavoro ed alla loro opera, la fisseranno con giustizia ed equità.
• Detti avvocati, poi, sia nel foro civile che nel penale, siano ammoniti a non creare un pericolo con ingiuste accuse, per amore o per odio verso qualcuno, o per passione. Infine questo comando fu dato da Dio a tutti gli uomini buoni: nelle adunanze e nei colloqui parlino sempre veracemente e secondo l’animo loro; non dicano nulla che possa nuocere alla stima di altri, neppure a proposito di coloro dai quali essi credono di essere danneggiati ed offesi; tenendo sempre presente che deve esistere con essi tale solidarietà e familiarità da risultare membra del medesimo corpo.
• Abiezione e turpitudine della menzogna. Perché i fedeli si possano guardare meglio dal vizio della menzogna, il Parroco spieghi la grande abiezione e turpitudine di questa colpa. Nelle sacre Scritture il demonio è chiamato «padre della menzogna» (Giov. 8, 44); che, non essendo stato saldo nella verità, è «menzognero e padre della menzogna». Aggiungerà, per estirpare un così grande vizio, i mali che tengono dietro alla menzogna; e poiché sono innumerevoli, mostrerà in essa la fonte e l’origine dei disordini e delle sciagure. Primo, spieghi in quale grave offesa a Dio ed in quanto Suo odio venga a cadere l’uomo falso e menzognero; e lo illustri con l’autorità di Salomone: «Sei sono le cose che il Signore odia, e la settima aborre l’anima sua: occhi superbi, lingua menzognera, mani che versano sangue innocente, cuore che macchina pessime intenzioni, piedi veloci nel correre al male, testimonio menzognero che proferisca cose false» (Pr. 6, 16-19); con quel che segue. Chi, dunque, potrebbe assicurare a chi è in odio speciale a Dio, di non esser tormentato dai più gravi tormenti? Inoltre, che cosa c’è di più impuro e di più turpe, come dice san Giacomo, che usare quella medesima lingua, con cui lodiamo Dio Padre, per dir male degli uomini, fatti ad immagine e somiglianza di Dio, così come se una fonte da un medesimo foro facesse scaturire acqua dolce ed amara? (Gc. III, 9, 11). Quella lingua, infatti, che prima dava lode e gloria a Dio, poi lo colpisce, per quanto le è possibile, di vituperio e di disdoro (vergogna, infamia, ndR), mentendo. Per questo avviene che i bugiardi sono esclusi dal possesso della beatitudine celeste. Infatti chiedendo David a Dio: «Signore, chi abiterà nel tabernacolo tuo?» - risponde lo Spirito santo: «Chi dice la verità in cuor suo, chi non fece inganno con la sua lingua» (Ps. XIV, 1, 4, 5).
• Ma il danno principale della menzogna è che essa è quasi insanabile malattia dell’animo. Infatti, il peccato che si commette accusando qualcuno falsamente d’una colpa, o denigrando la fama e la stima del prossimo, non viene rimesso se il calunniatore non dia soddisfazione dell’ingiuria a chi ha incriminato. Ma gli uomini ben difficilmente lo fanno, perché, come abbiamo avvertito, ne vengono distolti sopratutto da un falso pudore e da una certa vana opinione della propria dignità. Chi, dunque, è in questo peccato, non possiamo dubitare che sia condannato alle pene eterne dell’inferno. Né alcuno speri di poter ottenere perdono delle calunnie o della denigrazione fatta se prima non dia soddisfazione a colui, la cui dignità e fama egli ha denigrato in qualche modo, o pubblicamente in giudizio, o anche in adunanze private e familiari. Inoltre, questo danno è molto grave ed esteso, e colpisce tutti; perché dalla falsità e dalla menzogna sono rotti i vincoli più stretti della società umana: la lealtà e la verità. Tolti questi, ne segue una gran confusione nella vita, e gli uomini in nulla sembrano differire dai demoni.
• Il Parroco insegni, inoltre, che bisogna evitare la loquacità, così possiamo sfuggire anche gli altri peccati e ci si può correggere dal vizio della menzogna; vizio dal quale difficilmente si possono astenere le persone loquaci.
• In ultimo, il Parroco confuterà l’errore di quelli che, con i loro vani discorsi, si scusano, e difendono la menzogna sull’esempio dei furbi; i quali ritengono virtù, essi dicono, mentire a tempo debito. Il Parroco dirà, il che è verissimo, che «le aspirazioni della carne sono morte per l’anima» (Rm. 8, 6). Esorterà i suoi uditori a confidare in Dio nelle difficoltà, nelle angustie, senza ricorrere all’artificio della menzogna; poiché quelli che usano questo sotterfugio dichiarano, senz’altro, che si fanno forti della propria prudenza più che non abbiano speranza nella Provvidenza divina. A chi attribuisce la causa della sua menzogna al fatto che fu egli pure ingannato con la menzogna, bisogna far presente che «non è lecito agli uomini vendicarsi da se stessi», e che «non bisogna compensare il male col male, ma piuttosto vincere il male col bene»(Rm. XII, 17, 19, 21). E quand’anche fosse permesso dare questo contraccambio, a nessuno tuttavia è utile vendicarsi con proprio danno, essendo gravissimo danno quel che facciamo, dicendo menzogne. A quelli che adducono a scusa la debolezza e la fragilità della natura umana, si raccomandi il doveroso precetto di implorare l’aiuto divino e di non sottostare alla debolezza della natura.
• Quelli che oppongono la forza della consuetudine siano ammoniti, se hanno preso l’abitudine di mentire, a cercare di prendere l’abitudine contraria, cioè di dire il vero, soprattutto perché chi pecca per uso e consuetudine, commette più grave colpa degli altri. E poiché non manca chi si difende con la scusa che tutti gli uomini, si dice, mentiscono e spergiurano, bisogna combattere quest’opinione, dicendo che non si devono imitare i cattivi, ma piuttosto riprenderli e correggerli. Se invece noi stessi mentiamo, la nostra ammonizione ha meno autorità nella riprensione e correzione degli altri.
• A quelli che si difendono affermando che, col dire il vero, spesso ne ricevono danno, i sacerdoti rispondano che questa non è una difesa per essi, ma un’accusa, giacché è dovere d’un cristiano patire piuttosto qualsiasi danno che mentire.
• Restano le ultime due categorie di quelli che si scusano della menzogna: quelli che dicono di mentire per scherzo, e quelli che dicono di farlo perché non potrebbero né comprare né vendere bene, senza la menzogna; i Parroci dovranno allontanare gli uni e gli altri da tale errore. I primi potranno essere strappati al vizio, sia insegnando loro quanto in questo genere di peccato l’uso accresca la consuetudine di mentire, sia inculcando che bisogna render ragione persino d’ogni parola oziosa (Mt. 12, 26). Gli altri, poi, siano rimproverati ancora più acerbamente, perché nell’addotta giustificazione sta appunto la loro più grave accusa, poiché essi stessi dichiarano di non attribuire alcuna fede ed autorità all’insegnamento divino: «Cercate, pertanto, in primo luogo il regno di Dio e la Sua giustizia, ed avrete in soprappiù tutte queste cose» (Mt. 6, 33).
[Nota 1 alla pagina 367 presente sull’edizione del Catechismo Tridentino di Cantagalli, 2011: «I moralisti, spiegando con maggiore ampiezza questa materia, ammettono le così dette bugie ufficiose e le restrizioni mentali. Purché si eviti di farne un uso troppo frequente e ingiustificato», ndR].
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, studiamo il settimo dei comandamenti: «Non rubare», usando il semplice Catechismo del Santo Concilio di Trento.
• Spiegazione del comandamento. Fu antica consuetudine della Chiesa inculcare agli ascoltatori l’importanza e la natura di questo comandamento. Lo prova il rimprovero dell’Apostolo a coloro che premuniscono con ogni zelo gli altri da questi vizi, mentre essi ne sono stracarichi: «Tu che sei maestro agli altri, non insegni nulla a te stesso; vai predicando che non si deve rubare, e rubi» (Rm. 2, 21). Insistendo su questo insegnamento, non solo veniva corretta una colpa frequente in quei tempi, ma erano anche sedati i turbamenti e le liti, ed eliminate le altre cause dei mali che sogliono scaturire dal furto. Ma poiché anche il nostro tempo è infestato da simili reati e disordini, i Parroci, sulle orme dei santi Padri e dei maestri della disciplina cristiana, tornino spesso su questo precetto, spiegandone con assidua diligenza l’importanza e il contenuto. Innanzitutto dedicheranno la loro cura a spiegare l’infinito amore di Dio verso il genere umano, poiché volle non solamente tutelare, quasi con un presidio, la vita, il corpo e la fama nostra con i due divieti: Non ammazzare, Non commettere atti impuri, ma volle anche, con questo altro comandamento, Non rubare, munire esternamente e difendere le nostre sostanze. Che cosa infatti potrebbero significare le parole suddette, se non possedessero la virtù dei precedenti precetti? Comanda cioè Iddio che i nostri beni, costituiti sotto la Sua tutela, non siano da veruno violati o manomessi. E del singolare beneficio divino racchiuso nel precetto, dobbiamo essere particolarmente grati a Dio che ne è l’autore. E poiché ci è stato chiaramente indicato il modo migliore di nutrire e di esprimere la nostra gratitudine, che è non solo di accogliere apertamente la formulazione del precetto, ma di metterlo in pratica, i fedeli devono essere stimolati e infiammati a mostrare così il loro ossequio ad esso.
• Come i precedenti, anche questo precetto abbraccia due parti: quella, apertamente formulata, che proibisce il furto; l’altra, implicita nella prima, che impone di essere benevoli e generosi verso il prossimo. Parleremo innanzitutto della prima: Non rubare.
• Natura e specie del furto. Si avverta subito che col nome di furto non si intende semplicemente l’atto di sottrarre qualcosa di nascosto ad un padrone che non sa e non vuole, ma anche l’azione di ritenere apertamente la roba altrui, contro la volontà del proprietario, a meno che non si voglia pensare che, proibendo il furto, si siano volute tollerare le rapine compiute a mano armata, mentre l’Apostolo afferma: «I rapinatori non conseguiranno il regno di Dio» (1 Cor. 6, 10). Anzi, il contatto e la solidarietà con questa gente devono essere, sempre, secondo l’Apostolo, scrupolosamente evitati (1 Cor. 5, 10).
• Sebbene la rapina costituisca una colpa più grave del furto perché toglie dei beni coll’aggiunta della violenza contro la persona, e sia quindi più ignominiosa, nessuno si meravigli che la formula del comando divino usi il termine più lieve di furto, tralasciando quello di rapina. Ciò è stato fatto con ponderazione, perché l’ambito del furto è più vasto di quello della rapina. Questa infatti può essere perpetrata solamente da chi disponga di forza e di mezzi. Del resto tutti comprendono come la proibizione di alcuni peccati più leggeri implichi il divieto di colpe più gravi del medesimo genere.
• Il possesso e l’uso ingiusto delle cose altrui sono segnalati con vari nomi, secondo la diversità degli oggetti, sottratti ad insaputa e contro la volontà dei padroni. Se un bene privato è tolto ad un privato, l’azione è detta furto; se si sottrae qualcosa al bene pubblico, si compie peculato; traendo in schiavitù un uomo libero o un servo altrui, si commette un plagio; infine rubando un oggetto sacro, si cade nel sacrilegio. E questa è la forma più grave di questo delitto, che trae a privato godimento e a cupidigie riprovevoli beni categoricamente destinati, con disposizioni pie e sagge, al culto sacro, ai ministri della Chiesa, e ad usi di beneficenza.
• La legge divina non proibisce solamente l’atto esterno del furto, ma anche l’intenzione ed il proposito di rubare. Si tratta infatti di una legge spirituale, che mira all’anima, sorgente dei pensieri e dei propositi. Secondo la frase del Signore, in san Matteo: «Dal cuore partono i cattivi pensieri, gli omicidi, gli adulteri, le fornicazioni, i furti, le false testimonianze» (Mt. 15, 19).
• Gravità del furto. La gravita del crimine di furto emerge dalla stessa legge naturale e dal lume della ragione, essendo esso contrario alla giustizia, la quale vuole che a ciascuno sia attribuito il suo. La distribuzione e l’assegnazione dei beni, stabilite fin dagli inizi secondo il diritto delle genti, ratificate dalle leggi divine ed umane, devono infatti essere rispettate, sicché ognuno conservi, quanto in linea di diritto gli spetta, se non vogliamo che sia sovvertita la società umana. Dice l’Apostolo: «I ladri, gli avari, gli ubriachi, i maldicenti, i rapaci, non conseguiranno il regno di Dio» (1 Cor. 6, 10). Le numerose conseguenze del furto rivelano anch’esse l’enormità di questo delitto. Si vanno diffondendo, infatti, giudizi temerari e ingiusti su molti; scoppiano gli odi; sono alimentate le inimicizie; talora si giunge a gravissime condanne di innocenti.
• Corre l’obbligo del resto, a tutti divinamente imposto, di dare completa soddisfazione al derubato. Come dice sant’Agostino, il peccato di furto non viene perdonato, se non viene restituita la refurtiva (Lett. CLIII). La quale restituzione, quando uno si sia abituato ad arricchirsi con la roba altrui, diviene compito molto arduo, come è facile arguire dall’esperienza altrui e dal buon senso proprio. Il profeta Abacuc lo asserisce esplicitamente: «Guai a colui che accumula beni non suoi! Egli va impegolandosi in un fango densissimo» (Ab. 2, 6). Dove fango denso è definito il possesso delle sostanze altrui, dal quale gli uomini solo a fatica possono emergere ed uscire.
• Tanti sono i generi di furto, che non è agevole segnalarli tutti. Basterà perciò quel che abbiamo detto intorno al furto ed alla rapina, a cui può riportarsi in radice quel che ora diremo. I Parroci usino la massima cura e diligenza nell’indurre il popolo a detestare con orrore questo perverso delitto.
• Proseguiamo con le varie specie di questo vizio. Sono dunque ladri anche coloro che comprano oggetti rubati, o ritengono cose comunque trovate, occupate, sottratte. Dice sant’Agostino: «Se non hai reso quel che trovasti, hai rubato» (Serm. CLXXVIII). Qualora poi sia assolutamente impossibile rinvenire il padrone, la roba trovata sia destinata alla beneficenza. Chi non sente di dover restituire, si rivela capace di fare man bassa di tutto, se lo potesse.
• Altri trasgressori di questo comandamento. Si rendono rei della medesima colpa coloro che usano frodi e discorsi ingannevoli nel comprare e nel vendere; il Signore punirà queste loro frodi. In questo genere di furti si mostrano più insopportabili e più malvagi quelli che vendono come genuine, mercanzie adulterate e guaste, o che ingannano i compratori nel peso, nella misura, nella quantità e nelle norme della compravendita. Sta scritto infatti nel Deuteronomio: «Non avrai nel sacchetto diversi pesi» (25, 17). E nel Levitico: «Non commettete ingiustizia alcuna nel giudicare, nel computare, nel pesare e nel misurare. Sia giusta la stadera e (sempre) eguali i pesi, giusto il moggio e identico il boccale (sestario)» (XIX, 35). Sta scritto pure in un altro luogo: «è abominevole presso il Signore chi usa due pesi; una stadera ingannevole non è buona» (Pr. 20, 23).
• E anche furto manifesto quello degli operai e degli artigiani, che ricevono tutta intera la mercede, senza prestare l’opera giusta e dovuta. Né poi si distinguono dai ladri i servi che siano custodi infedeli dei padroni e delle loro cose; sono anzi più detestabili degli altri ladri, che non hanno sottomano le chiavi; perché con un servo ladro nulla in casa rimane sigillato, o chiuso.
• Inoltre commettono furto quelli che carpiscono denaro con parole finite e simulate, o con falsa mendicità; anzi il peccato di costoro è più grave, perché aggiungono al furto la menzogna.
• Si devono riporre nel numero dei ladri anche quelli che, dopo essere stati assunti a qualche ufficio privato o pubblico, fanno poco o nulla, trascurano il loro dovere, pur esigendo la paga e la ricompensa.
• Sarebbe cosa lunga e, come abbiamo detto, difficilissima, trattare di tutti gli altri furti escogitati da una solerte avarizia, che conosce tutti i mezzi per fare denaro. Ci sembra quindi giusto parlare ora della rapina, che forma il secondo capitolo di questo genere di crimini. Prima però il Parroco ammonisca il popolo cristiano di ricordare la sentenza dell’Apostolo: «Chi vuol farsi ricco, cade nella tentazione e nei lacci del demonio» (Tim. 6, 9). Né mai in alcun luogo gli cada dalla mente questo precetto: «Fate agli uomini quanto volete ch’essi facciano a voi» (Mt. 7, 12); tutti poi ricordino sempre il motto: «Non fare agli altri quel che non vorresti fosse fatto a te» (Tob. 4, 16; Lc. 6, 31).
• Chi si rende colpevole di rapina. Più esteso quindi è il campo della rapina. Poiché anche quelli che non danno la mercede dovuta agli operai, sono rapinatori; e san Giacomo li invita alla penitenza con queste parole: «Piangete, o ricchi, ululando sulle vostre sciagure, che vi piomberanno addosso» (Gc. 5, 1). E più sotto aggiunge la ragione per cui devono fare penitenza: «Ecco che la mercede degli operai, che hanno mietuto i vostri terreni, da voi defraudata, grida, e il loro grido è entrato nelle orecchie del Signore degli eserciti» (Gc. 5, 4). Questo genere di rapine è severamente condannato nel Levitico (XIX, 13), nel Deuteronomio (24, 14), nel Libro di Malachia (3, 5) e nel Libro di Tobia (4, 15). In questa classe di rapinatori sono inclusi coloro che non pagano, o carpiscono e prendono per sé le gabelle, i tributi, le decime e simili cose, dovute ai rettori della Chiesa ed ai magistrati.
• Si rendono rei di questa colpa gli usurai inesorabili e crudeli nelle rapine, che derubano e dissanguano il misero popolo con le loro usure. Consiste l’usura nel ricevere un’aggiunta in più oltre il capitale dato, sia denaro o qualsiasi altra cosa, che possa esser acquistata o stimata per denaro. Così infatti sta scritto nel libro di Ezechiele: «Non riceverà usura e sovrabbondanza (di denaro)» (Ez. 18, 17); e il Signore dice nel Vangelo di san Luca: «Date in prestito, senza aspettarne nulla» (6, 34). Sempre fu considerato gravissimo questo delitto, anche presso i pagani, e odioso più d’ogni altro. Da ciò il motto: «Cos’è far usura? E che cosa è uccidere un uomo?». Poiché quelli che danno a usura, vendono due volte la medesima cosa, o vendono quel che non esiste.
• Commettono rapine anche i giudici corrotti dal denaro, che emettono giudizi venali, e che, adescati con denaro e condoni, capovolgono le giustissime cause degli umili e dei diseredati.
• Sono condannati per la medesima colpa di rapina quelli che frodano i creditori, i debitori fraudolenti e tutti coloro, che, ottenuto un certo lasso di tempo per pagare, comprano mercanzie sulla parola propria o altrui, e non mantengono la parola giurata. Il crimine di costoro è anche più grave, perché i mercanti, in conseguenza del loro inganno e della loro frode, vendono più cara ogni cosa, con grave danno di tutta la cittadinanza. A costoro sembra convenire il detto di David: «Il peccatore prenderà in prestito e non pagherà» (Ps. 36, 21).
• E che diremo di quei ricchi che troppo duramente esigono, da quelli che non hanno da pagare, quel che presero in prestito, e, contro la proibizione di Dio, tolgono loro come pegno, anche le cose necessarie al mantenimento del loro corpo? Dice infatti Iddio: «Se riceverai in pegno dal tuo prossimo il vestito, glielo restituirai prima del tramonto. Esso infatti è l’unica cosa con cui si può coprire, è l’indumento della sua carne, e non ha altro in cui possa dormire; se griderà giustizia a me lo esaudirò, perché sono misericordioso» (Ex. 22, 26). La crudeltà della loro pretesa chiameremo dunque a buon diritto rapacità e rapina.
• Nel numero di coloro, che vengono chiamati rapinatori dai santi Padri sono quelli che, durante la carestia, incettano frumento e fanno sì che per loro colpa il mercato sia più caro e più difficile. Ciò vale anche per tutto quel che riguarda il mantenimento e tutte le cose necessarie alla vita; ad essi si riferisce quella maledizione di Salomone: «Chi nasconde le derrate, sarà maledetto fra le genti» (Prov. 11, 26).
• I Parroci dunque liberamente rimprovereranno costoro dei loro misfatti, e più ampiamente spiegheranno le pene minacciate per questi peccati.
• Chi è obbligato alla restituzione. Ciò che abbiamo detto riguarda le cose proibite; ora veniamo a parlare delle cose comandate da questo precetto, tra le quali ha il primo posto la soddisfazione o restituzione; infatti il peccato non viene rimesso, se non si restituisce il mal tolto. Ma, poiché non soltanto chi ha commesso un furto deve restituire il maltolto a colui che ha derubato, ma anche tutti quelli che parteciparono al furto sono obbligati alla restituzione, bisogna spiegare chi siano quelli che non possono sfuggire a quest’obbligo di soddisfare o di restituire.
• Parecchie sono le categorie di siffatta gente. La prima è di coloro che comandano di rubare; essi sono non solo compagni e autori del furto, ma anche i più malvagi tra quel genere di ladri. La seconda categoria, pari alla prima nella volontà sebbene inferiore negli effetti, e tuttavia da considerarsi allo stesso grado, è di quelli, che non potendo comandare, sono consiglieri e suggeritori di furti. Terza categoria è di coloro, che vanno d’accordo coi ladri. Quarta, quella di coloro che partecipano al furto, donde essi traggono lucro: se si può chiamar lucro quel che li conduce agli eterni tormenti, qualora essi non si ravvedano; e di loro cosi parla David: «Se vedevi un ladro correvi con lui» (Ps. 49, 18). Quinta categoria di ladri sono coloro che, potendo impedire il furto, sono tanto lontani dall’impedirlo e dall’opporsi; che anzi lasciano e permettono che esso avvenga. Sesta categoria sono coloro che, sapendo con certezza che è stato fatto un furto e dove, non svelano la cosa, ma fingono di non saperla. L’ultima categoria comprende tutti i complici, i custodi, i patrocinatori, e quanti offrono loro un ripostiglio ed un rifugio. Tutti costoro sono tenuti alla riparazione verso i derubati, e devono esser caldamente esortati a compiere questo dovere indispensabile. Né sono del tutto immuni da questa colpa neppure coloro che approvano e lodano il furto. Non sono poi alieni da questa medesima colpa i figli di famiglia e le mogli, che sottraggono di nascosto denaro ai padri e ai mariti.
• Bisogna inculcare la misericordia. In correlazione con questo comandamento sta la divina sentenza che noi dobbiamo aver compassione dei poveri e dei bisognosi; alleviarne le tristi condizioni e le angustie coi nostri mezzi e i nostri servigi. E siccome questo argomento deve esser trattato spessissimo e con la massima ampiezza, i Parroci cercheranno nei libri di uomini santissimi come Cipriano, Giovanni Crisostomo, Gregorio Nazianzeno ed altri, che ottimamente scrissero intorno all’elemosina, ciò che loro occorre per soddisfare a quest’obbligo.
• Infatti bisogna infiammare i fedeli all’ardore e all’alacrità nel soccorrere coloro, che devono vivere della pietà altrui. Bisogna anche insegnare quanto sia necessaria l’elemosina, affinché tutti possiamo mostrarci veramente, in pratica e con l’opera nostra, liberali verso i bisognosi, con questa argomentazione validissima che, cioè, nel supremo giorno del giudizio, Dio avrà in abominio e condannerà al fuoco eterno coloro che tralasciarono o trascurarono gli obblighi dell’elemosina; invece loderà e introdurrà nella patria celeste coloro che benignamente trattarono gli indigenti.
• L’una e l’altra massima furono pronunciate dalla bocca di Nostro Signore Gesù Cristo: «Venite, benedetti del Padre mio, possedete il regno preparato per voi; Via da me, maledetti, nel fuoco eterno» (Mt. 25, 34; Mt. 25, 41).
• Inoltre i sacerdoti citino i passi adatti a persuadere, per esempio: «Date e vi sarà dato» (Lc. 6, 38). Espongano la promessa di Dio, della quale non si può pensare niente di più ricco e magnifico: «In verità vi dico, nessuno ha abbandonato la casa ecc..., che non riceva il centuplo adesso in questo mondo e nel mondo avvenire la vita eterna» (Mc. 10, 29 e 30). Aggiungano quel che fu detto da Cristo: «Fatevi degli amici per mezzo del mammona d’iniquità, affinché, quando veniate a mancare, vi diano ricetto nelle tende eterne» (Lc. 16, 9).
• Vari modi di esercitare la misericordia. (I Parroci) espongano, poi, le varie specie di questo dovere, in modo che chi non può largire ai bisognosi tanto da sostentare la vita, almeno conceda prestiti al povero, secondo il precetto di Cristo nostro Signore: «Date in prestito, senza aspettarne nulla» (Lc. 6, 34). Il santo re David così esprime la felicità di chi agisce in tal modo: «Beato l’uomo che ha misericordia e dà in prestito» (Ps. 111, 5). È degno poi della cristiana pietà, quando non ci sia possibilità di beneficare altrimenti quelli che per vivere hanno bisogno della pietà altrui, esercitare un lavoro con le proprie mani, evitando così anche l’ozio, per poter alleviare l’indigenza dei bisognosi. A ciò esorta tutti l’Apostolo col suo esempio, nella lettera ai Tessalonicesi, con le parole: «Voi stessi sapete quanto sia necessario imitarci» (2 Tess. 3, 7). Parimente agli stessi: «Attendete a star quieti, ad adempiere il vostro ufficio e a lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ammaestrati» (1 Tess. 4, 11). Ed agli Efesini: «Chi rubava, ormai non rubi più; piuttosto lavori operando con le proprie mani quel che è buono, per avere di che dare il necessario a chi soffre» (Efes. 4, 28).
• Bisogna anche curare la frugalità ed avere riguardo ai beni altrui, per non essere di peso né molesti agli altri. Questa temperanza, certo, appare in tutti gli Apostoli, ma sopratutto splende in san Paolo di cui è quel motto ai Tessalonicesi: «Ricordatevi, o fratelli, del nostro lavoro e della nostra fatica: lavorando notte e giorno, per non aggravare nessuno di voi, vi predicammo il vangelo di Dio» (1 Tess. 2, 9). E lo stesso Apostolo in un altro luogo afferma: «Con fatica e con sudore, lavorando notte e giorno, per non aggravare nessuno di voi» (2 Tess. 3, 8).
• Bisogna tener lontani i cristiani da queste colpe. Ma perché il popolo fedele si tenga lontano da tutto questo genere di nefandi delitti, sarà compito dei Parroci rintracciare nei Profeti e prendere dagli altri Libri divini le parole di abominio dei furti e delle rapine, e le terribili minacce fatte da Dio a coloro che commettono quelle colpe. Esclama il profeta Amos: «Ascoltate, voi che calpestate il povero e fate perire i miseri della terra, dicendo: Quando passerà il mese, e venderemo le mercanzie? Allora potremo diminuire la misura, aumentare il siclo e usare stadere ingannevoli» (Amos 8, 4-5). Sono dello stesso tenore molte espressioni in Geremia (VII, 8 e seg.), nei Proverbi (Pr. 21, 6) e nell’Ecclesiastico (X, 9). Non c’è poi da dubitare che l’origine dei mali, da cui è oppressa questa età, sia in gran parte compresa in queste cause. Ma perché i Cristiani s’avvezzino a trattare con tutti i mezzi imposti dalla liberalità e dalla benignità i bisognosi e i mendichi - la qual cosa si riferisce all’altra parte del comandamento - i Parroci esporranno i grandissimi premi che Dio promette in questa vita e nell’altra agli uomini benefici e munifici.
• Bisogna respingere le scuse ingiuste. Ma poiché non manca chi, anche a proposito di furto, cerca di scusarsi, costui deve essere ammonito che Dio non accoglie nessuna scusa del suo peccato; che, anzi, il suo peccato non solo non sarà alleviato da quella giustificazione, ma maggiormente accresciuto.
• Ecco le insopportabili pretese di nobili che credono di diminuire la propria colpa, affermando di non essere discesi a toglier l’altrui per cupidigia o avarizia, ma per conservare il grado della famiglia e degli antenati, la cui stima e dignità andrebbero in rovina, se non fossero sostenute dall’aggiunta delle sostanze altrui. A costoro bisogna strappare questo pernicioso errore, e dimostrare nello stesso tempo che una sola è la maniera di conservare e aumentare le ricchezze, la potenza e la gloria degli antenati: ubbidire alla volontà di Dio e osservare i suoi precetti. Disprezzati questi, le ricchezze formate e conservate con ogni cura, sono distrutte; i re medesimi, precipitati dal soglio regale e dal sommo fastigio, sono umiliati; e al loro posto, talvolta, sono chiamati, per volere divino, uomini infimi, che spesso furono da loro grandemente odiati.
• È incredibile quanto si sdegni Dio con costoro; ne è testimone Isaia, in cui si trovano queste parole di Dio: «I tuoi principi furono infedeli e alleati di ladri; tutti amano i doni, e corteggiano le retribuzioni. Per questo il Signore Iddio degli eserciti e del forte d’Israele dice: Oh, mi consolerò dei miei nemici, e mi vendicherò dei miei avversari; volgerò la mia mano a te e purificherò la tua scoria nel fuoco» (Is. 1, 23-25).
• Non manca chi adduce come pretesto non lo splendore e la gloria, ma il proprio mantenimento e la possibilità d’una vita più comoda e agiata. Bisogna rintuzzare costoro e mostrare loro quanto empi siano le loro azioni e i loro discorsi, mentre preferiscono qualche comodità alla volontà e gloria di Dio, che noi offendiamo in modo straordinario (terribile, ndR) trascurando i Suoi precetti. Ma quale comodità mai può esservi nel furto, a cui tengono dietro i più gravi incomodi? Nel ladro infatti, dice l’Ecclesiastico, è confusione e pentimento (5, 17). Ma ammesso pure che ciò non sia (sempre, ndR), è certo che il ladro disonora sempre il Nome divino, ripugna alla santissima volontà Sua e disprezza i Suoi salutari precetti; da questa fonte deriva ogni errore, ogni malvagità, ogni empietà.
• E che dire dei ladri che affermarono di non peccare affatto, perché tolgono qualcosa a uomini ricchi e ben forniti, i quali da questo furto non soffrono danno, anzi neppure se ne accorgono? Infelice, certo, e pestifera è tale difesa.
• Qualcuno crede che debba essere accolta la sua scusa, ossia la propria consuetudine a rubare, in modo che difficilmente potrebbe desistere da quell’intenzione e da quell’azione. Costui, se non ascolta l’Apostolo che dice: «Chi rubava, ormai non rubi più» (Efes. 4, 28), voglia o non voglia, dovrà prendere anche la consuetudine degli eterni supplizi.
• Alcuni si scusano di avere rubato, essendosene data l’occasione; va infatti sulla bocca di tutti quel trito proverbio: l’occasione fa l’uomo ladro. Bisogna togliere a quelli che così pensano questa malvagia opinione e insegnare loro che si deve resistere alle cattive passioni. Poiché se si dovesse continuamente compiere quello che c’induce a fare la passione, qual misura, qual limite metteremo ai delitti ed alle nefandezze? Grandemente invereconda è dunque quella difesa o piuttosto confessione di somma cupidigia e di ingiustizia. Poiché chi dice di non peccare perché non ha occasione di peccare, confessa quasi nello stesso tempo che peccherà ogni volta che gli se ne offrirà il destro.
• Alcuni dicono di rubare per vendicarsi del furto loro fatto da altri. Ad essi bisogna rispondere che prima di tutto non è lecito vendicare le ingiurie; in secondo luogo, nessuno può esser giudice in causa propria; quindi molto meno si può concedere che essi infliggano ad altri la pena di colpe commesse contro di loro.
• In ultimo, alcuni credono abbastanza difeso e scusato il furto perché, essendo oppressi da debiti, non se ne possono liberare altrimenti che rubando. Con costoro bisogna ragionare così: non c’è debito più grave e da cui più sia oppresso il genere umano, di quello che ricordiamo ogni giorno nella divina preghiera: «Rimetti a noi i nostri debiti» (Mt. 6, 12); per cui è proprio da stolti preferire di essere debitori verso Dio, cioè peccare, per pagare quel che si deve agli uomini. Infatti è molto meglio essere gettati in carcere, che venir condannati agli eterni supplizi dell’inferno, essendo molto più grave esser condannato dal tribunale di Dio che da quello degli uomini. Queste persone devono, con suppliche, chiedere aiuto e pietà a Dio, da cui possono ottenere quel che loro occorre.
• Non manca, poi, chi, per scusare il furto, ricorre ad altre ragioni, che però ai Parroci prudenti e diligentissimi del loro ufficio non sarà difficile di ribattere in modo da poter avere un giorno un gregge zelante nelle buone opere (Tit. 5, 14).
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, studiamo il sesto dei comandamenti: «Non commettere atti impuri», usando il semplice Catechismo del Santo Concilio di Trento.
• Spiegazione del comandamento. Se il vincolo tra marito e moglie è il più stretto che esista, e nulla può essere loro più dolce che il sentirsi vicendevolmente stretti da un affetto speciale, nulla, al contrario, può capitare a uno di essi di più amaro che sentire il legittimo amore del coniuge rivolgersi altrove. Ragionevolmente, perciò, alla legge, che garantisce la vita umana dall’omicidio, segue quella che vieta la fornicazione o l’adulterio, affinché nessuno tenti di contaminare o spezzare quella santa e veneranda unione matrimoniale, da cui suole scaturire così ardente fuoco di carità.
• Toccando questo argomento, il Parroco usi la più prudente cautela e con sagge parole alluda a cose che esigono più la moderazione che l’abbondanza dell’eloquio. È da temersi infatti che, diffondendosi troppo a spiegare i modi con cui gli uomini possono trasgredire questo comandamento, finisca col dire frasi capaci di eccitare la sensualità, anziché reprimerla. Ad ogni modo il precetto racchiude molti elementi che non possono essere trascurati, ed il Parroco li spiegherà a suo tempo. Esso ha due parti: una che vieta apertamente l’adulterio; l’altra, più generale, che impone la castità dell’anima e del corpo.
• L’adulterio. Per iniziare l’insegnamento da quello che è vietato, diremo subito che adulterio è violazione del legittimo letto, proprio o altrui. Se un marito ha rapporti carnali con donna non coniugata, viola il proprio vincolo matrimoniale; se un individuo non coniugato ha rapporti con donna maritata, è contaminato, dal delitto di adulterio, il vincolo altrui.
• Sant’Ambrogio e sant’Agostino confermano che con tale divieto dell’adulterio è proibito ogni atto disonesto ed impudico. Ciò risulta direttamente dalla Scrittura del vecchio come del nuovo Testamento. Nei libri mosaici vediamo puniti altri generi di libidine carnale, oltre l’adulterio. Leggiamo nella Genesi la sentenza pronunciata da Giuda contro la nuora (Gn. 38, 24); nel Deuteronomio è formulato questo precetto: «tra le figlie d’Israele nessuna sia cortigiana» (Dt. 23, 17). Tobia così esorta il figliuolo: «Guardati, figlio mio, da ogni atto impudico» (Tb. 4, 13). E l’Ecclesiastico dice: «Vergognatevi di guardare la donna peccatrice» (41, 25). Nel Vangelo Gesù Cristo dichiara che dal cuore emanano gli adulteri e le azioni disoneste che macchiano l’uomo (Mt. 15, 19 - «Dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adultèri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie», ndR). L’apostolo Paolo bolla di frequente, con parole roventi, questo vizio: «Dio vuole la vostra santificazione; vuole che vi asteniate dalle impurità» (1 Tess. 4, 3). E altrove: «Evitate ogni fornicazione» (1 Cor. 6, 18); «Non vi mescolate agli impudichi» (1 Cor. 5, 9); «In mezzo a voi, non siano neppur nominate l’incontinenza, l’impurità di ogni genere e l’avarizia» (Efes. 5, 3); «Disonesti ed adulteri, effeminati e pederasti, non possederanno il regno di Dio» (1 Cor. 6, 9).
•L’adulterio è stato espressamente menzionato nel divieto, perché alla sconcezza che riveste in comune con tutte le altre forme di incontinenza, accoppia un peccato di ingiustizia verso il prossimo e la società civile. Inoltre è indubitato che chi non si tiene lontano dalle forme ordinarie dell’impudicizia, facilmente incapperà nel crimine di adulterio. Così è agevole comprendere come nel divieto dell’adulterio sia inclusa la proibizione di ogni genere di impurità contaminante il corpo. Del resto, che questo comandamento investa ogni intima libidine dell’animo, appare dalla natura stessa della legge, che è spirituale, e dalle esplicite parole di nostro Signore: «Udiste che fu detto agli antichi: Non fare adulterio. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per fine disonesto, in cuor suo ha già commesso adulterio su lei» (Mt. 5, 27).
• A ciò che riteniamo debba essere insegnato pubblicamente ai fedeli, si aggiungano i decreti del Concilio di Trento contro gli adùlteri e coloro che mantengono prostitute e concubine (Sess. 24, c. 8), tralasciando di parlare dei vari e multiformi generi di libidine sessuale, intorno ai quali il Parroco ammonirà i singoli fedeli, qualora le circostanze di tempo e di persona lo richiedano.
• Considerazioni per conservare la castità. Siano pure spiegate le prescrizioni che hanno forza di precetto. I fedeli devono essere ammaestrati ed esortati a rispettare con ogni cura la pudicizia e la continenza, a conservarsi mondi da ogni contaminazione della carne e dello spirito, attuando la santificazione nel timore di Dio (2 Cor. 7, 1). Si dica loro che, sebbene la virtù della castità debba maggiormente brillare in quella categoria di persone che coltiva il magnifico e pressoché divino proposito della verginità, pure essa conviene anche a coloro che menano vita celibataria o, congiunti in matrimonio, si mantengono mondi dalla libidine vietata. Le molte sentenze dei Padri, con cui siamo ammaestrati a dominare le passioni sensuali e a frenare l’istinto passionale, saranno dal Parroco accuratamente esposte al popolo, con una trattazione diligente e costante. Parte di esse riguarda il pensiero, parte l’azione.
• Il rimedio che fa leva sull’intelligenza tende a farci comprendere quanto grandi (gravi, ndR) siano la turpitudine ed il pericolo di questo peccato. In base a simile apprezzamento, più viva arderà in noi l’avversione per esso. Si tratta di un peccato che è un vero flagello, a causa di esso sugli uomini incombe l’ultima rovina: l’espulsione dal regno di Dio e lo sterminio. Questo può sembrare comune a ogni genere di peccato; ma qui abbiamo di caratteristico che i fornicatori, secondo la frase dell’Apostolo, peccano contro il proprio corpo: «Fuggite l’impudicizia; qualunque peccato l’uomo commetta, si svolge fuori del corpo, ma il fornicatore pecca sul proprio corpo» (1 Cor. 6, 18); vale a dire: lo tratta ignominiosamente, violandone la santità. A quelli di Tessalonica lo stesso san Paolo diceva: «Dio vuole la vostra santificazione; che vi asteniate da atti impuri; che ciascuno di voi sappia mantenere il vaso del suo corpo in santità e dignità, non nella irrequietezza del desiderio, come i pagani che ignorano Dio» (1 Tess. 4, 5).
• è cosa ben più ripugnante, se è un cristiano colui che si unisce turpemente ad una meretrice; perché rende membra di meretrice le membra di Gesù Cristo, come appunto dice san Paolo: «Non sapete che i vostri corpi sono membra di Gesù Cristo? Sottraendo le membra a Gesù Cristo, le faro membra della meretrice? Non sia mai. Ignorate forse che aderendo alla meretrice, ne risulta un solo corpo?» (1 Cor. 6, 15).
• Inoltre il Cristiano, sempre secondo san Paolo, è tempio dello Spirito santo (1 Cor. 6, 19); violarlo significa espellerne lo Spirito santo stesso.
• Tuttavia particolare malvagità è racchiusa nel delitto di adulterio. Infatti, come vuole l’Apostolo, i coniugi sono così vincolati da una scambievole sudditanza che nessuno dei due possiede illimitata potestà sul proprio corpo, ma sono così schiavi l’uno dell’altro che il marito deve uniformarsi alla volontà della moglie e la moglie a quella del marito (1 Cor. 7, 4). Ne consegue che chi dei due separa il proprio corpo, soggetto all’altrui diritto, da colui al quale è vincolato, si rende reo di specialissima iniquità. E poiché l’orrore dell’infamia è per gli uomini un valido stimolo a fare quanto è prescritto ed a fuggire quanto è vietato, il Parroco insisterà nel mostrare come l’adulterio imprima sugli individui un profondo segno di infamia. È scritto nella sacra Scrittura: «L’adùltero, a causa della sua fragilità di cuore, perderà l’anima sua; condensa su di sé la vergogna e l’abominio; la sua turpitudine non sarà mai cancellata» (Pr. 6, 32).
• La gravità di questa colpa può essere facilmente ricavata dalla severità della punizione stabilita. Nella legge fissata da Dio nel vecchio Testamento gli adulteri venivano lapidati (Lv. 20, 10; Dt. 22, 22). Anzi, talora per la concupiscenza sfrenata di uno solo, non il reo semplicemente, ma l’intera città fu condannata alla distruzione; tale fu la sorte dei Sichemiti (Gn. 34, 25). Del resto numerosi appaiono nella sacra Scrittura gli esempi dell’ira divina, che il Parroco potrà evocare per allontanare gli uomini dalla riprovevole libidine: - la sorte di Sodoma e delle città confinanti (Gn 19, 24); - il supplizio degli Israeliti che avevano fornicato nel deserto con le figlie di Moab (Num. 25); - la distruzione dei Beniamiti (Giud. XX).
• Se v’è qualcuno che sfugge alla morte, non si sottrae però a dolori intollerabili, a tormenti punitivi, che piombano inesorabili. Accecato com’è nella mente (ed è già questa pena gravissima), non tiene più conto di Dio, della fama, della dignità, dei figli, e della stessa vita. Resta così depravato ed inutilizzato, da non poterglisi affidare nulla di importante, o assegnarlo come idoneo ad alcun ufficio. Possiamo scorgere esempi di questo in David come in Salomone. Il primo, resosi reo di adulterio, subitamente cambiò natura e da mitissimo divenne feroce, sì da mandare alla morte l’ottimo Uria (II Sam. XI); l’altro, perduto nei piaceri delle donne, si allontanò talmente dalla vera religione di Dio, da seguire divinità straniere (3 Re, 11). Secondo la parola di Osea, questo peccato travia il cuore dell’uomo (Os. 4, 11) e ne acceca la mente.
• Rimedi per conservare la castità. Veniamo ai rimedi che riguardano l’azione da svolgere. Il primo consiste nel fuggire con ogni cura l’ozio. Impoltronendo nell’ozio, come dice Ezechiele (Ez. 16, 49), gli abitanti di Sodoma precipitarono nel più vergognoso crimine di concupiscenza. Sono poi da evitarsi con grande vigilanza gli eccessi nel mangiare e nel bere. Li satollai, dice il Profeta, ed essi fornicarono (Gerem. 5, 7). Il ventre ripieno provoca la libidine, come accennò il Signore con le parole: «Badate, che i vostri cuori non si appesantiscano nella crapula e nell’ebrietà» (Lc. 21, 34), e l’Apostolo: «Non vogliate ubriacavi, poiché il vino nasconde la lussuria» (Ep. 5, 18).
• Gli occhi sono i veicoli più pericolosi attraverso i quali l’animo suole accendersi alla libidine. Per questo il Signore ha detto: «Se il tuo occhio destro ti scandalizza, cavalo e gettalo via da te» (Mt. 5, 29). E molte sono in proposito le sentenze dei profeti. Giobbe dice ad esempio: «Strinsi un patto con gli occhi miei, di neppure pensare a una vergine» (Giob. 31, 1). Sono copiosi, anzi innumerevoli gli esempi di azioni perverse, provocate dalla vista. Peccò così David (II Sam. 11, 2); peccò così il re di Sichem (Gn. 34, 2); così finirono col farsi calunniatori di Susanna i vecchi, di cui parla Daniele (Dan. 13, 8). • Spesso incentivo non indifferente alla libidine offre la moda ricercata, che solletica l’occhio. Per questo ammonisce l’Ecclesiastico: «Volta la faccia dalla donna elegante» (9, 8). E poiché le donne sogliono badare troppo al loro abbigliamento, non sarà male che il Parroco attenda di frequente a premunirle in proposito, memore delle parole gravissime, che l’apostolo Pietro ha dettato sull’argomento: «La pettinatura delle donne non sia appariscente, i monili e l’abbigliamento non siano ricercati» (1 Pt. 3, 3); e di quelle di san Paolo: «Non badate ai capelli ben attorcigliati, agli ori, alle pietre preziose, alle vesti sontuose» (1 Tm. 2, 9); molte infatti che si erano adornate con oro e gioielli, smarrirono i veri ornamenti dell’anima e del corpo.
• Insieme all’incentivo libidinoso che è dato dalla raffinata ricercatezza delle vesti, occorre aggiungere quello che emana dai discorsi turpi ed osceni. L’oscenità delle parole, quasi fiaccola ardente, accende l’animo dei giovani: «Le perverse conversazioni, dice l’Apostolo, corrompono i buoni costumi» (1 Cor. 15, 33). E poiché il medesimo effetto producono, in misura anche più notevole, i balli ed i canti sdolcinati, occorre tenersi lontani anche da questi.
• Fra questi incitamenti alla voluttà vanno annoverati i libri osceni e trattanti dell’amore sessuale, che devono evitarsi con non minore severità delle figure rappresentanti qualcosa di turpe, la cui capacità di spingere al male e di infiammare i sensi giovanili è straordinaria. Il Parroco curi perciò soprattutto che siano osservate con il massimo rispetto le costituzioni sapienti del Concilio Tridentino in proposito (Sess. 25).
• Se con attenta cura e vigile amore si eviterà quanto abbiamo ricordato, sarà soppressa ogni occasione alla concupiscenza carnale; ma per la sua virulenza valgono in modo eminente la Confessione e la Comunione frequente; le assidue ed umili preci a Dio, accompagnate da elemosine e da digiuni. La castità è, in fondo, un dono che Dio non nega a chi rettamente lo cerca (1 Cor. 7, 7), poiché Egli non consente che siamo tentati sopra le nostre forze (1 Cor. 10, 13).
• Dobbiamo infine mortificare il corpo ed i suoi appetiti malsani, non solamente con i digiuni, quelli specialmente prescritti dalla santa Chiesa, ma anche con le vigilie, i pii pellegrinaggi e con macerazioni di altro genere. In queste pratiche, infatti, si manifesta la virtù della temperanza. Scriveva appunto san Paolo a quelli di Corinto: «Chi si appresta a gareggiare nella palestra, segue un regime di grande astinenza. Eppure essi ambiscono una semplice corona corruttibile, mentre noi l’aspettiamo immortale». E poco appresso: «Castigo il mio corpo e lo tengo in soggezione, affinché, dopo aver predicato agli altri, io stesso non divenga alla fine un reprobo» (1 Cor. 9, 25). Ed altrove: «Non vogliate pascere la carne nei suoi immoderati desideri» (Rm. 13, 14).
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, studiamo il quinto dei comandamenti: «Non ammazzare», usando il semplice Catechismo del Santo Concilio di Trento.
• Spiegazione del quinto comandamento. L’insigne felicità promessa ai pacifici, che saranno chiamati figli di Dio (Mt. 5, 9), deve stimolare in sommo grado i Pastori a spiegare ed inculcare con assidua diligenza, ai fedeli l’osservanza di questo comandamento; non v’è modo migliore di fondere le volontà umane nel rispetto universale e generoso di questo precetto, rettamente spiegato. Se ciò si verificherà, gli uomini, strettamente affratellati in un saldo consenso spirituale, conserveranno bene la pace e la concordia. Quanto sia necessario spiegare questo precetto risulta dalla circostanza che, dopo il diluvio universale, fu questa la prima proibizione emanata da Dio agli uomini: «Del vostro sangue farò vendetta sopra qualsiasi animale e faro vendetta della uccisione di un uomo sopra l’uomo» (Gn. 9, 5). Nel Vangelo, là dove il Signore spiega le antiche leggi, questa è al primo posto come si legge in San Matteo: «è comandato: Non ammazzare»; con tutto quel che segue nel passo indicato (5, 21). I fedeli dal canto loro devono prestare attento e volenteroso ascolto a questo comando. La sua forza vale a tutelare la vita di ciascuno. Con le parole infatti: Non ammazzare, è perentoriamente vietato l’omicidio. Perciò ciascuno deve accoglierlo con sì viva prontezza come se, con minaccia dell’ira di Dio e di altre gravissime pene stabilite, fosse tassativamente vietata la lesione di questo o quell’individuo. Come tale precetto è confortante ad essere ascoltato, così l’eliminazione del delitto che esso proibisce deve recare soddisfazione.
• Eccezioni al quinto comandamento. Spiegando il contenuto di questa legge, il Signore mostra che essa comprende due elementi: il primo, negativo: divieto dell’uccisione; il secondo, positivo: ingiunzione di estendere la nostra concorde e caritatevole amicizia anche ai nemici, per avere pace con tutti, sia pure affrontando con pazienza ogni contrarietà. Enunciata la legge che vieta di uccidere, il Parroco dovrà subito indicare le uccisioni che non sono proibite. Non è infatti vietato di uccidere animali. Se Dio ha concesso agli uomini di nutrirsene, deve essere lecito ucciderli. In proposito dice sant’Agostino: Non dobbiamo applicare la formula «non ammazzare» ai vegetali, cui manca ogni facoltà sensibile, né agli animali irragionevoli, che non sono collegati a noi da alcuna virtù razionale (La città di Dio, I, 20).
• Altra categoria di uccisioni permessa è quella, che rientra nei poteri di quei magistrati, i quali hanno facoltà di condannare a morte. Tale facoltà, esercitata secondo le norme legali, serve a reprimere i facinorosi e a difendere gli innocenti. Applicando tale facoltà, i magistrati non solamente non sono rei di omicidio, ma, al contrario, obbediscono in una maniera superiore alla Legge divina, che vieta di uccidere, poiché il fine della legge è la tutela della vita e della tranquillità umana. Ora, le decisioni dei magistrati, legittimi vendicatori dei misfatti, mirano appunto a garantire la tranquillità della vita civile, mediante la repressione punitiva dell’audacia e della delinquenza. Ha detto David: «Sulle prime ore del giorno soppressi tutti i peccatori del territorio, onde eliminare dalla città del Signore tutti coloro che compiono iniquità» (Ps. 100, 8).
• Per le medesime ragioni non peccano neppure coloro che, durante una guerra giusta, non mossi da cupidigia o da crudeltà, ma solamente dall’amore del pubblico bene, tolgono la vita ai nemici. Vi sono anzi delle uccisioni compiute per espresso comando di Dio. I figli di Levi non peccarono quando in un giorno solo uccisero tante migliaia di uomini; dopo di che, Mosè rivolse loro le parole: «Oggi avete consacrato le mani vostre a Dio» (Ex. 32, 29).
• Infine non è reo di trasgressione a questo precetto chi, non di spontanea volontà e di proposito, ma per disgrazia uccide un altro. È scritto nel Deuteronomio: «Chi per caso abbia colpito il suo prossimo, e si riesca a provare che né ieri, né ieri l’altro nutriva odio per il colpito, ma che recandosi insieme a far legna nel bosco, nel tagliare i tronchi, la scure gli sfuggì di mano e il ferro spiccato dal manico colpi l’amico e l’uccise» (XIX), tale uccisione non compiuta per atto di volontà e studiatamente, non può assolutamente imputarsi a colpa. Lo conferma la sentenza di sant’Agostino: «Nessuno pensi che possa esserci addebitato ciò che facciamo per il bene o per il lecito, anche se importi, senza il nostro volere, qualcosa di male» (Lett. XLVII, 5; CCIII, 6).
• Ma anche in tali casi tuttavia può talora esserci colpa: se cioè l’uccisore involontario sia intento a cosa ingiusta, o se l’uccisione si verifichi per negligenza e imprudenza, non essendo state valutate tutte le circostanze. Un esempio del primo caso: se uno percuotendo con un pugno o un calcio una donna incinta, provochi l’aborto, pur essendo ciò fuori dell’intenzione del percussore, non si può dire immune da colpa, non essendo in alcun modo lecito percuotere una donna incinta. Che la legge poi non colpisca chi uccide un altro in difesa della propria vita, avendo però adoperato ogni cautela, è evidente.
• Azioni proibite dal quinto comandamento. Queste sono dunque le categorie di uccisioni non comprese nella Legge. Fatta eccezione per esse, tutte le altre sono proibite, qualunque sia la qualità dell’uccisore, dell’ucciso e la modalità dell’atto omicida. Per quanto riguarda la persona dell’uccisore, nessuno sfugge al precetto: «non il ricco, non il potente, non il padrone, non i genitori. A tutti è vietato di uccidere, ripudiata ogni considerazione personale».
• Per quanto riguarda gli uccisi, anche qui la Legge ha un ambito universale, né c’è individuo per quanto umile e misero, il quale non sia tutelato dalla validità di questa legge. Né ad alcuno è lecito togliersi quella vita su cui nessuno ha così pieno potere da essere in diritto di sopprimerla quando voglia. Il tenore stesso del precetto lo indica, poiché non è detto: Non ammazzare altri; ma puramente e semplicemente: Non ammazzare.
• Infine avendo di mira i vari modi con cui può esser data la morte, neppure a questo proposito sussistono eccezioni. È vietato infatti non solamente uccidere chicchessia con le proprie mani, col ferro, con pietra, con bastone, con laccio o col veleno, ma anche il procurare la morte col consiglio, con l’aiuto, col concorso e qualsiasi altro mezzo. Sono evidenti l’ottusità e la fatuità degli Ebrei che ritenevano di rispettare la legge astenendosi semplicemente dall’uccidere con le proprie mani. Il cristiano che dalla parola di Gesù Cristo ha appreso come tale legge abbia un valore spirituale ed impone non solo di conservare pure le mani, ma casto ed incontaminato lo spirito, non ritiene davvero sufficiente quel che gli Ebrei credevano così di adempiere a sufficienza. Il Vangelo insegna che non è lecito neppure farsi vincere dall’ira. Il Signore infatti ha detto: «Ma io vi dico: chiunque si adira contro il suo fratello, sarà condannato in giudizio. E chi avrà detto al suo fratello: Raca, sarà condannato nel Sinedrio. E chi gli avrà detto: Stolto, verrà condannato al fuoco della Geenna» (Mt. 5, 22). [«Raca» è un termine ingiurioso d’incerta origine e praticamente impossibile a tradursi esattamente; forse per questo è stato lasciato nel suono originale. In aramaico «recà» significa vuoto, stupido. Spiegazione di mons. Salvatore Garofalo, ndR.].
• Da queste parole risulta nettamente che non è esente da colpa chi si adira contro il proprio fratello, anche se chiuda l’ira nel proprio animo. Chi poi all’ira concede una espressione esterna, pecca gravemente; e più gravemente pecca chi osi trattare duramente e svillaneggiare il proprio simile. Naturalmente tutto ciò è vero nel caso che non sussista alcuna plausibile ragione per l’ira; poiché c’è una legittima ragione di sdegno, ammessa da Dio e dalle leggi. E si verifica quando ci leviamo contro le colpe di coloro che sono sottoposti al nostro comando e alla nostra potestà. Lo sdegno del cristiano deve però prorompere non dai sensi, ma dallo Spirito Santo, dovendo noi essere i suoi templi, e dimora di Gesù Cristo (1 Cor. 6, 19).
• Molte parole del Signore si riferiscono alla perfezione di questa legge. Ad esempio: «Non opporre resistenza al male; Se ti avranno percosso sulla guancia destra, presenta anche l’altra; A chi vuol bisticciarsi con te per aver la tua tunica, dai pure il mantello; Continua ad andare per altre due miglia con chi ti avrà bistrattato già per un miglio intero» (Mt. 5, 39).
• L’omicidio. Da quanto siamo venuti dicendo è lecito arguire quanto siano proclivi gli uomini alle colpe vietate da questo comandamento, e quanto numerosi siano coloro che, se non con le mani, almeno con l’animo cadono in questo peccato. E poiché le sacre Scritture indicano nettamente i rimedi salutari contro questo pericoloso morbo, è dovere del Parroco farne diligente esposizione ai fedeli, insistendo specialmente sulla gravità mostruosa dell’omicidio, quale traspare da copiosissime ed esplicite testimonianze della sacra Scrittura (Gn. 4, 10; Gn. 9, 16; Lv. 24, 17). L’abominazione di Dio contro l’omicidio giunge nella Bibbia fino a punire le bestie ree di omicidio, comandando che sia ucciso l’animale che abbia leso un essere umano (Ex. 21, 28). Anzi, la principale ragione per cui Dio volle che ogni uomo avesse orrore del sangue, è appunto qui: affinché conservasse integralmente mondi dal riprovevole omicidio l’animo e le mani. Sono in realtà omicidi del genere umano, e quindi nefasti avversari della natura, tutti coloro che, per quanto è loro dato, sovvertono l’opera universale di Dio sopprimendo l’uomo per il quale Dio dichiara di avere creato il mondo visibile (Gn. 1, 26). E poiché è scritto nella Genesi ch’è vietato di commettere omicidi, avendo Dio creato l’uomo a Sua immagine e somiglianza, fa veramente una sfacciata ingiuria a Dio, quasi volesse menare con violenza le mani contro di Lui, chiunque toglie di mezzo una Sua immagine (Gn. 9, 6). Meditando ciò con animo ispirato, David pronunciò gravi lamenti contro i sanguinari, quando disse: «Rapidi sono i loro passi verso lo spargimento di sangue» (Ps. 13, 36). Non disse egli puramente: uccidono, ma: spargono sangue, quasi a far risaltare la detestabilità del delitto e la smisurata crudeltà dell’omicida. E per illustrare come siano violentemente spinti dall’istinto diabolico al delitto, premette: Corrono rapidi i loro passi.
• Azioni inculcate dal quinto comandamento. In sostanza quanto nostro Signore Gesù Cristo prescrive che sia osservato con questo comandamento, mira a farci conservare rapporti pacifici con tutti. Dice infatti, interpretandolo: «Se tu stai per fare l’offerta all’altare e là ti viene alla memoria che un tuo fratello ha qualche cosa contro di te, abbandona la tua offerta davanti all’altare, e va prima a riconciliarti col tuo fratello e poi ritorna a fare la tua offerta» (Mt. 5, 23), con quel che segue. Il Parroco spiegherà tutto ciò in modo che s’intenda come tutti, senza eccezione, devono essere inclusi nel medesimo sentimento di carità. E a tale sentimento, nella spiegazione del precetto, stimolerà quanto più sarà possibile i fedeli, perché in esso riluce sopra tutto la virtù dell’amore del prossimo.
• Infatti, vietandosi apertamente con questo comandamento l’odio, poiché chi odia il proprio fratello è omicida (1 Giov. 3, 15), ne segue che c’è qui implicito il precetto dell’amore e della carità. E se nel comandamento che studiamo è imposta la legge della carità e dell’amore, nel medesimo tempo sono formulati i precetti di tutti quei servizi ed atti che sogliono scaturire dalla carità. «La carità è paziente», dice san Paolo (1 Cor. 13, 4); anche la pazienza dunque ci è comandata; e con essa, secondo la parola del Salvatore, noi saremo in possesso delle anime nostre (Lc. 21, 19).
• Segue, come prossima compagna della carità, la beneficenza, perché «la carità è benigna». La virtù della benignità o della beneficenza possiede una sfera vasta, esplicandosi sopratutto nel provvedere ai poveri il necessario, agli affamati il cibo, agli assetati la bevanda, ai nudi il vestito. Essa vuole che la nostra liberalità vada con maggiore larghezza a chi più abbisogna del nostro soccorso. Le opere della beneficenza e della bontà, per sé già cosi meritevoli, assumono un valore insigne, se dirette ai nostri nemici. Disse infatti il Salvatore: «Amate i vostri nemici; fate del bene a chi vi odia» (Mt. 5, 44). Analogamente ammonisce l’Apostolo: «Se il tuo avversario soffre la fame, nutrilo; se ha sete dagli da bere; così facendo, accumulerai sul suo capo carboni ardenti. Non ti far vincere dal male, ma vinci il male col bene» (Rm. 12, 20). Infine, volendo esporre tutta la legge della carità, che è benigna, riconosceremo che il precetto ordina di uniformare sempre le nostre azioni a mitezza, a dolcezza e a tutte le altre virtù affini.
• Però il compito più alto e più riboccante di carità, nel quale dobbiamo con maggior cura esercitarci, è quello di perdonare e di dimenticare con cuore sereno le ingiurie ricevute. Come abbiamo detto, la sacra Scrittura ammonisce insistentemente di farlo senza riluttanza, non solo dichiarando beati coloro che ciò praticano (Mt. V, 4, 9, 44), ma proclamando perdonate da Dio le loro colpe (Eccli. XXVIII, 2; Mt. 4, 14; Mc. 11, 25; Lc. 6, 37; Efes. 4, 32; Col. 3, 13) - ed imperdonabili quelle di coloro che vi si rifiutano o sono negligenti nel farlo (Eccli. XXVII, 1; Mt. 6, 15; 18, 34; Mc. 11, 26).
• I motivi di perdonare le offese. Poiché la brama della vendetta è quasi innata nello spirito degli uomini, il Parroco usi tutta la diligenza non solo nell’insegnare, ma proprio nell’inculcare e persuadere i fedeli che dimenticare le offese e perdonarle è stretto dovere del cristiano. Ed essendo copiose le testimonianze degli scrittori sacri in proposito, ne faccia tesoro per spezzare la pertinacia di coloro che hanno l’animo indurito nella voluttà della vendetta. Abbia perciò pronte le ponderate ed opportunissime argomentazioni dei Padri, fra cui tre meritano speciale menzione.
• Innanzi tutto, chi si ritiene ingiuriato deve convincersi che la causa principale del fatto non va ricercata in colui contro il quale agogna vendetta. L’ammirabile Giobbe gravemente danneggiato da Sabei, da Caldei e dal demonio, essendo uomo retto e pio, non tiene conto di loro, ma esce in queste pie e sante parole: «Il Signore donò, il Signore tolse» (Giob. 1, 21). Sull’esempio e sulla parola di quell’uomo pazientissimo, i cristiani vogliano persuadersi che in verità quanto soffriamo in questa vita, deriva da Dio, padre ed autore di ogni giustizia come di ogni misericordia. La Sua immensa misericordia non ci punisce come avversari, ma ci corregge e castiga come figli.
• A ben considerare le cose, gli uomini sono qui semplicemente ministri ed emissari di Dio; pur potendo un uomo odiare malvagiamente un altro e desiderargli ogni male, non può in realtà nuocergli se non lo permetta Dio. Persuasi di ciò, Giuseppe sostenne serenamente gli empi propositi dei fratelli (Gn. XLV, 5), e David le ingiurie di Simei (2 Re, 16, 10). In queste considerazioni rientra l’argomento svolto con grande dottrina dal Crisostomo, secondo il quale ciascuno è causa del proprio male. Infatti coloro che si ritengono maltrattati, se ben considerino la loro situazione, si accorgeranno di non aver subito ingiuria o danno dagli altri, potendo le lesioni e le offese provenire apparentemente dall’esterno; ma siamo in realtà noi stessi la causa del nostro male, contaminando l’animo con le nefaste passioni dell’odio, della cupidigia, dell’invidia.
• In secondo luogo, due insigni vantaggi ricadono su coloro che, spinti dal santo amore di Dio, perdonano di buon grado le offese ricevute. Il primo è questo: Dio ha promesso che chi rimette agli altri i torti, otterrà il perdono delle proprie colpe (Mt. 6, 14); donde appare quanto Gli sia gradito simile atto di virtù. L’altro sta nella nobiltà e nella perfezione conseguite da chi perdona. Dimenticando le ingiurie, diveniamo in certo modo simili a Dio, il quale fa sorgere il sole egualmente sui buoni e sui cattivi e distribuisce la pioggia su giusti ed ingiusti (Mt. 5, 45).
• Infine, devono essere spiegati gli inconvenienti a cui andiamo incontro, non perdonando le ingiurie a noi recate. Perciò il Parroco farà considerare a coloro che non vogliono perdonare ai propri nemici, come l’odio non solo sia un grave peccato, ma divenga più grave col persistervi. Chi è padroneggiato da questo sentimento, assetato del sangue dell’avversario, e pieno di speranza nella vendetta, trascorre notte e giorno in un tale permanente sconvolgimento malefico dello spirito che non sembra mai sgombro dal fantasma della strage o di qualche azione nefasta. Costui giammai, o solo da straordinari motivi, potrà essere indotto a perdonare del tutto, o a dimenticare in parte le ingiurie. A buon diritto viene paragonato alla ferita su cui il dardo è rimasto infitto.
• Sono molteplici in verità i peccati stretti insieme da comune vincolo nella colpa unica dell’odio. San Giovanni disse chiaramente in proposito: «Chi odia il proprio fratello giace nelle tenebre, e procede nell’oscurità, ignaro della sua meta; le tenebre tolsero il lume dai suoi occhi» (1 Gv. 2, 11), cosicché è destinato a cadere di frequente. Come, ad esempio, potrebbe approvare i detti o i fatti di colui che odia? Di qui i fallaci giudizi temerari, le ire, le invidie, le maldicenze e simili manifestazioni di malevolenza, che vanno a colpire anche chi è legato da parentela o da amicizia alla persona dell’odiato. Da una colpa ne nascono così decine; e non a torto si dice che questo è il peccato del demonio, che fu omicida fin dall’inizio. Il Figlio di Dio, nostro Signore Gesù Cristo, disse appunto che i Farisei erano generati dal diavolo proprio perché desideravano di metterlo a morte (Gv. 8, 44).
• Quanto abbiamo detto fin qui riguarda le ragioni che possono addursi per inculcare la determinazione di questo peccato. Ma nei monumenti della letteratura sacra è facile anche rinvenire i rimedi più opportuni a tanto flagello. Il primo e il più efficace è l’esempio del nostro Salvatore, che noi dobbiamo proporci di imitare. Sebbene la più tenue ombra di mancanza non potesse offuscare il suo immacolato candore, quantunque percosso con verghe, coronato di spine e confitto sulla croce, pronunciò queste parole, ricche di misericordia: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno» (Lc. 23, 34). L’effusione di questo sangue, secondo la testimonianza dell’Apostolo, parla ben più eloquentemente che quello di Abele (Ebr. 12, 24).
• Un secondo rimedio viene proposto dall’Ecclesiastico, e consiste nell’aver presenti la morte ed il giorno del giudizio. Ricorda, esso dice, i tuoi ultimi eventi, e non peccherai in eterno (Eccl. 7, 40). In altri termini: pensa molto spesso che tra poco ti coglierà la morte; e poiché in quell’ora suprema sarà per te d’interesse massimo impetrare l’infinita misericordia di Dio, è necessario che essa ti sia dinanzi ora e sempre. Così quella bramosia di vendetta che cova in te, si estinguerà prontamente, non esistendo mezzo più valido, a ottenere la misericordia divina, del perdono delle ingiurie e dell’amore verace per coloro che, con la parola o con le azioni, offesero te o i tuoi.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, studiamo il quarto dei comandamenti: «Onora il padre e la madre, e vivrai a lungo sulla terra che il Signore Dio tuo ti donerà», usando il semplice Catechismo del Santo Concilio di Trento.
• Natura ed estensione del comandamento. Sebbene dal punto di vista della dignità e della nobiltà del loro oggetto i precedenti comandamenti siano superiori, quelli che ora incontriamo sono così necessari da meritare giustamente di essere trattati subito dopo. Se i primi mirano direttamente al nostro ultimo fine che è Dio, gli altri ci formano all’amore del prossimo, e, sebbene con giro più ampio, ci riconducono anch’essi a Dio, per amore del quale circondiamo di carità il nostro prossimo. Per questo Gesù Cristo definì simili i due precetti dell’amore di Dio e del prossimo (Mt. 22, 39 Mc. 12, 31).
• E' arduo esprimere a parole le ripercussioni benefiche di questa carità del prossimo, che produce frutti abbondanti e squisiti, oltre ad essere segno della pronta obbedienza al primo fondamentale precetto. Dice san Giovanni: «Chi non ama il proprio fratello che egli vede sensibilmente, come potrà amare Dio che non vede» (1 Giov. 4, 20)? Analogamente, se non rispettiamo e non amiamo i genitori, cui dobbiamo secondo Dio tanto ossequio, e ci sono sempre al fianco, quale tributo di onore saremo mai capaci di sciogliere a Dio, sommo e ottimo padre, che sfugge a ogni sensibile percezione? Si capisce dunque la stretta affinità dei due precetti.
• L’ambito di questo comandamento è vastissimo. Oltre a coloro che ci generarono, sono parecchi coloro che dobbiamo rispettare come i genitori, a causa della loro autorità, della loro dignità, per i vantaggi che ci arrecano, o l’eminente officio che occupano. Il precetto inoltre facilita il compito dei genitori e, in genere, di tutti i superiori, chiamati a far sì che quanti vivono sotto il loro potere si uniformino alla Legge divina. Tutti costoro troveranno la loro missione più agevole, se sarà universalmente e praticamente compreso che, per volere di Dio, si deve tributare il più profondo rispetto ai propri genitori. E, per ottenere tale intento, è necessario conoscere la differenza che sussiste fra i precetti della prima e quelli della seconda tavola.
• Differenza dei tre primi precetti dagli altri. Perciò il Parroco spieghi al popolo queste verità, ricordando anzi tutto che i precetti del Decalogo furono incisi su due tavole. Nella prima, come apprendiamo dai Santi Padri, erano contenuti i tre già esposti; gli altri erano scolpiti nella seconda tavola. Tale distribuzione ci fu opportunamente proposta affinché l’ordine stesso materiale servisse a distinguere la natura dei precetti. Tutto ciò infatti che nella sacra Scrittura è comandato o vietato da una legge divina, rientra in uno dei due generi di azioni: secondo che vi è incluso l’amore verso Dio o l’amore verso il prossimo. I primi tre comandamenti suesposti inculcano l’amore verso Dio; gli altri sette abbracciano i rapporti sociali fra gli uomini.
• Si capisce quindi perfettamente la ragione per cui viene fatta la distinzione, e così alcuni comandamenti sono riportati alla prima tavola, gli altri alla seconda. L’argomento soggiacente ai tre primi precetti, di cui abbiamo già parlato, è Dio, vale a dire il sommo bene: per gli altri è il bene del prossimo. Quelli mirano al supremo amore, questi a un amore più vicino; quelli riguardano il fine ultimo, questi i mezzi per raggiungerlo. Inoltre l’amore di Dio poggia su Dio stesso; Dio infatti deve essere amato in grado sommo, per se stesso, non già a causa di altri. Invece l’amore del prossimo scaturisce dall’amore di Dio, e ad esso va rapportato come ad una regola fissa. Amiamo infatti i genitori, obbediamo ai padroni, rispettiamo i superiori, specialmente perché Dio li creò e volle che fossero costituiti in autorità, perché colla loro opera egli regge e tutela l’umana collettività. Dio impone di prestare ossequio a tali persone; e noi lo prestiamo perché esse ricevono da Dio l’investitura della loro dignità: sicché la deferenza verso i genitori, deve rivolgersi più a Dio che agli uomini. A proposito della riverenza dovuta ai superiori, in san Matteo si legge: «Chi accoglie voi, accoglie me» (Mt. 10, 40). E l’Apostolo nella lettera agli Efesini istruendo i servi ammonisce: «O servi, obbedite ai vostri padroni secondo la carne, temendo e tremando, nella semplicità del vostro cuore, come obbedireste a Gesù Cristo, non adempiendo il vostro dovere per essere visti e bramosi di piacere agli uomini, ma come servi di Gesù Cristo» (Efes. 6, 5).
• Occorre inoltre riflettere che non c’è onore, venerazione, o culto prestato a Dio, che possano dirsi degni, potendo l’amore di Dio essere intensificato all’infinito. È necessario perciò che il nostro amore di Dio divenga di giorno in giorno più ardente. Per suo stesso comando dobbiamo amarlo con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le nostre forze. L’amore invece con cui abbracciamo il prossimo, ha limiti ben definiti, poiché Dio comanda di amare i nostri fratelli come noi stessi (Mt. 22, 37 Lc. 10, 27). Chi travalichi questi confini in modo da amare di un uguale amore Dio e il prossimo, commette in realtà gravissima colpa. Dice perciò il Signore: «Se uno viene da me, e non odia il padre, la madre la moglie, i figliuoli, i fratelli, le sorelle, e perfino la sua vita, non può essere mio discepolo» (Lc. 14, 26). Col medesimo spirito è stato pure ingiunto: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti» (Lc. 9, 60). Così disse Gesù a un tale che mostrò desiderio di volere prima sotterrare il proprio padre e poi seguire il Signore. Più esplicita spiegazione di questa differenza è in san Matteo: «Chi ama suo padre o sua madre più di me, non è degno di me» (Mt. 10, 37). Eppure non può cadere dubbio sul dovere di amare e rispettare profondamente i propri genitori. Ma perché sussista la vera pietà, occorre che il più eminente onore e culto sia tributato a Dio, padre e causa di tutto. Di modo che i genitori mortali devono essere amati in maniera tale che tutta l’intrinseca forza dell’amore sia rivolta al Padre celeste ed eterno; e qualora i comandi paterni siano in contrasto con i comandamenti di Dio, i figli antepongano senza esitazione la volontà divina al volere dei genitori, memori del motto divino: «Occorre obbedire a Dio prima che agli uomini» (Atti 5, 29).
• Il significato della parola «onorare». Proseguendo, il Parroco spiegherà le parole del comandamento e innanzi tutto il significato del vocabolo onorare. Esso significa nutrire verso qualcuno un elevato concetto e fare il massimo conto di tutto ciò che gli appartiene. In tale onore sono conglobati l’amore, l’ossequio, l’obbedienza, la riverenza. A ragion veduta, nella formula del comandamento è inserita la parola onore, anziché quella di amore o di timore, sebbene i genitori debbano pure essere vivamente amati e temuti. Chi ama, infatti, non sempre ossequia e obbedisce; e chi teme, non sempre ama; invece quando si onora qualcuno schiettamente, lo si ama e lo si rispetta.
• Premesso ciò, il Parroco tratterà dei genitori, mostrando chi siano coloro che vanno sotto questo nome. Sebbene la legge alluda prevalentemente a quei genitori da cui abbiamo tratto la vita, tuttavia l’appellativo spetta anche ad altri, contemplati parimente dalla Legge, com’è facile arguire da molti passi scritturali. Oltre ai nostri genitori, compaiono nelle sacre Scritture altre categorie di padri, a ciascuno dei quali è dovuto il debito onore. Innanzi tutto sono chiamati padri i Reggitori, i Pastori, i Sacerdoti della Chiesa, come risulta dall’Apostolo, che scrive ai Corinzi: «Non vi dico ciò per mortificarvi, ma vi ammonisco quali figli diletti. Anche se avete avuto diecimila pedagoghi in Gesù Cristo, non avete avuto molti padri. Io solo vi ho generato in Gesù Cristo, mediante il vangelo» (1 Cor. 4, 14). E nell’Ecclesiastico sta scritto: «Sciogliamo lodi ai personaggi gloriosi, ai nostri padri nella loro generazione» (44, 1). Son detti, in secondo luogo, padri coloro che sono rivestiti di comando, di autorità giudiziaria, di potere, e governano quindi lo Stato. Naaman, per esempio, è chiamato «padre dai servi». Inoltre diamo il nome di padri a coloro, la cui tutela, cura, e saggia probità costituiscono garanzia per altri. Tali appaiono i tutori, i curatori, i pedagoghi, i maestri. Così i figli dei profeti chiamavano padri Elia ed Eliseo. Infine, nominiamo padri i vecchi e gli avanzati in età, a cui pure dobbiamo riverente ossequio. Nelle sue ammonizioni il Parroco insista molto sul dovere di onorare i padri di ogni genere, ma soprattutto coloro che ci han dato la vita. Ad essi allude particolarmente la Legge divina, essendo essi per dir cosi, un’immagine del Dio immortale, e offrendoci il segno della nostra origine. Ne ricevemmo la vita; se ne servi Dio per infonderci lo spirito immortale; ci trassero ai Sacramenti, ci educarono alla religione, alla cultura, alla vita civile, alla integrità santa dei costumi.
• Il Parroco spiegherà in seguito come il termine madre sia qui giustamente menzionato, perché siano da noi apprezzati i benefici e i titoli di merito della madre nostra, ricordando la trepidante cura con cui ci portò nel grembo, e il travaglio penoso con cui ci diede alla luce e ci educò.
• Amore verso i genitori. Il nostro contegno verso i genitori deve essere tale che l’onore loro tributato appaia scaturito dall’amore e dall’intimo sentimento dell’animo. Tutto ciò per stretto dovere di reciprocità, poiché essi nutrono tali sentimenti verso di noi che non rifuggono da nessuna fatica, disagio, e rischio per il nostro bene; e nulla arreca loro più letizia dell’affetto intimo dei figli diletti. Giuseppe, costituito in Egitto in posizione affine a quella del re per dignità e potere, accolse con ogni manifestazione di ossequio il padre venuto in Egitto (Gn. XLVI,29); e Salomone si fece incontro alla madre che sopraggiungeva, ossequiandola e collocandola alla sua destra nel trono reale (3 Re 2, 19). Vi sono altre maniere di manifestare il rispetto dovuto ai genitori. Li onoriamo infatti anche quando imploriamo da Dio che conceda loro prosperità in ogni evento, li faccia rispettati e accetti fra gli uomini, e li renda degni del Suo compiacimento e di quello di tutta la corte celeste.
• Similmente prestiamo ossequio ai genitori, subordinando il nostro parere alla loro volontà e al loro giudizio. Ce ne ammonisce Salomone: «Presta ascolto, figlio mio, all’autorità di tuo padre e non dimenticare i precetti della madre tua; si aggiungerà così grazia al tuo capo, e una collana al tuo collo» (Pr. 1, 8). Fanno eco le esortazioni di san Paolo: «O figli, obbedite nel Signore ai vostri genitori, com’è giusto» (Efes. 6, 1). E altrove: «Figli, obbedite sempre ai vostri genitori, come piace al Signore» (Col. 3, 20). Confermano gli esempi dei santi: Isacco, tratto legato al sacrificio, obbedisce umilmente senza protestare (Gn. 12, 9); i Recabiti, per non trasgredire il consiglio paterno, si astennero per sempre dal vino (Gerem. 35, 6).
• Onoriamo pure i nostri genitori imitandone le buone azioni e i retti costumi: equivale a esprimere loro il più alto senso di ossequio, cercare di imitarli quanto più è possibile. E li onoriamo ancora, non solo ricercandone, ma attuandone i consigli.
• Li onoriamo anche provvedendo tutto ciò che il loro mantenimento e il benessere esigono. Lo prova la testimonianza esplicita di Gesù Cristo, che, rimproverando ai Farisei la loro empietà, esclama: «E perché anche voi trasgredite il comando di Dio in grazia della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: Onora il padre e la madre; e: Chi maledirà il padre o la madre, sia punito di morte. Voi altri invece dite: Chiunque dica al padre o alla madre: Sia offerta di sacrificio quello con cui potrei aiutarti, non è più obbligato a onorare il padre o la madre; e così con la vostra tradizione avete annientato il comandamento di Dio» (Mt. 15, 3). Che se dobbiamo assolvere il nostro obbligo di rispetto verso i genitori in ogni momento, il dovere si fa più urgente in occasione delle loro gravi infermità. Cureremo allora che non tralascino nulla di quanto spetta alla confessione dei peccati e agli altri sacramenti necessari al Cristiano, mentre la morte si approssima. E faremo di tutto perché possano vedere di frequente persone pie e religiose, capaci di sostenerne e corroborarne col consiglio la debolezza, o di indirizzarne i buoni sentimenti verso la speranza dell’immortalità. Sottratto così lo spirito a ogni preoccupazione umana, tutto lo rivolgano a Dio, e in mezzo al corteggio beatissimo della fede, della speranza e della carità, muniti di tutti i conforti religiosi, non riterranno ormai temibile la morte, dal momento che è necessaria, ma anzi desiderabile, in quanto schiude l’adito all’eternità.
• Infine può rendersi onore ai genitori anche dopo che sono trapassati, curandone i funerali, preparandone le esequie, dando loro conveniente sepoltura, provvedendo alla celebrazione degli anniversari, adempiendone regolarmente la volontà testamentaria. • L’onore ai prelati ed ai prìncipi. Meritano la nostra riverenza, oltre ai nostri genitori, anche gli altri che portano il nome di padri. Tali sono i Vescovi, i Sacerdoti, i Re, i prìncipi, i magistrati, i tutori, i curatori, i maestri, i pedagoghi, i vecchi, e altri. Tutto costoro sono degni di ricevere, sebbene in varia misura, qualche tributo del nostro affetto, della nostra obbedienza e delle nostre sostanze. Sta scritto a proposito dei Vescovi e degli altri Pastori: «I Sacerdoti che adempiono degnamente il loro ministero, siano ritenuti meritevoli di un duplice onore, specialmente coloro che si distinguono nel ministero della parola e nella dottrina» (1 Tm. 5, 17). Quante prove di attaccamento non diedero i Galati all’Apostolo? Egli ne dà loro testimonianza palmare, ispirata a benevolenza: «Riconosco che, se fosse stato possibile, voi vi sareste strappati gli occhi per darmeli» (Gal. 4, 15).
• Ai Sacerdoti devono essere fornite le risorse necessarie al sostentamento della vita. Onde l’Apostolo chiede: «Chi ha mai portato le armi a proprie spese?» (1 Cor. 9, 7). E nell’Ecclesiastico è detto: «Rispetta i Sacerdoti. Dà ad essi la parte loro, come t’è stato comandato: le primizie e (la vittima) d’espiazione» (7, 31). Anche l’Apostolo insegna che si deve loro obbedire: «Siate sottomessi ai vostri superiori ed eseguitene i comandi. Essi vigilano, essendo tenuti a rendere ragione delle anime vostre» (Ebr. 13, 17). Anzi, da nostro Signore Gesù Cristo è stato esplicitamente dichiarato che dobbiamo sottostare ai Pastori, anche se malvagi: «Sulla cattedra di Mosè si assisero gli scribi e i farisei. Osservate e fate pertanto ciò che vi diranno; ma non fate secondo le opere loro: che dicono e non fanno» (Mt. 23, 2).
• Lo stesso dicasi a proposito dei Re, dei prìncipi, dei magistrati, di tutti coloro - insomma - al cui potere siamo soggetti. L’Apostolo, nella lettera ai Romani, spiega ampiamente quale genere di rispetto, di ossequio e di sudditanza debba essere loro prestato (Rm. 13, 1); inculca anche di pregare per loro (1 Tm. 2, 2). San Pietro raccomanda: «Siate sottomessi ad ogni creatura umana, in vista di Dio: così al Re, quale sovrano, come ai subalterni, quali suoi delegati» (1 Pt. 2, 13). In verità l’ossequio che tributiamo loro va riferito a Dio. Infatti l’eminente grado della dignità esige rispetto dagli uomini, perché implica un’analogia col potere divino. Rispettandolo, del resto, veneriamo la provvidenza di Dio, che conferisce ai dignitari la funzione pubblica, e di essi si serve come di delegati della propria potestà.
• Qualora i magistrati si rivelino malvagi ed empi, noi non onoriamo i loro vizi, ma l’autorità divina che è in essi. Potrà forse apparire cosa incredibile, ma è pur vero che per quanto siano implacabilmente ostili a noi, non possiamo trovare in questo fatto una ragione sufficiente per negare ossequio a coloro che sono costituiti in autorità. Sappiamo dei servizi prestati da David a Saul, sebbene a lui inimicissimo, onde poteva esclamare: «Mi mostrai pacifico verso coloro che odiavano la pace» (Ps. 119, 7). Qualora però comandino cosa malvagia e iniqua, tralasceremo di prestar loro ascolto; perché allora non parlano più in virtù di un potere legittimo, ma in base a un titolo ingiusto e ad una perversione dell’animo.
• Premio spettante a chi osserva questo comandamento. Spiegato minutamente tutto questo, il Parroco mostri quale premio sia riservato a coloro che obbediscono a questo divino precetto. Il suo frutto più notevole è che vivranno a lungo; poiché in verità sono degni di godere quanto più a lungo è possibile di tale beneficio coloro che ne conservano perenne memoria. Ora, chi onora i propri genitori mostra gratitudine per la vita e l’educazione ricevuta; è giusto dunque e conveniente che viva fino alla più tarda vecchiaia. Si aggiunga quell’insigne spiegazione della divina promessa, la quale garantisce non solo il godimento della vita eterna beata, ma anche di questa vita terrena. Dice infatti san Paolo: «La pietà giova a tutto, comprendendo in sé la promessa della vita presente e della futura» (1 Tm. 4, 8). Né si tratta di un compenso tenue e spregevole; sebbene a uomini ricolmi di santità, quali Giobbe, David, Paolo, la morte sia apparsa desiderabile, e per uomini piombati nella miseria e nei dolori il prolungamento della vita non rappresenti una gioia. Poiché la clausola che delucida quelle parole: «La vita che il Signore ti donerà», promette evidentemente non solo prolungamento dell’esistenza, ma anche serenità e tranquilla incolumità di vita. Nel Deuteronomio infatti alle parole: «Affinché tu campi lungo tempo», sono aggiunte le altre: «Affinché tutto avvenga per te favorevolmente» (Deut. 5, 16); parole che sono poi ripetute dall’Apostolo (Efes. 6, 3).
• Noi affermiamo che codesti beni sono il sovrappiù, per coloro la cui pietà viene ricompensata da Dio. Se così non fosse, la promessa divina non sarebbe costantemente fedele, poiché talora è più breve l’esistenza di coloro che dimostrano più profonda riverenza verso i loro genitori. Ciò può accadere per molte ragioni. Può essere innanzi tutto provvidenziale per essi uscire di vita prima di abbandonare il sentiero della virtù e della rettitudine religiosa. Alcuni possono essere sottratti al mondo, affinché il male non faccia deviare il loro intelletto e la seduzione non affascini il loro spirito (Sap. 4, 11). Altri possono essere strappati al corpo quando sia imminente uno sconvolgimento generale delle cose, sicché sfuggano la sventura dei tempi. Dice infatti il profeta: «Dal volto del male è stato allontanato il giusto» (Is. 57, 1). In tal caso si evita il rischio della loro virtù e della loro salvezza, quando la giustizia e il castigo sono esercitati da Dio sui mortali; o si risparmia loro l’amarissimo lutto del cuore di fronte alle disgrazie dei parenti e degli amici. Sicché dovremmo molto temere quando accade che i buoni muoiano innanzi tempo.
• Castigo che attende i trasgressori. D’altro canto, se su coloro che sono riconoscenti verso i propri genitori piovono le ricompense di Dio, fierissimi castighi sono riservati ai figli snaturati ed ingrati. Sta scritto: «Chi avrà lanciato imprecazioni a suo padre e a sua madre, morrà di morte violenta» (Ex. 21, 17 Lv. 20, 9); «Chi rattrista suo padre e scaccia sua madre, è un essere obbrobrioso e disgraziato» (Prov. 19, 26); «La lucerna di colui che avrà bistrattato suo padre o sua madre si spegnerà nel più folto delle tenebre» (Prov. 20, 20); «L’occhio di colui che sogghigna a suo padre e irride al parto della madre sua, sia scavato dai corvi dei torrenti e divorato dai figli dell’aquila» (Prov. 30, 17). Leggiamo nella sacra Scrittura che molti recarono offesa ai loro genitori, ma leggiamo pure che l’ira di Dio infierì per trarne vendetta; Egli non lasciò David invendicato, ma alla scelleratezza di Assalonne impose il dovuto castigo, punendolo, a causa del suo peccato, con tre colpi di lancia (2 Re 18, 14). A proposito poi di chi rifiuta ossequio ai Sacerdoti è scritto: «Chi superbamente rifiuterà ossequio al precetto del sacerdote in funzione, o alla sentenza del giudice, morrà» (Deut. 17, 12).
• Doveri dei genitori verso i figli. La Legge divina che ha sancito l’ossequio filiale e l’obbedienza verso i genitori, ha pure stabilito i doveri e le mansioni proprie dei genitori. Ad essi impone inculcare nei figliuoli le discipline sante e i costumi integri, di suggerire loro i sani precetti del vivere, affinché, religiosamente istruiti, onorino piamente e indefettibilmente Dio, come leggiamo essere stato fatto dai genitori di Susanna (Dan. 13, 3). Perciò il Sacerdote ammonirà i genitori di mostrarsi ai figli quali maestri di virtù, di equità, di continenza, di modestia e di pietà. Dovranno in modo speciale evitare tre scogli su cui è più facile incappare. Innanzi tutto si asterranno dal parlare e comandare ai figliuoli con asprezza; lo dice l’Apostolo nella lettera ai Colossesi: «O padri, non vogliate provocare a sdegno i vostri figli, perché non si avviliscano» (Col. 3, 21). C’è pericolo che, temendo di tutto, acquistino una natura fragile e pusillanime. Raccomanderà perciò che, evitando l’eccessiva severità, preferiscano correggere anziché punire i propri figliuoli. D’altra parte, qualora sia stata commessa una colpa e siano quindi necessari la riprensione e il castigo, non siano stimolati a transigere da eccessiva indulgenza. Spesso infatti accade che i figli siano sciupati dalla esagerata mitezza dei genitori. Da così malsana indulgenza allontani l’esempio di Eli, sommo sacerdote, il quale, essendo stato troppo debole con la propria figliuolanza, incontrò l’estremo castigo (1 Re 4, 18).
• Infine badino bene i genitori a non vagheggiare, cosa orribile, intenti volgari nella educazione e istruzione dei figli. Ci sono molti che pensano ad una cosa sola: lasciare ai figli sostanze abbondanti, un pingue e vistoso patrimonio, ed esortano i loro rampolli non già alla religione, alla pietà, alla regola delle sante virtù, bensì all’avarizia e all’aumento dei beni di famiglia. Costoro non si preoccupano della buona fama e della salvezza dei figli, ma solo badano a che siano sempre più ricchi. Si può immaginare un programma più turpe? Finiscono così col lasciare ai figli non solo una eredità cospicua, ma anche un pesante fardello di colpe e di nefandezze, che li fa essere non guide al cielo, ma pessimi iniziatori all’eterno supplizio dell’inferno.
• Il Parroco con sapienti consigli istruisca i genitori, stimolandoli a imitare il virtuoso esempio di Tobia (Tob. 4). Se avranno educato i figli al culto divino e alla santità, ne riceveranno in cambio frutti copiosi di amore, di rispetto e di ossequio.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Come già comunicato, in data 20 febbraio, 5 e 6 aprile 2017 l'Associazione Sursum Corda ha consegnato alla Caritas diocesana di Potenza, tramite un proprio Associato, circa 180 capi di abbigliamento, nuovi ed usati. In data 15 giugno 2017 abbiamo altresì donato, sempre alla Caritas diocesana di Potenza, alcune apparecchiature di raffreddamento e di riscaldamento per ambiente, numerose scarpe da donna, altri capi di abbigliamento femminile ed una decina cappelli in paglia - vari colori e forme - per i giochi estivi dei bambini.
Dalle «Lettere» di san Giovanni di Dio. Cristo è fedele e a tutto provvede
Se guardassimo alla misericordia di Dio, non cesseremo mai di fare il bene tutte le volte che se ne offre la possibilità. Infatti quando, per amor di Dio, passiamo ai poveri ciò che Egli stesso ha dato a noi, ci promette il centuplo nella beatitudine eterna. O felice guadagno, o beato acquisto! Chi non donerà a quest’ottimo mercante ciò che possiede, quando cura il nostro interesse e ci supplica a braccia aperte di convertirci a Lui e di piangere i nostri peccati e di metterci al servizio della carità, prima verso di noi e poi verso il prossimo? Infatti come l’acqua estingue il fuoco, così la carità cancella il peccato (cfr. Sir 3, 29). Vengono qui tanti poveri, che io molto spesso mi meraviglio in che modo possano esser mantenuti. Ma Gesù Cristo provvede a tutto e tutti sfama.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, studiamo il terzo dei comandamenti: «Ricordati di santificare le feste», usando il semplice Catechismo del Santo Concilio di Trento.
• Oggetto del comandamento. Lavorerai per sei giorni, compiendo tutti i tuoi doveri. Ma il settimo giorno è del Signore Dio tuo; in quello, nulla farete tu, tuo figlio e tua figlia, il tuo servo e la tua serva, il tuo giumento, l’ospite che dimora in casa tua; infatti in sei giorni il Signore fece il cielo, la terra e tutto ciò che è in essi; e nel settimo giorno si riposò. Per questo il Signore benedisse il sabato e lo santificò. Con questo comando della Legge è giustamente e ordinatamente prescritto quel culto esterno che dobbiamo a Dio. Si tratta in fondo di un corollario del precedente comandamento: «Non nominare il nome di Dio invano». Non possiamo infatti astenerci dal prestare culto esterno e dall’offrire il nostro ringraziamento a Colui che veneriamo nell’anima, ed in cui riponiamo la nostra fiducia e speranza. E poiché le cure umane non permettono agevolmente agli uomini di assolvere simile compito, è stato fissato un tempo in cui possano farlo comodamente.
• Trattandosi di comandamento che arreca mirabili frutti, preme che il Parroco ponga ogni studio nel commentarlo. La prima parola della formula: Ricordati, infiammerà già di per sé il suo zelo. Se i fedeli devono ricordare il precetto, spetta al Pastore inculcarlo senza tregua nei loro cuori. Quanto poi convenga ai fedeli rispettarlo, traspare dal fatto che, ciò facendo, saranno portati a rispettare più facilmente i rimanenti obblighi della legge. Infatti, fra le altre azioni da compiere nei giorni festivi, v’è quella di recarsi in chiesa ad ascoltare la parola di Dio. Una volta istruiti nelle divine prescrizioni, i fedeli custodiranno con tutto il cuore la Legge del Signore.
• Per questo il rispetto del Sabato e il culto divino sono raccomandati spessissimo nella Scrittura, nell’Esodo ad esempio, nel Levitico, nel Deuteronomio, in Isaia, in Geremia, in Ezechiele; dovunque si riscontrano passi che inculcano il rispetto del giorno festivo. Speciali esortazioni vanno rivolte a chi governa e ai magistrati, affinché per quanto riguarda il mantenimento e l’incremento del culto divino, pongano il loro potere a disposizione dei reggitori ecclesiastici e ordinino al popolo di sottostare alle prescrizioni sacerdotali.
• Nella spiegazione del comandamento si deve aver cura che i fedeli sappiano in che cosa esso coincide con gli altri, ed in che cosa ne differisce; cosi comprenderanno perché noi rispettiamo e riteniamo per giorno sacro non più il Sabato ma la Domenica. Una differenza intanto è questa: gli altri comandamenti del Decalogo sono naturali e perpetui, né possono in nessun modo essere cambiati; sicché, per quanto la Legge di Mosè sia stata abrogata, il popolo Cristiano rispetta sempre i comandamenti contenuti nelle due tavole, non in virtù della prescrizione mosaica, ma perché si tratta di precetti rispondenti alla natura, la cui forza stessa ne impone agli uomini il rispetto. Questo precetto invece del culto del Sabato, per quanto riguarda il giorno prescelto, non è circoscritto e fisso, ma mutabile; non si riferisce ai costumi, ma ai riti; non è naturale, non avendoci istituito o comandato la natura di prendere un dato giorno, anziché un altro, per dare a Dio culto esterno; a solamente dal tempo in cui il popolo d’Israele fu liberato dalla servitù del Faraone, esso rispettò il Sabato. Ma al momento in cui tutti i riti ebraici e le cerimonie dovevano decadere, alla morte cioè di Cristo, anche il Sabato doveva essere cambiato. Infatti essendo tali cerimonie pallide immagini della luce, necessariamente sarebbero state rimosse all’avvento della luce e della verità, che è Cristo Signore. Scriveva in proposito san Paolo ai Galati, rimproverando i cultori del rito mosaico: «Voi osservate i giorni, i mesi, le stagioni, gli anni: temo per voi che cioè io per voi abbia lavorato invano» (4,10). Nel medesimo senso si esprimeva con i Colossesi (2,16). E questo valga per le differenze.
• Coincide invece con gli altri precetti non già nel rito e nelle cerimonie, ma in quanto implica qualcosa che rientra nella Morale e nel diritto naturale. Il culto e l’ossequio religioso a Dio, formulati in questo comandamento, sgorgano infatti dal diritto di natura, essendo proprio la natura che ci spinge a consacrare qualche ora al culto di Dio. Non constatiamo infatti che tutti i popoli consacrano alcuni giorni alla pubblica celebrazione di sacre cerimonie? L’uomo è tratto da natura a dedicare un tempo determinato ad alcune funzioni elementari, quali il riposo del corpo, il sonno, e simili. Per la stessa forza naturale è spinto a concedere, oltre che al corpo, un po’ di tempo allo spirito, affinché si rinfranchi nel pensiero di Dio. Che in una parte del tempo si venerino le cose divine e si tributi a Dio il dovuto onore, rientra quindi nell’insieme dei precetti riguardanti i costumi. Perciò gli Apostoli stabilirono che fra i sette giorni, il primo fosse consacrato al culto divino, e lo chiamarono giorno del Signore.
• Anche san Giovanni nell’Apocalisse ricorda il giorno del Signore (I,10). E l’Apostolo comanda che si facciano collette ogni primo giorno della settimana (1Cor. 16,2), che è la Domenica, secondo la spiegazione del Crisostomo. Evidentemente fin da allora il giorno domenicale era sacro.
• Molteplici parti del comandamento. Affinché i fedeli sappiano come debbono comportarsi in quel giorno e da quali azioni si debbano astenere, non sarà male che il Parroco spieghi minutamente il precetto, che può dividersi praticamente in quattro parti.
• Innanzi tutto indicherà genericamente quel che prescrivono le parole: Ricordati di santificare il Sabato. Opportunamente al primo posto è stato collocata l’espressione Ricordati, poiché il culto di questo giorno appartiene alla legge cerimoniale. Sembrò saggio ammonire formalmente in proposito il popolo, dal momento che la legge naturale, pur insegnando che in un dato tempo qualsiasi si doveva venerare Dio con culto religioso, non prescriveva in quale giorno di preferenza si dovesse fare.
• In secondo luogo il Parroco mostri ai fedeli come la formula suggerisca il modo ragionevole con cui dobbiamo lavorare durante la settimana, in maniera cioè da non perdere mai di vista il giorno festivo. In questo, dobbiamo quasi render conto a Dio delle nostre azioni e delle nostre opere; è necessario quindi che compiamo sempre azioni tali da non meritare la condanna di Dio, e da non lasciare nei nostri spiriti, secondo il motto biblico, tracce di singhiozzi e di rimpianti (1 Re 25,31).
• Infine la formula ci insegna, e dobbiamo ben rifletterci, che non mancheranno le occasioni per dimenticare il precetto, trascinati dall’esempio di coloro che lo trascurano, assorbiti dagli spettacoli e dai giuochi che allontanano troppo spesso dal pio e religioso rispetto del santo giorno.
• Ma veniamo ormai a parlare del significato del Sabato. Sabato, vocabolo ebraico, vuol dire cessazione; quindi sabatizzare vale cessare e riposarsi. Il settimo giorno ricevette il nome di Sabato, appunto perché, compiuto l’universo cosmico, Dio ristette dall’opera già compiuta (Gen. 2,3). Così il Signore chiama questo giorno nell’Esodo (20,8). Più tardi tale nome fu conferito, non più soltanto al settimo giorno, ma, a causa della sua dignità, a tutta la settimana. Per questo il fariseo dice nel Vangelo di san Luca: Digiuno due volte nel Sabato (Lc. 18,12). Questo per quanto riguarda il significato del Sabato.
• La santificazione del Sabato, secondo le indicazioni bibliche, consiste nell’astensione da tutti i lavori e affari materiali, come indicano apertamente le parole seguenti del precetto: Non lavorerai. Ma non è qui tutto; perché in tale ipotesi sarebbe stato sufficiente dire nel Deuteronomio: Osserva il Sabato (5,12), mentre invece vi si aggiunge: Per santificarlo. Dunque il giorno del Sabato è un giorno religioso, che va consacrato ad azioni divine o ad occupazioni sacre. Sicché lo rispetteremo integralmente se adempiremo gli atti di religione verso Dio. E questo è propriamente il Sabato, che Isaia chiama delizioso (LVIII,13), poiché i giorni festivi sono come le delizie del Signore e degli uomini pii. Che se al rispetto religioso così intero e santo del Sabato aggiungeremo le opere di misericordia, allora, secondo la promessa del medesimo profeta (LVIII,6), ci meriteremo premi inestimabili. Dunque il pieno valore del comandamento esige che l’uomo ponga tutte le sue energie perché nei giorni fissati, lontano dagli affari e dal lavoro materiale, possa attendere al pio culto del Signore.
• Misteri del giorno consacrato al Signore. Nella seconda parte del comandamento è detto che, per ordine divino, il settimo giorno è consacrato al culto di Dio. Sta scritto infatti: Lavorerai per sei giorni e farai tutto quello che devi. Ma il settimo giorno è il Sabato del Signore Dio tuo. Tali parole vogliono significare che il Sabato deve essere consacrato al Signore con opere di religione, e che questo settimo giorno simboleggia il riposo del Signore. Fu consacrato a Dio, perché non sarebbe stato bene rilasciare all’arbitrio del popolo rozzo scegliersi la giornata, col pericolo di seguire le consuetudini sacre degli Egiziani. Fra i sette giorni, fu prescelto l’ultimo per il culto del Signore: e la cosa è piena di mistero; perciò Dio nell’Esodo (Ex. 31,13) e in Ezechiele (20,2) chiama il Sabato un segno: Badate a rispettare il mio Sabato, perché è un segno pattuito fra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché sappiate che io sono il Signore che vi santifica. Vale a dire: esso fu il segno che indicava agli uomini la necessità di dedicarsi a Dio, di mostrarsi santi ai suoi occhi, osservando come a Lui era consacrata anche una giornata speciale. Infatti è santo il giorno in cui gli uomini devono in maniera particolare coltivare la santità e la religione. Inoltre il Sabato è come un segno e un ricordo commemorativo dell’avvenuta formazione di questo mirabile universo. Di più, fu un segno tramandato alla memoria degli Israeliti perché fossero indotti a ricordare costantemente che l’aiuto di Dio li aveva affrancati dal durissimo giogo del dominio egiziano. Dice infatti il Signore: Ricordati di essere stato schiavo in Egitto e che ti liberò di là il Signore Dio tuo con la forza della sua mano e l’intervento del suo braccio. Per questo ti impose di rispettare il Sabato (Dt. 5,15).
• Infine è il simbolo del Sabato spirituale e di quello celeste. Il Sabato spirituale consiste in un santo e mistico riposo; e si celebra quando, sepolto in Cristo l’uomo vecchio (Rm. 6,4), si rinasce a vita nuova e si compiono fervidamente azioni confacenti alla pietà cristiana. Allora, coloro che erano una volta tenebre e ora invece sono luce nel Signore, procederanno sui sentieri della bontà, della giustizia, della verità, come figli della luce, astenendosi dal partecipare alle insane opere delle tenebre (Efes. 5,8).
• Il Sabato celeste poi, secondo il commento di san Cirillo al passo apostolico: è lasciato un altro sabato al popolo di Dio (Ebr. 4,9), consiste in quella vita, nella quale, vivendo con Cristo, godremo di tutti i beni, essendo estirpata ormai ogni radice di peccato, secondo il detto: Non vi saranno leoni, non vi passeranno belve; ma ivi si aprirà una strada pura e santa (Is. 35,9). In realtà lo spirito dei santi consegue nella visione di Dio tutti i beni. Si esortino dunque i fedeli e si stimolino con le parole: Affrettiamoci a entrare in quel supremo riposo (Ebr. 4,11).
• Il popolo Giudaico rispettava, oltre il settimo giorno, anche altri giorni festivi stabiliti dalla Legge, affinché fosse sempre viva la memoria degli insigni benefici ricevuti. La Chiesa di Dio trasportò la ricorrenza festiva del Sabato alla Domenica; perché in questo giorno, per la prima volta, brillò la luce sul mondo, ed in esso, in virtù della risurrezione del Redentore che aprì l’adito alla vita eterna, la nostra vita, affrancata dalle tenebre, fu ricondotta nelle regioni della luce. Perciò gli Apostoli lo chiamarono giorno del Signore. Già nella Bibbia tale giorno appare solenne, come quello in cui ebbe principio la creazione del mondo, ed in cui lo Spirito santo fu infuso negli Apostoli.
• Agli inizi della Chiesa e nei tempi susseguenti, gli Apostoli ed i nostri santi Padri istituirono altri giorni festivi, affinché alimentassimo sempre la memoria santa dei divini benefici. Fra gli altri sono ritenuti più solenni i giorni che commemorano i misteri della nostra Redenzione; poi quelli consacrati alla santissima Vergine e Madre; infine quelli dedicati agli Apostoli, ai Martiri, ai Santi che regnano con Cristo. Nella vittoria di questi santi rifulge ed è esaltata la potente benevolenza di Dio; ad essi vien tributato onore, anche perché il popolo sia stimolato ad imitarne le virtù.
• Al rispetto del comandamento induce pure efficacemente la parte della formula che dice: Lavorerai per sei giorni; il settimo giorno è il Sabato del Signore. Il Parroco perciò deve copiosamente spiegarla. Da quelle parole è lecito desumere che i fedeli devono essere esortati a non trascorrere la loro esistenza nell’ozio; ma al contrario, memori della raccomandazione apostolica, ciascuno compia il suo lavoro con le proprie mani (1 Tess. 4,11; Efes. 4,28). Con tale precetto, inoltre il Signore comanda di non rimandare alla domenica nulla di ciò che dobbiamo compiere negli altri giorni, perché lo spirito non sia allontanato nel giorno festivo dalle occupazioni sante.
• Quale lavoro è vietato nei giorni festivi. Il Parroco illustrerà poi la terza parte del comandamento, che spiega in qualche modo come si debba rispettare il Sabato, e da quali opere ci dobbiamo astenere. Dice il Signore: In quel giorno non farete nulla: né tu, né tuo figlio, né tua figlia, il tuo servo o la tua serva, il tuo giumento e il tuo ospite che è in casa tua. Con queste parole siamo avvertiti di evitare assolutamente quanto può ostacolare l’esercizio del culto divino. Si intuisce infatti che è vietato ogni genere di lavoro servile, non davvero perché questo sia di natura sua disonorevole e malvagio, ma solo perché ci allontana da quel culto divino che rappresenta lo scopo del precetto. A quanta maggior ragione i fedeli dovranno evitare in quel giorno i peccati, che non solamente distraggono lo spirito dall’esercizio delle cose divine, ma ci separano radicalmente dall’amore di Dio!
• Non sono però vietate le azioni che appartengono al culto divino, anche se siano servili; quali apparecchiare l’altare, adornare il tempio per il dì festivo, e simili. Perciò il Signore ha detto che i sacerdoti possono nel tempio violare il Sabato ed essere senza colpa (Mt. 12,5). Neppure si devono ritenere vietate dalla legge quelle azioni la cui sospensione nel giorno festivo può determinare gravi danni. Anche i sacri Canoni lo permettono. Il Signore nel Vangelo dichiarò che molte altre azioni possono compiersi nei giorni di festa, ed il Parroco ne troverà agevolmente l’indicazione in san Matteo ed in san Giovanni.
• Ad ogni modo, perché nulla fosse omesso di tutto ciò che può impedire il rispetto del Sabato, fu menzionato persino il giumento. Anche da questi animali sono impediti gli uomini dall’attendere alla celebrazione del Sabato, poiché se in questo giorno si fa lavorare la bestia da soma, lavorerà anche l’uomo che deve guidarla. Essa non può da sola compiere un lavoro; soltanto aiuta l’uomo nel suo intento. E poiché di festa nessun lavoro è consentito, neppure alla bestia è lecito lavorare, essendo essa cooperatrice docile dell’uomo. Di modo che la legge finisce con l’avere pure un’altra portata; poiché se Dio vuole che l’uomo risparmi gli animali nel lavoro, tanto più vuole che si astenga dall’essere disumano con coloro che hanno posto la loro capacità a suo servizio.
• Il Parroco infine non dimentichi di insegnare con cura in quali opere debbano invece trascorrere i cristiani i giorni festivi. Andranno in chiesa per assistere con devota attenzione al sacrificio della santa Messa, partecipare di frequente ai divini sacramenti della Chiesa, istituiti per la nostra salute e per la cura delle nostre ferite spirituali. Nulla può fare di meglio il cristiano che confessare spesso i suoi peccati ai sacerdoti. A tal fine il Parroco esorterà di frequente il popolo, traendo copia di argomenti da quanto è stato detto e stabilito a proposito del sacramento della Penitenza. Né si limiterà a stimolare il popolo ad accostarsi a questo sacramento, ma assiduamente lo spingerà ad avvicinarsi spesso al santo sacramento della Eucaristia.
• I fedeli inoltre devono ascoltare con religiosa attenzione la predica. Che cosa di più intollerabile e di più indegno che il disprezzo, o l’indifferenza verso la parola di Gesù Cristo? Infine i fedeli devono esercitarsi nelle preci e nelle lodi divine, ponendo tutte le loro cure nell’apprendere le regole della vita cristiana. Metteranno in pratica premurosamente quei doveri che rientrano nella sfera della pietà, quali l’elemosina ai poveri e ai bisognosi, la visita agli infermi, la consolazione e il conforto agli addolorati. Come dice san Giacomo: La religione pura e immacolata agli occhi di Dio Padre sta qui: visitare gli orfani, e confortare le vedove nei loro affanni (I,27). Da quanto abbiamo detto sarà facile desumere quali siano le trasgressioni che si commettono contro questo comandamento.
• Ragioni del comandamento. Il Parroco abbia sempre presenti passi autorevoli, da cui attingere argomenti capaci di indurre il popolo ad obbedire scrupolosamente al precetto. Il mezzo più efficace però è che il gregge dei fedeli comprenda bene la giustizia e la ragionevolezza dell’obbligo di dedicare alcuni giorni all’esclusivo culto di Dio, al riconoscimento ed alla religiosa venerazione di nostro Signore, da cui ricevemmo incommensurabili e innumerevoli benefici. Se pure ci avesse comandato di compiere ogni giorno atti di culto religioso verso di Lui, non dovremmo alacremente obbedire al suo cenno, in virtù dei suoi infiniti benefici? Invece ha voluto pochi giorni per sé. Potremo dunque essere negligenti nell’assolvere un così modesto compito, al quale non possiamo sottrarci senza gravissima colpa?
• Mostri poi il Parroco l’intimo valore del comandamento: chi l’osserva coscienziosamente non sembra costituito al cospetto di Dio, in colloquio con lui? In realtà rivolgendo preghiere a Dio ne contempliamo la maestà, parliamo con Lui; ascoltando i predicatori, udiamo la voce di Dio, che arriva per loro mezzo alle nostre orecchie, quando trattano piamente delle cose divine; nel Sacrificio dell’altare poi adoriamo presente nostro Signore Gesù Cristo.
• Di tutti questi beni godono coloro che ubbidiscono al comandamento. Mentre chi lo trascura, è ribelle a Dio e alla Chiesa, sordo al divino comando, realmente nemico di Dio e delle sue sante leggi. Basta riflettere al fatto che tale divino comandamento può essere rispettato senza alcun sacrificio. Dio non ha imposto ardue fatiche da affrontarsi in suo onore: ha voluto semplicemente che trascorressimo i suoi giorni festivi liberi da cure terrene. Non è dunque indizio di sfrontata temerità il rifiuto di obbedienza? Ricordiamo i terrificanti supplizi a cui Dio sottopose i violatori del comando, quali sono narrati nel libro dei Numeri (15,32). Per non incappare in questa grave offesa di Dio, sarà bene ripetere mentalmente e molto spesso il monito: ricordati; e tenere costantemente dinanzi agli occhi gli insigni vantaggi, che abbiamo mostrato scaturire dal rispetto dei giorni festivi, e tutte quelle argomentazioni, che il pastore zelante saprà ad ogni occasione prospettare e illustrare.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, studiamo il secondo dei comandamenti: «Non nominare il nome di Dio invano», usando il semplice Catechismo del Santo Concilio di Trento.
• Importanza del secondo comandamento. Nel primo comandamento della Legge divina che comanda di onorare Dio piamente e santamente, è necessariamente incluso questo secondo che segue. Infatti, chi vuole che gli si tributi onore, chiede con questo stesso che si usino a suo riguardo sempre parole rispettose e si evitino le parole dispregiative, come apertamente ricordano le parole di Malachia: Il figlio rispetta il padre, e il servo il suo padrone: se io sono padre, dov’è l’onore che mi si deve? (Mal. 1,6). Tuttavia, data l’importanza della cosa, Dio volle separatamente emanare e formulare questa Legge sull’onore dovuto al suo Nome santissimo e divino.
• (Tragga di qui il Parroco la convinzione che non basta parlare di tale argomento in termini generici. Si tratta di un tema su cui deve fermarsi a lungo, enumerando con ogni cura ai fedeli tutto ciò che vi si riferisce. Non tema mai di eccedere in diligenza, perché non mancano individui cosi accecati nelle tenebre dell’errore da osare di bistrattare, con le parole, Chi è glorificato dagli angeli). Non impressionati dalla Legge una volta emanata, costoro non ristanno dall’offendere senza vergogna ogni giorno, ogni ora anzi, e quasi ogni minuto, la maestà di Dio. Non udiamo tutt’intorno giuramenti sprecati per ogni quisquilia, discorsi tutti “infiorati” di imprecazioni e scongiuri, fino al punto che nulla si vende, si acquista o si contratta, senza far intervenire la solennità di un giuramento, senza usurpare migliaia di volte il nome santissimo di Dio nelle cose più sciocche e insignificanti? (Usi dunque il Parroco tutta la sua diligenza nell’ammonire spesso i fedeli sulla gravita ripugnante di questa colpa).
• Spiegando questo comandamento, non si dimentichi che la legge implicitamente accoppia alla proibizione l’imposizione di ciò che gli uomini devono fare. Proibizione e imposizione devono essere spiegate però separatamente. In primo luogo, perché più agevole ne sia l’esposizione, si indichi ciò che la Legge comanda, poi quello che proibisce. Comanda che il nome di Dio sia onorato e con esso non si facciano che giuramenti santi; proibisce poi di offenderlo, di invocarlo stoltamente, di giurare con esso alcunché di falso, di vano, di temerario.
• Come si onora il nome di Dio. Spiegando ai fedeli la parte in cui si comanda di tributare onore al nome divino, (il Parroco ricordi che) col nome di Dio non si intendono solamente le lettere, le sillabe, il puro vocabolo; ma si faccia riflettere al suo valore che designa la maestà onnipotente ed eterna del Dio uno e trino. Si capisce quanto stolta fosse la superstizione di alcuni Giudei, i quali scrivevano il nome di Dio, ma non osavano pronunciarlo, quasi che tutto consistesse nelle quattro lettere ebraiche, anziché nella divina realtà. E sebbene sia detto al singolare: Non nominare il nome di Dio, il divieto deve applicarsi non ad un solo nome speciale, ma a tutti quelli che sogliono attribuirsi a Dio. Essi sono parecchi: ad esempio: Signore, Onnipotente, Signore degli eserciti, Re dei re, Forte, e altri simili, contenuti nella Scrittura, i quali tutti esigono uguale venerazione.
• (Il Parroco) insegnerà poi in quale modo debba prestarsi il debito onore al Nome divino, perché il popolo Cristiano, le cui labbra devono sciogliere inni ardenti di lode a Dio, non può ignorare queste cose, utilissime, anzi necessarie alla salvezza. Molteplici sono le forme in cui può esprimersi la lode del Nome divino. Ma in quello che stiamo per dire sembra compresa l’importanza di tutte le altre. Lodiamo innanzitutto il Signore quando, al cospetto di tutti, lo riconosciamo fiduciosi come Dio e Signore nostro, professando insieme e proclamando che Gesù Cristo è l’autore della nostra salvezza. Lo stesso, quando attendiamo amorosamente alla conoscenza della parola, con cui si è espressa la volontà di Dio, meditandola assiduamente, studiandola con cura, leggendo o ascoltando, secondo le capacità e le incombenze di ciascuno di noi. Parimenti veneriamo e celebriamo il nome divino, quando celebriamo, per dovere o per sentimento di pietà, le lodi divine, e a Dio rendiamo grazie per ogni evento, prospero od avverso che sia. Dice il profeta: Benedici, o anima mia, il Signore e non dimenticare le sue elargizioni (Ps. 102,2). Sono parecchi i salmi davidici in cui sono soavissimamente cantate, con senso squisito, le lodi di Dio. Ed è sommamente eloquente il fatto di Giobbe esempio di pazienza, il quale, piombato in disgrazie terribili, non ristette giammai dal lodare Dio con animo invitto. Anche noi dunque, quando siamo afflitti dai dolori dei sensi e dello spirito, o siamo straziati dalla sventura, rivolgiamo le nostre forze alla lode alta di Dio, con la frase di Giobbe: Sia benedetto il nome del Signore (Jb. 1,21). Non si loda meno il Signore, però, invocandone fiduciosamente il soccorso affinché ci liberi dai mali, o almeno ci infonda forza e costanza per tollerarli serenamente. Il Signore stesso vuole che così facciamo: Invocami nel dì della tribolazione; ti libererò e tu mi renderai onore (Ps. 49,15). Implorazioni di questo genere trovano mirabili esempi in copiosi passi biblici e specialmente nei salmi 16, 43 e 118.
• Infine noi onoriamo il nome di Dio quando, a garanzia della parola data, lo invochiamo a testimone. Simile maniera di onorarlo differisce notevolmente dalle precedenti. Quelle che abbiamo enunciato, infatti, sono di loro natura così commendevoli che nulla v’è per gli uomini di più beatificante e di più desiderabile del trascorrere in esse notte e giorno. David esclama: Canterò le lodi del Signore in ogni istante; la sua lode fiorirà incessantemente sulle mie labbra (Ps. 33,2). Invece il giuramento per quanto buono in sé, non può essere lodevolmente usato di frequente. E la ragione della divergenza sta in ciò, che il giuramento fu istituito solo per essere un rimedio alla umana fragilità, quale strumento di prova per quanto asseriamo. Ora, come le medicine corporali vanno usate solo quando è necessario, e l’uso loro frequente rappresenta un pericolo, così il giuramento non può essere benefico, se non in caso di grave e seria opportunità. Se troppo spesso è ripetuto, lungi dal giovare, finisce col recare sensibile danno. Opportunamente insegna san Giovanni Crisostomo che il giuramento entrò nelle consuetudini umane molto tardi, quando nel mondo, non più giovane, ma adulto, il male si era propagato per lungo e per largo; tutto era fuori del proprio ordine; tutto era perturbato e sconvolto in una vasta confusione; e, per disgrazia più grande di ogni altra, gli uomini tutti erano caduti in una ripugnante schiavitù dinanzi agli idoli. Allora, poiché nessuno, in mezzo alla iniqua doppiezza universale, poteva credere alla parola altrui, fu giocoforza invocarvi sopra la testimonianza di Dio.
• Definizione del giuramento. Nell’ambito di questa parte del comandamento, il fine principale è di istruire i fedeli sul modo di usare santamente il giuramento. (Il Parroco quindi insegnerà innanzi tutto che) giurare è chiamare Dio in testimonio, qualunque sia la formula adoperata per farlo. Dire: Dio mi è testimone, o: Per Iddio, è la stessa cosa. Si ha ancora giuramento quando, per ispirare fiducia, giuriamo nel nome di certe cose create, quali, ad esempio, i Vangeli sacri di Dio, la Croce, le reliquie dei Santi, il loro nome e simili. Ma poiché simili cose di suo non sono capaci di conferire autorità e forza a un giuramento - e ciò può farlo solo Dio, la cui divina maestà si riflette in esse - ne segue che chi giura per il Vangelo, giura per Dio stesso, la verità del quale è contenuta e illustrata nei Vangeli. Lo stesso dicasi dei Santi, che furono templi di Dio, credettero nella verità evangelica, la rispettarono con ogni ossequio, la propagarono fra i popoli.
• Il giuramento è pure implicito in alcune formule di esecrazione, come quella adoperata da san Paolo: Invoco Dio a testimone contro l’anima mia (2Cor. 1,23). Chi pronunzia la formula del giuramento in questo modo, si sottopone al giudizio di Dio, vendicatore della menzogna. Non neghiamo che alcune di queste formule possono intendersi prive della forza di un giuramento; sarà utile però applicare anche ad esse le regole e le osservazioni formulate per il giuramento propriamente detto.
• Vi sono due generi di giuramenti: col primo, detto assertorio, affermiamo con forza religiosa una cosa passata o presente. Così dice l’Apostolo nella lettera ai Galati: Dio mi è testimone che io non mentisco (Gal. 1,20). Col secondo, detto promissorio, che comprende anche le minacce e riguarda il futuro, promettiamo e assicuriamo una cosa futura. A questa seconda categoria appartiene, per esempio, la promessa solenne fatta da David alla moglie Betsabea, nel nome di Dio, che suo figlio Salomone sarebbe stato l’erede del trono e gli sarebbe succeduto.
• Condizioni del giuramento legittimo. All’essenza del giuramento basta il chiamare Dio in testimone; ma perché esso sia giusto e santo si richiedono parecchie altre condizioni che devono spiegarsi con cura. Come attesta san Girolamo, le ha brevemente enunciate Geremia, quando scrisse: Giurerai, viva il Signore, con verità, con ponderazione, e con giustizia (Jr. 4,2). Con queste poche parole egli ha riassunto gli elementi del perfetto giuramento: verità, ponderazione del giudizio e giustizia.
• Al primo posto nel giuramento deve stare la verità, in quanto l’asserzione giurata deve essere vera e chi la emette la sappia tale, non per una leggera o temeraria congettura, ma in forza di saldissimi argomenti. Anche il giuramento promissorio esige la verità, dovendo, colui che promette, avere il proposito saldo di mantenere a suo tempo la promessa. L’uomo probo non si disporrà mai a promettere cosa contraria ai santissimi precetti di Dio; e quel che avrà promesso di fare con giuramento, giammai lo muterà, a meno che la situazione di fatto non sia così sostanzialmente cambiata che mantenere la promessa significherebbe incorrere nell’ira di Dio offeso. Anche David mostra quanto la verità sia necessaria nel giuramento, col definire giusto colui che giura in favore del prossimo, e non sa ingannare (Ps. 14,4).
• Segue il giudizio ponderato: non si deve giurare avventatamente, ma a ragion veduta. Chi vuol giurare, rifletta anzitutto se ce n’è la necessità, e consideri la situazione in tutti i suoi aspetti, per accertarsi che veramente esige il giuramento. Tenga conto del tempo, del luogo e di tutte le altre circostanze. Non si faccia trascinare da odio, da amore o da qualsiasi altro perturbamento spirituale, ma solo dalla necessità delle cose. Se simile accurata indagine non sarà stata premessa, il giuramento sarà senza dubbio temerario, com’è quello di coloro che per le cose più futili, senza alcun serio motivo, quasi per una pessima consuetudine contratta, giurano ad ogni istante. Così fanno ogni giorno venditori e compratori; quelli per vendere a più alto prezzo, questi per comprare a più basso: gli uni e gli altri esaltano o deprezzano, giurando, la mercanzia. E poiché i giovanetti mancano, a causa dell’età, di quell’acume che è necessario alla ponderazione richiesta dal giuramento, papa san Cornelio stabilì che non si chieda mai il giuramento a ragazzi di età inferiore ai quattordici anni, epoca della pubertà.
• Infine la giustizia: questa è necessaria soprattutto nei giuramenti promissori; perciò chi promette il disonesto e l’ingiusto pecca giurando, e accumula peccato su peccato, se mantiene la promessa. Abbiamo di ciò un esempio nel Vangelo, dove si narra del re Erode che, vincolato da una perfida promessa, donò in premio alla ballerina la testa di san Giovanni Battista (Mc. 6,23). E può ricordarsi anche il giuramento degli Ebrei, che, secondo il racconto degli Atti degli Apostoli, giurarono di non mangiare finché non avessero ucciso san Paolo (Act. 23,12).
• Chi rispetti tutte queste clausole e circondi il giuramento con queste condizioni, come altrettanti presidi, potrà con tranquilla coscienza giurare, come si può mostrare con molti argomenti. L’immacolata e santa Legge di Dio non comanda forse: Temerai il Signore Dio tuo; a lui solo servirai; nel suo nome giurerai? (Dt. 6,10-13). E David ha lasciato scritto: Saranno lodati tutti coloro che giureranno nel suo nome. Del resto la Scrittura mostra come gli stessi luminari della Chiesa, i santissimi Apostoli, ricorsero al giuramento, come risulta pure dalle lettere di san Paolo. Si aggiunga che gli stessi angeli giurano talora, poiché è detto nell’Apocalisse di san Giovanni evangelista che un Angelo giurò nel nome di Colui che vive nei secoli (10,3). Anzi giura Dio stesso, signore degli Angeli. Leggiamo infatti nel vecchio Testamento che Dio ripetute volte corrobora con giuramento le sue promesse ad Abramo (Gn. 22,16 Ex. 33,1) e a David, il quale esclama a proposito del giuramento di Dio: Ha giurato il Signore, e non se ne pentirà: tu sei sacerdote in eterno, secondo l’ordine di Melchisedec (Ps. 109,4).
• La ragione stessa spiega agevolmente come il giuramento sia lodevole se ne indaghiamo attentamente l’origine e la finalità. Il giuramento infatti nasce dalla fede che gli uomini hanno in Dio, autore di tutta la verità, incapace così di ingannarsi come di ingannare, agli occhi del quale tutto appare senza veli (Hebr. 4,13), che provvede con meravigliosa provvidenza e regge l’universo. Vivendo in tale fede, gli uomini invocano Dio a testimone della verità, perché è cosa empia non credere a Lui. Il giuramento infine tende unicamente a comprovare la giustizia e l’innocenza umana, a chiudere le liti e le controversie, come insegna l’Apostolo nella sua lettera agli Ebrei (Hebr. 6,16).
• A tale dottrina non possono contrapporsi le parole del Salvatore in san Matteo: Udiste che fu detto agli antichi: Non spergiurare; ma adempi i tuoi giuramenti al Signore. Io però vi dico di non giurare in modo alcuno, né per il cielo che è trono di Dio; né per la terra, che è sgabello dei suoi piedi; né per Gerusalemme, che è la città del gran Re. Non giurare per la tua testa, perché non puoi far bianco o nero un solo capello. Ma sia il vostro parlare: Si, si; No, no: il di più viene dal maligno (Mt. 5,33). Non può infatti scorgersi in queste parole una proibizione formale e generale del giuramento, dal momento che abbiamo visto sopra come lo stesso Signore e gli Apostoli hanno giurato più volte. Dobbiamo pensare piuttosto che Gesù Cristo volle biasimare la distorta opinione dei Giudei, che nel giuramento fosse da evitarsi soltanto la menzogna, finendo col giurare e col chiedere l’altrui giuramento ogni momento, per le cose più insignificanti. Il Salvatore deplora questo pessimo costume e impone di astenersi dal giurare, finché non lo richieda una necessità.
• In realtà il giuramento è nato dalla fragilità umana e dal male; esso sta ad indicare l’incostanza di chi giura o la diffidenza di colui per cui giuriamo, deciso a non credere in altra maniera. Però anche il bisogno può essere sufficiente motivo di scusa. La frase del Salvatore: Sia il vostro parlare: Si, si; No, no, mostra senza dubbio che il giuramento è da lui vietato nelle conversazioni familiari, e che non dobbiamo essere inclinati ad emetterlo ogni momento. Intorno a ciò dovranno essere caldamente ammoniti (dal Parroco) i fedeli, poiché, come mostrano le Scritture e gli insegnamenti dei Padri, mali pressoché infiniti sgorgano dalla eccessiva facilità a giurare. È scritto nell’Ecclesiastico: Il tuo labbro non contragga l’abitudine del giurare: essa porta molti al precipizio. E poco dopo: L’uomo che giura molto, si riempirà di cattiveria e i malanni assedieranno la sua casa (33,9-12). Molte belle considerazioni in materia si trovano nelle opere di san Basilio e di sant’Agostino contro la menzogna. Fin qui abbiamo parlato di quel che è comandato; parliamo ora di quel che è vietato dal secondo comandamento.
• Come si pecca contro questo comandamento. Ci viene proibito di invocare invano il nome di Dio. È quindi chiaro che pecca gravemente chi formula giuramenti senza motivo, ma temerariamente. La gravità della colpa traspare dalle stesse parole: Non invocherai invano il nome del tuo Dio, quasi volesse così addurre la ragione per cui simile colpa è tanto grave e riprovevole, in quanto lede la maestà di Colui che noi riconosciamo come nostro Dio e Signore. È così vietato innanzitutto di giurare il falso. Chi non rifugge dal peccato di porre sotto la garanzia di Dio il falso, fa gravissima ingiuria a Dio, attribuendogli o l’ignoranza, per cui suppone che non conosca una determinata verità, o una certa deformità di affetti, per cui lo suppone disposto a corroborare col proprio Nome la menzogna. Né giura falsamente solo colui che con giuramento afferma per vero quanto sa che è falso, ma anche chi giurando sostiene una cosa che, vera in sé, è però da lui reputata falsa. Menzogna infatti è asserzione difforme dall’intimo convincimento; perciò anche costui mentisce ed è spergiuro.
• Parimenti è spergiuro chi afferma con giuramento una cosa che ritiene vera, ed è falsa, sempre nel caso che non abbia adottato tutte le precauzioni per formarsi un concetto chiaro e sicuro della medesima; in tal caso, sebbene fra parola e pensiero vi sia corrispondenza, costui contravviene al precetto. E vi contravviene pure chi promette con giuramento di far qualcosa, e poi, o si propone di non farla, o effettivamente non la fa. Tale valutazione si applica anche a coloro che fecero a Dio un voto e non mantengono.
• Si manca al precetto anche quando manchi la giustizia, uno dei tre coefficienti del giuramento legittimo. Chi giuri di commettere un peccato mortale, un omicidio, ad esempio, pecca contro il comandamento, per quanto parli seriamente e sinceramente, e il suo giuramento abbia quella nota di verità, che già indicammo come indispensabile.
• Vanno segnalati anche quei tipi di giuramento, che nascono da un sentimento di dispregio, come nel caso di chi giuri di non voler obbedire ai consigli evangelici, che esortano al celibato e alla povertà. Sebbene nessuno sia obbligato ad osservarli, chi però giuri con solennità di non volerli seguire, mostra di disprezzare e calpestare i consigli divini.
• Inoltre viola questo precetto e pecca consapevolmente colui che giura il vero, sapendolo tale solo in base a fragili e remote congetture. Infatti, sebbene la verità accompagni simile giuramento, esso in qualche modo implica il falso, in quanto il giurare così negligentemente espone al più grande pericolo di spergiuro. Infine giura abusivamente chi giura per gli dèi falsi e bugiardi. Qual cosa più difforme dalla verità che l’invocare a testimoni divinità menzognere ed illusorie, al posto del vero Dio?
• Vietando lo spergiuro, la Scrittura dice: Non contaminerai il nome del tuo Dio (Lv. 19). è proibita dunque ogni disistima di tutto ciò a cui, in virtù di questo comandamento, dobbiamo ossequio; e fra l’altro, della parola di Dio, veneranda agli occhi non solo delle persone pie, ma anche delle empie, come mostra nel Libro dei Giudici il racconto che riguarda Eglon re dei Moabiti (3,20). Orbene, gravissima ingiuria si arreca alla parola di Dio torcendo la Scrittura dal suo retto significato all’asserzione di dottrine eretiche ed empie. Ci ammonisce in proposito il Principe degli Apostoli: Vi sono nelle Scritture frasi ardue che gli ignoranti e i superficiali fraintendono a loro dannazione (2 Pietr. 3,16). Parimenti la Sacra Scrittura è contaminata quando le sue venerabili sentenze, da uomini sconsigliati, sono tratte a significati profani, sconvenienti, favolosi, sciocchi, magici, calunniosi e simili. Il sacro Concilio Tridentino vuole che si avverta che ciò non si può fare senza peccato.
• Infine, come onorano Dio coloro che ne implorano il soccorso nelle calamità, così gli negano il dovuto onore coloro che non ne invocano l’aiuto. David li redarguisce: Non invocarono il Signore, e tremarono di paura quando non v’era ragione di temere (Ps. 13,5). Ma di ben più detestabile scelleratezza si rendono rei coloro che osano, con labbra vergognosamente impure, bestemmiare e maledire il Nome santo di Dio, che tutte le creature dovrebbero magnificare e benedire; oppure il nome dei Santi che regnano con Dio. Questo peccato è così mostruoso che la Scrittura talora, dovendo parlare della bestemmia, preferisce parlare di benedizione (1R. 21,13).
• Pene per i trasgressori del precetto. Poiché l’orrore per la punizione e il supplizio suole efficacemente comprimere l’inclinazione a peccare, il Parroco che vuole eccitare più vivamente l’animo dei fedeli e stimolarlo al rispetto del comandamento, ne spiegherà convenientemente la seconda parte o appendice: Il Signore non riterrà innocente colui, che abbia invocato vanamente il nome del Signore stesso, suo Dio (Ex. 20,7). Insegni innanzitutto che ragionevolmente sono state unite al precetto le minacce che lumeggiano la gravità della colpa e la misericordia divina verso di noi. Egli non si compiace della dannazione degli uomini e per indurci a evitare la sua ira punitrice, ci atterrisce con salutari minacce, affinché preferiamo sperimentarlo benevolo, anziché irato. Insista dunque il Pastore su questo punto con ogni cura; faccia conoscere al popolo l’orrore della colpa, ne insinui più veemente abominazione, affinché i fedeli siano più diligenti nell’evitarla. Voglia inoltre mostrare come sia sviluppata nell’uomo la tendenza a commetterla, non essendo stato sufficiente promulgare la legge, poiché fu necessario aggiungerle delle minacce. Non si può immaginare quanto tale considerazione sia proficua. Come nulla è più pernicioso della spavalda sicurezza d’animo, così nulla è più giovevole della consapevolezza della propria nullità. Infine, (il Parroco) spieghi come Dio non abbia stabilito alcun determinato supplizio, ma semplicemente dichiarato che chiunque si macchia di questo delitto, non sfuggirà alla vendetta. Per cui devono esserci di monito le nostre pene quotidiane, potendosi plausibilmente congetturare che gli uomini sono colpiti da sventure perché non obbediscono a questo precetto. Ed è probabile che riflettendo a ciò, se ne guarderanno più premurosamente per l’avvenire. In conclusione, ripieni di santo timore, i fedeli fuggano con ogni studio questo peccato. Se nel dì del giudizio ci sarà chiesto conto di ogni parola oziosa (Mt. 12,36), che cosa dire dei peccati più gravi, che implicano una diretta offesa al nome divino?
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Titolo originale: Imitare il Santo e resistere alle passioni neopagane, dal Roma del 29 maggio 2017. I Santi sono «coloro che, praticando eroicamente le virtù secondo gl’insegnamenti e gli esempi di Gesù Cristo, meritarono special gloria in cielo ed anche in terra, dove, per autorità della Chiesa, sono pubblicamente onorati ed invocati» (Catechismo, n° 175).
Dichiara difatti il Card. Prospero Lambertini (poi Papa Benedetto XIV): «Infine, per porre fine ad una così grande disputa, diremo che chi osa affermare che il Pontefice erri in questa o quella canonizzazione, è difensore di una proposizione erronea e meritevole di pene gravissime, provoca scandalo a tutta la Chiesa, è offensivo verso i Santi, favorisce gli eretici che negano l’autorità della Chiesa nella canonizzazione dei Santi, sa di eresia, in modo tale da spianare la via agl’infedeli nell’irridere i Fedeli. (…) Allo stesso modo (è reo) chi fornisce il proprio assenso a chi insegna che non sia di fede che il Papa sia infallibile nella canonizzazione dei Santi, né sia di fede che questo o quel canonizzato sia Santo» (* Opus de servorum Dei beatificatione … t. I, Neapoli, 1773, pag. CXIV).
Noi veneriamo i Santi «come amici di Dio e per i doni che hanno da Lui» (Catechismo, n° 174). Sempre nel De servorum Dei beatificatione … (Bononiae, 1737, pag. 297) si legge: «Dio è lodato nei Suoi Santi, e mentre onoriamo i servi, l’onore si riversa nel Signore (…). Infatti nessun cristiano dubita (chi ne dubita quindi non è vero cristiano …), e questo è attestato nella Sacra Scrittura, che il Signore è lodato nei Suoi Santi, e chi onora loro, onora direttamente il Signore, come attesta Egli stesso dicendo: Chi onora voi, onora me, e chi accoglie voi, accoglie me; ed ancora: Ciò che avete fatto ad ognuno dei miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me».
Venerare significa «riconoscere ed onorare la dignità, la potenza e la superiorità di qualcuno, ma non comporta che gli si riconosca dominio e potestà suprema ed assoluta su tutte le creature» (Comm. al Catech., P. Dragone, pag. 219).
I Santi furono servi fedeli di Dio nel tempo della prova ed ora sono i Suoi amici prediletti e colmati di onori da Lui. Quando onoriamo gli Angeli ed i Santi, soprattutto Maria Santissima, l’onore diretto a loro sale fino a Dio e Lo glorifica come datore di ogni bene. Spiega ancora il Dragone: «Sono detti Santi coloro che in vita hanno praticato la virtù cristiana in grado eroico, e dopo la loro morte sono stati onorati dalla Chiesa con il titolo di Santi. Ciò che dà diritto al titolo di Santo è l’aver praticato la virtù in grado eroico. Eroismo si richiede per confessare la vera fede nei tempi di persecuzione; eroismo esige il perdono dei nemici che ti calunniano, ti spogliano dei tuoi beni, ti calpestano» (pag. 221). I Santi sulla terra «condividono l’ignominia di Cristo e, come Lui, sono perseguitati, oppressi, calunniati, crocifissi, trattati come la spazzatura del mondo. Dio, dopo la loro morte, li glorifica con Cristo, e quando li vuole onorati anche sulla terra con un culto speciale, manifesta la Sua volontà concedendo loro uno speciale potere d’intercessione, che si esplica con grazie e miracoli in favore della Chiesa militante. La Chiesa, infallibile interprete della divina volontà, eleva queste anime eroiche agli onori degli altari, conferendo loro il titolo di Beati e di Santi, proponendoli al culto, all’ammirazione, all’imitazione dei fedeli, ed indicandoli come potenti intercessori in nostro favore davanti al trono di Dio».
San Pio X insegna ancora che «noi veneriamo anche il corpo dei Santi, perchè servì loro ad esercitare le virtù eroiche, fu certamente tempio dello Spirito Santo, e risorgerà glorioso alla vita eterna (n° 176). Le reliquie e le immagini non sono venerate in se stesse, ma in quanto furono del Santo, e perchè lo rappresentano. Tutta la venerazione tributata alla reliquia ed all’immagine è diretta al Santo stesso» (Catechismo, n° 177).
Venerare un Santo significa lodare Dio. Per onorare degnamente un Santo bisogna imitarlo: è necessario rispettare rigorosamente i Comandamenti di Dio, i Precetti della Chiesa, i doveri del proprio stato, praticare integralmente le virtù cristiane contro ogni vanagloria, ostentazione, passione disordinata e neopaganesimo.
Carlo Di Pietro dal Roma
(*) «... ut tantae questioni finem denique imponamus, si non haereticum, temerarium tamen, scandalum toti Ecclesiae afferentem, in Sanctos injuriosum, faventem haereticis negantibus auctoritatem Ecclesiae in Canonizatione Sanctorum, sapientem haeresim, utpote viam sternentem Infidelibus ad irridendum Fideles, assertorem erroneae propositionis, et gravissimis poenis obnoxium dicemus eum, qui auderet asserere, Pontificem in hac aut illa Canonizatione errasse, huncque aut illum Sanctum ab eo canonizatum non esse Cultu Duliae colendum; quemadmodum assentiuntur etiam illi, qui docet de Fide non esse, Papam esse infallibilem in Canonizatione Sanctorum, nec de fide esse, hunc aut illum Canonizatum esse Sanctum» (Trad. it. di M. Martone - anticipazione tratta da un libro in uscita - Il De servorum Dei beatificatione … è stato paragonato da Papa Pio XII alla Somma Th. di san Tommaso d'Aquino: «Come questa presenta il compendio che la sacra dottrina fu dal principio ed in ogni tempo, così l’opera del Lambertini offre una compiuta visione della tradizione ecclesiastica in materia di culto e di canonizzazione dei santi, dei criteri e delle modalità accolte come norme, fin da principio e nelle epoche successive, nel considerare e nel proclamare alcuno come santo»).
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, studiamo il primo dei comandamenti: «Non avrai altro Dio fuori di me», usando il semplice Catechismo del Santo Concilio di Trento. Duplice valore del precetto. Il primo posto nel Decalogo spetta ai comandamenti che riguardano Dio; il secondo, a quelli che riguardano il prossimo; perché quanto facciamo al prossimo ha la sua ragione in Dio. Amiamo infatti il prossimo secondo lo spirito del comando divino, quando lo amiamo per amore di Dio. E tali precetti riguardanti Iddio sono formulati nella prima tavola. Nella formula surriferita è racchiuso un duplice comando: il primo positivo, l’altro negativo, poiché il comando: Non avrai altro Dio fuori che me, contiene anche l’aggiunta: rispetterai me come vero Dio, né presterai ossequio ad altri dèi.
• Nella prima parte, a loro volta, sono impliciti i precetti della fede, della speranza, e della carità. Dicendo che Dio è immobile, immutabile, lo riconosciamo, a buon diritto, sempre uguale a se stesso e verace: dunque è necessario che, aderendo ai Suoi oracoli, prestiamo pieno assenso alla Sua autorità. Considerando poi la Sua onnipotenza, la Sua clemenza, la Sua facilità a beneficare, come potremmo non riporre in Lui tutte le nostre speranze? E, contemplando le ricchezze della Sua bontà e del Suo amore riversate su di noi, potremmo non amarLo? Di qui il preambolo e la conclusione che, nel formulare comandi, Dio usa costantemente nella Scrittura: Io, il Signore.
• Ecco, poi, la seconda parte del comandamento: Non avrai altro Dio fuori che me. Il Legislatore ha usato tale formula non perché tale verità non fosse sufficientemente chiara nel precetto positivo: Onorerai me come solo Dio; poiché se è Dio, è unico; ma per la cecità dei moltissimi, che un tempo, pur credendo di venerare il vero Dio, prestavano culto a una moltitudine di dèi. Di tali ve ne furono molti pure tra gli Ebrei che, secondo il rimprovero di Elia, zoppicavano da due lati. Tali furono pure i Samaritani che onoravano contemporaneamente il Dio d’Israele e le divinità dei Pagani.
• Fra tutti i comandamenti, il primo è il più importante; non già per ordine di sola precedenza, ma per i suoi motivi, per la sua dignità, e la sua eccellenza. Dio infatti deve riscuotere da noi un affetto e un ossequio infinitamente maggiori di quelli a cui possano aver diritto re e padroni. Egli ci ha creati, ci governa, ci ha nutriti fin da quando eravamo nel seno di nostra madre, ci ha tratto alla luce; Egli ci fornisce il necessario alla vita e all’alimentazione.
• Mancano a codesto comandamento coloro che non hanno fede, speranza e carità; e sono tanti! Infatti rientrano in questa categoria gli eretici, gli increduli circa le verità proposte dalla Chiesa, nostra santa madre; coloro che prestano fede ai sogni, ai presagi e a tutte le altre vane fantasie; quelli che perdono la speranza della propria salvezza, cessando di confidare nella divina bontà; coloro, infine, che contano unicamente sulle ricchezze, sulla salute e sulle forze del corpo. Questa materia è più largamente spiegata da coloro che hanno scritto intorno ai vizi e ai peccati.
• Legittimità del culto dei Santi. La venerazione e la invocazione dei santi angeli e delle anime beate ammesse al godimento della gloria celeste, oppure il culto dei corpi e delle ceneri dei santi, sempre ammesso dalla Chiesa cattolica, non trasgredisce il primo comandamento. Sarebbe folle il supporre che, vietando il re a chiunque altro di prendere il proprio posto e di esigere onore e rispetto reali, per questo imponga di non tributare ossequio ai suoi magistrati. Si dice, è vero, che i cristiani adorano gli angeli, seguendo le orme dei santi dell’antico Testamento; ma non tributano loro la medesima venerazione attribuita a Dio. Che se leggiamo di angeli che talvolta hanno rifiutato la venerazione umana, si deve intendere che non vollero si mostrasse loro quell’ossequio che è dovuto unicamente a Dio (Ap. 19,10; Ap. 22,9). Il medesimo Spirito Santo il quale proclama: A Dio solo onore e gloria (1Tm. 1,17), comanda di circondare di onore i genitori e gli anziani (Ex. 20,12; Dt. 5,16; Lv. 19,32).
• Del resto, uomini santi che rispettavano l’unico vero Dio, adoravano, secondo la testimonianza biblica, i sovrani, vale a dire s’inchinavano supplichevoli dinanzi a loro (1 Re 24,9). Ora, se sono così onorati i re, per mezzo dei quali Dio governa il mondo, agli spiriti angelici, della cui opera Dio si serve per reggere non solo la sua Chiesa ma tutto l’universo, e che ci aiutano a liberarci ogni giorno dai più grandi pericoli dell’anima e del corpo, anche se non si mostrano visibili a noi, non renderemo un onore tanto più grande quanto più alta è la dignità di quelle intelligenze beate di fronte alla maestà dei regnanti?
• Si tenga conto, inoltre, dell’intensa carità con cui essi ci amano. Ispirati da questa effondono preghiere, secondo la chiara testimonianza della Scrittura (Dan. 10,13), per le regioni cui sono preposti, ed assistono senza dubbio coloro dei quali sono custodi, offrendo le nostre preci e le nostre lacrime a Dio. Non disse forse il Signore nel Vangelo: Guai a coloro che scandalizzano i bambini, perché gli angeli vedono sempre il volto del Padre che è nei cieli? (Mt. 18,6). Essi dunque si devono invocare, poiché sono continuamente al cospetto di Dio, ed assumono ben volentieri il patrocinio della nostra salvezza loro affidato.
• Di invocazioni agli angeli esistono nella santa Scrittura esempi significativi. Giacobbe chiede all’angelo, col quale aveva lottato, che lo benedica; lo costringe anzi a farlo, dichiarando che non lo lascerà libero, se non dopo averne ricevuta la benedizione (Gn. 32,24). Né la vuole soltanto da colui che scorgeva, ma anche da quegli che non vedeva, quando dice: L’angelo che mi trasse da tutti i mali, benedica questi figliuoli (Gn. 48,16). Perciò è lecito anche dedurre che, lungi dal diminuire la gloria di Dio, l’onore tributato ai santi che si sono addormentati nel Signore, le invocazioni ad essi rivolte, la venerazione portata alle loro reliquie e alle loro ceneri, aumentano tanto più questa gloria, quanto meglio stimolano la speranza degli uomini, la rassodano spingendoli all’imitazione dei santi. Lo comprovano il secondo concilio Niceno, quelli di Gangra e di Trento, e infine l’autorità dei santi Padri. Per meglio riuscire alla confutazione di chi impugna questa verità, (... si) legga lo scritto di san Girolamo contro Vigilanzio, e specialmente il Damasceno.
• Quanto abbiamo detto è soprattutto confermato dalla consuetudine trasmessa dagli Apostoli, costantemente ritenuta nella Chiesa di Dio, e appoggiata alle testimonianze della Scrittura che celebra mirabilmente le lodi dei santi. Non si potrebbe desiderare nulla di più chiaro e di più solido. Di alcuni santi gli oracoli divini hanno tessuto l’elogio. Come gli uomini potrebbero rifiutare loro un onore particolare? (Eccli. 44). Si rifletta che occorre invocarli ed onorarli, anche perché essi offrono perennemente preci per la salvezza degli uomini; e molti benefici elargiti da Dio sono dovuti al loro merito e al loro favore. Se infatti si fa gran festa in cielo per un peccatore pentito (Lc. 15,7), non si adopreranno i cittadini del cielo per aiutare i penitenti? E, se sono invocati e implorati, potranno non impetrare il perdono dei peccati, propiziandoci la grazia di Dio? Che se alcuni obietteranno essere superfluo il patrocinio dei santi perché è Dio che sovviene alle nostre preghiere senza bisogno d’interpreti, si risponderà a queste empie voci con le parole di sant’Agostino: Dio spesso non concede se non in seguito all’intervento efficace del mediatore che scongiura (Sull’Ex. q. CXLIX). Il che è confermato dagli esempi eloquenti di Abimelech e degli amici di Giobbe ai quali Dio perdonò le colpe per le preghiere di Abramo e di Giobbe (Gn. 20; Gb. 42). E se qualcuno osserverà che il ricorso ai santi, quali intermediari e patroni, è dovuto alla povertà e debolezza della propria fede, gli si replicherà con l’esempio del Centurione. Questi, pur essendo ricco di una fede la quale meritò la più alta lode da nostro Signore, tuttavia inviò a lui gli anziani dei Giudei perché volessero impetrare la guarigione al suo servo malato (Mt. 8,10; Lc. 7,9).
• Senza dubbio confessiamo che uno solo è il nostro mediatore, Gesù Cristo, il quale ci riconciliò col Padre celeste col Suo sangue (Rm. 5,10), e, garantita l’eterna redenzione, una volta entrato nel Santuario, non cessa un istante di intercedere per noi (He. 9,12). Ma da ciò non segue affatto che non sia lecito fare appello al favore dei santi. Se in realtà non fosse consentito di invocare il soccorso dei santi perché abbiamo un solo patrono, Gesù Cristo, l’Apostolo non avrebbe davvero insistito nel volere che le preghiere dei fratelli viventi lo soccorressero presso il Signore (Rm. 15,30). Dunque non solo la preghiera dei santi che sono in cielo, ma neppure quella dei giusti viventi, possono attenuare la gloria e la maestà del Cristo mediatore. E chi non scorgerà prove luminose dell’obbligo di onorare i santi, e del patrocinio che essi assumono di noi, nei prodigiosi fatti che si compiono presso i loro sepolcri, con la restituzione di occhi, mani, membra di ogni genere a chi ne mancava, con la resurrezione di morti tornati in vita, col fatto di demoni cacciati dai corpi umani? Molti riferirono di averne udito il racconto; moltissimi, individui serissimi, di aver letto; né mancano testimoni ineccepibili, quali sant’Ambrogio e sant’Agostino, che attestarono nelle loro lettere di aver visto. Che più? Se le vesti, i panni, e la stessa ombra dei santi ancora in vita scacciarono le malattie e ridonarono le forze, chi oserà porre in dubbio che Dio possa effettuare i medesimi portenti per mezzo delle ceneri, delle ossa e delle altre reliquie dei santi? Si ricordi quel cadavere che, portato per caso nel sepolcro di Eliseo, immediatamente rivisse a contatto del suo corpo (IV Re 13,21).
• Norme sulla illiceità delle immagini. Seguono le parole: Non ti farai opere di scultura a immagine di cose esistenti nell’aria, sulla terra o nelle acque; non le adorerai, non presterai loro culto. Alcuni, ritenendo che fosse qui enunciato un secondo precetto, pensarono che i due ultimi precetti del decalogo ne formassero invece uno solo. Ma sant’Agostino, considerando quei due ultimi come distinti, afferma che le parole in questione appartengono al primo precetto (Sull’Ex q. LXXI); e noi adottiamo volentieri simile sentenza, che è comunissima nella Chiesa. Ma c’è di rincalzo l’ottima ragione che, nel testo biblico (Es. 20,5s.), premio e castigo per il precetto sono enunciati al termine di questa pericope in maniera unitaria come per ciascun precetto. Né si creda che con tale precetto sia del tutto vietata l’arte di dipingere, di rappresentare, di scolpire. Leggiamo infatti nelle Scritture che, per comando divino, furono fatti simulacri e immagini di Cherubini (Ex. 25,18 III Re 6,23) e del serpente di bronzo (Num. 21,8). Dobbiamo perciò interpretare la proibizione nel senso che, prestando ai simulacri un culto come a delle divinità, si viene a togliere qualcosa al vero culto di Dio. Ed è chiaro che, nell’ambito di questo comandamento, in due modi possiamo gravemente ledere la divina maestà. In primo luogo, venerando come divinità idoli e simulacri, o ritenendo che dimori in essi qualche virtù divina, per cui si debba prestare loro venerazione, si possa chiedere loro qualcosa, e riporre in essi quella fiducia che vi riponevano una volta i pagani, rimproverati spesso dalla Scrittura di collocare la loro speranza negli idoli. In secondo luogo, tentando di raffigurare con i mezzi dell’arte la forma della divinità, quasi che questa possa scorgersi con gli occhi corporei, o esprimersi con colori e figure. Esclama il Damasceno: Chi potrà esprimere un Dio che non cade sotto la presa dei sensi, non ha corpo, non può essere circoscritto in alcun termine, né descritto da alcuna rappresentazione? (La fede ort. 4,16).
• Più ampiamente spiega la cosa il secondo concilio Niceno (Atti 3 e 4). Luminosamente l’Apostolo disse dei pagani che avevano deformato la gloria di Dio incorruttibile, riducendola alle immagini dell’uomo corruttibile, degli uccelli, dei quadrupedi, dei serpenti (Rm. 1,23), venerando come divinità simulacri di questa foggia. Anche gli Israeliti, che dinanzi al simulacro del vitello gridavano: Ecco, o Israele, i tuoi dèi che ti trassero fuori dalla terra di Egitto (Ex. 32,4), furono chiamati idolatri, avendo ridotto la gloria divina alle proporzioni di una bestia erbivora (Salm. 105,20). Avendo quindi il Signore rigorosamente vietato di prestare culto a divinità straniere per sopprimere ogni infiltrazione idolatrica, proibì pure di trarre dal bronzo o da qualsiasi altra materia rappresentazioni della divinità. Illustrando il divieto, Isaia esclama: A quale cosa avete voi rassomigliato Dio? quale immagine farete di lui? (Is. 40,18). Che tale sentenza sia racchiusa in questo precetto risulta, oltre che dagli scritti dei santi Padri che, secondo l’esposizione del settimo Concilio (Atti 2 e 4), l’interpretano a questa maniera, anche dalle parole abbastanza esplicite del Deuteronomio, dove Mosè, volendo allontanare il popolo dall’idolatria, dice: Non vedeste nessuna immagine il giorno in cui il Signore, sull’Oreb, vi parlò di mezzo al fuoco (Dt. 4,15). Così si esprimeva il sapientissimo legislatore, affinché, cadendo in errore, non si foggiassero un simulacro della divinità, e finissero col tributare a una cosa creata l’onore dovuto a Dio.
• Utilità del culto delle immagini. Non si creda tuttavia che sia un mancare alla religione e un trasgredire la legge di Dio, l’esprimere con figure sensibili, adoperate così nel vecchio come nel nuovo Testamento, qualche Persona della santissima Trinità. Non v’è infatti individuo così grossolano il quale possa ritenere espressa da quella figura la divinità. Ad ogni modo (... si) spieghi come, mediante quelle figure, siano significate proprietà o azioni attribuite a Dio. Così, quando, sulle indicazioni di Daniele (Dan. 7,9), si rappresenta l’Antico dei giorni seduto sul trono, con i libri aperti dinanzi, si vuole significare l’eternità e l’infinita sapienza di Dio, in virtù delle quali Egli scorge tutti i pensieri e le azioni degli uomini per giudicarli.
• Gli angeli, poi, vengono raffigurati in forme umane e con le ali perché i fedeli comprendano quanto essi siano ben disposti verso il genere umano e come siano pronti ad eseguire le incombenze volute dal Signore. Sono infatti spiriti al servizio di coloro che bramano l’eredità della salvezza (He. 1,14). Il simbolo della colomba e le lingue di fuoco menzionati nel Vangelo (Mt. 3,16; Mc. 1,10; Lc. 3,22; Jn. 1,32) e negli Atti degli apostoli (2,3), quali proprietà esprimano dello Spirito santo è troppo noto perché occorra darne ampia spiegazione.
• Siccome, poi, nostro Signore Gesù Cristo, la Sua santa e purissima Genitrice e tutti i santi dotati di natura umana, ebbero naturalmente figura umana, non solo non è vietato dal presente precetto dipingerne ed onorarne le immagini, ma è stato sempre considerato come atto che manifesta, in modo sicuro, animo grato e devoto. Lo confermano i monumenti dell’età apostolica, i Concilii ecumenici, innumerevoli scritti di Padri dottissimi e religiosissimi, tutti concordi fra loro. Non solo è lecito tenere immagini nelle chiese, onorarle e prestar loro culto, purché la venerazione prestata s’intenda diretta ai loro prototipi, ma (... si) mostrerà anche come ciò sia stato fatto sempre fino ad oggi, con grandissimo vantaggio dei fedeli, come si vede fra l’altro dal libro del Damasceno sulle immagini, e dal settimo concilio che è il secondo Niceno.
• Ma l’avversario del genere umano si sforza sempre con le sue frodi e sofismi di pervertire le istituzioni più sante. Per questo il Parroco, nel caso che il popolo sgarri, cercherà di fare quanto è in lui per correggere gli abusi, secondo il decreto del concilio Tridentino, e, senz’altro, all’occasione ne commenterà il testo stesso. Il Parroco mostri agl’incolti e a coloro che ignorano l’uso stesso delle immagini, che queste mirano a far conoscere la storia dei due Testamenti e ad alimentarne la memoria. Cosicché, stimolati dal ricordo delle divine gesta, siamo sempre più tratti a venerare ed amare Dio. Le immagini dei santi sono poste nei templi affinché essi siano onorati, e noi, sulle loro orme, ne riproduciamo la vita ed i santi costumi.
• Pene contro i trasgressori del primo comandamento. Io sono il Signore Dio tuo, forte, geloso, che faccio ricadere la iniquità dei padri nei figli, fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano; e, nel medesimo tempo, misericordioso abbondantemente verso coloro che mi amano e osservano i miei comandamenti (Ex. 20,5s). Due cose vanno spiegate a proposito di quest’ultima parte del precetto. Innanzi tutto che, sebbene a causa della maggiore gravità della trasgressione del primo precetto e dell’inclinazione degli uomini a commetterla, la pena sia opportunamente qui menzionata, in realtà si tratta di un’appendice comune a tutti i precetti. Ogni legge infatti spinge gli uomini al rispetto delle prescrizioni col premio e con la pena. Per questo frequenti promesse divine sono disseminate nella sacra Scrittura. Tralasciando quelle pressoché innumerevoli contenute nel vecchio Testamento, ricordiamo le parole del Vangelo: Se vuoi entrare nella vita, rispetta i comandamenti (Mt. 19,17); ed altrove: Solo chi adempie il volere del Padre mio che è nei cieli entrerà nel regno celeste (Mt. 7,21). In un altro luogo: Ogni albero che non fa buon frutto, sarà tagliato e gettato nel fuoco (Mt. 3,10). Altrove: Chiunque si adira contro il suo fratello, sarà condannato in giudizio (Mt. 5,22). Infine: Se non perdonate agli uomini, nemmeno il Padre vostro perdonerà a voi le vostre mancanze (Mt. 6,15), etc... In secondo luogo, si ricordi che questa appendice deve essere spiegata (dai Parroci, ndR) in maniera molto diversa agli individui perfetti e a quelli carnali. Ai primi infatti, che operano sotto la guida di Dio (Rm. 8,14) e a lui obbediscono con animo alacre e docile, esso parla quale annuncio di letizia e quale prova luminosa del volere divino, ben disposto verso di loro. Essi riconoscono così la premura di Dio, amantissimo di loro, il quale, ora con i premi, ora con le pene, quasi costringe gli uomini al proprio culto e alla religione. Ne scorgono così l’infinita bontà, e vedono che cosa comandi loro, e come voglia far convergere la loro opera verso la gloria del nome divino. Né solo riconoscono tutto ciò, ma nutrono speranza che Dio, come comanda ciò che vuole, cosi darà le forze necessarie per obbedire alla Sua legge. Per gli individui carnali, invece, non ancora affrancati dallo spirito del servaggio, e che si tengono lontani dal peccato più per timore delle pene che per amore della virtù, quell’appendice ha sapore di forte agrume. Perciò dovranno essere incoraggiati con esortazioni pie e quasi condotti per mano là dove vuole la Legge. Ogni volta che venga l’occasione di spiegare uno qualsiasi dei comandamenti, il Parroco tenga presenti queste considerazioni.
• Due stimoli. Mirando agli uomini carnali come agli spirituali, egli (il Parroco, ndR) adotterà i due pungoli o stimoli, contenuti nell’appendice del precetto, capaci di eccitare efficacemente gli uomini al rispetto della Legge. In primo luogo, si spieghi l’inciso, in cui è detto che Dio è forte, con tanta maggiore diligenza, in quanto spesso la carne, meno colpita dai terrori delle divine minacce, va mendicando tutti i pretesti per sfuggire all’ira di Dio e alla pena stabilita. Chi però tiene per fermo che Dio è forte, ricorda piuttosto il motto del grande David: Dove mi rifugerò lungi dal tuo spirito? dove, lungi dal tuo volto? La stessa carne, diffidente talora delle divine promesse, si raffigura così forti i nemici da reputarsi incapace di resistenza. Invece la fede salda e sicura, nulla temendo, poggiata com’è sulla forza e la virtù divina, conforta e rafforza gli uomini, esclamando: Il Signore è la mia luce e la mia salvezza; di chi avrò paura? L’altro stimolo è rappresentato dalla stessa gelosia divina. Infatti gli uomini pensano talora che Dio non curi le cose umane, e non si preoccupi neppure del nostro ossequio, o della nostra disobbedienza alla Legge. Ne segue un grande disordine nella vita. Ma se noi ricordiamo che Dio si preoccupa di tutto, saremo più attenti al nostro compito. Naturalmente quella specie di gelosia che attribuiamo a Dio, non implica un turbamento dell’animo, ma solo quel divino amore e quell’alta carità, per cui Dio non tollera che un’anima si allontani impunemente da Lui - Ecco, perirà chi da te si allontana, tu distruggi chiunque ti è infedele - e irrimediabilmente punisce quanti se ne allontanano. La gelosia è dunque in Dio quella Sua serenissima e sincera giustizia, per la quale l’anima, corrotta dalle false opinioni e dalle perverse cupidigie, è ripudiata, e, quasi adultera, allontanata dal connubio divino. Tale gelosia divina la sperimentiamo invece come un sentimento soavissimo e dolcissimo, quando l’alta e ineffabile volontà di Dio verso di noi si manifesta da questo stesso zelo per noi. Non v’è fra gli uomini amore più appassionato, unione più intima di quella che vien data dal vincolo coniugale. Orbene, Dio mostra di quale amore ci prediliga, quando, paragonandosi spesso allo sposo e al marito, si dichiara geloso. Il Parroco si fermi perciò a dimostrare come gli uomini debbano essere tanto preoccupati del culto e dell’onore divino, da essere detti anch’essi a buon diritto piuttosto gelosi che amanti, sull’esempio di colui, il quale ha detto di sé: Mi sono mostrato geloso dell’onore del Signore Iddio degli eserciti. Imitino Cristo stesso che disse: Lo zelo per la tua casa mi divora (Jn. 2,17). Deve essere poi spiegata la sentenza di minaccia. Dio non tollera che i peccatori rimangano impuniti, ma li castigherà, come un padre fa con i figli, o li punirà duramente come un giudice severo. Volendo significare ciò, Mosè ha detto: Constaterai che il Signore Iddio tuo è Dio forte e fedele: egli rispetta il patto e usa misericordia a chi lo ama; rispetta i suoi precetti fino alla millesima generazione; ma anche ripaga senza indugio chi lo odia (Dt. 7,9). E Giosuè: Non potrete servire il Signore, poiché Dio è santo e forte nel suo zelo; non perdonerà ai vostri scellerati peccati. Se abbandonerete il Signore e servirete a divinità straniere, Egli si rivolgerà contro di voi, tormentandovi e determinando la vostra rovina (Gios. 24,19). Il Parroco ricordi al popolo che la maledizione divina si propaga fino alla terza e alla quarta generazione degli empi. Non già nel senso che i posteri debbano sempre necessariamente portare la pena delle colpe degli avi, ma nel senso che, se questi e i loro figli non hanno espiato, non tutta la loro posterità riuscirà a evitare l’ira e la pena divina. Va ricordato in proposito l’esempio del re Giosia. Dio gli perdonò per la sua singolare pietà, e gli concesse di scendere in pace nel sepolcro dei padri per non assistere alle sciagure dei tempi imminenti, determinate su Giuda e su Gerusalemme dall’empietà di Manasse suo avo. Ma, dopo la sua morte, la vendetta di Dio raggiunse i suoi posteri, non risparmiando neppure i figli di Giosia (2R. 32,2-19; 2R. 33,25-29).
• In che modo poi queste parole della legge si possano conciliare con la sentenza del Profeta: L’anima che avrà peccato, perirà (Ez. 8,4), lo mostra chiaramente l’autorità di san Gregorio, concorde in questo con tutti gli antichi Padri, dicendo: Chiunque imita l’iniquità di un malvagio genitore, è vincolato pure dalla colpa di lui; ma chi non ne imita la malvagità, non porta il suo carico morale; per questo il figlio cattivo di un cattivo padre non sconta solamente le colpe proprie, ma anche quelle di suo padre, non avendo temuto di accoppiare alla perversione paterna, contro cui sa irato il Signore, anche la propria malvagità. È giusto del resto che colui il quale, sotto lo sguardo di un giudice severo, non ha ritegno di battere le vie di un genitore malvagio, sia tenuto nella vita presente a scontare pure le colpe dell’iniquo suo padre. Ricorderà però il Parroco che la bontà e la misericordia di Dio superano la Sua giustizia: rivela la Sua ira infatti fino alla terza e alla quarta generazione, ma riversa la Sua misericordia fino alla millesima. L’inciso poi: «Di coloro che mi odiano», vuole rilevare la gravità del peccato. Che cosa di più orribile e di più nefasto che odiare la Bontà per essenza e la Verità somma? Ciò vale per tutti i peccatori; perché, come chi rispetta i precetti di Dio, ama Dio (Jn. 14,21); così chi disprezza la legge di Dio e non rispetta i suoi comandamenti, giustamente può dirsi che lo odia. Infine la frase ultima: «A coloro che mi amano», insegna il modo e il motivo del rispetto della Legge. Infatti è necessario che coloro i quali osservano la Legge di Dio siano indotti a obbedirgli dal medesimo amore che li spinge verso di Lui: cosa che vedremo anche nella trattazione dei singoli comandamenti.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, Cornelio ALapide nei suoi Tesori definisce, con san Bernardo, la vanagloria «male sottile, segreto veleno, peste occulta, artefice d’inganni, madre dell’ipocrisia, dell’invidia, sorgente dei vizi, fomite di delitti, ruggine delle virtù, verme roditore della santità, accecamento dei cuori, che cambia i rimedi in malattie e fa della medicina una causa di languore».
Il Crisostomo la chiama «madre dell’inferno». San Basilio dice che la vanagloria è «cortese predone delle ricchezze spirituali, gaio nemico delle anime nostre, tarlo delle virtù, ladro gentile di tutti i nostri beni». Come un tesoro messo in pubblico e lasciato senza guardia, viene presto rubato, così ogni virtù che ama essere conosciuta ed encomiata si risolve ben presto in fumo. Come la cera si scioglie vicino al fuoco, così l’anima dinanzi al fuoco della vanagloria, perde tutto il pregio di ogni sua virtù.
Sant’Agostino così parlava di Dio: «O Signore, colui che attribuisce a sé la gloria del vostro bene ed a voi non la tributa, è ladro e predone; simile al diavolo che tentò rapire a Voi la gloria vostra». Dice il Signore: «Seminano vento e raccolgono tempesta» quelli che fanno qualche buona opera per averne lode, poiché la vanagloria è tempesta che tormenta con mille cure e pensieri e inquietudini e affanni e dolori.
Coloro che agiscono per vanagloria, gettano le opere loro in un sacco senza fondo, o, come dice san Gerolamo, «seminano cose vane, e non raccolgono che frutti vani e vuoti». Infelice chi cerca di essere lodato di una buona azione! Egli ne perde il merito, e sarà punito della colpa che commette invanendosi dell’azione compiuta (cf. San Matteo, VI, 1).
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, in questi giorni ricorre il centenario delle apparizioni della Vergine Maria a Fatima, in Portogallo. Cerchiamo di capire cosa sia una vera apparizione e come deve comportarsi il buon cattolico davanti a tali episodi straordinari. L’apparizione - insegna l’Enciclopedia Cattolica, Vol. I, colonna 1700 seg., Imprimatur 1948 - è una manifestazione soprannaturale e sensibile per la quale un oggetto spirituale o corporale si rende presente ai sensi esterni od interni. L’apparizione è correlativa alla visione (che in seguito studieremo), e spesso le due voci vengono usate promiscuamente. Sant’Agostino (Contra Adimantum, cap. ultimo: PL 42, 171; De Genesi ad Litteram, XII, 6 seg.: PL 34, 458 seg.) distingue le visioni in corporali, immaginative ed intellettuali: solo alle visioni delle due prime categorie corrisponde propriamente l’apparizione.
Fenomeno d’ordine sensibile, l’apparizione è prevalentemente una manifestazione d’ordine visivo. Anche il tatto è interessato nell’apparizione, in quanto serve a controllare ed a rafforzare l’oggettività delle manifestazioni riferite dalla vista. E poiché la vista ed il tatto sono i due sensi che più direttamente riferiscono la realtà oggettiva, nell’apparizione si produce ciò che i moderni chiamano «sentimento della presenza». Chi ha una apparizione, cioè, è convinto di essere in contatto immediato con l’oggetto che gli si è manifestato, e non già di subirne un influsso più o meno lontano o di trovarsi solo dinanzi ad una immagine, ad una riproduzione di esso. A quanto è riferito dai grandi mistici che ne hanno fatto esperienza, ad esempio da santa Teresa (Vita, 28), questo sentimento di presenza è proprio anche delle apparizioni immaginative e ne costituisce appunto la differenza nei confronti delle pure rappresentazioni della fantasia. Per la diversa autorità dalla quale sono attestate e, quindi, per la diversa fede che meritano, le apparizioni si distinguono in bibliche ed extra-bibliche.
Le prime sono garantite dall’autorità stessa di Dio, autore principale della Sacra Scrittura, e perciò vanno credute con piena e sicura fede. Le altre invece si appoggiano su documenti o su testimonianze ordinarie; e quindi ad esse si deve quella fede che meritano i documenti o le testimonianze. Spieghiamoci meglio. Le apparizioni bibliche sono compiute da Dio (in futuro parleremo di teofania) o dagli angeli; l’angelo Raffaele appare a Tobia e lo accompagna nel viaggio (Tob. 5, 5-12, 22); Gabriele appare a Zaccaria (Lc. 1, 8-22), ed a Maria (Lc. 1, 26-38); un angelo appare più volte a san Giuseppe (Mt. 1, 20; 2, 13); gli angeli annunziano ai pastori la nascita di Gesù (Lc. 2, 8-15); un angelo conforta Gesù nell’agonia del Gethsemani (Lc. 22, 43); un angelo annunzia alle pie donne la risurrezione di Gesù (Mt. 28, 2-5); un angelo appare al centurione Cornelio (Act. 10, 3), ecc. Altre sono compiute dai morti, risorti o no: a Giuda Maccabeo apparvero Onia e Geremia (II Mach. 15,11-16); agli Apostoli apparve sul Tabor Mosè (Mt. 17, 3); dopo la risurrezione di Gesù, molti defunti uscirono dalla loro tomba ed apparvero a molte persone a Gerusalemme (Mt. 27, 53) - vedere anche il nostro Sursum Corda, Comunicato n° 24, ndR; Gesù risorto apparve a Maria Maddalena (Mc. 16, 9), indi a san Pietro (Lc. 24, 35), ai due discepoli nella via di Emmaus (Lc. 24, 15), agli Apostoli riuniti nel cenacolo (Mc. 16, 14; Mt. 28, 17; Io. 20, 19), a Saulo sulla via di Damasco (Act. 9, 3-7), ecc. Le apparizioni bibliche sono in maggior parte narrate come percepite dai sensi esterni; non mancano però le apparizioni ai sensi interni o immaginative, cui si collegano i sogni in cui si rivela la volontà divina (II Mach. 15, 11; Mt. 1, 20; 2, 13).
Dopo chiusa la rivelazione col termine dell’età apostolica, spesso apparvero il Signore o la Vergine, gli angeli o i demoni o i santi, come attestano la storia e la agiografia, antiche e recenti. A tutti note sono le apparizioni di Paray-le-Monial, di Lourdes, della Salette, di Fatima. Le vite dei santi, poi, ad esempio di santa Teresa, di santa Margherita Maria, del santo Curato d’Ars, di santa Gemma Galgani, riferiscono abbondantemente le molte apparizioni avute da queste anime privilegiate. Nel medioevo vi fu tutta una fioritura di apparizioni eucaristiche, nel quadro di molti altri miracoli che avevano per centro l’Eucaristia (cf. P. Browe, Die eucharistischen Wunder des Mittelalters, Breslavia 1938). La liturgia cattolica ha consacrato il ricordo di alcune tra queste apparizioni con l’istituzione di apposite feste: così l’11 febbraio celebra l’apparizione della Madonna di Lourdes; l’8 maggio l’apparizione di san Michele sul monte Gargano. Di altre feste l’origine è connessa con qualche apparizione, come ad esempio la festa della Madonna di Lourdes (11 febbraio); della Madonna della Mercede (24 settembre); del S. Cuore, etc... Con il riconoscimento avuto dalla Chiesa, tali apparizioni si impongono in modo particolare alla credenza dei fedeli: non come articoli di fede, ma come fatti storici della cui autenticità, data l’estrema prudenza della Chiesa nell’ammetterli, non si può ragionevolmente dubitare (vedere anche il nostro Sursum Corda, Comunicati n° 35 e 36, ndR).
Circa le apparizioni sulle quali la Chiesa non ha espresso alcun giudizio, qualsiasi apprezzamento deve essere subordinato a determinati criteri: - un criterio storico (se attraverso lo studio dei documenti e delle testimonianze, l’asserita apparizione risulti realmente avvenuta); - un criterio psicologico (se mediante l’esame delle condizioni intellettuali, morali e psichiche del soggetto si escluda o no l’allucinazione); - un criterio teologico (se l’asserita apparizione sia dovuta ad intervento divino oppure a forze occulte della natura o diaboliche - dopo studieremo lo spiritismo, ndR). Chi ha delle apparizioni è convinto di trovarsi in contatto diretto con la persona che gli appare. Ma la realtà che si manifesta al veggente è la verità oggettiva della persona medesima che si fa presente nell’apparizione o è qualcosa di diverso, per quanto sensibile e quindi reale? La questione è, per alcuni punti, motivo di discussione fra i teologi.
Si conviene che nelle teofanie non è l’essenza di Dio che viene in rapporto con i sensi dell’uomo; ciò è impossibile per l’assoluta spiritualità di Dio, il quale quindi si manifesta attraverso qualche strumento. Analogicamente si pensa sia per le apparizioni degli angeli, sia per quelle dei santi o dei morti, fino a quando questi non abbiano ripreso il loro corpo. La discussione, quindi, si limita all’umanità di Gesù, se nelle apparizioni dopo l’ascensione al cielo, si sia manifestata nella sua realtà corporale; ed alla Santissima Vergine, il cui corpo si trova già glorioso in cielo. Si è d’accordo nel ritenere che all’Apostolo Paolo Gesù è apparso col Suo corpo reale (I Cor. 9, 1), «corporaliter praesente» e non soltanto «aliqualiter apparente» (san Tommaso, Sum. Theol., III, 57, a. 6 ad 3 - «Cristo salendo al cielo una volta per sempre, ha acquistato per sé e per noi il diritto alla dimora celeste per tutta l’eternità. Tuttavia questa dignità non viene menomata, se in via eccezionale qualche volta Egli ritorna sulla terra: o per mostrarsi a tutti come nel giudizio universale; o a qualcuno in particolare, come nella conversione di san Paolo. E perché nessuno creda che ciò sia avvenuto non per la presenza fisica di Cristo, ma mediante una qualsiasi apparizione, si noti che ciò contrasta con quanto dice l’Apostolo stesso, a conferma della resurrezione: “E infine, dopo tutti, è apparso anche a me, come all’aborto”. Ora, questa visione non potrebbe confermare la verità della resurrezione, se egli non avesse visto direttamente il vero corpo [del Signore]», ndR). Altrimenti l’Apostolo non avrebbe potuto, da tali apparizioni, provare la verità della risurrezione (I Cor. 15, 4-13). Per le altre apparizioni, le opinioni discordano. Comunemente si ammette dai teologi che Gesù possa lasciare il cielo per rendersi visibile in terra nella realtà del Suo corpo. Scrive quindi l’Angelico: «Dignitati mansionis caelestis non derogat si ex aliqua dispensatone Christus quandoque corporaliter ad terram descendat» (ibid.).
Oltre questa possibilità, alcuni teologi, quali Scoto e gli scotisti, Suàrez ed altri, partendo dal presupposto che la multilocazione dei corpi (dopo vedremo la bilocazione) non ripugna, ritengono che, pur rimanendo in cielo, il Signore possa nello stesso tempo essere localmente presente in terra con il Suo corpo e rendersi quindi visibile. Per san Tommaso ed i tomisti, invece, l’ipotesi della multilocazione del corpo importa intrinseca ripugnanza: «Ponere quod aliquod corpus sit localiter in hoc loco et tamen sit in alio loco, est ponere contradictoria simul» (Quodlib. 3, a. 2). Essi, quindi, spiegano le apparizioni del Signore o mediante l’intervento di qualche elemento fisico che in forma sensibile e reale rappresenti il corpo del Salvatore, o per un’effettiva modificazione, prodotta, per azione divina, nell’organo visivo del veggente. Pertanto, trattando delle apparizioni eucaristiche, quando cioè nel sacramento «apparet miraculose caro vel puer», l’Angelico non esita a scrivere che in esse «non videtur propria species Christi, sed species miraculosa formata vel in oculis intuentium vel etiam in ipsis sacramentalibus dimensionibus». E la ragione è evidente: «Corpus Christi non potest in propria specie videri nisi in uno loco» (Sum. Theol., III, q. 76, a. 8, ad 2 - «In simili apparizioni non si vedono le sembianze proprie di Cristo, come si è detto; ma delle sembianze miracolosamente prodotte, o negli occhi degli spettatori, o addirittura entro le dimensioni del sacramento», ndR). Analogamente a quelle del Signore, vengono spiegate anche le apparizioni della Vergine. Tuttavia il fatto che nelle varie apparizioni la Madonna appaia ora in una forma ora in un’altra, sembra confermare che non sia il suo vero corpo che si manifesti, ma solo una forma sensibile che lo rappresenta (come nel caso delle apparizioni di Gesù bambino, per esempio, ndR). Fine della citazione dall’Enciclopedia Cattolica.
Dunque chi ci dice se un’apparizione è vera, ossia se l’asserita apparizione sia dovuta ad intervento divino, oppure a forze occulte della natura o diaboliche, oppure ad invenzioni semplicemente umane? Ce lo dice solo l’autorità della Chiesa. L’opinione di un parroco è «autorità della Chiesa»? Non lo è, se non nella misura in cui essa è uniforme al pronunciamento dell’autorità. Difatti un’ispirazione solo privata od un’esperienza interiore non sono sufficienti (cf. Denzinger, 3033). Il giudizio privato, ancora, può essere offuscato da influssi esterni («pregiudizi, passioni o cattiva volontà, etc...», cf. Denzinger, 3876). In attesa di un pronunciamento ufficiale della Chiesa, il buon cattolico come deve comportarsi? Se intende interessarsi all’asserita apparizione, il che non è affatto obbligatorio, si richiede che sia prudente ed attento ai pronunciamenti precipui della Chiesa: «L’obbedienza [alla Chiesa - difatti] deve essere perfetta perché è richiesta dalla fede stessa, ed ha in comune con la fede che non può essere separata da essa; anzi, se non è assoluta pur avendone tutti gli aspetti le resta soltanto un’apparenza di obbedienza, ma di fatto scompare» (cf. Sapientiae christianae, Papa Leone XIII). Un’autentica apparizione (ossia dovuta ad intervento divino) può diffondere una falsa dottrina, può istigare alla disobbedienza ed all’errore, può sostituirsi alla Chiesa? No in tutti i casi; soprattutto noi crediamo nella Chiesa, non nelle apparizioni. Deve essere nostra la sentenza di Sant’Agostino dove dice: «Non crederei [neanche] al Vangelo se non mi ci inducesse l’autorità della Chiesa cattolica» (Contra ep. man. 5, 6; cf. Contra Faustum 28, 2).
A cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

L’adesione non comporta nessun aggravio economico e, comunque, il 5‰ viene automaticamente detratto dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ed il ricavato destinato agli Enti che hanno fatto richiesta.
Come donare il 5 per mille a Sursum Corda
Su tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi (Modello Unico, 730, CUD ecc.) è presente un riquadro appositamente creato per la destinazione del 5 per mille. Nel riquadro sono presentate tre aree di destinazione del 5 per mille. Scelga quella dedicata al “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’ art. 10, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 460 del 1997” (la prima in alto a sinistra). È sufficiente la Sua firma ed il numero del Codice fiscale di SURSUM CORDA:
01 94 40 30 764
La quota della Sua imposta sul reddito sarà devoluta per le attività dell’Associazione Sursum Corda.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, dato che il tema è particolarmente importante nonché attuale, parliamo di «Legittima difesa» (cf. «Enciclopedia Cattolica», Vol. IV, Vaticano, Imprimatur 1950, dalla colonna 1581 a seguire). Chi, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui, riguardante l’incolumità personale, o un bene prezioso in proprio possesso, contro il pericolo attuale di un’aggressione ingiusta, ferisce o uccide l’aggressore, si dice agire per legittima difesa, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. La liceità della legittima difesa sgorga dallo stesso diritto di natura ed è ammessa da tutti i diritti positivi.
• Già Cicerone, parlando di questo diritto, lo ascrive alla legge naturale: «A natura cuique tributum, ut se et corpus suum tueatur declinetque ea, quae ei nocitura sunt» (De Officiis, I, I). E Gaio: «Naturalis ratio permittit se defendere» (D. 9, 2, 45). Ma nel diritto romano era lecito solo difendersi, con l’uccisione dell’aggressore, quando era in gioco la vita, l’integrità personale ed il pudore; non già se si trattava di beni, a meno che per ragione del tempo e del luogo dell’aggressione non fosse in pericolo l’incolumità personale, oppure il ladro aggredisse, percuotendo la vittima. Tuttavia non era illecito prevenire l’aggressore e difendere in maniera cruenta non solo se stesso, ma anche i propri cari. Poco si sa di preciso sul diritto barbarico in materia, per la diversità delle fonti e dei pareri degli interpreti; ma pare che la difesa legittima non fosse considerata come istituto a sé, sia per la natura oggettiva dell’antico diritto germanico, sia ancora per la facoltà data ai privati di vendicare l’omicidio. Il diritto canonico antico confermò la liceità della difesa cruenta. Innocenzo III circoscrisse i limiti della difesa «cum moderamine inculpatae tutelae».
Nell’ambito della liceità dell’uccisione per legittima difesa si fece rientrare anche la difesa dei beni di fortuna. La dottrina canonica, già lungamente discussa dai decretisti, venne ulteriormente elaborata dai teologi moralisti, sotto il controllo del Magistero ecclesiastico, che corresse le sentenze troppo lassiste o rigoriste degli uni e degli altri. Fu riprovata così la sentenza di coloro che pretendevano estendere il campo della liceità della legittima difesa alla tutela dell’onore (Denz-U, 1117, 1180); o dei beni materiali di scarsissimo valore o che non sono attualmente in nostro possesso (ibid., 1182 seg.); o dichiaravano legittima la soppressione del giudice nell’imminenza della dizione di una ingiusta sentenza, altrimenti inevitabile, di un falso accusatore o di un falso testimone (ibid., 1118), dell’adultero o della moglie sorpresi in flagrante adulterio (ibid., 1119); oppure accordavano la scriminante della legittima difesa anche a colui che avesse potuto altrimenti sottrarsi efficacemente all’aggressione, per esempio, con la fuga (ibid., 1180). Tutti casi in cui non si verifica lo stato di necessità; in cui la soppressione dell’avversario non sempre è il mezzo più adatto per tutelarsi o manca il senso di proporzione dei valori. D’altra parte furono considerate come infette di rigorismo le sentenze di coloro che non riconoscevano mai lecita la soppressione dell’aggressore, in quanto nella difesa legittima si avrebbe sempre una sproporzione di valori nella preferenza data alla propria vita temporale sulla salvezza eterna del prossimo. Sentenze che trovarono eco anche in giuristi e filosofi, che vissero più o meno al margine del pensiero cristiano. Nel diritto canonico odierno (Codice Pio-Benedettino del 1917, ndR) è stabilito che la legittima difesa contro un ingiusto aggressore «si debitum servetur moderamen», esclude del tutto il delitto e quindi la punibilità; mentre, se non è osservato il dovuto «moderamen» attenua l’imputabilità (can. 2205 § 4).
• Fondamento della liceità. Siamo d’accordo sulla liceità della difesa legittima entro determinati limiti ben definiti, più difficile è trovare la ragione ultima della liceità appunto per questo contrasto di valori e di diritti nostri e di altri, e per l’universalità del precetto: «Non occides», che pare non consentire eccezioni all’infuori di un mandato speciale di Dio. San Tommaso (Sum. Theol., II-II, q. 64, a. 7) sembra in materia applicare il principio del duplice effetto. L’atto di colui che si difende, uccidendo l’aggressore, è da riguardarsi sotto un doppio aspetto: in quanto è diretto alla conservazione della propria vita, ed in quanto produce l’uccisione dell’aggressore. Difendersi è nell’ambito della più piena liceità, essendo connaturale che l’uomo tenda a conservare la sua esistenza quanto più può. L’uccidere poi l’aggressore, quando ciò non è voluto, ma solo permesso per gravissime ragioni, non è ugualmente imputabile al soggetto. Ma su questo passo di san Tommaso, che si è cercato di riferire nel senso più ovvio, si è fermata e formata tutta una gamma di interpretazioni e di sentenze dall’Azpilcueta al card. De Lugo, da sant’Antonino a sant’Alfonso, dal Lessio al Cathrein, al Waffelaert, al Van Hove, soprattutto perché il santo Dottore sembrerebbe proibire a chi si difende di intendere direttamente l’uccisione dell’aggressore: il che ad alcuni sembra inaccettabile, anche perché sarebbe una sottigliezza eccessiva e poco pratica. Perciò, oltre le diverse presentazioni del pensiero di san Tommaso, sono state elucubrate altre spiegazioni, più o meno convincenti. Alcuni infatti spiegano la liceità ricorrendo ad una specie di delegazione che la pubblica autorità farebbe a chi si trovi in simili circostanze. Ma si può osservare che i Codici parlano solo di effetto scriminante della difesa legittima. Altri ricorrono alla necessità di tutelare in questa maniera l’ordine sociale e conseguentemente di promuovere il bene comune; per quanto, si potrebbe osservare che al più si ha in ciò un criterio manifestativo della liceità dell’atto e non la ratio ultima. Altri si appellano al conflitto di diritti in caso incompatibili: il che suppone provato ciò che si deve dimostrare: la liceità di togliere la vita all’aggressore. Il Puffendorff trova la ragione ultima nel fatto che nei doveri di natura nessuno può chiedere ad altri quello che egli non adempie ed anzi positivamente trasgredisce. Chi aggredisce ingiustamente i diritti di un altro, perde i propri e si mette da sé fuori della legge. Ma anche i mutui doveri tra gli uomini procedono in ultima analisi da Dio e non cessano senza che in qualunque maniera egli lo voglia o consenta. Meno convincente è poi la teoria della necessità del diritto o dell’autorizzazione di Stato (Notstand und Notrecht), per cui l’uccisione dell’aggressore, per il semplice fatto che è necessaria alla propria conservazione o permessa dallo Stato, sarebbe lecita (Carrara, Pessina, ecc.). La soluzione è da altri prospettata in base a queste considerazioni. Nell’omicidio si ha una duplice ingiuria: contro Dio, vero padrone della nostra vita; verso il prossimo, che per il fatto che esiste ha diritto alla vita. Ma chi aggredisce è conscio di provocare una reazione, e quindi è responsabile in causa delle conseguenze e toglie alla reazione stessa cruenta il carattere formale di ingiuria; secondo il detto: «volenti non fit iniuria». Che poi questa difesa cruenta di se stesso non sia contraria all’ordinamento etico, che fa capo a Dio, può in parte rilevarsi dall’istinto di difesa insito negli animali e nell’uomo, che per moto spontaneo tende ad opporsi all’aggressore in qualsiasi modo: la voce della natura pare essere la voce del Creatore. Inoltre la coercibilità, cioè la facoltà morale di difendere un proprio diritto anche con la forza a determinate condizioni, è una qualità del diritto stesso, anche se non essenziale, e come tale deriva da Dio, autore delle cose e dei diritti. Ora il diritto alla vita è un bene sommo: la sua coercibilità deve dunque estendersi al sommo; sarebbe invece illusoria ed inefficace, se non giungesse fino alla difesa cruenta.
• Nella Sacra Scrittura non si trovano altri elementi che ci rendano manifesta la volontà divina. C’è un passo del Vecchio Testamento (Ex. 22, 2-3) che sembra consentire la difesa cruenta contro il ladro notturno, ma è incerto se ivi si tratti di una disposizione di diritto positivo o di diritto naturale. D’altra parte, però, non si può dimostrare in alcun modo dalla Sacra Scrittura l’illiceità della legittima difesa, perché i passi di Mt. 5, 38-39; 26, 52; Rom. 12, 18-19, che parrebbero presentare qualche difficoltà, sono comunemente interpretati nel senso che ivi si vieti soltanto la cupidigia della vendetta. Una fonte della dottrina della Chiesa è anche il Magistero ecclesiastico, che ha sentenziato nel senso sopra indicato. È dunque lecita la legittima difesa prima di tutto contro colui che è formalmente ingiusto aggressore. È anche lecita contro chi è aggressore ingiusto solo materialmente, perché all’atto pratico un simile esame è quasi sempre impossibile e d’altra parte l’argomento tratto dalla coercibilità del diritto vale contro qualsiasi tipo di ingiusto aggressore.
• Condizioni per la liceità della difesa legittima. Ma la facoltà del ricorso alla forza fisica per la tutela di un diritto non può essere mai illimitata: altrimenti sarebbe arbitraria e sconvolgerebbe, anziché tutelare, l’ordine etico e giuridico. Ciò vale anche per il caso della legittima difesa. Dopo quanto si è detto, è facile definire questi limiti, che i moralisti riassumono nella formola desunta dal Codice Giustinianeo «inculpatae tutelae moderatione» (Cod. 8, 4, I). In linguaggio più semplice, gli elementi costitutivi della moderatio sono: aggressione ingiusta, reazione proporzionata, necessità della difesa.
- 1. Aggressione ingiusta. Per la scriminante del moderame si richiede che l’agente operi per respingere una violenza da sé e da altri, violenza ingiusta o nella sostanza o nel modo, violenza in atto. Dal pericolo nasce un legame di fraternità universale, per il quale la reazione e la tutela ricevono l’impronta della legittimità da chiunque esercitate ed a favore di chiunque: dalla forma egoistica e personale della difesa di sé e dei suoi, si assurge così alla forma altruistica ed impersonale della difesa del diritto. Ingiusta è poi la violenza che viene inferta senza diritto; e basta che la violenza sia ingiusta in sé, senza bisogno di riferirla alla responsabilità dell’aggressore. Fosse anche questi un maniaco od un ubriaco, se l’atto suo ha fatto sorgere la necessità di una pronta reazione, la reazione è giustificata. Tuttavia perché abbia effetto scriminante è necessario che la violenza, e cioè il male o il pericolo contro cui si reagisce, sia attuale, almeno moralmente. Una semplice minaccia, non accompagnata da atti o circostanze, che inducano nel minacciato il timore dell’imminente esecuzione, non basterebbe per togliere l’imputabilità della reazione; ma può d’altra parte bastare il timore dell’imminente esecuzione, essendo massima antica di diritto e di senso comune, che «nemo tenetur exspectare donec percutiatur». Se l’attacco fu respinto, e, senza ragionevole motivo di temere che l’aggressore perseveri e ritorni all’ostilità, l’aggredito trascende contro di lui a violenze ulteriori, non sarà per queste invocabile la giustificazione del moderame. In tutti questi casi si deve piuttosto parlare di vendetta, e al più, a norma delle varie circostanze, a seconda del sentimento, che trasse il soggetto ad agire, si avrà la figura dell’eccesso di difesa o della provocazione.
- 2. Reazione proporzionata. Non si può togliere al prossimo un bene massimo per un bene minimo o per un bene altrimenti difendibile. Per questo requisito la legittima difesa deve restringersi agli attentati fatti alla vita, all’integrità personale, alla libertà, agli attentati al pudore, che siano tali da mettere la vittima in condizioni di doversi difendere. Il moderame per l’attentato ai beni va regolato moralmente in proporzione al valore intrinseco del bene conteso, alle condizioni di chi è minacciato ed alle possibilità di poterlo altrimenti rivendicare. Per queste ragioni non è facile una traduzione in cifre, per quanto da alcuni tentata. Certamente non può essere inferiore alla materia relativamente grave del furto (cf. Denz-U, 1181).
- 3. Necessità della difesa. Questa deve essere esaminata ed intesa tanto in rapporto alle proporzioni fra la reazione e la violenza contro la quale si reagisce, quanto in rapporto alla possibilità di altrimenti evitarla. La proporzione tra la violenza e la reazione non deve essere intesa in un senso solo materiale, ma bisogna aver riguardo anche ai mezzi, dei quali può disporre l’agente al momento dell’aggressione, alla possibilità per lui di far fronte all’imminente pericolo di agire diversamente, ed allo stato dell’animo suo. Quanto alla inevitabilità del pericolo occorre che questo sia tale da non potersi evitare con la preghiera, con le acclamazioni o con la fuga. L’obbligo però di fuggire non può affermarsi per chi abbia la consegna di restare al suo posto o che non lo possa fare senza perdere gravemente il proprio decoro. Nella valutazione di tutto ciò occorre attendere al turbamento d’animo prodotto nell’aggredito dal timore della violenza o del pericolo. Questi elementi costitutivi del moderame, oltre che nel diritto naturale, sono più o meno tenuti presenti anche nel diritto positivo. Anche i codici penali sogliono considerare la difesa legittima come circostanza che esclude il reato (alcuni codici però la prendono in considerazione solo per alcuni reati). ...
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, oggi analizziamo, col Prof. Ballerini («Breve apologia per giovani studenti, contro gli increduli dei nostri giorni», Parte II, Firenze, Imprimatur 1914, dalla pagina 165 a seguire), i criteri o segni per riconoscere la religione rivelata da Dio, ossia la vera religione.
• Necessità di criteri e segni. Né l’uomo potrebbe credere ad una religione divina se prima non fosse certo che Dio ha parlato, né Dio potrebbe esigere fede dall’uomo se prima non gli facesse conoscere con certezza che Egli ha veramente parlato. Occorrono dunque delle prove. È assurdo supporre che Iddio parli e poi non si curi che la Sua parola venga conosciuta e creduta; o che, volendo questo, non dia all’uomo i mezzi necessari per conoscere ed accertarsi che è veramente parola di Dio. Cristo ha detto: «Chi non crederà, sarà condannato». E non potendo Iddio nella Sua giustizia condannare chi non è colpevole, deve aver impresso alla Sua religione quei caratteri che la mostrano veramente divina. Perciò la Chiesa ha condannato la dottrina di coloro che asserivano: «L’assenso di fede soprannaturale e utile alla salute può stare colla notizia solo probabile della rivelazione, anzi col timore che Dio non abbia parlato». Proposizione XXI fra le condannate da Papa Innocenzo XI il 2 marzo 1679. Lo stesso errore venne da Papa san Pio X condannato nella proposizione XXV del Decreto Lamentabili: «L’assenso di fede si appoggia in ultima analisi su di una congerie di probabilità». E Papa Pio IX nella Enciclica Qui pluribus del novembre 1846 scriveva: «Perché l’umana ragione non s’inganni né erri in affare di tanta importanza, deve diligentemente scrutare il fatto della rivelazione divina, affinché le consti con certezza che Dio ha veramente parlato».
• Motivi di credibilità. Le prove che dimostrano una data religione essere veramente rivelata da Dio, si dicono motivi di credibilità, i quali si possono definire: Segni chiari ed evidenti per cui tutti gli uomini possono conoscere con certezza che Dio ha veramente parlato. Se la rivelazione fosse fatta immediatamente a ciascuno di noi, come avveniva ai Profeti, allora, per essere certi del fatto della rivelazione, non occorrerebbero altri dati che quelli della interna esperienza con cui l’uomo sa d’aver avuto una tale comunicazione da Dio. Ma la cosa non va così. La rivelazione viene a noi trasmessa da quelli che l’ebbero da Dio. Bisogna dunque esaminare il fatto stesso o la religione che dicesi rivelata, per vedere se essa presenta caratteri o garanzie che la dimostrino tale. Nessuno in base ai motivi puramente soggettivi della sua coscienza ha diritto di affermare il fatto della rivelazione. Dobbiamo dunque rivolgerci ai motivi oggettivi.
• Questi sono di due specie, negativi e positivi. I primi ci mostrano che non può esser rivelata quella religione cui mancano tali segni o requisiti. E questi sono: che le cose rivelate siano conformi, o almeno non ripugnanti ai dettami della ragione - non siano indegne di Dio - non siano storicamente false - e che colui, il quale dicesi inviato da Dio, sia di una morale edificante, quale appunto si conviene ad un inviato dal Signore. Una religione che mancasse di tali requisiti e contenesse qualche cosa di assurdo o di immorale, non potrebbe certamente essere rivelata da Dio. È però facile capire che questo criterio non è adatto per tutti e non è sufficiente neppure pei dotti. Non è adatto per tutti: perché pochi sono capaci di scorgere la conformità o non ripugnanza degli insegnamenti religiosi con i dettami della ragione. Non è sufficiente neppure per i dotti: perché la conformità o non ripugnanza di una dottrina religiosa con i principii della nostra ragione prova, tutt’al più, che quella dottrina può essere rivelata, non già che di fatto lo sia, potendo essa provenire da insegnamenti puramente umani o naturali. Con questo criterio sarebbero inoltre esclusi o compromessi i misteri soprannaturali. Occorrono dunque altri criteri di indole positiva, i quali non solo ci facciano conoscere che una data dottrina può essere rivelata perché nulla ha di ripugnante con i principii della retta ragione, ma ancora che quella dottrina è di fatto veramente rivelata.
• Questi criteri possono essere interni ed esterni. Sono interni quelli desunti dalla sublimità, eccellenza e trascendenza delle dottrine rivelate su tutte le altre. Questo carattere non può certamente mancare alle dottrine rivelate, ma non tutti sono capaci di rilevarlo. Non si deve però confondere questo criterio o motivo interno-oggettivo, desunto dagli stessi veri rivelati, col criterio o motivo interno-soggettivo, desunto dalla corrispondenza delle dottrine rivelate coi bisogni dell’anima nostra. I seguaci dell’immanenza vitale o psicologica si appigliano a quest’ultimo criterio in senso esclusivo. Essi negano che la ragione possa dimostrare con certezza l’esistenza di Dio ed il fatto della rivelazione. E tuttavia sostengono che la divinità della religione si possa egualmente dimostrare dal lato psicologico, in quanto risponde a tutte le esigenze ed aspirazioni della nostra natura. Ma questa dottrina, presa nel senso esclusivo in cui la propongono i modernisti, non si può accettare. Noi pure ammettiamo che l’accordo tra la religione rivelata ed i bisogni dell’anima è indizio della sua divina origine, ma solo quando sia già dimostrata l’esistenza di Dio ed il fatto della rivelazione divina; perché, allora, fondandoci sul concetto della sapienza divina, che fa tutte le cose ordinatamente, possiamo considerare quella corrispondenza come un segno di verità. Ma per chi ritiene non dimostrata né dimostrabile l’esistenza di Dio ed il fatto della rivelazione, quell’accordo non dice nulla: esprime solo il fatto soggettivo di una religione conforme alla nostra natura, senza sapere se questa religione sia vera o falsa, rivelata o no.
• L’esperienza religiosa. A questa dottrina è identica l’altra della «esperienza del divino», e della «esperienza religiosa», che gli stessi modernisti fanno valere come criterio per giudicare della verità della religione cristiana rivelata. Ma anche qui dobbiamo intenderci. Che la religione rivelata, ed in concreto, la cristiana, produca mirabili effetti in chi la pratica come si deve - per esempio la pace dello spirito, la tranquillità della coscienza, il distacco dalle cose mondane, il desiderio delle celesti, ecc. - e che questi effetti si possano considerare come un indizio della divinità della religione cristiana, nessuno lo nega. Ma ognuno vede che intanto possiamo sentirci obbligati a praticare la religione cristiana, sottostare ai sacrifizi che ci impone, credere alle sue dottrine ed a suoi dogmi, in quanto siamo già certi che essa viene da Dio ed è perciò obbligatoria per tutti. Occorrono dunque dei criteri antecedenti all’esperienza religiosa, i quali dimostrino a tutti la divinità del Cristianesimo in sé stesso e persuadano ad abbracciarlo e praticarlo. Perché uno possa determinarsi a vivere secondo i dettami di una data religione (esperienza religiosa), deve già essere persuaso della verità di quella religione e dell’obbligo di vivere in conformità ai dettami della medesima. La vera esperienza religiosa consegue, dunque, come effetto alla dimostrazione già fatta. [I primi cristiani non si sono convertiti al Cristianesimo in base all’esperienza fatta, ma in base a quella da farsi, cioè, in base ai motivi che li convinsero della divinità del Cristianesimo e dell’obbligo di vivere secondo i suoi dettami]. Dunque non è vero quanto affermano i modernisti. L’esperienza religiosa non è criterio né unico né primario: è solo argomento di conferma. Ed anche in quest’ultimo senso, è noto quali e quante sieno le fluttuazioni ed incertezze a cui soggiace l’esperienza religiosa, secondo il carattere e le disposizioni degli individui. Mai, quindi, avremo una norma certa e sicura di giudizio, se non la pigliamo dall’esterno. Di qui le giuste argomentazioni dell’Enciclica Pascendi Dominici gregis (di Papa san Pio X) contro l’esperienza religiosa dei modernisti, che potrebbe giustificare ogni religione.
• La dottrina dei valori morali. Né punto dissimile è la dottrina dei valori morali nel giudicare della bontà o verità di una religione. Nel fatto, cioè, che una data religione riconosce e favorisce più delle altre il valore morale della vita, si vorrebbe trovare la ragione o il criterio che ci deve far preferire quella religione a tutte le altre. Il filosofo Danese Höffding ha lavorato più di ogni altro a formulare questo sistema nella sua Filosofia della religione (La pensée humaine, ses formes et ses problemes. Trad. d’après l’edition danoise par F. de Coussance, Paris, Alcan, 1911). Nel fatto religioso egli vede espresso essenzialmente un bisogno ed una volontà di mantenere i valori della vita al di là dei limiti entro i quali la volontà umana può agire a loro riguardo; e quella religione che in tal modo esercita più vivamente la sua efficacia, dovrà essere la preferita. A parte tutte le osservazioni in contrario, ciò che ha di vero questa dottrina conviene con quanto abbiamo già detto. Ma il fatto storico di una religione veramente rivelata da Dio, non si potrà mai affermare con vera certezza in base a tale criterio. [Anche in questo caso si può parlare solamente di argomento di conferma, ndR].
• Criteri o motivi esterni. Conviene dunque, per accertarsi intorno al fatto della rivelazione, far capo ai motivi esterni; cioè a quei fatti soprannaturali e sensibili che accompagnano la divina rivelazione, come prove e testimonianze della sua divina origine. E questi sono i miracoli e le profezie, per mezzo dei quali Iddio ci assicura essere veramente Sua, ossia divinamente rivelata, quella dottrina in conferma della quale furono operati. [Sappiamo, difatti, che i veri miracoli e le vere profezie non esistono nelle false religioni, ndR]. Solo questi ultimi criteri, come ognuno vede, sono accessibili a tutti, e provano con certezza che veramente divina, e, quindi, rivelata da Dio è quella dottrina che li possiede. Perché non potendo i miracoli e le profezie venire da altri che da Dio, e non potendo Iddio prestarsi a suggellare l’impostura, se c’è una religione confermata da veri miracoli e da vere profezie, questa non può essere che divina, ossia divinamente rivelata. [Nel prossimo articolo citeremo la Somma Teologica, san Tommaso d’Aquino, II-II, Questione 178, Argomento 2, Se gli iniqui possano far miracoli, ndR]. Questi criteri, inoltre, più di tutti gli altri rispondono all’esigenza della stessa critica. Se la rivelazione esiste è un fatto, e, come tale, dev’essere dimostrata con prove storiche o argomenti di fatto. Come fatto straordinario e soprannaturale, poi, deve essere provata con altri fatti parimenti straordinari e soprannaturali. E tali sono appunto i miracoli e le profezie. «Se alcuno dirà che la rivelazione divina non possa rendersi credibile con segni esterni, e che perciò dalla sola interna esperienza, o privata ispirazione, gli uomini debbono essere condotti alla fede; sia anatema». Così si esprime il Concilio Vaticano (1869 - 1870), De fide, can. 3.
«Se questa religione, scriveva Gaetano Negri, si limitasse ad esporre dogmi che fossero accessibili alla mente umana e che contenessero in sé stessi la prova della loro verità, certo, in tal caso, non vi sarebbe alcun bisogno di un fatto esterno che ne garantisse la credibilità; ma non vi sarebbe, nel medesimo tempo, nessuna ragione per credere che quella dottrina è di origine divina [...]. Al contrario, una rivelazione soprannaturale deve essenzialmente consistere di dogmi, i quali siano superiori alla nostra intelligenza, dei quali noi non possiamo intendere la ragione, perché questa ragione si trova in una causa che non è da noi analizzabile. Ma, in questo caso, è pur necessaria una garanzia la quale assicuri l’uomo ch’egli, accettando ciò che non comprende, non s’inganna, e questa garanzia è il miracolo. Una dottrina la quale è all’ infuori della logica della [sola] ragione, deve essere provata da un fatto il quale è all’infuori della logica della natura. L’uomo non può giudicare che sui fatti. A giudizii naturali corrispondono fatti naturali; a giudizii sovrannaturali, fatti soprannaturali». Lo scrive in Segni dei tempi. A parte alcune inesattezze di linguaggio, il Prof. Ballerini attesta che qui viene espresso lo stesso pensiero di san Tommaso in Contra gent., 1. III, cap. 154: «Quia sermo propositus (la rivelazione divina) confirmatione indiget ab hoc ut recipiatur, nisi sit per se manifestatus, ea autem quae sunt fidei sunt humanae rationi immanifesta, necessarium fuit aliquid adhiberi quo confirmaretur sermo praedicantium fidem. Non autem confirmari poterat per aliqua principia rationis per modum demonstrationis, quum ea quae sunt fidei rationem excedant. Oportuit igitur aliquibus indiciis confirmari praedicantium sermonem, quibus manifeste ostenderetur huiusmodi sermonem processisse a Deo, dum praedicantes talia operarentur..., quae non posset facere nisi Deus».
(a cura di CdP)
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, quante volte ci è capitato di sentire, o purtroppo di dire in passato (Dio ci perdoni), l’illogica frase: «Io sono credente, ma non sono praticante»? Analizziamo e scardiniamo questa proposizione di evidente contraddizione con l’aiuto del dotto Padre Franco («Risposte alle obiezioni più popolari contro la religione», ed. IV, Capo XLV, Roma, Civiltà Cattolica, 1864, con Imprimatur, dalla pagina 429 alla pagina 438).
Vi sono alcuni, i quali non oppongono troppi argomenti alla fede, che anzi si vantano di essere cattolici, solo aggiungono, poi, che essi «non praticano», e vogliono dire che non riducono la loro “fede” all’atto degli esercizi della fede cattolica. Ciò dicendo, credono che ciò possa dirsi e farsi lecitamente. Essi sono persuasi esservi come due tipologie di cattolicesimo, l’uno accompagnato dalle opere, l’altro senza di esse: tutti e due ottimi al bisogno, e che sia possibile scegliere l’uno o l’altro a piacimento, secondo il proprio parere, in base alle circostanze, come il sentimento suggerisce.
Io ho conosciuto - ricorda il Padre Franco - qualcuno che giungeva persino in casa a fare qualche lettura buona, a vivere con una certa onestà, ma che si sarebbe lasciato fare a pezzi piuttosto che entrare in una chiesa, oppure accostarsi ad un confessore: tanto si dava a credere non esservi alcun nesso tra l’essere cattolico ed il praticare la religione. Il perché, se v’è massima che meriti un poco di esame, è tutto qui descritto. Buon per noi tuttavia, che, ad intenderne l’assurdità di tale pretesa, non è necessaria molta sottigliezza d’ingegno; basta ponderare i termini che qui si oppongono.
Che cosa vuol dire «io sono cattolico», che cosa vuol dire «io non pratico»? Io sono cattolico vuol dire, io sono certo, per quella maggior certezza che può darsi al mondo, qual è quella fede che Dio m’ha imposto con tali e tali obblighi; ed io non pratico, vuol dire, nonostante la certezza dell’obbligazione che Dio m’ha imposto, io reputo che mi sia lecito non dar retta a Dio, e non fare ciò che Egli mi comanda. Ponderate, o lettore, tutta la vastità di questa contraddizione. Quali sono le pratiche esteriori più comuni imposte dalla fede cattolica? Esse si riducono alla Messa, all’orazione della Chiesa, all’assistere alla divina parola, alla confessione, alla comunione, all’astinenza dalle carni, ai digiuni e poco altro. Di tutte esse la fede fa ordinazioni speciali, dichiarandole del tutto obbligatorie, e chi è cattolico come tali le riconosce.
• Dunque, in particolare, vuol dire per esempio: «io, ammaestrato dalla fede, riconosco che mi è necessaria l’orazione, che senza di essa non adoro Iddio, né Lo tratto da padrone supremo, né come fonte di tutti i beni, né posso impetrare perdono delle mie colpe, né grazia di alcun tipo; anzi non posso evitare molte e gravi cadute»; ma nonostante tutto soggiungere: «né farò orazione, né mi raccomanderò a Dio, e mi terrò lontano soprattutto da quelle preghiere tanto più efficaci, che si fanno in comune nella Chiesa dal popolo cristiano». E questo è solo un esempio fra tanti.
• Vuol dire, «io riconosco e tengo per fede, che nella Sua Chiesa Gesù Cristo ha stabilito un Sacrificio, al quale ha ordinato che tutti prendano parte, poiché sarà il solo Sacrificio della nuova legge, ed in esso vi sarà la sola Vittima che piacerà al Signore, che potrà placarLo, che farà discendere dal cielo tutte le grazie»; e tuttavia aggiungere poi: «non vi assisterò né molto né poco, checché ne sia di tanti misteri».
• Vuol dire, «io riconosco e concedo che la parola divina è il mezzo per cui, di provvidenza ordinaria, Dio parla alle anime dei fedeli, li ammaestra, li conforta, li compunge, li stacca dal vizio, li trae alla virtù»; ma, nonostante tutto ciò sia innegabile alla fede, «io non ne farò niente e mi comporterò come credo».
• Vuol dire, «io sono certo per fede, che ho obbligo di sottoporre i miei peccati all’augusto tribunale di penitenza, che senza questa condizione mai non mi saranno perdonati, che vivendo in stato di colpa posso in ogni momento essere traboccato nel baratro eterno, come vedo accadere a tanti che muoiono da insensati»; e ciononostante protesto, che «mai soddisferò a quell’obbligo, che mai mi presenterò al tribunale di penitenza, poi si vedrà per l’eterna salute».
• Vuol dire, «io tengo per fede, che Gesù Cristo, per quell’immenso affetto che mi ha portato, ha istituito un Sacramento tutto di amore, nel quale vuole unirsi a me in maniera ineffabile; che in esso m’ha preparato tesori di grazie congiunti alle più tenere ed inaudite significazioni di una carità veramente divina; che il parteciparlo è condizione del tutto indispensabile affinché io abbia accesso all’eterna beatitudine»; e tuttavia, «nonostante che io non possa mettere in dubbio queste verità, poiché dico di professare la fede cattolica, né acconsentirò mai ad accostarmi al sacro Altare, né farò alcun caso di tutto l’amore divino, né della mia eterna salute».
• Vuol dire, «io son convinto e tengo per fede, che ho obbligo di manifestare esternamente con le opere quello che credo interiormente col cuore»; e tuttavia «farò professione di astenermi da tutte quelle opere esteriori, che sono manifestazione di ciò che credo nel cuore» (sic!).
• Queste e molte altre cose simili vuol dire quell’illogica frase: «Io sono cattolico, ma non pratico». Ora io chiedo ad un lettore di buona fede - soggiunge il dotto Padre Franco - si può essere più ingiuriosi di così contro la Divinità? Se voi diceste, «io sono turco, epperò non pratico: io sono protestante, epperò non pratico: io sono ateo e miscredente, epperò non pratico», voi parlereste iniquamente senza dubbio, ma pure sarebbe logica la conseguenza. Difatti, chi può mettere in pratica una religione, che reputa favola e menzogna? Chi può riconoscere una legge, che stima fatta da chi non ha alcuna autorità? Ma riconoscere vera la fede cattolica, la quale impone siffatti obblighi, e poi ritrarsene, non è la più irragionevole maniera che vi sia di pensare, discorrere ed operare? Prosegue negli articoli odierni del Centro Studi Vincenzo Ludovico Gotti (tag Credente non praticante) ...
(a cura di CdP)
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Sostenitori, noi leggiamo in sant’Ambrogio (Psal. 1): «Se risuscitiamo quaggiù in mezzo ai morti, risusciteremo altresì nel cielo. Se non siamo sulla terra membri disseccati, ma riceviamo la rugiada della parola divina e gli aiuti dello Spirito Santo, vivremo nell’eterno soggiorno».
Il giorno di Pasqua, un Angelo scese dal cielo, ed un terremoto scosse il sepolcro. Al fine di risorgere alla vita spirituale, ancora noi abbiamo bisogno dell’assistenza del cielo, vale a dire della grazia dello Spirito Santo. È d’uopo che il timore di Dio e la compunzione del cuore, simili ad un terremoto, scuotano in una certa maniera il peccatore. Le donne si domandavano con inquietudine chi sarebbe capace di sollevare l’enorme pietra che copriva la tomba. Nell’opera della risurrezione del peccatore, la più difficile impresa è altresì quella di rimuovere la pietra del sepolcro; questa pietra è l’accidia. Essa pesa, in alcuni casi, da molti anni sul cuore d’un gran numero di peccatori, e, come un grave coperchio di sepolcro, ne chiude l’ingresso in modo che neppure un raggio di luce celeste possa penetrarvi. E così, ridotta all’impossibilità d’udire alcuna parola d’incoraggiamento che la solleciti ad uscire di questo stato di morte, l’anima non s’avvede neppure più delle spaventose tenebre che l’avviluppano, e continua a rimanere assopita nel sonno della morte.
E che? I nostri cuori sarebbero ancora coperti da questa pietra sepolcrale? Passata la Pasqua, noi saremo ancora così indolenti come in precedenza? Sarebbe forse vero che, invece di risorgere, noi ci fossimo sempre più internati nella tomba per continuare il nostro sonno? Presso il sepolcro di Gesù v’erano delle guardie condottevi dai suoi nemici, le quali se ne pentirono dopo che il Cristo risuscitò. Ve ne sono altresì che vegliano al fianco della tomba del peccatore, che il nostro nemico capitale, Satana, ivi ha collocato; queste sono la superbia, e la figlia di lei, la falsa vergogna. Esse non permettono al peccatore di risorgere, ma lo persuadono di continuo a proseguire il sonno, assicurandolo che le sue colpe non sono che inezie. Questa falsa vergogna sovente chiude la bocca a più d’un peccatore, proprio come i nemici di Gesù tenevano custodito il suo sepolcro.
Sono ancora lì queste guardie? La superbia continua sempre a dirvi che i vostri peccati non sono se non “peccatucci”? E la vergogna riesce sempre a chiudervi la bocca, allorché si tratta della vostra confessione pasquale? Sciagurati voi, se questi satelliti di Satana v’assediano ancora, perché in tal caso non siete risuscitati! Allorché Gesù risuscitò, lasciò nel sepolcro i pannilini e i lacci in cui era avviluppato. Tale è lo stato dell’anima nostra. Spesso essa è involta da inclinazioni e desideri perversi, come da fasce che la tengono schiava. In tal caso accade a noi quello che accadde a Lazzaro al momento della sua risurrezione. Come lui, noi non possiamo uscire dal sepolcro dei nostri peccati, perché le nostre malvagie passioni e le tendenze sregolate ci stringono, come con catene, le quali, quando abbiam fatto qualche sforzo per ricuperare la nostra libertà ci fanno ben presto ricadere nel nostro antico sonno.
Franchiamoci dunque da questi impedimenti, rompiamo i vincoli che ci tengono legati al peccato, liberiamoci da ogni legame colpevole, da qualunque affetto sregolato: questo è assolutamente indispensabile, se vogliamo risorgere con Gesù Cristo. Dopo la Sua risurrezione, il corpo di Gesù fu un corpo glorioso e di abbagliante beltà. Per quanto disfatto e sfigurato fosse quando fu deposto nel sepolcro, risuscitò circondato da una luce e da una purezza meravigliosa. Simile sarà l’anima nostra dopo la risurrezione: poc’anzi orribilmente contraffatta dalle cicatrici del peccato, dovrà risplendere poi in tutta la luce dell’innocenza. Essa avrà per ornamenti le buone risoluzioni e le pie determinazioni, che debbono essere come i primi fiori, le primizie della nostra trasformazione alla vita della grazia. Se dubitiamo che un tal cambiamento siasi di già operato, consultiamo il nostro specchio, voglio dire la nostra coscienza: interroghiamola spesso. Quando le donne si recarono al sepolcro, gli Angeli dissero loro: «Voi cercate il vivo fra i morti; esso è risuscitato, e non è più qua». Voglia il cielo che possiamo far trasalire di gioia il nostro Angelo Custode, costringendo il demonio ad esclamare, allorché dopo la risurrezione verrà con la sua truppa, cioè i seduttori del secolo, a ricercarci nel sepolcro della perdizione: «Voi cercate i vivi fra i morti, i convertiti fra i peccatori; essi sono risuscitati, e non si trovano più qua» [Dal Prontuario del Predicatore, Houdry - Porra, Vol. IV, parte I, pag. 547 e seg., Imprimatur 1934].
Esempio. Nelle omelie di Haub, si narra che un giovane libertino, avendo incontrato dopo la Pasqua una persona con la quale aveva avuto delle colpevoli relazioni ma che si era convertita, parve stranamente sorpreso nel vedere come quella si portasse verso di lui e gli passasse accanto senza salutarlo, quasi che non l’avesse giammai conosciuto. Egli le si avvicinò e le disse: «Non mi riconosci dunque tu più? Io sono sempre quel medesimo di una volta» ; ma essa gli rispose: «è possibilissimo che voi siate ancora il medesimo di quello che eravate; per quel che mi riguarda, io non sono più la medesima che conoscete». [Nach Veit’s Homilienkranz].
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

L’Associazione Sursum Corda ONLUS di Pignola (PZ), come previsto dallo Statuto, dona il giorno 11 aprile, nell’ambito del progetto «Sursum corda 2017», alla Casa circondariale di Potenza, numero 16 copie del volume «La Rivoluzione secondo Mons. de Ségur» (prezzo simbolico di copertina euro 10,00).
Nel libro - 168 pagine in carta avoriata, con un comodo indice dei nomi e delle parole - l’Autore intende denunciare e contrastare «la rivolta di tutti i satanassi contro Dio, la Patria, la famiglia, l’autorità». Perché alcuni popoli soccombono nell’immoralità e nella mollezza, pur regolati da milioni di leggi? Perché si succedono governi sempre meno adeguati? Perché gli Stati della vecchia Europa si vedono derubati delle loro sovranità? Perché alcune “entità” sovranazionali promuovono irriducibilmente l’ingiustificata immigrazione di massa? Perché gli autonominati paladini dei “diritti dell’uomo” esportano simulacri di democrazia con guerre ed intrighi? Perché la Chiesa sembra rovinosamente crollare sotto la guida di increduli burocrati aperti a tutto fuorché al vero Gesù Cristo? Perché la somma di tutti gli errori, oggi, prende i nomi di “ecumenismo, libertà, uguaglianza, fratellanza, ...”? Perché gran parte della stampa e dell’informazione, più o meno consapevolmente, non dice il vero? Chi è l’Anticristo e quando verrà? A questi e molti altri attualissimi interrogativi risponde il Prelato già nel 1860, presagendo, grazie alla sua fede cattolica integrale e sulla base di acute analisi storiche e teologico - politiche intransigenti, tutto quello che sarebbe accaduto: egli “vede” il futuro! Difensore dell’infallibilità del Papa e della Chiesa, il cieco Monsignor de Ségur, che oggi verrebbe calunniosamente definito “fondamentalista” ed “oscurantista”, in questo libro affronta «La Rivoluzione», nel tentativo di «svelare ed abbattere gli errori e le fallacie, gl’inganni e le menzogne, con cui le settarie congiure tentano d’alienare i popoli». Un compendio di dottrina cattolica antirivoluzionaria e di teologia politica che non può essere trascurato soprattutto da chi si dice cattolico e politico. Gaston de Ségur è stato uno scrittore apologetico ed ascetico, nato dai Conti di Ségur a Parigi il 15 aprile 1820, ivi morto in fama di santità il 9 giugno 1881. Il libro «La Rivoluzione», per Sursum Corda, è stato curato dal giornalista e saggista lucano Carlo Di Pietro.
L’Associazione ha, inoltre, confermato alla Direzione della Casa circondariale la disponibilità gratuita all’ascolto dei carcerati, al sostegno morale, alla spiegazione del «Catechismo di san Pio X», anche più volte a settimana.
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

Stimati Associati e gentili Lettori, chiediamoci col Padre Ippolito Porra - Prontuario del Predicatore, Vol. IV, parte I, pag. 490 e seg., Imprimatur 1934 - cosa sia la bestemmia. «Si peccaverit vir in virum, placari ei potest Deus; si autem in Dominum peccaverit, quis orabit prò eo?» (I. Dei Re, 2). Questa sentenza suona così: «è più difficile ottenere il perdono delle colpe fatte direttamente contro Dio, che di quelle commesse contro gli uomini». Di questo primo genere sono le bestemmie, che sono come tante frecce lanciate contro Dio. I bestemmiatori imitano quei popoli barbari, che, come si dice, quando sentono strepitare il tuono, lanciano le frecce in alto, per opporle alle folgori, oppongono le loro armi alle armi di Dio. Qui si domanda il profeta: «Quem blasphemasti? cantra quem exaltasti vocem tuam?» (IV. Dei Re, 6). «Chi bestemmi? Contro chi lanci il tuo grido diabolico?». Quelle frecce, che tu vibri contro il cielo, ripiomberanno su te stesso. «Sepulcrum patens est guttur eorum» (Salmo, 5). La loro bocca è una tomba sempre aperta. Teodoreto scrive che queste parole riguardano specialmente i bestemmiatori. Da un sepolcro aperto esce un’esalazione fetente, un odore insopportabile, indice di un essere morto, corrotto od in preda alla corruzione. Tomba aperta la bocca del bestemmiatore; le sue bestemmie hanno un odore puzzolente alle orecchie dei cristiani, dei benpensanti, rivoltano. Sono indice che egli è uno spirito morto, corrotto e da chiudersi nell’inferno.
• «Sanctificetur nomen tuum» (San Matteo, 6). La prima domanda, che noi rivolgiamo a Dio nell’orazione domenicale è che «sia santificato il tuo nome». E, secondo alcun dottori, non a caso Gesù Cristo pose prima questa invocazione. Ma perché vedeva la tendenza quasi generale di disonorare il nome di Dio con le bestemmie, per questo nel primo articolo della preghiera, che i cristiani avrebbero recitato ogni giorno, pose la benedizione e la santificazione dell’adorabile Nome divino. Si santifichi il nome di Dio, che è lo splendore e la gloria di Dio stesso, che significa il Suo potere, la Sua santità, la Sua fedeltà, la Sua grandezza!
• Alcuni esempi. Nel villaggio di Edinghausen, non lontano dalla città di Bielfeld, un empio bestemmiatore della religione pensò un giorno di mettere in ridicolo il Sacramento della Eucaristia. Si sedette a mensa con i suoi amici, prese del pane e del vino, pronunciò su di essi le parole della consacrazione, e quindi li distribuì ai compagni. Quando toccò a lui di prendere quel pane e quel vino, si sentì venir male, lasciò cadere il capo sulla tavola, e dopo alcuni secondi era già morto. Questa storia non può essere messa in dubbio. Possa servire di esempio a tutti coloro, che si burlano dei sacri ministri e mettono in ridicolo le verità della religione ! (Smidt).
• Quando Ruperto, elettore palatino, nominato imperatore in luogo di Wenzel di Boemia, andò a Speier, un gran numero di condannati, come solevasi fare nelle elezioni di un nuovo imperatore, gli presentò domanda di grazia. Ruperto, avendo voluto che si prendessero informazioni sulla loro condotta, venne a sapere che uno di essi, cittadino di Speier, era stato esiliato per aver bestemmiato sovente il nome di Dio. Allora l’imperatore diede questa memoranda sentenza: «Farò grazia a tutti, fuorché al bestemmiatore, il quale continuerà a rimanere in esilio: poiché gli uni mancarono verso gli uomini, laddove l’altro peccò contro Iddio stesso e commise il più gran delitto di lesa maestà» (Lohn., Bibl., I, 236).
• Luigi IX, re di Francia, aveva fatto una legge, secondo la quale, a chiunque fosse convinto di bestemmia sarebbe stata forata la lingua con un ferro arroventato. Ora avvenne che un cittadino di Parigi si fece uscire di bocca pubblicamente una bestemmia orribile, e fu accusato davanti al re. Il re gli fece subire la pena stabilita, senza che fosse possibile ottenere grazia. A coloro che volevano intercedere per colui, rispose: «Lo perdonerei volentieri, se si fosse reso colpevole verso di me, ma non perdonerò giammai a colui che insulta pubblicamente alla maestà di Dio. Volentieri mi farei io stesso forare la lingua con un ferro arroventato, se con ciò potessi bandire la bestemmia dal mio regno». Il medesimo re raccomandò al suo figlio che quando fosse giunto a regnare, non lasciasse giammai impunita alcuna bestemmia (Idem., 226).
• Enrico II, re di Francia, ordinò che i bestemmiatori fossero puniti di morte come gli omicidi (Ber. Berc., Stor. Eccl., T. XVIII). Luigi XIV pubblicò anch’egli nel 1666 una legge contro la bestemmia. Tutti quelli che erano convinti d’aver bestemmiato il nome di Dio, della SS. Vergine e dei Santi, erano obbligati a pagare una multa che ogni volta si aumentava. La quinta volta si mettevano alla gogna, dalle ore otto del mattino sino ad un’ora dopo il mezzogiorno. Alla sesta trasgressione si bruciava loro il labbro superiore sul palco, ed alla settima l’inferiore. Se poi non si emendavano, si tagliava loro la lingua. Ancora: erano sottoposti alla multa, anche quelli che non accusavano colui che avessero udito bestemmiare (Idem., Lib. 78).
• Secondo l’antica disciplina ecclesiastica, ecco quali erano le pene che dovevano subire coloro i quali bestemmiavano contro Dio, la SS. Vergine ed i Santi. Il penitente doveva stare in piedi per sette domeniche consecutive innanzi alla porta della chiesa, l’ultima domenica senza mantello ed a piedi nudi con una fune intorno al collo. Inoltre era tenuto per quelle sette settimane a digiunare tutti i venerdì a pane ed acqua. In tutto quel tempo non poteva entrare in alcuna chiesa. Ogni domenica era obbligato a mantenere uno, due, e fino a tre poveri secondo che i suoi mezzi glielo permettevano. Se ricusava di sottomettersi alla penitenza gli era interdetto l’ingresso alla chiesa, e dopo morte gli si negava la sepoltura ecclesiastica (March. Hort., past. 503)
• Citiamo alcuni fatti, proprii a darci un’idea dell’orrore che deve ispirarci la bestemmia ed ogni specie di profanazione del nome di Dio. Quando a san Policarpo fu intimato dal giudice pagano di bestemmiare il Cristo, sotto pena di perdere la vita se non lo facesse, egli rispose con fermezza: «Sono ottantasei anni che lo servo, e non mi ha fatto mai del male; come potrei io bestemmiare il mio Re e il mio Salvatore?». Questo fu il linguaggio di quel santo vegliardo; egli amò meglio morire che bestemmiare il suo Dio (Euseb., Hist. Eccl., lib. 4). Sant’Ignazio di Loyola era solito dire che, se avesse dovuto essere precipitato nell’inferno, il suo maggior tormento sarebbe stato quello di sentir bestemmiare Iddio (Lohn., Bibl., I. 232). San Francesco Saverio scrisse in una delle sue lettere: «Io sono talvolta disgustato della vita, e preferirei morire piuttosto che continuare a vivere in un mondo in cui si bestemmia Iddio così spesso, e dove il suo onore è così indegnamente sconosciuto» (Idem.).
• Un soldato, essendosi confessato di aver l’abitudine di proferire giuramenti e bestemmie, e avendo dichiarato sinceramente che si sarebbe convertito qualora avesse conosciuto qualche rimedio efficace contro quella tendenza, il confessore gli consigliò di chinarsi come se volesse baciare lo sgabello dei piedi del Signore e di recitare questa preghiera: «Signore perdonatemi!». Il soldato seguì il consiglio, e fece grandi progressi nell’opera della sua conversione: ma avendo un giorno, in un combattimento, lasciato cadere la sua spada, proferì un orribile giuramento, e subito s’inchinò verso la terra seguendo il consiglio del suo Confessore. Mentre egli era così curvo, una palla passò sopra il suo capo, e l’avrebbe infallibilmente ucciso se fosse stato diritto. Da quel punto, non si sentirono mai più proferire da lui né giuramenti né bestemmie (Ibid.). Un empio, avendo un giorno proferito delle bestemmie alla presenza di san Girolamo, il Santo gli rivolse severi rimproveri : «I cani, gli disse, abbaiano in difesa del loro padrone; e voi sembra vi meravigliate perché io faccia sentir la mia voce, quando si tratta dell’onore di Dio? Tacerò io, quando si bestemmia il nome del Signore? Iddio me ne guardi! Posso morire, ma tacermi quando ascolto un simile linguaggio, non mai» (Nach., Sturml., B. 4, S. 178).
•Alcune sentenze: 1.- «Se voi amate Iddio nostro Signore con tutto il cuore, ditemi, potete voi ascoltare con indifferenza che si bestemmi e disprezzi il Suo nome, e che, invece di santificarlo, si disonori nella maniera la più vergognosa?» (San Bernardo, Sermone 44 in Cant.). 2.- «Tutti gli altri peccati sembrano derivare piuttosto dalla ignoranza o dalla debolezza umana, ma la bestemmia ha la sua fonte in una perfidia che non appartiene se non a Satana. Più la persona ingiuriata è alta in dignità, e più l’ingiuria è grande; quindi, quale enorme peccato non deve essere mai la bestemmia la quale si rivolge contro Dio stesso!». (Ibid., T. IV, Serm. 33). 3.- «O lingua diabolica, che cosa è mai che può indurti a vomitare bestemmie ed ingiurie contro il tuo Creatore, contro Colui che ti ha redento col sangue del Suo Figliuolo e ti ha consacrato per mezzo dello Spirito Santo, come un istrumento destinato a cantare le Sue laudi e la sua gloria?» (Ibid.). 4.- «Nulla è più odioso della bestemmia: tutte le altre colpe hanno per oggetto le cose di quaggiù, come l’avarizia, la lussuria, la gola: ma la bestemmia colpisce quello che v’è di più sublime, è rivolta al cielo» (San Gerolamo). 5.- «E che! con quella bocca medesima che gusta tutti i giorni tanti benefici di Dio, con quella lingua con la quale pregate, sulla quale ricevete il sacro corpo del Salvatore, oserete proferire delle bestemmie e dei giuramenti contro a Dio?» (Sant’Ephrem). 6.- «Voi che bestemmiate, non temete voi che il fuoco piova dal cielo per divorarvi, o che la terra si apra sotto i vostri piedi per inghiottirvi? Non v’illudete, o uomini: è impossibile sfuggire alla mano della giustizia divina. Iddio non vuole che alcuno si burli di lui» (Didacus, Stella in luce).
(A cura di CdP)
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

L’Associazione Sursum Corda esorta vivamente i propri Associati, Sostenitori e simpatizzanti a prendere parte al Pellegrinaggio Osimo - Loreto 2017, organizzato dall’Istituto Mater Boni Consilii.
Programma della manifestazione.
• Sabato 20 maggio 2017. - Ore 14:00 appuntamento ad Osimo, al parcheggio della chiesa san Carlo, in Via Molino Mensa, 1 (dal centro storico: direzione Macerata); sistemazione dei bagagli e inquadramento dei pellegrini. Si raccomanda la massima puntualità. - Ore 15:00 partenza a piedi; a Osimo venerazione del corpo di san Giuseppe da Copertino; sosta al santuario della B. V. Addolorata di Campocavallo; arrivo a Castelfidardo, distribuzione dei bagagli, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
• Domenica 21 maggio 2017. - Ore 7:45 Santa Messa. - Ore 9:00 colazione; sistemazione dei bagagli. - Ore 9:45 partenza; sosta al sacrario delle Crocette a Castelfidardo; arrivo a Loreto e pranzo al sacco. - Ore 14:30 processione alla basilica e preghiera nella Santa Casa di Loreto. - Ore 16:00 partenza del pullman per riportare i pellegrini a Osimo. - Ore 16:30 arrivo ad Osimo e fine del pellegrinaggio.
• Come raggiungere Osimo. - Per chi viaggia sull’autostrada A 14: uscire al casello di Ancona Sud-Osimo. - Per chi viaggia in treno: scendere alla stazione ferroviaria di Osimo. In questo caso comunicare l’orario d’arrivo all’organizzazione, che provvederà a venire prendere i pellegrini alla stazione. Per il viaggio di ritorno si invita a prendere il treno alla stazione di Loreto.
• Modalità del pellegrinaggio. - I pellegrini percorrono a piedi l’intero itinerario del pellegrinaggio (22 km), lasciando il sabato pomeriggio le automobili al parcheggio del san Carlo a Osimo. La domenica pomeriggio da Loreto un pullman ricondurrà i pellegrini alle automobili. - Prima dell’inizio del pellegrinaggio i bagagli personali saranno caricati su un furgone che li trasporterà direttamente a Castelfidardo, nel luogo del pernottamento. Durante il percorso i pellegrini in difficoltà potranno usufruire del servizio di alcuni pulmini. - Lungo il cammino i sacerdoti assicurano l’assistenza spirituale (recita del Santo Rosario, canti, meditazioni, confessioni). Si raccomanda di non usare i telefonini durante la marcia.
• I pasti. - Cena di sabato sera: in una trattoria. - Colazione di domenica mattina: all’Hotel Parco a Castelfidardo. - Pranzo di domenica: pranzo al sacco alle porte di Loreto. Ogni pellegrino deve arrivare al pellegrinaggio con il necessario (cibo, bevande, posate, ecc.), l’organizzazione fornisce del pane fresco e dell’acqua. Si consigliano inoltre bevande e alimenti energetici per la marcia e per le pause. • Attrezzatura e abbigliamento. - I pellegrini devono portare: a) un bagaglio con gli effetti personali per pernottamento: si consiglia di mettere un’etichetta con proprio nome sui bagagli per facilitare lo smistamento; b) un bagaglio con il cibo e bevande per il pranzo al sacco della domenica. - Si consiglia di portare una borraccia e uno zainetto per la marcia, contenete il necessario in caso di pioggia, gli effetti personali, gli energetici, ecc. Si consigliano delle scarpe comode ed un copricapo per proteggersi dal sole. Si invitano gli uomini ad evitare l’uso delle bermuda; si suggerisce alle signore ed alle signorine l’uso delle gonne sotto le ginocchia e un velo o copricapo per le preghiere nelle chiese e per l’assistenza alla Santa Messa.
• Pernottamento. - I pellegrini pernottano in alcune strutture alberghiere a Castelfidardo. Sono disponibili camere da due o tre posti, divise per le donne e per gli uomini. - I partecipanti devono quindi adattarsi a dormire con altri pellegrini. Ovviamente i nuclei familiari utilizzano la stessa camera. - I posti-letto sono limitati, quindi “chi primo arriva, bene alloggia”. - Per i ragazzi sono disponibili alcuni posti-letto in una sistemazione più economica. - Per mantenere lo spirito del pellegrinaggio e non disturbare gli altri partecipanti, i pellegrini sono invitati a rientrare nelle camere entro la mezzanotte.
• Quota di partecipazione. - La quota comprende: la camera d’albergo, la cena del sabato sera, la colazione della domenica mattina, l’uso della sala per il pranzo al sacco di domenica, il viaggio in pullman Loreto - Osimo al termine del pellegrinaggio. - Per gli adulti: 65,00 euro. - Per i bambini sino ai 14 anni: 50,00 euro. - Chi avesse delle difficoltà economiche (studenti, famiglie numerose, ecc.) non rinunci al pellegrinaggio: l’organizzazione potrà facilitare l’iscrizione. - Chi fosse impossibilitato a partecipare può inviare un’offerta per contribuire alle spese organizzative e per favorire l’iscrizione delle persone più bisognose. - N.B. Le iscrizioni sono relative alle singole persone e non alle associazioni, si prega pertanto di non partecipare al pellegrinaggio con bandiere o magliette relative a gruppi particolari.
• Versamento delle quote. - Prima del pellegrinaggio: versamento sul c.c. postale n. 51 17 99 27 intestato a: Ass. Mater Boni Consilii Onlus - Casa San Pio X specificando: “Pellegrinaggio a Loreto” (si prega di inviare per posta o per e-mail la copia del versamento). - Direttamente a Osimo mettendo la quota in una busta col nominativo del/i pellegrino/i da consegnare al sacerdote responsabile. - Agli iscritti impossibilitati a partecipare verrà trattenuta una quota di 30,00 euro.
• Le iscrizioni si devono effettuare UNICAMENTE alla Casa San Pio X entro giovedì 11 maggio 2017: - Casa San Pio X, Via Sarzana n. 86, 47822 San Martino dei Mulini (RN), Tel. 0541.758961, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note

In data 20 febbraio, 5 e 6 aprile 2017 l'Associazione Sursum Corda ha consegnato alla Caritas diocesana di Potenza, tramite un proprio Associato, circa 180 capi di abbigliamento, nuovi ed usati, tutti in buono stato, molti dei quali confezionati in singole buste. L'iniziativa è rivolta ai cristiani bisognosi che si trovano disoccupati, in serie difficoltà economiche, in pessimo stato di salute, purtroppo dimenticati da chi dovrebbe occuparsi materialmente di loro. L'acquisto o la raccolta di abbigliamento per i cristiani bisognosi proseguirà, a Dio piacendo, per tutto l'anno 2017. La prossima consegna è prevista per il mese di giugno 2017. Chi volesse contribuire può contattare l'Associazione per inviare beni di necessità od effettuare una donazione. Affidiamo tutti gli Associati, i Sostenitori ed i simpatizzanti alla protezione di San Giovanni di Dio!
Dalle «Lettere» di san Giovanni di Dio. Cristo è fedele e a tutto provvede
Se guardassimo alla misericordia di Dio, non cesseremo mai di fare il bene tutte le volte che se ne offre la possibilità. Infatti quando, per amor di Dio, passiamo ai poveri ciò che Egli stesso ha dato a noi, ci promette il centuplo nella beatitudine eterna. O felice guadagno, o beato acquisto! Chi non donerà a quest’ottimo mercante ciò che possiede, quando cura il nostro interesse e ci supplica a braccia aperte di convertirci a Lui e di piangere i nostri peccati e di metterci al servizio della carità, prima verso di noi e poi verso il prossimo? Infatti come l’acqua estingue il fuoco, così la carità cancella il peccato (cfr. Sir 3, 29). Vengono qui tanti poveri, che io molto spesso mi meraviglio in che modo possano esser mantenuti. Ma Gesù Cristo provvede a tutto e tutti sfama.
- Rinnovo annuale dell’iscrizione a Sursum Corda, anno 2017
- Comunicato numero 54. Bisogna esaminare tutte le religioni per riconoscere quella vera?
- Comunicato numero 53. Chiesa e Rivoluzione: può esserci conciliazione?
- Comunicato numero 52. San Giuseppe protettore della Chiesa
- Comunicato numero 51. Che cos’è la carità
- [Anticipazione] La Rivoluzione secondo mons. Gaston de Ségur
- L’Associazione Sursum Corda compie un anno: resistere al rispetto umano
- Comunicato numero 50. I cosiddetti cristiani moderni negano la legge di Gesù
- L’Associazione Sursum Corda dona 200 tascabili di «Preghiere cristiane» al carcere di Potenza
- Comunicato numero 49. La bolla «Exsurge Domine» contro Lutero























![[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1](/images/stories/virtuemart/product/resized/[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1_0x130.jpg)