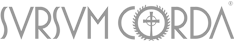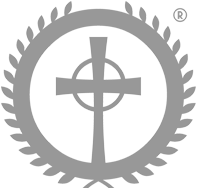Stimati Associati e gentili Sostenitori, Vi ricordiamo di leggere sul nostro sito il nuovo Regolamento sul trattamento dei dati personali. Il link da usare è il seguente: cliccare qui. Il dotto Abate Ricciotti oggi ci parla delle nozze di Cana.
• § 281. Il colloquio con Nathanael è un nuovo punto di partenza per la cronologia dell’evangelista San Giovanni; egli fa sapere che «il terzo giorno dopo quel colloquio si fecero nozze in Cana della Galilea, ed era la madre di Gesù colà; e fu invitato anche Gesù, e i suoi discepoli, alle nozze» (Giov., 2, 1-2). Poiché, come abbiamo visto, Nathanael era appunto di Cana, è verosimile che egli stesso abbia invitato Gesù e i suoi discepoli Andrea, Pietro, Giovanni e Filippo alle nozze, le quali saranno state di qualche parente o amico di Nathanael stesso; tuttavia dalle parole di Giovanni sembra risultare chiaramente che era la madre di Gesù colà anche prima dell’arrivo del figlio, e ciò induce a congetturare che pure tra Maria e uno degli sposi esistesse qualche legame: come parente o amica, ella si sarà recata là qualche giorno prima per aiutare le donne di casa nei preparativi, specialmente della sposa, ch’erano lunghi. Non hanno invece alcuna verosimiglianza certi almanaccamenti tardivi che vedono nello sposo o Nathanael stesso, l’evangelista Giovanni, o altri. La Cana visitata comunemente oggi in Palestina è Kefr Kenna, che seguendo la strada maestra sta circa a 10 chilometri a nord-est di Nazareth sul percorso verso Tiberiade e Cafarnao, mentre ai tempi di Gesù la distanza fra questa Cana e Nazareth era 3 o 4 chilometri più breve. Ma anticamente esisteva un’altra Cana ridotta oggi a un campo di ruderi, Kirbet Qana, a 14 chilometri a nord di Nazareth. Si disputa fra gli archeologi quale di questi due luoghi sia la Cana del IV Vangelo; in favore di ambedue i luoghi esistono ragioni non spregevoli, sebbene non decisive, e le stesse relazioni scritte degli antichi visitatori sono applicate in favore dell’uno o dell’altro. La questione dunque è tuttora incerta, e d’altra parte non è cosa indispensabile risolverla. Le nozze di Cana furono i nissū’īn del cerimoniale giudaico (§ 231). La festa che li accompagnava era certamente la più solenne di tutta la vita per la gente di basso e medio grado sociale, e poteva durare anche più giorni. La sposa usciva dalle mani delle parenti e delle amiche tutta agghindata pomposamente, con una corona in testa, imbellettata in viso, con gli occhi splendenti di collirio, con i capelli e le unghie dipinti, carica di collane, braccialetti e altri monili per lo più falsi o presi in prestito. Lo sposo, incoronato anch’esso e circondato dagli «amici dello sposo», andava sul far della sera a rilevare la sposa dalla casa di lei, per condurla alla propria; la sposa lo attendeva circondata dalle sue amiche, munite di lampade ed acclamanti al giungere dello sposo. Dalla casa della sposa a quella dello sposo si procedeva in corteo, a cui prendeva parte tutto il paese, con luminarie, suoni, canti, danze e grida festose. Tanta era l’autorità morale di siffatti cortei, che perfino i rabbini interrompevano le lezioni nelle scuole della Legge ed uscivano con i loro discepoli a festeggiare gli sposi. A casa dello sposo si teneva il pranzo, con canti e discorsi augurali, i quali talvolta non erano immuni da allusioni ardite, specialmente quando il pranzo era inoltrato e la comitiva era tutta più o meno brilla. Si beveva infatti senza parsimonia, si tracannava cordialmente, essendone tanto rara l’occasione per gente che tutto l’anno faceva vita grama e stentata. E si bevevano vini speciali, messi in serbo da gran tempo e custoditi appunto per quella festa; ancora oggi si possono scorgere in un oscuro angolo di qualche casa araba file di misteriose giarre, e il padrone di casa dirà con compunzione grave che non devono toccarsi perché è vino per nozze. Del resto nelle sacre Scritture ebraiche si leggeva che il vino letifica il cuore dell’uomo, e quella gente voleva obbedire alle Scritture almeno nella letizia nuziale.
• § 282. A tale festa così cordiale, così umana anche nelle sue debolezze, volle partecipare Gesù, come certamente pure Maria avrà contribuito al pomposo rivestimento della sposa. Quando Gesù era ancora ragazzo a Nazareth, sua madre gli avrà più volte narrato che un po’ di festicciuola era stata fatta anche quando si erano celebrati i nissū’īn per lei, ed ella era entrata in casa di Giuseppe (§ 239). Allora era sorta una nuova famiglia, che Gesù aveva onorata e santificata con un’obbedienza trentennale; adesso, ch’egli sta per uscire da questa famiglia, quasi si volge addietro con rimpianto e vuole onorare e santificarne il principio morale costitutivo. Per questa ragione Gesù, il nato da vergine e che morirà vergine, interviene a nozze al termine della sua vita privata e al cominciare di quella pubblica. Anzi, la cominciò con un miracolo tale che, mentre dimostrava la potenza di lui, direttamente servì a rendere sempre più liete e festose quelle nozze. Accortamente San Giovanni (2, 11), dopo aver raccontato il miracolo, conclude osservando che quello di Cana fu l’inizio dei «segni» miracolosi di Gesù. A Cana Gesù ritrovò sua madre dopo circa due mesi d’assenza. Era stata forse la prima lunga assenza di lui dalla casa paterna; essendo già morto Giuseppe, la bottega in quel tempo era rimasta inoperosa e Maria senza compagnia. In quella prima solitudine, più che mai, ella avrà ripensato a lui, alla sua nascita e alla sua preannunziata missione, intravedendo che questa stava per cominciare: e avrà fatto ciò, mentre doveva schermirsi dalle domande delle indiscrete donne del paese, o anche dai frizzi degli acrimoniosi parenti (§ 264), che avranno voluto sapere perché Gesù l’avesse lasciata sola, e dove fosse andato, e a quale scopo, e quando sarebbe tornato. Adesso, a Cana, ella se lo rivedeva davanti, già chiamato Rabbi, considerato come un maestro e circondato da alcuni fervorosi discepoli: indubbiamente la previsione fatta nella sua solitudine stava per avverarsi. Ma, anche davanti al Rabbi, Maria rimase sempre madre, quale si era mostrata davanti al ragazzo dodicenne disputante nel Tempio. Da buona madre di famiglia Maria, durante quel pranzo di nozze, avrà sorvegliato insieme con le altre donne che tutto procedesse regolarmente, e le vivande e ogni cosa fossero pronte. Senonché sul finire del pranzo - o perché si erano fatti male i calcoli, o perché erano sopraggiunti convitati imprevisti - venne a mancare proprio il principale, il vino. Le massaie che amministravano ne furono costernate. Era il disonore per la famiglia che ospitava; i convitati non avrebbero risparmiato proteste e scherni, e la festa sarebbe finita bruscamente e ignominiosamente, come quando a teatro in una scena decisiva viene a mancare la luce.
• § 283. Maria s’avvide subito della mancanza, e previde la vergogna degli ospitanti; tuttavia non ne fu costernata come le altre donne. Al suo spirito la presenza del suo figlio Rabbi diceva tante cose che non diceva agli altri; soprattutto ella ricollegava quella presenza con la previsione da lei fatta nella sua solitudine di Nazareth. Non era forse giunta l’ora di lui? Dominata da questi pensieri Maria, fra lo smarrimento generale a mala pena dissimulato, dice sommessamente a Gesù: «Non hanno vino». E dice a lei Gesù: «Che cosa (è) a me e a te, donna? Non ancora è giunta l’ora mia» (Giov., 2, 3-4). Gesù pronunziò queste parole in aramaico, e secondo questa lingua esse vanno interpretate. In primo luogo donna era un appellativo di rispetto, circa come l’appellativo (ma)donna nel Trecento italiano. Un figlio chiamava ordinariamente madre la donna che lo aveva generato, ma in circostanze particolari poteva chiamarla per maggior riverenza donna. E donna chiamerà nuovamente Gesù sua madre dall’alto della croce (Giov., 19, 26); ma anche prima, secondo un aneddoto rabbinico, un mendicante giudeo aveva chiamato donna la moglie del grande Hillel, come Augusto aveva chiamato donna Cleopatra, e così in altri casi. Più tipica è l’altra espressione che cosa (è) a me e a te...?, è certamente traduzione della frase fondamentale ebraica mah lī wal (āk) che ricorre più volte nella Bibbia. Ora, il significato di questa frase era precisato nell’uso molto più dalle circostanze del discorso, dal tono della voce, del gesto, ecc., che dal semplice valore delle parole; tutte le lingue hanno di tali frasi idiomatiche in cui le parole sono rimaste un semplice pretesto per esprimere un pensiero, e che verbalmente non si possono tradurre in altra lingua. Nel caso nostro una parafrasi, che tenga qualche conto anche delle parole ebraiche, potrebbe essere questa: Che (motivo fa fare) a me e a te (questo discorso)?; il che, indipendentemente dalle parole, equivale all’espressione italiana: Perché mi fai questo discorso? Era insomma una frase ellittica con la quale si ricercava la recondita ragione per cui tra due persone avveniva un discorso, un fatto, e simili. Con questa risposta Gesù declinava l’invito fattogli da Maria, e ne adduceva come ragione il fatto che ancora non era giunta l’ora sua. Dunque in quelle tre sole parole di Maria non hanno vino (seppure furono dette quelle tre sole) era nascosto l’invito a compiere un miracolo, e la mira dell’invito era nettamente designata dalle circostanze esterne ma soprattutto dai pensieri interni e dal volto materno di colei che invitava. Gesù, che si rende ben conto di tutto, rifiuta, come già nel Tempio aveva rifiutato di subordinare la sua presenza nella casa del Padre celeste a quella nella sua famiglia terrena (§ 262): ancora non è giunta l’ora di dimostrare con miracoli l’autorità della propria missione, poiché il precursore Giovanni sta ancora svolgendo la sua. Tuttavia il dialogo fra Maria e Gesù non è finito; anzi le sue più importanti parole non furono mai pronunziate da labbro, ma solo trasmesse da sguardo a sguardo. Come già nel Tempio Gesù dopo il rifiuto aveva obbedito lasciando subito la casa del Padre celeste, così dopo questo nuovo rifiuto accede senz’altro all’invito di Maria. La madre, nel dialogo muto seguito al dialogo parlato, viene assicurata che il figlio acconsente; perciò senza perdere tempo si volge agli inservienti e dice loro: Fate tutto ciò che vi dirà!
• § 284. Nell’atrio di quella casa erano sei grandi pile destinate alle abluzioni delle mani e delle stoviglie prescritte dal giudaismo: perciò le pile erano di pietra, perché secondo i rabbini la pietra non contraeva impurità come la terracotta. Ed erano pile grandi, contenendo ciascuna due o tre volte la normale «misura» giudaica, la quale si aggirava sui 39 litri; dunque, tutte insieme avevano una capacità di circa 600 litri. Naturalmente il pranzo era lungo, i convitati erano molti, e quindi tutta quell’acqua necessaria era stata in gran parte consumata e le pile erano quasi vuote. Gesù allora dette ordine di riempire totalmente le pile; gl’inservienti corsero al pozzo o alla cisterna vicina, e in pochi viaggi le pile furono colme. Non c’era altro da fare; e dice a quelli: «Attingete adesso, e portate al direttore di mensa». E quelli portarono (Giov., 2, 8). Tutto si era svolto in pochi minuti, anche prima che il direttore di mensa notasse lo smarrimento delle donne e s’avvedesse che non c’era più vino; la discretezza di Maria aveva impedito anche il dilagare dello scandalo familiare. Quando il direttore di mensa si vide davanti una nuova specie di vino, e l’ebbe assaggiata com’era suo ufficio, rimase strabiliato, tanto che dimenticò anche il sussiego della sua carica e parlò con la schiettezza del buon popolano. Avvicinatosi allo sposo, gli dice: «Ogni uomo passa prima il vino buono, e quando sono brilli quello peggiore; tu (invece) hai serbato il vino buono fin qui!» (Giov., 2, 10). Le parole del direttore di mensa non alludono a qualche uso corrente, che non ci è attestato da nessun documento antico; vogliono essere piuttosto un complimento spiritoso, che fa notare quanto fosse inaspettata sul finire del pranzo quell’ambrosia e in quella quantità. Ma, a quelle parole, lo sposo probabilmente guardò ben bene in faccia il direttore di mensa, domandandosi se proprio lui non fosse il più brillo di tutti: egli, lo sposo, non si era mai sognato di riserbare per la fine del pranzo quella sorpresa del vino migliore. Alcune poche interrogazioni rivolte agli inservienti e alle donne indirizzarono le ricerche su Maria e poi su Gesù, e tutto fu spiegato. Così questo primo miracolo, dice San Giovanni, «Gesù manifestò la sua gloria e credettero in lui i suoi discepoli». Ciò non meraviglia, se si pensa all’entusiasmo che già avevano per Gesù i suoi pochi discepoli. Ma quale sarà stata l’impressione prodotta sui commensali dal miracolo? Dissipati i fumi del convito e dimenticato il sapore di quel misterioso vino, avranno essi ripensato al significato morale dell’avvenimento?
• § 285. Dopo la festicciuola e il miracolo Gesù si recò a Cafarnao, «egli e la madre di lui e i fratelli e discepoli di lui, e colà rimasero non molti giorni» (Giovanni, 2, 12). Questa permanenza a Cafarnao fu breve, perché Gesù aveva deciso di recarsi a Gerusalemme per l’imminente Pasqua; ma fin da allora Cafarnao servì a Gesù come abituale dimora in Galilea, divenendo sua patria adottiva invece di Nazareth. Dalla sua famiglia egli già si era staccato, ed all’istituzione familiare aveva anche dedicato in omaggio il suo primo miracolo: adesso si staccava anche dall’umilissimo suo paese, trasferendosi in luogo più opportuno per la sua missione che cominciava. Cafarnao era sulla riva nord-occidentale del lago di Tiberiade non lontano dallo sbocco del Giordano nel lago. Situata a 13 chilometri a nord della città di Tiberiade e a circa 30 a oriente di Nazareth, era presso i confini fra il territorio di Erode Antipa e quello di Filippo; perciò era fornita anche d’un ufficio di dogana, ed era luogo di transito. Sul lago aveva un piccolo porto conveniente per i pescatori. La vita religiosa vi doveva essere intensa e non molto disturbata dall’ellenismo insediato poco sopra; suo presidio ivi era, come sempre, l’edificio della sinagoga oggi fortunatamente conservato e ritornato alla luce, sebbene nella precisa forma in cui è stato ritrovato sembri appartenere a tempi posteriori a quelli di Gesù. Il suo nome Kephar Nahūm, «villaggio di Nahum», proveniva da un personaggio Nahum a noi ignoto; in tempi molto posteriori si venerò ivi la tomba di un rabbino Tanhum, il cui nome fu poi deformato in Tell Hūm, che è l’odierno nome del luogo. A imitazione di Gesù, man mano verranno a stabilirsi a Cafarnao anche i suoi primi discepoli oriundi della vicina Bethsaida, quali Simone Pietro e Andrea. Quanto a Simone Pietro, è probabile che già avesse a Cafarnao legami di parentela; se egli, genero generoso, alberga ivi in casa sua la propria suocera (§ 300), non è arrischiato supporre che la moglie di lui fosse appunto di Cafarnao. Più tardi poi, per designare Cafarnao, si finirà per chiamarla senz’altro «la città propria» di Gesù (Matteo, 9, 1), sebbene lo stesso documento poco appresso designi Nazareth ancora come «la patria di lui» (Matteo, 13, 54). Il libro usato è «Vita di Gesù Cristo» - Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano e Roma, 1941, dell’Abate Giuseppe Ricciotti: riposi in pace! Fine.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.


























![[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1](/images/stories/virtuemart/product/resized/[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1_0x130.jpg)