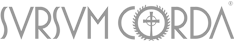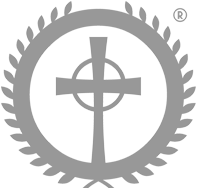Stimati Associati e gentili Sostenitori, tra le conseguenze immediate, anzi una proprietà essenziale della divina ispirazione, è l’inerranza, ossia l’infallibilità di quanto scrive l’agiografo e scrittore sacro. Ne abbiamo già parlato a sufficienza anni fa su Sursum Corda, studiando altresì le sentenze della Chiesa a riguardo. Infallibilità di quanto scrive l’agiografo, né potrebbe essere altrimenti: dal momento che quello scritto è, in tutto rigore del termine, parola di Dio, è perciò stesso posto sotto la garanzia di quella infinita veracità a cui ripugna essenzialmente ogni errore. Nel caso di libri storici, la verità garantita per infallibile sarà la verità storica di quanto ci vien narrato con tutti i relativi particolari della narrazione. Sennonché, a voler percepire con ogni esattezza tale verità, fa d’uopo che si tengano presenti varie osservazioni, che sono, per così dire, come altrettanti punti di vista, ove dobbiamo collocarci per riportarne la giusta visione. Nell’odierno approfondimento ci faremo aiutare dal P. F. S. Porporato, «La verità nei libri storici della Bibbia», SOS (Collezione di Opuscoli Apologetici per le Persone Colte), imprimatur 1945.
• Verità della citazione e verità del contenuto. Anzitutto conviene badare a distinguere il racconto che l’agiografo dà come suo proprio o che approva, da quanto egli riferisce semplicemente come racconto altrui.
• Alcuni esempi. Prendiamo il fatto della morte di Saulle. L’agio-grafo ce lo racconta nel primo libro dei Re (31, 3-6). L’infelice monarca, nella battaglia contro i Filistei sulle alture di Gelboe, ha avuto l’esercito in piena rotta e volto in fuga. Egli stesso, gravemente ferito, si vede in procinto di cadere nelle mani dei nemici. In tale frangente, prega il suo scudiero di ucciderlo, ma questi ricusa. Saulle, allora, afferra la propria spada e vi si getta sopra, troncandosi così la vita con un suicidio. A quella vista lo scudiero ne imita l’esempio, anch’egli si uccide allo stesso modo. Questa la narrazione fatta dall’agiografo e che viene ripetuta nel libro l° dei Paralipomeni (10, 1 segg.), quasi con le medesime parole. Ora ecco nel libro 2 dei Re (1, 1 segg.), una seconda narrazione del medesimo fatto, ma con particolarità ben diverse. Un amalecita si è recato tutto frettoloso da Davide che stava nella città di Siceleg, tuttora ignaro dell’accaduto, e gli narra la sconfitta dell’esercito e la morte di Saulle sui monti di Gelboe. L’aveva visto nell’atto che, gravemente ferito, stava ricurvo appoggiato sulla propria lancia: era oppresso da spasimi atroci. All’avvicinarsi dei nemici, Saulle stesso l’aveva chiamato a gettarsi sopra di lui e a finirlo: egli lo aveva fatto. In prova, mostrava il diadema e i braccialetti tolti all’ucciso e portati lì davanti a Davide. Come non vedere che la seconda narrazione contraddice alla prima? Falsità, dunque, nell’agiografo ispirato? Per nulla.
• L’agiografo non fa che riferire il racconto tale e quale fu in realtà esposto dall’amalecita, e di questo solo si rende garante (veritas citationis); che poi a quel racconto risponda l’esattezza storica (veritas rei citatae = verità del contenuto nella citazione) è ben altro. L’agiografo stesso lo nega implicitamente, dal momento che proprio nel capo ultimo del libro precedente ci ha narrato la morte di Saulle ben altrimenti. L’opportunità, però, dell’episodio è evidente. Senza di esso l’atto magnanimo di Davide che, lungi dal rallegrarsi, punisce di morte l’amalecita per avere ucciso l’Unto del Signore e che piange cordialmente sulla morte di Saulle, statogli tanto nemico, non sarebbe giunta a conoscenza dei posteri.
• Allo stesso modo è da sciogliere la difficoltà che sorge sulla morte di Antioco IV Epifane. Tre volte vien essa narrata. Nel primo libro dei Maccabei (capo 6, 1-16), è detto che Antioco, stando in Persia e bramando di impadronirsi dei tesori racchiusi nel tempio di una città della Elimaide, da una sollevazione popolare è costretto a darsi alla fuga. Intanto eccogli recate le funeste notizie delle sconfitte toccate dai suoi nella Giudea, onde ripieno di tristezza profonda muore, non già a Babilonia, come falsamente viene da alcuni interpretato, ma mentre è m viaggio alla volta di Babilonia, dove aveva intenzione di giungere. Tale il testo greco che dice: «Si ritirò per tornare in Babilonia». Nel secondo libro dei Maccabei (9, 3), Antioco, dopo la fuga di Elimaide, è fatto morire a Ecbatana (leggi Aspadana, la Gabe dei Greci, rispondente all’odierna Ispahan). È questo un particolare che rende più precisa la notizia, troppo vaga, del libro precedente, designando il punto del viaggio, ove realmente ebbe le tristi notizie della Giudea e dove, colpito da morbo schifoso e ribaltato dal cocchio, in preda alla vergogna, al dispetto, ai rimorsi, morì. Come si vede nulla di contraddittorio nei due testi. Essi si integrano a vicenda: il secondo, più ricco di particolari, illustra il primo, e in essi i due autori sacri hanno esposto direttamente il loro pensiero. Ora ecco come, invece, narra la lettera scritta dai Giudei di Gerusalemme ai Giudei di Alessandria in Egitto e riportata al principio del secondo libro dei Maccabei (2, 10-17). Antioco, trovandosi in Persia, sotto pretesto di sposare la dea Nannea, cerca d’impadronirsi dei tesori del tempio a titolo di dote. I sacerdoti fingono di accontentarlo, ma appena è entrato nel tempio, chiuse subito le porte, uccidono lui e tutti i suoi a colpi di pietre [Cfr. Zerwick, in Verbum Domini, 19 (1939), pag. 308-314. C’è chi pensa che nella citata lettera si parli di Antioco III il grande, ucciso appunto mentre voleva rapire i tesori del tempio di Bel e di Nannea in Elimaide. Ma essa parla evidentemente della morte del persecutore dei Giudei (1, 72) e non fu mai tale Antioco III. Pertanto vi si hanno da vedere riflesse le false voci che, in un primo tempo, corsero nella Giudea sulla morte di Antioco Epifane].
• La contraddizione ai due primi racconti è palese. Falsità dunque nell’agiografo ispirato? No. È una citazione, e altro è che la lettera sia stata veramente scritta quale vien riportata, e di questo ci assicura con infallibile certezza l’agiografo, altro che sia vero il suo contenuto a proposito della morte di Antioco. L’agiografo stesso tacitamente ci avverte di correggere, quando egli narrerà poi quella stessa morte in ben altra maniera al capo 9, 1-28.
• Qualche difficoltà. Questo principio che lo storico ispirato non fa sue le parole del documento citato, salvo il caso in cui le approvi o espressamente o in altra maniera equivalente, ha un’ampia applicazione, e alla sua luce si dileguano non poche difficoltà che certi critici vorrebbero far passare come altrettanti abbagli storici dell’agiografo. Leggono, per esempio, nel primo libro dei Maccabei (8, 1-17) l’elogio fatto dei Romani e della loro politica, e gridano: Ciò è falso; come è falso che il senato si adunasse (vers. 15) ogni giorno, falso che un solo eletto annualmente avesse in mano il governo della repubblica (vers. 16). Chi non sa che i consoli annui erano due? Nello stesso libro (12, 6-18. 20-23) due lettere, l’una del sommo sacerdote Gionata agli Spartani, l’altra del re spartano Areo in risposta ai Giudei, parlano di comunanza di stirpe tra Giudei e Spartani (sono fratelli e della stirpe di Abramo ). Ma chi vorrà ciò ammettere per vero?
• Ebbene con l’osservazione fatta qui sopra sarà facile la risposta. Nel primo caso l’agiografo non ci esprime il proprio pensiero, ma si limita a riferire quanto Guida Maccabeo aveva udito dire dei Romani (et audivit Iudas... 8, 1), per la voce che ne correva; che poi tal voce non rispondesse alla realtà dei fatti, è cosa in cui l’agiografo non entra. Nel secondo caso l’agiografo non fa che riportare le due lettere, ove è espressa quell’opinione; ma di suo non una parola che confermi o che approvi: tutta la responsabilità è quindi lasciata agli autori dei documenti [Parimenti quando scriverà che Giasone, già usurpatore del Sommo sacerdozio, andato ramingo in diverse parti, finalmente si ridusse presso gli spartani, sperando di trovare colà un rifugio per l’affinità di razza (quasi pro cognatione refugium habiturus - 2 Macc. 5,10), manifestamente non vi esprime il pensiero suo proprio, bensì quello di Giasone].
• Caso invece ben diverso è quando, per esempio, l’Autore del 3 e 4 dei Re e l’Autore dei Paralipomeni indicano i documenti a cui attingono le notizie che scrivono. Essi allora non riferiscono semplicemente, ma manifestamente mostrano di approvare quanto riferiscono, facendoselo proprio: perciò ce ne garantiscono la piena verità. Si osservi ancora in che differente maniera parla l’autore sacro, quando narra (2 Macc. 12, 43) che Giuda Maccabeo aveva inviato al tempio di Gerusalemme, per l’offerta d’un sacrificio a prò dei caduti in battaglia, la colletta di 2000 dramme (12000 dice la Volgata). Due idee avevano suggerito quel fatto: riguardavano l’una la finale risurrezione dei corpi con la relativa sopravvivenza delle anime dopo morte, l’altra i suffragi giovevoli a coloro che erano morti nella pietà. Ora, per l’una e per l’altra, l’agiografo appone il suggello della sua approvazione: qualifica la prima come «giudizio giusto e pio» [bene et religiose de resurrectione cogitans (Judas) vv. 43, 44]; chiama la seconda «pensiero santo e salutare» (sancta ergo et salubris est cogitatio pro defunctis exorare ut a peccatis salvantur, v. 46).
• I discorsi nei libri storici. Quanto abbiamo detto delle citazioni, lo possiamo applicare anche ai discorsi che troviamo riferiti nei libri storici della Bibbia. Anche qui indubbiamente avrà luogo la «verità della citazione» (veritas citationis) e non sarebbe lecito credere che tali discorsi siano invenzione fittizia dell’autore che scrive. Perciò ci sembra che hanno avuto torto quanti, nei discorsi dei libri dei Maccabei, pretesero che fosse salva tale verità per questo solo che quei discorsi sono conformi alle idee e all’indole di chi parla, adatti alle condizioni del tempo e come sbocciati spontanei dalla realtà stessa degli avvenimenti [Fra questi si ha da annoverare anche il Knabenbauer, Commentarius in duos libros Macch., Parisiis (1907), p. 358]. Hanno poi errato quanti, nei discorsi del quarto Vangelo, vollero vedervi «non discorsi veri e propri del Signore, ma composizioni teologiche dello scrittore, poste in bocca al Signore» (Commiss. Biblica circa l’autore e la verità storica del 4° Vangelo, 29 maggio 1907, n. 3. Cfr. anche il decreto «Lamentabili», prop. 16).
• Hanno errato quanti, col Renan (Histoire des origines du Christianisme, Tome II; Les Apotres, Paris, 1866, pag. XXVIII s.), vollero giudicare dei discorsi contenuti negli Atti Apostolici (che sono ben 27) alla stregua di quelli che ci offrono gli storici classici: Erodoto, Tucidide, Senofonte fra i Greci; Sallustio, Tito Livio e anche Tacito fra i latini; dove i pensieri elaborati dal genio di chi scrive, per artifizio retorico, sono messi in bocca or a questo or a quel personaggio, a volte per metterne in rilievo l’animo e il carattere, altre volte per descrivere, in modo più drammatico, la situazione di un dato momento. Si è detto, quanto ai discorsi riportati dagli Atti, che sono troppo brevi: tanto brevi che il più lungo di essi, quello di Santo Stefano (cap. 7), non pare possa durare più di sette o dieci minuti: or come possono aversi per autentici? Fa davvero meraviglia che l’occhio della critica siasi fatto così miope da non riuscire a vedere cosa tanto manifesta, che cioè quei discorsi San Luca li reca soltanto in compendio e non già per intero. Si è ripetuto che l’uniformità di stile in discorsi appartenenti a tanti personaggi così diversi, tradisce l’artifizio della finzione. Ma non è forse naturale che chi redige un compendio lo faccia sempre in uno stile che è lo stile suo proprio, massime quando il compendio è fatto in altra lingua da quella in cui i discorsi furono pronunziati? È il caso di San Luca che compendia e non solo, ma che, il più delle volte, compendia in lingua greca discorsi aramaici.
• Ciò posto, non si ha diritto di esigere altro che questo, che i pensieri, pur così compendiati nello stile dell’autore, siano veramente di quel dato oratore a cui vengono attribuiti. Ebbene che sia appunto così e non altrimenti, ce lo garantisce la divina ispirazione, la quale per ciò che spetta alla «veritas citationis» non può assolutamente errare. Del resto anche considerati unicamente dal lato letterario, quei discorsi mostrano tale autenticità, che il celebre filologo Fr. Blass, acattolico, poté scrivere: «Che ha da fare Luca con gli storici greci e romani, mentre non v’è neppure il minimo indizio che li abbia letti o li abbia imitati? Quanto più attentamente si considerano questi discorsi (di San Luca) tanto più si trovano ragioni che vietano di riferirli ad una libera retorica dello scrittore, tanto sono adattati egregiamente ai tempi e alle persone... Davvero mi meraviglio che in cosa tanto manifesta possano alcuni ancora dubitare» (Acta Apostolorum - editio philologica. Guttingen, 1895, pag. 11).
• Ma che pensare per ciò che riguarda alla «veritas rei citatae» e cioè al contenuto del discorso citato? Diremo subito che, ove non intervenga l’approvazione esplicita o tacita dell’agiografo, il solo fatto di essere un discorso riportato nella Scrittura non conferisce al discorso alcun nuovo valore, oltre quello che esso ha da se stesso. Esaminiamo il discorso di Santo Stefano, tenuto davanti al Sinedrio di Gerusalemme, e riportato da San Luca al capo settimo degli Atti. Quanto è ivi contenuto è tutto vero? I particolari di alcuni fatti (7, 4. 14-16) mal si accordano con i particolari che dei medesimi fatti ci dà il testo ebraico del Genesi (33, 19 cf. 23, 8-19; 11, 32; 46, 26 s.) riprodotto nella nostra Volgata, tanto che gravi autori, quali San Beda Venerabile, Dottore della Chiesa, il Beato Rabano Mauro, Melchior Cano ed altri non esitano a confessare che quelli sono errori, incorsi, per manco di memoria, durante la foga del parlare. Ebbene siano errori, non vogliamo qui discutere: diremo però che tali errori non sarà lecito mai di addebitarli a San Luca. Egli, da storico coscienzioso, ci dà, sì, fedelmente la sostanza del discorso tenuto, ma delle singole asserzioni ne lascia, come è naturale, la responsabilità a chi le ha pronunziate. Il quale, pur essendo pieno di Spirito Santo per confondere i Giudei, non consta che nel parlare fosse anche divinamente ispirato nel senso stretto della parola, in modo da non incorrere nessun errore, neanche in particolari di minima importanza.
• Citazioni implicite? Più sottile e delicata è la questione, non forse l’agiografo, senza dar segno nessuno di citazione, faccia tuttavia di fatto una citazione in ciò che narra, riportando documenti da lui posseduti, ma senza volerne garantire la veracità. È il caso delle cosiddette «citazioni implicite o tacite», mediante le quali da alcuni si vorrebbero risolte una quantità di difficoltà bibliche, specie in materia di storia. Esagerazione. Ecco a proposito il responso della pontificia Commissione Biblica. Richiesta se, per spiegare le difficoltà che si incontrano in alcuni passi della Sacra Scrittura che riferiscono fatti storici, sia lecito all’esegeta cattolico dire che in essi si tratta della citazione tacita o implicita di un documento, scritto da un autore non ispirato, di cui l’autore ispirato non intende approvare o far sue le asserzioni, le quali per conseguenza si possono considerare come non immuni da errore, rispondeva il 13 febbraio 1905 nei termini seguenti: «No, non è lecito, eccettuato il caso in cui, con buoni argomenti, si possa dimostrare: l.o) che l’agiografo davvero cita effati o documenti altrui; 2.o) che egli non li fa suoi né li approva; sicché a buon diritto si possa ritenere che non parli in nome proprio. Sempre inteso che bisogna essere disposti ad accettare il senso e il giudizio della Chiesa». E ben a ragione: perché altrimenti quel principio potrebbe aprire la via a infinite applicazioni errate e condurre a un dubbio metodico e a un pratico scetticismo circa il reale valore e l’oggettività della storia biblica.
• Le genealogie bibliche. Un’altra osservazione conviene tener presente. È un canone di senso comune, che ogni testo, dunque anche il sacro, debba essere spiegato nella luce della mentalità di chi scrive, e secondo l’indole particolare e la proprietà del linguaggio in cui scrive: linguaggio che in determinati casi potrà essere affatto convenzionale. Perciò pretendere che la verità sia espressa secondo un dato criterio particolare, o peggio, sia espressa secondo i criteri propri di noi occidentali, di noi figli del nostro secolo, sarebbe un’esorbitanza ridicola. Noi, per esempio, in una genealogia siamo soliti enumerare con accuratezza i singoli anelli della serie genealogica, e ci suonerebbe male, se un individuo determinato apertamente si dicesse figlio o generato da tale che in realtà è il suo nonno o bisnonno o altro più remoto antenato. Sono questi gusti e costumi nostri, ma senza paragone differentissimi dai gusti e costumi dei semiti e in genere degli orientali. Per essi «figlio» è sinonimo di «discendente», perciò dirlo generato da un suo antenato, qual che esso sia, è cosa usuale e corrente, massime quando lo schema genealogico è fatto per uno scopo mnemonico. Orbene lo scritto ispirato rispecchia quest’usanza, e chi, applicando ad essa i criteri nostri, presume di coglierla in fallo, non fa che mostrare la propria imperizia circa la conoscenza dei costumi di età e di popoli che non sono i nostri. Esemplifichiamo.
• Troviamo nei primi capi del Genesi che, posto a capostipite Adamo, ci viene tracciato un albero genealogico dei patriarchi che si succedono. Ma di che genere è questa successione? Immediata o mediata? Di questo tace la Scrittura, e benché dei singoli anelli dica sempre che il precedente generò il seguente, posta la spiegazione data più sopra, noi non siamo obbligati a vederci l’una piuttosto che l’altra successione, dal momento che l’una e l’altra vi possono aver luogo. «Quindi lo parole, per esempio, Sem a 100 anni generò Arfaxad e visse di poi cinquecento anni si possono spiegare in questo modo: Sem a cento anni generò un tale N. da cui (per una serie di membri non determina in individuo e dopo un tempo non indicato) fu generato Arfaxad». Un indizio, poi, che la successione non sia immediata potrebbe essere il modo artificioso onde paiono disposti i Patriarchi nella loro genealogia: sono dieci prima del diluvio (Gen., 5), parimenti dieci (Così nella versione greca dei 70, dove tra Arphaxah e Sale viene interposto Cainan. Cfr. Luc., 3, 36) dopo il diluvio (Gen., 11, 10 e seg.). Che proprio tanti e non più siano stati così prima come dopo il diluvio, non par credibile e chi dicesse che sotto il numero simbolico di dieci si nasconde lo scopo mnemonico, non andrebbe lontano dal vero. Da quanto abbiamo esposto, risulta che è impresa da non mai venirne a capo voler fissare l’anno del diluvio partendo dall anno della creazione dell uomo. Abbiamo un bell’addizionare gli anni dei singoli patriarchi, nominati nel capo 5 del Genesi, ma sappiamo noi le lacune che tra l’uno e l’altro poterono intervenire? Si aggiunga che, per colpa di copisti, facili ad alterare le cifre nella successiva trascrizione dei codici, l’età stessa assegnata ai singoli patriarchi spesso varia secondo i diversi testi (Massoretico, Samaritano, Settanta) e conseguentemente varia la somma totale. Questa, infatti, secondo il testo Massoretico (e quello della Volgata), sarebbe di 1.656 anni; secondo il Pentateuco Samaritano di 1.307; secondo la versione di Settanta di 2.262. Con dati di tal genere ognuno vede l’impossibilità di stabilire una vera e propria cronologia da Adamo al diluvio. E altrettanto si dica dal diluvio ad Abramo, appoggiati al capo 11, 10-26 del Genesi, per le stesse ragioni. Adunque poiché nulla di preciso afferma la Scrittura, qualunque sia l’epoca che, in base agli studi geologoci e paleontologici, si assegni al diluvio, non si avrà mai nulla che contraddica alla Bibbia.
• Degno di considerazione è un altro esempio del Nuovo Testamento. San Matteo, nel tessere l’albero genealogico di Gesù Cristo (1, 1-16) lo divide nettamente in tre gruppi: da Abramo a Davide, primo gruppo; da Davide all esilio di Babilonia, secondo gruppo; dal ritorno dall’esilio fino a Gesù Cristo, terzo gruppo. In ognuno di essi numera quattordici generazioni: vi sono però lacune che appaiono evidenti in più d’un punto, non causate davvero da ignoranza, ma appositamente volute. Così, a tacer d’altro, nel 2° gruppo (v. 8) tra Ioram e Ozia sono omessi i Re Ochozia, Gioas e Amasia, eppure si continua a dire: Ioram generò Ozia, come fin dal principio non dubita di chiamare Gesù Cristo figlio di Davide e Davide figlio di Abramo, e così prosegue in seguito la successione come se avvenisse sempre da padre in figlio con sempre lo stesso verbo tecnico: «generò». E una genealogia così fatta, senza alcun timore di vederla o contraddetta o ripudiata, San Matteo la presenta agli occhi dei suoi connazionali, come prova irrefragabile di un punto capitale, che cioè Gesù di Nazareth è il Messia aspettato, perché verifica in sé la prima delle condizioni del Messia, quella di essere discendente di Davide (È assai probabile che nello schema genealogico adottato da San Matteo la ragione simbolica vi entrasse anche per qualche cosa, se si considera che le tre consonanti del nome di David, prese nel loro valore numerico ebraico e insieme addizionate, danno appunto il numero 14. Infatti dalet uguale 4; vav uguale 6; dalet uguale 4; onde si ha 4 più 6 più 4 uguale 14 in ogni serie, ossia tante volte David quante sono le serie). Dato lo scopo mnemonico a cui si mira, data l’ampiezza di significato che ha la voce «figlio» e il verbo «generare», quella genealogia, benché in sé incompleta, sta indubbiamente nei limiti della verità. Anche San Luca (3, 23-32) segue l’istessa norma, tessendo a sua volta la genealogia di Gesù, non però in linea discendente, come fa San Matteo, ma in linea ascendente da Gesù ad Adamo. Enumera così una serie di settantasette membri, chiamando sempre il precedente figlio del seguente, quantunque venga a omettere parecchi degli anelli intermedi. E così la conoscenza degli usi genealogici presso gli Ebrei ci illumina a conoscere la verità storica della Scrittura in fatto di genealogia, nonostante la singolarità del modo onde viene proposta.
• In San Luca il numero degli antenati nel periodo che va da Davide a Gesù Cristo è di molto maggiore che non in San Matteo: di più sono tutti nomi diversi, tranne due: Salatiel e Zorobabele. Secondo una sentenza che ha la sua probabilità, San Luca ci avrebbe riferito gli antenati di Maria Vergine. Altri sostengono che anche qui abbiamo descritti gli antenati di San Giuseppe, non però secondo la genealogia naturale, come in San Matteo, ma secondo la genealogia legale. Difatti la legge detta del Levirato, dal latino Levir uguale cognato, (Deut. 25, 5-6) così diceva: «Se dei fratelli abitano insieme e l’uno di essi muore senza figli, la moglie del morto non dovrà maritarsi a un estraneo, ma il suo cognato (Levir) se la piglierà per moglie e il primogenito che essa darà alla luce andrà sotto il nome del fratello defunto, né sarà cancellato il nome di costui di mezzo a Israele». In forza di questa legge Eli, essendo morto senza figli, il fratello suo Giacobbe ne dovette sposare la moglie, onde il primogenito di questo matrimonio, Giuseppe, era figlio di Giacobbe per discendenza naturale, ma figlio di Eli per discendenza legale. Un’altra spiegazione è stata proposta, appellando a un genere speciale di adozione, in uso presso gli Ebrei, per cui in certi casi, il genero (nel caso nostro San Giuseppe sposo di Maria ) entrava a far parte della famiglia del suocero (nel nostro caso della famiglia di Eli, padre di Maria) in qualità di figlio adottivo del suocero stesso...
• Usi linguistici ebraici. E non meno ci illuminerà la conoscenza dell’uso linguistico proprio dell’Oriente e degli Ebrei in particolare. L’universalità del diluvio. Una difficoltà insormontabile parve a molti l’ammettere che il diluvio abbia inondato tutta quanta la terra (universalità geografica assoluta). Leggevano infatti al capo 7 del Genesi che Dio determinò di sterminare dalla faccia della terra tutti gli esseri da lui fatti (verso 4), che le acque del diluvio predominarono e aumentarono grandemente sopra la terra e copersero tutti i più alti monti che sono sotto il cielo (verso 19), che fu consumata ogni carne che ha moto sopra la terra, gli uccelli, le bestie, le fiere e tutti i rettili (verso 23). D’altra parte mille difficoltà accampava la scienza contro una siffatta universalità geografica; difficoltà d’una serietà indiscutibile. Come salvare la verità della Bibbia? Ricorrere a una moltiplicazione di miracoli, sempre facili a supporre ma difficilissimi a provare? Non occorre. Basterà ricordare una semplice norma di ermeneutica, ma assai importante, che cioè la Scrittura usa talora modi di dire convenzionali per cui «tutta la terra», «sotto ogni parte del cielo», (e per conseguenza tutti i monti e tutti gli animali che vi sono contenuti), sono espressioni che si limitano al cosiddetto orizzonte geografico, ossia alla terra, al cielo, ai monti, agli animali che sono conosciuti da chi parla o nell’ambito del soggetto di cui si parla, e nulla più.
• E non è questa un’asserzione gratuita, trovata per il bisogno della causa. Altri esempi abbiamo proprio nello stesso Pentateuco. Leggiamo al capo 41 del Genesi che, al sopravvenire della carestia dei sette anni predetti da Giuseppe, in tutte le regioni prevalse la fame (verso 54); che da tutti i paesi si veniva in Egitto a comprare grano da Giuseppe, essendo grande la fame in tutta la terra (verso 57). Ora queste espressioni nessuno pensò mai ad estenderle all’intero globo terrestre: tutti le hanno sempre ristrette alle regioni vicine all’Egitto. Parimenti nel Deuteronomio (2, 25) il Signore dice: «Oggi comincerò a mandare il terrore e lo spavento sopra i popoli che abitano sotto qualunque parte del cielo ». Ora è chiaro che si tratta non di altro che dei popoli limitrofi alla Palestina. Del resto, anche il terzo libro dei Re, al cap. 10, 23-24, quando ci farà sapere di Salomone che tutto il mondo desiderava di vederlo per udire la sapienza di cui Dio l’aveva fornito, tutto ciò si dovrà intendere con la restrizione che lo stesso libro ebbe segnato al capo 4, 34, quando scriveva: «Da tutti i popoli e da tutti i re della terra, quanti avevano udito parlare della sua sapienza, si veniva a udire la sapienza di Salomone». E San Luca, quando parlerà dell’editto di Cesare Augusto per il censimento di tutto il mondo (2, 1), non vorrà significare l’intero mondo abitato, ma soltanto l’impero romano; e quando dirà che nel giorno della Pentecoste erano a Gerusalemme uomini di tutte le nazioni che sono sotto il cielo (Atti 2. 6), in questa espressione egli non comprenderà se non quelli che poco dopo enumera nominatamente (Atti 2, 9), e che sono ben lungi dall’essere tutte quante le nazioni della terra. Adunque la stessa Scrittura ci insegna che siamo in pieno diritto di applicare a un’universalità relativa parole che, prese in sé, suonerebbero universalità assoluta. Si dirà che, stando a questi principii, si potrebbe negare anche l’universalità antropologica del diluvio e non solo la geografica e la zoologica. Difatti se le parole «tutta la terra», «ogni carne», possono essere intese in senso ristretto, perché non si potrà fare lo stesso dell’espressione «tutti gli uomini»? Qui entriamo in una questione più delicata. Primieramente tutti gli uomini ben possiamo supporli circoscritti tuttora in una determinata regione, se facciamo indietreggiare la data del diluvio in un tempo assai più vicino ad Adamo di quanto non si sia fatto: cosa che non ci è punto vietata. Di poi non c’è da esitare: se per la formazione di certe razze e di certi linguaggi la scienza antropologica riuscisse a dimostrare la necessità di ammettere l’esistenza di uomini non toccati dal diluvio, non per questo la Scrittura sarebbe in fallo. La Bibbia non è una stona del mondo, ma solo del popolo di Dio, sicché nel racconto del diluvio, essa perde di vista tutti gli altri uomini che non hanno relazione con la storia della Redenzione. Agli occhi dell’autore sacro i «figli di Dio» discendenti da Set, e le «figlie dell’uomo» le donne cioè di quelle nazioni in mezzo alle quali vivevano i Patriarchi, costituivano «tutti gli uomini» dei quali Dio aveva decretato la distruzione. Quando il mondo patriarcale è corrotto, tutta la terra è corrotta.
• Anche il P. Vaccari così nota al nostro proposito: «Che il diluvio non si sia esteso a tutto l’orbe terracqueo è ora sentenza comune di tutti gli interpreti cattolici: non sarebbe stato fisicamente possibile. Sulla sua estensione relativamente agli uomini non regna uguale unanimità. I più tengono ancora con gli antichi che si estese a tutti gli uomini senza eccezione. Altri, in piccolo ma crescente numero, opinano che neanche per gli uomini il diluvio fu universale. Si appoggiano da una parte sui dati delle scienze profane (etnografia, glottologia, ecc.), dall’altra sulla Bibbia stessa che... non si occupa dei rami laterali, che non hanno relazione con la storia del popolo eletto. Il diluvio fu un tremendo castigo della corruzione esposta (6, 1-5), e l’arca di Noè, fuori della quale tutti perirono, è simbolo della Chiesa, fuori della quale non vi è salute (1 Piet., 3, 20); al valore di questa doppia lezione basta che il diluvio abbia raggiunto tutti i colpevoli e che tutti gli uomini a cui si estese il diluvio vi siano anche periti, tranne i rifugiati nell’arca. Se la scienza veramente dimostrerà che non tutti gli uomini perirono nel diluvio noetico, non perciò potrà accusarsi la Bibbia d’errore». (La Sacra Bibbia tradotta dai testi originali, Vol. I, p. 77-78. Firenze, Salani, 1943). • I “fratelli” di Gesù. Quando l’eretico Elvidio perfidiava in negare la perpetua verginità di Maria SS. ricorrendo alla Scrittura, giocava d’astuzia, con falsare il punto di vista donde si hanno da guardare e intendere locuzioni e vocaboli. Leggeva nei Vangeli medesimi e in altri passi del Nuovo Testamento che si attribuivano a Gesù dei fratelli; tanto gli era bastato per menare trionfo. Trionfo stolto. È infatti risaputo che gli Ebrei, come in generale i Semiti, poverissimi di termini che distinguano fra loro i vari gradi di parentela, solevano con uno stesso vocabolo (’ach; aram, ’acha) designare non solo il fratello propriamente detto, ma anche il nipote, anche il cugino e in generale tutti i congiunti di qualunque grado fossero: ed è del pari risaputo che questo uso, in tutta la sua ampiezza, si è riflesso nella voce adelfós della versione greca dei LXX (Basti pensare che oggigiorno spesso si usa dire «fratello» addirittura ad un caro amico, ndR). Perciò nessuna meraviglia che la locuzione usata a significare i congiunti di Gesù, sorta nell’ambiente aramaico della primitiva catechesi, passando nel linguaggio greco, trovasse senz’altro il vocabolo adelfós come suo corrispondente, al modo stesso che era avvenuto presso i LXX in casi analoghi. Ed ecco la locuzione oi adelfoi toú Iesoú, oi adelfoi toú Kyriou = fratres Jesu, fratres Domini, che indica non altro se non i congiunti di Gesù. Di questi si danno anche i nomi: sono Giacomo, Giuseppe, Giuda e Simone, ma nessuno di essi mai è detto né nei Vangeli, né altrove figlio di Maria o di Giuseppe, anzi ai due primi (Giacomo e Giuseppe) si assegnano espressamente il proprio padre, Alfeo o Cleofa, e la propria madre Maria, sorella = parente di Maria SS.ma (cf. Matt. 27, 25; Marc. 11, 40; 16, 1; Giov. 19, 25). Il senso pertanto voluto vederci da Elvidio, con attribuire alla parola fratelli un unico significato, è falso.
• La solita sua astuzia usava Elvidio, quando pretendeva di rincalzare il suo argomento con l’appiglio alle parole di San Matteo, ove è detto che «Giuseppe non conobbe Maria, sua sposa, fino a che ebbe partorito il figlio suo primogenito» (1, 25). Un nuovo tentativo di falsare il punto di vista donde si hanno a guardare e intendere locuzioni e vocaboli. Il pensiero è ivi espresso mediante una proprietà linguistica, ben conosciuta nella Scrittura, la quale, nel dire che una cosa non fu fatta fino a un memento indicato, lì fa punto e non procede oltre. Avvenne di poi, non avvenne? Non se ne dice nulla, la cosa deve giudicarsi da altri criteri. Ecco, per esempio, dei passi ove l’avverbio «àd ki = fino a tanto che» esclude evidentemente l’avveramento ulteriore di ciò che si dice non essere avvenuto. «Micol non ebbe figli fino a tanto che morì», così nel secondo libro dei Re (6, 23). Da questa espressione chi sogna mai di inferire che la Scrittura attribuisca dei figli a Micol dopo la morte? «Nessuno conobbe la tomba di Mosè sino al giorno presente», così nel Deut. (34, 6). Chi sogna mai di credere che quella tomba si sia trovata di poi? Adunque la semplice locuzione: «ciò non fu fatto fino a tanto che...» non dà alcun diritto a concludere che dopo sia avvenuto davvero.
• Gesù “figlio primogenito”. Ma, s’insiste ancora, Gesù non è forse chiamato figlio primogenito? Sì, non però da San Matteo, il cui testo critico manca di quell’appellativo, bensì da San Luca il quale scrive: «(Maria) partorì il figlio suo primogenito» (2, 7). Ora Elvidio esclamava: «Primogenito non si può chiamare se non chi ha fratelli dopo di sé». Falso, ribatteva già San Girolamo, falso è l’asserto di Elvidio. E il grande dottore che non ha pari nell’interpretare le Scritture, con gli esempi alla mano, mostrava che nell’uso biblico, unica autorità in materia, il nome di primogenito è dato senz’altro al primo nato, senza ancora sapere se altri ne vengano dopo o no. Tale il caso della legge, ripetuta a più riprese (Es. 13,2.12.15; 34,19; Lev. 27,26; Num. 8,16), la quale comandava che ogni primogenito, ossia, (si noti la spiegazione data dalla Scrittura stessa) ogni maschio uscito il primo dal seno materno, fosse consacrato e offerto al Signore e che fosse riscattato con lo sborso di 5 sicli (circa 20 lire) un mese dopo la nascita. La legge chiama adunque primogenito colui che fu generato per il primo, colui che è tuttora unico, necessariamente unico e unico potrebbe in seguito rimanere. Tale pure il caso dell’ultima piaga dell’Egitto, ove afferma la Scrittura che tutti i primogeniti furono uccisi dall’angelo sterminatore. Si noti bene: tutti i primogeniti. O diremo che quanti non ebbero altri generati dopo di sé siano stati risparmiati? La supposizione è semplicemente ridicola. Prosegue la prossima settimana... a cura di CdP






























![[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1](/images/stories/virtuemart/product/resized/[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1_0x130.jpg)