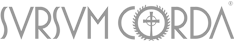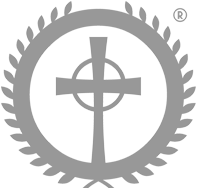Prima parte. §562. Potevano essere circa due ore dopo la mezzanotte. Il gruppo delle guardie, recando con sé l’arrestato, rifece in senso inverso la stessa strada fatta poche ore prima da Gesù con gli Apostoli, e attraversato il Cedron risalì sulla collina occidentale della città, ov’era la casa del sommo sacerdote Anna. Giunta ivi la scorta si divise; l’arrestato e le guardie del Sinedrio rimasero nella casa, mentre i soldati della coorte romana si ritirarono nel loro quartiere sulla fortezza Antonia. Quanto avvenne allora è narrato in maniera diversa dai quattro Evangelisti. Dei tre Sinottici, Matteo e Marco offrono una narrazione sostanzialmente uniforme; da essi però si discosta notevolmente Luca, il Sinottico che scrive dopo di loro; infine Giovanni, secondo il suo solito, fa precisazioni e integrazioni ai tre racconti precedenti presupponendoli già noti. Fra i Sinottici, Matteo e Marco parlano di una presentazione di Gesù avvenuta di notte, e di un’altra davanti al Sinedrio avvenuta di buon mattino; Luca invece parla soltanto della presentazione mattinale davanti al Sinedrio. Giovanni, per conto suo, distingue una presentazione davanti al sommo sacerdote non più in carica, Anna, della quale tacciono i Sinottici, e una successiva presentazione davanti al sommo sacerdote allora in carica, Caifa; egli invece non parla di una presentazione davanti al Sinedrio. Per concordare queste varie relazioni basta avere presente quanto rilevammo più volte nel passato: cioè che i Sinottici spesso non si preoccupano né dell’integrità della narrazione né della serie cronologica dei fatti, e che d’altra parte San Giovanni evita abitualmente di ripetere il racconto dei Sinottici, pur facendo un tacito assegnamento su di esso con la mira di integrarlo. Così ad esempio, poiché Anna non era stato neppur nominato dai Sinottici, Giovanni comincia la narrazione precisando che Gesù fu condotto dapprima presso Anna (§ 164), e solo in seguito segnala che fu condotto presso Caifa, che è il sommo sacerdote di cui parlano i Sinottici. Molto probabilmente, a cagione anche della loro parentela, Anna e Caifa abitavano ambedue nello stesso edificio in appartamenti differenti. Una tradizione assai antica, risalendo almeno al secolo IV, colloca la casa di Caifa sulla collina occidentale della città a poche decine di metri a settentrione del tradizionale cenacolo (§ 535). Se Gesù fu condotto dapprima presso Anna, la ragione fu probabilmente che costui, non più in carica ma sempre potentissimo (§ 52), aveva suggerito la maniera di catturare il Rabbi galileo; quasi in conseguenza di questa sua operosità e per deferenza al suo straordinario potere, il suo genero Caifa aveva dato ordine che l’arrestato fosse condotto direttamente presso Anna. A questo punto pertanto si inizia il processo di Gesù, che si svolse in due fasi differenti, presso due sedi differenti, e in forza di argomenti in parte differenti. La prima fase è religiosa: Gesù, imputato di delitto religioso, compare davanti al tribunale nazionale-religioso del Sinedrio e ivi è dichiarato degno di morte. Ma questa sentenza ha valore soltanto teoretico, perché, come già sappiamo (§ 59), il Sinedrio non poteva eseguire le sentenze capitali da esso pronunziate se non fossero state individualmente ed esplicitamente approvate dal rappresentante dell’autorità di Roma. Allora, per far sì che la propria sentenza non rimanga sterile e inefficace, il Sinedrio si rivolge al procuratore romano e qui si apre la seconda fase del processo: la quale si svolge, non più davanti ai giudici di prima, ma davanti al tribunale civile del procuratore; inoltre i giudici di prima compaiono nel nuovo tribunale in funzione di accusatori, e presentano accuse solo in minor parte religiose e in maggior parte politiche.
Prima parte. §562. Potevano essere circa due ore dopo la mezzanotte. Il gruppo delle guardie, recando con sé l’arrestato, rifece in senso inverso la stessa strada fatta poche ore prima da Gesù con gli Apostoli, e attraversato il Cedron risalì sulla collina occidentale della città, ov’era la casa del sommo sacerdote Anna. Giunta ivi la scorta si divise; l’arrestato e le guardie del Sinedrio rimasero nella casa, mentre i soldati della coorte romana si ritirarono nel loro quartiere sulla fortezza Antonia. Quanto avvenne allora è narrato in maniera diversa dai quattro Evangelisti. Dei tre Sinottici, Matteo e Marco offrono una narrazione sostanzialmente uniforme; da essi però si discosta notevolmente Luca, il Sinottico che scrive dopo di loro; infine Giovanni, secondo il suo solito, fa precisazioni e integrazioni ai tre racconti precedenti presupponendoli già noti. Fra i Sinottici, Matteo e Marco parlano di una presentazione di Gesù avvenuta di notte, e di un’altra davanti al Sinedrio avvenuta di buon mattino; Luca invece parla soltanto della presentazione mattinale davanti al Sinedrio. Giovanni, per conto suo, distingue una presentazione davanti al sommo sacerdote non più in carica, Anna, della quale tacciono i Sinottici, e una successiva presentazione davanti al sommo sacerdote allora in carica, Caifa; egli invece non parla di una presentazione davanti al Sinedrio. Per concordare queste varie relazioni basta avere presente quanto rilevammo più volte nel passato: cioè che i Sinottici spesso non si preoccupano né dell’integrità della narrazione né della serie cronologica dei fatti, e che d’altra parte San Giovanni evita abitualmente di ripetere il racconto dei Sinottici, pur facendo un tacito assegnamento su di esso con la mira di integrarlo. Così ad esempio, poiché Anna non era stato neppur nominato dai Sinottici, Giovanni comincia la narrazione precisando che Gesù fu condotto dapprima presso Anna (§ 164), e solo in seguito segnala che fu condotto presso Caifa, che è il sommo sacerdote di cui parlano i Sinottici. Molto probabilmente, a cagione anche della loro parentela, Anna e Caifa abitavano ambedue nello stesso edificio in appartamenti differenti. Una tradizione assai antica, risalendo almeno al secolo IV, colloca la casa di Caifa sulla collina occidentale della città a poche decine di metri a settentrione del tradizionale cenacolo (§ 535). Se Gesù fu condotto dapprima presso Anna, la ragione fu probabilmente che costui, non più in carica ma sempre potentissimo (§ 52), aveva suggerito la maniera di catturare il Rabbi galileo; quasi in conseguenza di questa sua operosità e per deferenza al suo straordinario potere, il suo genero Caifa aveva dato ordine che l’arrestato fosse condotto direttamente presso Anna. A questo punto pertanto si inizia il processo di Gesù, che si svolse in due fasi differenti, presso due sedi differenti, e in forza di argomenti in parte differenti. La prima fase è religiosa: Gesù, imputato di delitto religioso, compare davanti al tribunale nazionale-religioso del Sinedrio e ivi è dichiarato degno di morte. Ma questa sentenza ha valore soltanto teoretico, perché, come già sappiamo (§ 59), il Sinedrio non poteva eseguire le sentenze capitali da esso pronunziate se non fossero state individualmente ed esplicitamente approvate dal rappresentante dell’autorità di Roma. Allora, per far sì che la propria sentenza non rimanga sterile e inefficace, il Sinedrio si rivolge al procuratore romano e qui si apre la seconda fase del processo: la quale si svolge, non più davanti ai giudici di prima, ma davanti al tribunale civile del procuratore; inoltre i giudici di prima compaiono nel nuovo tribunale in funzione di accusatori, e presentano accuse solo in minor parte religiose e in maggior parte politiche.
• § 563. Il processo religioso cominciò con un interrogatorio a cui Anna sottopose Gesù; ma esso non fu una vera inquisizione ufficiale, fu piuttosto un orientamento giuridico della questione o anche una soddisfazione personale che volle prendersi l’inquirente, in attesa che giudici e testimoni ufficiali fossero convocati in quell’ora notturna e intervenissero personalmente. Anna interrogò Gesù circa i suoi discepoli e il suo insegnamento. Gesù rispose: «Io palesemente ho parlato al mondo; io sempre insegnai in sinagoga e nel tempio dove tutti i Giudei s’adunano, e di nascosto non parlai (di) nulla. Perché interroghi me? Interroga quei che udirono che cosa parlai loro. Ecco: costoro sanno le cose che dissi io» (Giov., 18, 20-21). L’imputato rispondeva in maniera conforme al diritto delle genti: presso tutti i popoli, compreso l’ebraico, un accusato non rendeva testimonianza riguardo a se stesso; testimonianze valide erano soltanto quelle rese da testimoni alieni degni di fede, e Gesù con la sua risposta rinvia il giudice appunto a tali testimoni. Egli non è stato fondatore di società segrete o insegnante d’una sapienza arcana e gelosa: ha parlato in luoghi pubblici e a tutti quei che si presentavano; costoro perciò potranno render testimonianza del suo insegnamento. In maniera analoga si era difeso, cinque secoli prima, Socrate davanti ai giudici ateniesi; anch’egli aveva parlato sempre palesemente, e se qualche testimonio avesse affermato d’aver udito da lui cose che non tutti avevano potuto udire sarebbe stato un mentitore. L’inappuntabile risposta di Gesù dovette provocare in Anna un gesto di dispetto, perché l’inquirente certamente sperava che l’imputato con la sua risposta fornisse argomenti per la sua futura accusa ufficiale. Il gesto stizzoso di Anna fu notato da uno dei presenti, servitore assai zelante, il quale stimò giusto prendere le parti dell’inquirente e andare incontro al suo segreto desiderio; trovandosi perciò vicino a Gesù, gli dette uno schiaffo esclamando scandalizzato: «Così rispondi al sommo sacerdote?». Rispose a lui Gesù: «Se parlai male, rendi testimonianza circa il male; se invece bene, perché mi percuoti?» (Giov., 18, 22-23). Con questo schiaffo termina ciò che noi sappiamo dell’interrogatorio di Anna, il quale del resto non dovette esser lungo. Visto il contegno misuratissimo che l’imputato teneva e forse anche desiderando di non ingolfarsi nelle vicende del processo, Anna inviò senz’altro Gesù legato al sommo sacerdote in carica, il proprio genero Caifa. Il tragitto dall’una all’altra abitazione fu brevissimo, perché, come supponemmo (§ 562), consistette nell’attraversare un cortile o atrio a cui facevano capo i vari appartamenti.
• § 564. Nel frattempo in casa di Caifa si erano radunati vari membri del Sinedrio, e quando furono in numero bastevole sottoposero Gesù a un regolare interrogatorio, ove si raccolsero i primi elementi della procedura ufficiale riguardante l’imputato. Tuttavia la seduta del Sinedrio in vera funzione di tribunale fu tenuta soltanto più tardi, sul far del mattino, quasi per integrare ed applicare i risultati del primo saggio fatto durante la notte. Matteo e Marco sembrano attribuire l’interrogatorio di Gesù alla seduta notturna; Luca, cronologicamente più preciso, lo attribuisce alla seduta mattinale, e indubbiamente la sua attribuzione è da preferirsi. Riportammo altrove le prescrizioni minutissime ed accuratissime che si leggono nel Talmud riguardo ai processi, specialmente a quelli che potevano concludersi con una sentenza capitale (§ 60); ma accennammo anche che tutta quella legislazione, così ampia e sapiente, era anche troppo sapiente perché si potesse attuare nella pratica. Essa in realtà fu messa in iscritto soltanto dal secolo II dopo Cristo in poi, e agli storici imparziali appare oggi come una teoria astratta, come una visione ideale della perfetta amministrazione della giustizia, piuttosto che come un codice normativo da seguirsi nella pratica; senza ripensare alle Utopie di Platone e di Tommaso Moro e senza uscire dallo stesso Israele, l’ampia e minuziosa legislazione di Ezechiele (capp. 40-48) riguardo al futuro Tempio aveva già offerto un tipico saggio di siffatte teorie o visioni ideali. È stato osservato giustamente da studiosi moderni, anche Israeliti, che la legislazione talmudica dei processi sembra congegnata in maniera da rendere impossibile una sentenza capitale: è certo poi che essa, fissata in scritto quando la nazione giudaica aveva perduto ogni autonomia politica ed era rappresentata dai soli Farisei (§ 87), poté essere elaborata senza alcuna aderenza al presente e attribuita arbitrariamente al passato come un prodotto della “tradizione”. Che essa fosse totalmente inventata in occasione di questa sua codificazione, non è verosimile; ma le norme osservate per consuetudine ai tempi dell’autonomia e prima della codificazione dovevano essere rare e scarne e certamente ben lontane da quella precisione e minuziosità che ricevettero poi nello scritto. Ai tempi di Gesù, in mancanza della codificazione, vigevano soltanto norme consuetudinarie, di cui però non possiamo oggi stabilire il numero e l’indole: possiamo ritenere in genere che esse corrispondevano solo ad una minima parte di ciò che più tardi risultò codificato. Sarebbe quindi falso metodo confrontare - come si è fatto - le disposizioni processuali del Talmud con la pratica seguita nel processo di Gesù, per vedere se e fino a qual punto quelle disposizioni vi furono osservate: di molte di esse, infatti, non sappiamo neppure se allora esistessero. Esisteva certamente, ad esempio, la norma solenne e antica (Numeri, 35, 30; Deuteronomio, 17, 6; 19, 15) secondo cui nessuno poteva esser condannato se non in forza di testimonianze aliene, e non mai di una sola ma almeno di due o tre; al contrario non è sicuro che esistesse la norma codificata più tardi secondo cui in seduta notturna non potevano essere trattati processi criminali, e anche l’altra secondo cui una condanna a morte non poteva essere pronunziata nel giorno stesso della discussione del processo. Certo è che, nel processo di Gesù, tutte e tre queste norme non risultano osservate.
• § 565. Essendo pertanto stati preparati nella seduta notturna gli argomenti principali per la seduta mattinale, questa fu tenuta «appena si fece giorno» (Luca, 22, 66), cioè appena cominciarono a diradarsi le tenebre notturne, anche prima della piena alba (§ 576). Dovevano essere circa le nostre ore cinque antimeridiane. Alla seduta notturna saranno intervenuti o i più focosi avversari di Gesù oppure i frequentatori più assidui della casa del sommo sacerdote; a quella mattinale invece intervennero i membri di tutti e tre i gruppi del Sinedrio (Luca, ivi; cfr. § 58). In osservanza pertanto dell’antica e solenne norma suaccennata si cominciò con escutere «molti... testimoni», i quali però erano «falsi»; ma sia che la subornazione di tali testimoni fosse stata fatta in maniera affrettata e vaga, sia che essi riferendosi ad antichi fatti e discorsi di Gesù confondessero particolarità ben diverse, le loro «testimonianze non erano concordi» (Marco, 14, 56). Con tali deposizioni il processo non faceva un passo avanti e non si salvavano neppure le apparenze della legalità; giacché anche se a quei tempi non vigeva la norma, codificata più tardi, secondo cui il testimone doveva precisare esattamente il giorno, l’ora, il luogo, e tutte le altre minute circostanze del delitto attestato (§ 60), si richiedeva evidentemente che le deposizioni non si contraddicessero a vicenda. Qui invece si contraddicevano. Alla fine, tuttavia, si presentarono due testimoni che sembrarono concordi: il numero legale minimo, di due, c’era, e pareva esserci anche la concordia. Costoro deposero che Gesù aveva pronunziato le seguenti parole: «Posso demolire il santuario d’Iddio e in tre giorni edificar(lo)» (Matteo, 26, 61); ovvero secondo l’altra relazione: «Io demolirò questo santuario manufatto, e in tre giorni (ne) edificherò un altro non manufatto» (Marco, 14, 58). Ma anche questa doppia testimonianza, all’ulteriore inquisizione dei giudici, non risultò concorde nei suoi particolari: soprattutto, poi, essa non era vera né quanto allo spirito né quanto alla lettera. La testimonianza infatti si riferiva evidentemente alle parole pronunziate da Gesù più di due anni prima, in occasione della cacciata dei mercanti dal Tempio (§ 287); ma già vedemmo che quelle parole erano metaforiche e si riferivano, non già al Tempio di Gerusalemme, ma al corpo di Gesù stesso. Inoltre, anche volendo prendere quelle parole come dirette al Tempio di Gerusalemme, Gesù non aveva espresso il proposito di demolire egli stesso il Tempio, bensì aveva sfidato i suoi avversari a demolirlo (Demolite questo santuario, ecc.); dunque egli tutt’al più sarebbe stato il ricostruttore del Tempio, eventualmente demolito dai Giudei, non già il suo demolitore. Ma ricostruire il Tempio poteva esser titolo di encomio, non già argomento di accusa; una delle pochissime benemerenze che, mezzo secolo avanti, Erode il Grande si era procurato agli occhi dei Giudei osservanti era stata appunto quella di aver ricostruito più suntuosamente di prima il Tempio da lui stesso man mano demolito (§ 46). Certamente testimoni e giudici non credevano che Gesù potesse fare quanto Erode il Grande aveva fatto; ma essi in tal caso potevano concludere tutt’al più che l’imputato era un vanesio, un sognatore, un millantatore, non già un empio e un bestemmiatore.
• § 566. Senonché la doppia testimonianza riguardo al Tempio era troppo opportuna perché quei giudici, in difetto d’altri capi d’accusa, se la lasciassero sfuggire: essa poteva valere almeno come prova che Gesù aveva ritenuto possibile o aveva profetizzato la distruzione del Tempio. Ora, quando si trattava di quel cumulo di sassi e di travi che costituivano il Tempio materiale, i Giudei dei tempi di Gesù perdevano immediatamente il lume degli occhi, come l’avevano perso sei secoli prima i Giudei dei tempi di Geremia. L’antico profeta era stato giudicato degno di morte perché aveva predetto da parte di Dio che il Tempio sarebbe stato distrutto (Geremia, 7, 4 segg.; 26, 6 segg.); e le scritture di lui, nelle quali si narrava questa predizione insieme col suo puntuale avveramento e con l’empio trattamento fatto al profeta, erano tuttora venerate come sacre da coloro che stavano là assisi a giudicare Gesù: ma l’insegnamento che essi ne trassero fu di ripetere in maniera peggiorativa quanto i loro antenati avevano fatto al profeta del Dio d’Israele. Vedendo infatti che pure quest’ultima testimonianza stava per sfumare, il sommo sacerdote prese una risoluzione decisiva. Levatosi in piedi, Caifa tentò di ottenere da Gesù qualcosa che in apparenza fosse una sua giustificazione di fronte all’accusa dei testimoni, ma che in realtà avrebbe implicato l’imputato nella discussione inducendolo a confessioni; gli disse perciò: «Non rispondi nulla? Che cosa testificano costoro di te?». Ma la desiderata risposta non venne, e Gesù serbò un silenzio assoluto. Allora il sommo sacerdote, assumendo un atteggiamento ispirato e solenne, insistette: «Ti scongiuro per il Dio vivente affinché ci dica se tu sei il Cristo (Messia), il Figlio d’iddio». L’atteggiamento del sommo sacerdote sembrava quello di un uomo che, tutto preso dal desiderio della verità, aspettasse soltanto una parola d’assicurazione per affidarsi e rendersi totalmente ad essa; udendolo si sarebbe detto che, a una risposta affermativa di Gesù, egli si sarebbe prostrato riverente davanti a lui riconoscendolo come il Messia d’Israele. Si noti inoltre, accuratamente, che Caifa ha scongiurato Gesù a dichiarare se egli sia il Cristo, il Figlio d’iddio. Cosicché i termini dell’interrogazione sono due; Gesù potrà affermare o negare di essere il Cristo, ossia il Messia, e oltre a ciò di essere il Figlio d’Iddio. È probabile che Caifa, in questo scongiuro, usasse i due termini come praticamente sinonimi; tuttavia egli stesso e gli altri membri del Sinedrio mostreranno in seguito di saper ben distinguere il preciso significato dei due termini, e attribuiranno al termine «il Figlio d’Iddio» un significato distinto e assai più alto che quello di «Messia».
• § 567. Il momento era davvero solenne. Tutta l’operosità, tutta la missione di Gesù apparivano quasi riassunte nella risposta che egli avrebbe data allo scongiuro del sommo sacerdote. Chi interrogava era rivestito dell’autorità somma e ufficiale in Israele; chi rispondeva era colui che nella sua vita aveva serbato quasi costantemente occulta la sua qualità di Messia per ragioni d’oculata prudenza, confidandola soltanto negli ultimi tempi e soltanto a persone opportune e predisposte. Ma allora le ragioni di prudenza avevano cessato di esistere: pericoloso che fosse, era ben giunto il momento di dichiarare apertamente la propria qualità davanti all’intero Israele, rappresentato dal sommo sacerdote e dal Sinedrio. Tuttavia la risposta, che Gesù aveva già pronta, sarebbe stata certamente oggetto di scandalo per coloro a cui era diretta, a causa delle loro particolari condizioni di spirito: inoltre sarebbe stato necessario dapprima mettere bene in chiaro taluni principii sui quali essi potevano equivocare. Gesù quindi prudentemente ammonì: «Se io ve (lo) dico, non (mi) crederete; se poi (vi) interrogherò, non (mi) risponderete» (Luca, 22, 67-68). Questa ammonizione deluse per un momento l’ansiosa aspettativa dell’intera assemblea, i cui membri perciò dovettero esortare l’imputato a rispondere, ripetendogli alla rinfusa la domanda del sommo sacerdote per ottenere la dichiarazione che essi si aspettavano. Gesù allora, indirizzandosi al sommo sacerdote rispose: «Tu (l’)hai detto»; il che significava: «Io sono ciò che tu hai detto» (§ 543). A questa schematica affermazione l’imputato aggiunse una dichiarazione rivolta all’intera assemblea: «Senonché vi dico, da adesso vedrete il figlio dell’uomo seduto a destra della “Potenza” e veniente sulle nubi del cielo». Questa aggiunta adduce, fondendoli insieme, due celebri passi messianici (Daniele, 7, 9. 13; Salmo 110 ebr., 1); essa infatti vuole precisare il senso della schematica affermazione di Gesù ricollegandola con le sacre Scritture ebraiche, e nello stesso tempo appellarsi ad una futura prova di quella affermazione cioé al ritorno glorioso del Messia «sulle nubi del cielo», predetto dalle Scritture.
• § 568. Appena udite le parole di Gesù tutti i Sinedristi insorsero protesi e vibranti, e a gara domandarono all’imputato: T»u dunque sei il Figlio d’Iddio?» (Luca, 22, 70). Dalla precedente risposta di Gesù essi già avevano ottenuto la preziosa confessione che egli si reputava Messia: poteva tuttavia rimanere un dubbio, cioè se egli si reputasse bensì Messia ma non già «Figlio d’Iddio» nel senso ontologico dell’appellativo. In realtà, le allusioni fatte da Gesù ai due passi messianici mettevano sufficientemente in chiaro anche questo punto; tuttavia i Sinedristi, ansiosi di ottenere una piena dichiarazione dall’imputato, gliene rivolsero formale domanda: «Tu dunque sei oltreché il Messia anche il Figlio d’Iddio?». Più precisi ed esatti di così, quei giudici non potevano essere. Più precisa ed esatta non poté essere la risposta di Gesù, la quale nel silenzio palpitante del tribunale risonò: «Voi dite che io sono»; il che significava: «Io sono ciò che voi dite» cioè il Figlio d’Iddio. Ottenuta questa nettissima affermazione, il sommo sacerdote gridò esterrefatto: «Ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, adesso avete udito la bestemmia! Che ve (ne) pare?». Tutti a gran voce risposero: «è reo di morte!». Per rendere più visivo e più impressionante il suo sdegno, il sommo sacerdote mentre aveva lanciato il primo grido si era anche strappato l’orlo superiore della tunica, com’era usanza di fare quando si assisteva ad una scena di sommo cordoglio; ma in realtà se quell’uomo avesse mostrato palesemente sul volto i veri sentimenti che aveva nel cuore, il suo aspetto sarebbe apparso illuminato di profonda e sincera gioia. Egli infatti credeva d’esser riuscito a far bestemmiare Gesù, e con ciò ad implicarlo nella sua propria condanna.
• § 569. Senonché l’interrogazione rivolta dal sommo sacerdote a Gesù aveva costituito una procedura del tutto illegale. Poiché fino allora era mancata la prova testimoniale, si era cercato di rendere l’imputato testimonio avverso a se stesso, contro la norma stabilita in Sanhedrīn, 9 b, e di sorprenderlo in un preteso delitto flagrante; in tal modo non si teneva più conto dei pretesi delitti passati per concentrarsi unicamente su uno presente, e Gesù non figurava più come un imputato responsabile di antiche colpe ma come un innocente arrestato per esser provocato a bestemmiare. Inoltre Gesù, affermando di essere il Messia, non aveva affatto bestemmiato: in primo luogo perché egli in quella sua affermazione non aveva impiegato il nome di Dio, bensì aveva prudentemente sostituito al pronome personale o generico di Dio (Jahveh ovvero Elohīm) l’appellativo di «Potenza» come solevano fare i rabbini; in secondo luogo, perché attribuire a se stesso o ad altri unicamente la qualità di Messia d’Israele non poteva considerarsi una bestemmia. Senza uscire infatti dal rabbinismo più ortodosso, un secolo più tardi il grande Rabbi Aqiba proclamerà Messia quel Bar Kokeba che guiderà l’ultima e più catastrofica ribellione della Giudea contro Roma; eppure, nonostante questa fallace proclamazione, Rabbi Aqiba non solo non fu giudicato bestemmiatore ma rimase poi sempre come uno dei più illustri luminari del giudaismo dell’Era Volgare. Perciò l’affermazione messianica che Gesù aveva fatta di se stesso, anche se non era accettata, poteva essere giudicata dai suoi avversari tutt’al più vana e millantatrice quale di un allucinato od esaltato - come in realtà fu giudicata da alcuni contemporanei l’affermazione di Rabbi Aqiba - ma bestemmia contro la Divinità non era in alcun modo. Perché dunque il presidente gridò, e il tribunale confermò, che Gesù aveva bestemmiato? Evidentemente in forza della risposta affermativa data da Gesù all’ultima interrogazione: «Tu dunque sei il Figlio d’iddio?». In questa domanda il termine «il Figlio d’Iddio» certamente non è - nell’intenzione stessa dell’interrogante - un pratico sinonimo del termine Messia, bensì rappresenta in confronto con questo termine un ulteriore progresso, un climax, e riveste un significato assai superiore: gli interroganti volevano sapere da Gesù se egli, nel significato ontologicamente vero, si riteneva «il Figlio d’iddio». Avendo Gesù risposto in maniera affermativa, fu giudicato bestemmiatore. E così il processo religioso era finito e la sentenza era stata data: Gesù era stato giudicato reo di morte come bestemmiatore. La procedura era riuscita al sommo sacerdote in maniera superiore alla sua aspettativa. Visto che era inutile sperare nelle deposizioni dei testimoni subornati, egli si era rivolto direttamente all’imputato prendendo di mira dapprima la qualità di Messia, perché ottenuta una confessione su questo punto il reo confesso ne avrebbe dovuto rispondere poi in sede politica davanti al procuratore romano. Senonché la confessione era stata così ampia e solenne, che aveva portato spontaneamente all’altra interrogazione se l’imputato fosse - oltreché Messia - anche «il Figlio d’Iddio». Questa nuova interrogazione, più delicata e decisiva che mai, aveva ottenuto pure essa una risposta pienamente affermativa. Cosicché, in conclusione, l’inquirente aveva trionfato in ambedue i campi: in quello nazionale-politico, perché l’imputato aveva confessato di essere il Messia d’Israele; in quello rigorosamente religioso, perché aveva confessato di essere vero Figlio d’Iddio. Questa seconda confessione era stata decisiva davanti al tribunale del Sinedrio; la prima verrà addotta e sarà egualmente decisiva davanti al tribunale del procuratore romano. Questi fatti avvennero - come già accennammo (§ 564) - nella seduta mattinale, la quale fu definitiva e incorporò nella sua procedura i risultati provvisori ottenuti nella seduta notturna. Ma nel frattempo erano già avvenuti e tuttora avvenivano altri fatti, che qui raggruppiamo a parte. Prosegue la prossima settimana ...
Da «Vita di Gesù Cristo», imprimatur 1940, Abate Giuseppe Ricciotti, 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.

























![[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1](/images/stories/virtuemart/product/resized/[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1_0x130.jpg)