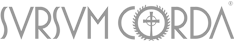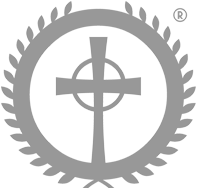Stimati Associati e gentili Sostenitori, entriamo nel vivo delle fonti storiche che riguardano Nostro Signore Gesù Cristo. Oggi, per grazia di Dio, studieremo il capitolo: «Il Vangelo secondo San Matteo». Abate Giuseppe Ricciotti («Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941),
• § 114. Il primo Vangelo è attribuito all’apostolo Matteo, chiamato anche Levi e già pubblicano (§ 306), da una costante tradizione che risale al principio del secolo II. Il già allegato Papia di Jerapoli, che verso l’anno 120 scrisse cinque libri di Spiegazione dei detti del Signore, affermava in essi che: Matteo in dialetto ebraico coordinò i detti; ciascuno poi li interpretò com’era capace (in Eusebio, Hist. eccl., III, 39, 16). Altre testimonianze successive - quali quelle di Ireneo (Adv. hær., III, 1, 1), di Tertulliano (Adv. Marcion., IV, 2), di Clemente Alessandrino (Stromata, I, 21), ecc. - confermano più o meno esplicitamente la notizia di Papia. È anche certo che tutta l’antichità cristiana, in una gran quantità di attestazioni che sarebbe inutile elencare, ha attribuito a Matteo precisamente il primo dei nostri Vangeli canonici e non un altro scritto. Che cosa esattamente afferma Papia dello scritto di Matteo? Egli dice che in esso Matteo coordinò i detti di Gesù: ossia che, non solo raccolse insieme, ma anche secondo un dato ordinamento, i detti in questione. La lezione «coordinò» è data da cinque codici su sette, ed è certamente la giusta; soltanto due codici leggono «coscrisse», che è lezione meno attendibile. Gli antichi, infatti, badavano molto in un’opera letteraria all’«ordinamento»: secondo essi uno scrittore doveva in primo luogo provvedere al ritrovamento di un soggetto, quindi sottoporre il soggetto all’«ordinamento»; questo ordinamento, poi, non era sempre quello cronologico, bensì presso gli stessi storici era sovente l’ordinamento logico, fondato o sull’analogia delle varie trattazioni, o sulla congiunzione di causa ed effetto, o sull’unità di luogo e di persone, e simili. Questi precetti dei grammatici greci erano abbastanza noti e praticati anche presso i Giudei ellenisti. L’autore del II Maccabei, che ricapitola i cinque libri di Giasone di Cirene, rammenta ciò che si addice al principio del suo lavoro (segue citazione dal greco ... 2, 30); che dalla Vulgata (2, 31) è tradotto con larghezza più verbale che concettuale: «intellectum colligere, et ordinare sermonem, et curiosius partes singulas quasque disquirere». E che Papia abbia qui di mira questo ordinamento letterario, risulta da quanto egli ha detto immediatamente prima circa il Vangelo di Marco (citeremo l’intero passo al § 128), ove afferma che Marco scrisse esattamente, ma non già con ordinamento; al contrario, nello scritto di Matteo egli ritrova con soddisfazione questo «ordinamento».
• § 115. Ora, quali sono i detti contenuti nello scritto di Matteo? Etimologicamente il termine greco significa detti (sentenze, oracoli); ma particolarmente, presso scrittori giudei e cristiani, significava anche passi in genere della sacra Scrittura, che contenessero indifferentemente sia sentenze sia fatti. Papia stesso usa altrove il termine in questo secondo senso più ampio: nel già accennato passo ove parla del Vangelo di Marco, dice che questo contiene le cose o pronunziate o operate da Gesù; eppure, immediatamente appresso, egli designa questo complesso narrativo come detti di Gesù. Inoltre la stessa opera scritta da Papia era bensì intitolata Spiegazione dei detti del Signore, ma dagli accenni e citazioni che ne rimangono risulta che essa trattava, oltreché delle sentenze, anche dei fatti di Gesù e dell’età apostolica. Per conseguenza, non solo l’antichità cristiana, ma anche tutti gli studiosi indistintamente fino al secolo XIX inoltrato, ritennero che questi detti attribuiti da Papia a Matteo designino il primo dei nostri Vangeli canonici: tanto più che di un’opera assegnata a Matteo o ad altri Apostoli, conteneva solo sentenze di Gesù, non esiste né attestazione né traccia alcuna trasmessa dall’antichità. Se poi passiamo a confrontare questi dati, strettamente positivi, con il contenuto del nostro primo Vangelo, troviamo una adeguata corrispondenza alle due caratteristiche rilevate da Papia: quella dell’appellativo di detti, e quella dell’«ordinamento» letterario.
• § 116. E in primo luogo, fra i Vangeli sinottici, Matteo è quello che concede il più ampio spazio alle parole di Gesù, le quali occupano circa tre quinti dell’intero scritto: perciò con particolare ragione esso poteva esser designato come una raccolta di detti, pur conservandosi a questa parola il significato usuale meno rigoroso che includeva anche la narrazione di fatti. Inoltre, la raccolta dei discorsi di Gesù ivi riferiti è stata ripartita in cinque gruppi, secondo quella norma di «ordinamento» letterario che stava a cuore a Papia. Il primo gruppo contiene ciò che si potrebbe definire lo statuto del regno fondato da Gesù, cioè il Discorso della montagna (Matteo, capp. 5-7); il secondo contiene le istruzioni date agli Apostoli per diffondere il regno (cap. 10); il terzo, le parabole del regno (cap. 13); il quarto, i requisiti morali per appartenere al regno (cap. 18); il quinto, il perfezionamento del regno e la sua consumazione nei fini estremi (capp. 23-25). Notevole è che ognuno di questi gruppi è preceduto da poche parole d’introduzione, ed è poi seguito da una conclusione, la quale tutte le volte è, con minime mutazioni, questa: «E avvenne che, quando Gesù ebbe terminato o questi discorsi o queste parabole», ecc. (7, 28; 11, 1; 13, 53; 19, 1; 26, 1). Notevole è anche che siffatto «ordinamento» in cinque gruppi, certamente non fortuito, corrisponde numericamente ai cinque libri in cui Papia aveva diviso la sua opera di Spiegazione dei detti del Signore; il che potrebbe far sospettare, benché la cosa non sia punto certa, che Papia avesse seguito nella sua opera l’«ordinamento» da lui segnalato nello scritto di Matteo, se in essa egli si era occupato soprattutto dei discorsi di Gesù.
• § 117. L’antico pubblicano Matteo, quando mise mano a questa sua opera, era certamente uomo abituato da gran tempo a scrivere, perché senza la quotidiana scrittura non avrebbe potuto nel passato tenere in bell’ordine nel suo tavolo da gabelliere le note dei pagamenti; al contrario gli altri Apostoli, sebbene non fossero privi di lettere, dovevano avere in genere più familiarità con remi e reti da pescatori che non con pergamene e calami da scrittori (salvo forse i due benestanti figli di Zebedeo), e ciò specialmente subito dopo la morte di Gesù quando iniziarono da soli la loro missione. Testimoni oculari delle azioni di Gesù erano stati tutti egualmente, ma l’abilità scritturale di Matteo era un vantaggio tecnico sugli altri Apostoli, e questo dovette far sì che fosse assegnato di preferenza a lui l’incarico di mettere in iscritto la catechesi orale degli stessi Apostoli. Quando Matteo si mise all’opera è possibile, sebbene non dimostrato, che già circolasse qualche scritto contenente detti o fatti di Gesù; ma anche se ciò potesse dimostrarsi, si tratterebbe certamente di saggi ancora scarsissimi sia per numero sia per contenuto, composti inoltre per iniziativa privata e privi d’ogni carattere ufficiale. Al contrario, l’incarico dato a Matteo rispondeva all’opportunità che la catechesi orale degli Apostoli fosse ampiamente e ufficialmente riecheggiata in un documento scritto, ricevendone quel sussidio pratico che era richiesto, come vedemmo (§ 106), dalla crescente diffusione della buona novella. Il tipo di catechesi da mettersi in iscritto non poté essere se non quello già collaudato dalla pratica della Chiesa, e le cui linee maestre erano state tracciate da chi aveva la sovreminenza sui banditori ufficiali della buona novella: fu perciò il tipo di catechesi che metteva capo a Pietro (§ 113), senza però escludere il sussidio di altri elementi provenienti dal collegio apostolico che non entravano ordinariamente nel quadro di quella predominante catechesi. In conclusione lo scritto riassunse il pensiero dell’intero collegio apostolico, pur attenendosi alle linee principali della catechesi di Pietro.
• § 118. Un documento quale quello di Matteo, composto da un testimone dei fatti, garantito e sussidiato da altri testimoni, inquadrato entro le linee maestre di un insegnamento ufficiale, esteso su un’ampiezza che non fu mai più raggiunta da scritti dello stesso genere, era destinato immancabilmente ad acquistare un valore singolare. Troviamo infatti che il Vangelo di Matteo, come ci viene presentato dalla concorde antichità quale primo in ordine di tempo, cosi è primo quantitativamente per impiego fattone fin dai primi tempi: basti ricordare che, da parte cattolica, Giustino martire, alla metà del secolo II, impiega il nostro Matteo non meno di centosettanta volte, e che prima di lui gli antichissimi eretici Ebioniti impiegavano il solo Vangelo di Matteo, a detta di Ireneo (Adv. hær., III, 11, 7), ma probabilmente alterato come già accennammo (§ 96).
• § 119. Tuttavia, da principio, all’impiego ed all’ampia diffusione dello scritto di Matteo si opponeva il grave ostacolo della lingua in cui era stato composto. La notizia già comunicataci da Papia, che Matteo scrisse in dialetto ebraico - è in realtà confermata da altri antichi - quali Ireneo, Origene, Eusebio, Girolamo i quali egualmente parlano di lingua ebraica o paterna: quasi certamente il termine ebraico designa qui l’aramaico (come nel contemporaneo Flavio Giuseppe, Guerra giud., VI, 96; cfr. V, 272, 361; ecc.), giacché ai tempi di Matteo in Palestina si parlava aramaico; ad ogni modo, ebraico o aramaico che fosse, la lingua primitiva semitica era inaccessibile ai cristiani di stirpe non giudaica ed anche a moltissimi altri provenienti dal giudaismo della Diaspora, i quali non conoscevano altro che il greco. Ma l’ostacolo fu superato, bene o male, nella maniera accennata dallo stesso Papia: i detti, nel loro testo originale semitico, andarono in mano ai vari lettori e catechizzatori, ciascuno poi li interpretò com’era capace. Le quali parole lasciano intravedere un ampio lavorio sorto ben presto attorno a un testo così opportuno e autorevole: alcuni catechizzatori ne avranno tradotto oralmente, in maniera estemporanea, quegli squarci che volta per volta occorrevano al loro ministero; altri avranno anche apprestato traduzioni scritte, e queste poterono essere sia parziali sia, più raramente, totali; non dovettero anche mancare scritti che, come la Spiegazione dello stesso Papia, erano piuttosto di esegesi illustrativa che di semplice traduzione. Ma l’osservazione di Papia, che ciascuno interpretò com’era capace, fa anche comprendere che in tutto quel lavorio la buona volontà spesso non era accompagnata da un’adeguata perizia, soprattutto riguardo alla conoscenza della lingua da cui si traduceva o anche in cui si traduceva. Sant’Agostino segnala il caso analogo delle traduzioni latine della Scrittura fatte dal testo greco dei Settanta: «Qui enim Scripturas ex hebræe lingua in græcam verterunt, numerari possunt, latini autem interpretes nullo modo. Ut enim fidei temporibus in manus venit codex græcus et aliquantum facultatis sibi utrisque linguæ habere videbatur, ausus est interpretari» (De doctr. christ., II, 11). [Traduzione: Si possono infatti contare coloro che tradussero le Scritture dall’ebraico in greco, ma è impossibile contare i traduttori latini. Fin dai primi tempi della fede, infatti, man mano che uno veniva in possesso d’un codice greco ed era convinto di possedere un po’ di conoscenza dell’una e dell’altra lingua, subito si metteva a tradurre, ndR]. È anche del tutto possibile che i molti, che nel sesto decennio del secolo I avevano già scritto sui fatti di Gesù (§ 110), usufruissero ampiamente della composizione di Matteo, pur unendola con altri elementi desunti dalla tradizione di testimoni o di loro discepoli.
• § 120. Ma la Chiesa, che aveva adombrato della sua autorità la catechesi scritta in semitico da Matteo, dovette a un certo punto estendere la sua vigilante cura anche alle traduzioni del testo originale, per timore che quell’autorità ufficiale fosse indebitamente invocata ad adombrare traduzioni che non meritavano tanto onore. Ciò che precisamente avvenisse non ci è noto, ma le conseguenze sono chiare ed eloquenti. Le traduzioni puramente orali ed estemporanee dovettero sempre più diminuire, col diminuire dei catechizzatori ch’erano in grado di intendere l’originale semitico; le traduzioni scritte, parziali o totali che fossero, rimasero nell’ombra, cioè nell’uso privato e non ufficiale, e perciò destinate prima o dopo a perdersi. Una sola traduzione non andò perduta e giunse fino a noi, ma appunto perché fu adottata ufficialmente dalla Chiesa in sostituzione del troppo arduo testo semitico originale: è il testo greco del nostro Matteo canonico. Da chi sia stata fatta questa traduzione noi non sappiamo, come ai suoi tempi confessava di non saperlo San Girolamo. Certamente fu compiuta qualche decennio dopo ch’era apparso lo scritto di Matteo, quando cioè effondendosi sempre più il cristianesimo fuori della Palestina, diventava sempre meno usabile il testo originale semitico: risulta anche, da accurati raffronti letterari, che la traduzione fu compiuta dopo ch’erano apparsi gli altri due Vangeli sinottici, delle cui espressioni letterarie essa risente. Il traduttore, infatti, non limitò il suo lavoro ad una semplice trasposizione delle parole da una lingua all’altra: bensì, oltre a ricercare una certa spigliatezza letteraria e quindi a non seguire servilmente la lettera anche per questa ragione, egli nello stesso tempo ebbe di mira la catechesi pratica. Poiché nel frattempo erano apparsi i due Vangeli di Marco e di Luca, scritti originariamente in greco e rispecchianti in maniera più diretta le catechesi rispettivamente di Pietro e di Paolo, il traduttore li tenne sott’occhio durante il suo lavoro, e nel rendere in greco il testo semitico si avvicinò per la scelta delle espressioni a quelle che trovava già impiegate in passi paralleli dei due nuovi Vangeli greci: con ciò egli volle imprimere una certa uniformità letteraria a quei tre documenti, che rispecchiavano la catechesi fondamentalmente unica.
• § 121. La stessa mira della catechesi influì anche in altre maniere sulla traduzione. Trasportato in greco, lo scritto di Matteo allargava enormemente il suo campo d’azione e poteva raggiungere lettori non giudei, cioè non abituati a idee ed espressioni tipicamente semitiche; d’altra parte il testo semitico di Matteo doveva avere (come risulta dal confronto con gli altri due Sinottici) talune espressioni che potevano o essere fraintese o suscitare meraviglia presso gli accennati lettori. Perciò il traduttore, per adattare meglio lo scritto al nuovo campo di catechesi, rimosse queste occasioni di errore e di meraviglia, e pur conservando il senso fondamentale attenuò la forza di certe frasi. Sembra anche probabile che egli abbia spostato taluni passi del testo originale raggruppandoli differentemente, conforme ai modelli di Marco o di Luca, ancora perché questo nuovo raggruppamento gli parve opportuno per l’uso catechetico. Questi criteri larghi non erano affatto inconciliabili con l’idea di «traduzione» presso gli Ebrei, come appare chiaramente da vari casi dell’Antico Testamento; per limitarsi al solo Ecclesiastico, le antiche versioni di questo libro fatte direttamente dal testo ebraico originale (sia esso, o no, quello ritrovato un quarantennio addietro) mostrano che i vari traduttori seguirono criteri d’una libertà estrema. Molto più discreto di essi fu invece il traduttore di Matteo; egli seguì criteri che, pur non essendo i rigorosi odierni, s’ispirano a quella libertà ch’era vantaggiosa allo scopo supremo della catechesi. Ma il fatto stesso che la Chiesa approvò e adottò la traduzione da lui apprestata, e che i più antichi scrittori ecclesiastici la impiegarono come testo di Vangelo canonico, dimostra che quella traduzione riproduceva in maniera «sostanzialmente identica» l’originale semitico. Troppo gelosa era la vigilanza della Chiesa per tollerare che il maestoso nome assegnato alla più antica e autorevole scrittura del suo insegnamento ufficiale, venisse attribuito a una traduzione che di quella scrittura fosse soltanto un evanescente simulacro; il rigore usato più tardi dalla stessa Chiesa contro gli scritti apocrifi, i quali parimenti si rifugiavano sotto gloriosi ma mentiti nomi e talvolta erano perfino libere rimanipolazioni di libri canonici, conferma la suddetta vigilanza abituale ed è una garanzia anche per quanto riguarda la traduzione greca di Matteo.
• § 122. L’indipendenza da un servilismo verbale, testé rilevata nel traduttore di Matteo, offre anche occasione a metter bene in luce un principio importantissimo per l’interpretazione dei racconti evangelici in genere. Troviamo, cioè, che un’eguale indipendenza dal servilismo verbale è mantenuta dagli evangelisti stessi nelle loro narrazioni, sì, da discordare verbalmente fra loro anche nel riferire testi rigorosamente fissati alla lettera ovvero parole di specialissimo valore dottrinale. [A proposito del traduttore di Matteo, dove diciamo che questi «attenuò la forza di certe frasi», proviamolo con alcuni esempi, ne bastino un paio. In Marco, 6, 5, è detto che Gesù non poteva colà fare alcuna potenza (miracolo), salvo che curò pochi malati ecc.; in Matteo 13, 58, l’espressione è attenuata, e suona : Non fece colà molte potenze, a causa dell’incredulità di quelli. Più complicato è il caso del dialogo del giovane ricco con Gesù. In Marco, 10, 17-18 (cfr. Luca, 18, 18-19), il giovane dice: Maestro buono, che cosa farò perché (io) possa ereditare (la) vita eterna? Ma Gesù gli disse: Perché mi dici buono? Nessuno (è) buono se non uno, Iddio. In Matteo, 19, 16-17 (greco) il dialogo è attenuato in questo modo: Maestro, che cosa dì buono farò perché (io) abbia (la) vita eterna? Ma egli disse: Perché mi interroghi circa il buono? Uno è il buono]. Torniamo, adesso, alla indipendenza dal servilismo verbale. Ad esempio, la tavoletta di condanna fatta apporre da Pilato sulla croce di Gesù recava senza dubbio un testo rigorosamente fissato alla lettera; eppure quest’unico testo è riportato con le seguenti divergenze verbali: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei (Giovanni, 19, 19); Costui è Gesù, il re dei Giudei (Matteo, 27, 37); Il re dei Giudei, costui (Luca, 23, 38); Il re dei Giudei (Marco, 15, 26). Più grave ancora è il caso dell’Eucaristia, istituita una sola volta da Gesù e con parole ben precise; eppure anche qui se confrontiamo la materialità delle parole, riferite sia dai tre Sinottici sia da San Paolo (I Corinti, 11), troviamo nette divergenze. Ora, tutto ciò dimostra che la preoccupazione della catechesi antica, e quindi anche degli evangelisti canonici che dipendono da essa, era la fedeltà sostanziale non già quella grettamente verbale, e che essi ricercavano l’adesione alla verità del senso non già alla materialità della lettera. Il culto della lettera materiale apparirà solo 16 secoli più tardi, quando la [cosiddetta] Riforma protestante dimenticherà che i Vangeli dipendono dalla catechesi e li giudicherà basati in maniera autonoma sulla pura lettera; ma gli evangelisti stessi, con la loro indipendenza dalla lettera, danno una formale smentita storica al giudizio della [pretesa] Riforma, e il traduttore greco di Matteo conferma questa smentita imitando gli evangelisti nella libertà verbale.
• § 123. Riguardo al tempo in cui Matteo scrisse in semitico il suo Vangelo, abbiamo un solo argomento ben certo, ma oltre a questo soltanto delle probabilità. La certezza è data dalla uniforme e costante attestazione degli antichi documenti, secondo cui Matteo fu cronologicamente il primo evangelista canonico: è quindi anteriore a Luca che fu scritto non dopo l’anno 62, come pure è anteriore a Marco scritto poco prima di Luca. Più in su di questo estremo limite abbiamo solo delle probabilità: se i molti che scrissero circa i fatti di Gesù lungo il sesto decennio trassero parecchio del loro materiale dall’opera di Matteo, come sopra supponemmo (§ 119), questa autorevole fonte deve risalire ai primi anni di quel decennio, ossia circa al 50-55. A questa conclusione sembra opporsi il noto passo di Ireneo (Adv. hær., III, 1, 1), che nel testo greco (in Eusebio, Hist. eccl., V, 8, 2) suona letteralmente cosi: Matteo fra gli Ebrei nella propria lingua di essi produsse anche una scrittura di vangelo, evangelizzando Pietro e Paolo in Roma e fondando la chiesa; quindi, dopo la dipartita di costoro, Marco, il discepolo e l’interprete di Pietro, ci trasmise anch’egli per iscritta le cose predicate da Pietro, ecc. Il tratto che riguarda Matteo contrappone la pubblicazione del suo scritto semitico alla evangelizzazione di Pietro e Paolo a Roma, e sembra ben supporre che i due fatti fossero contemporanei: quindi Matteo avrebbe scritto dopo l’inizio dell’anno 61, nel qual tempo Paolo giunse a Roma secondo il noto racconto degli Atti, 28, 14 segg. Si è tentato spiegare questo tratto supponendo che Ireneo non s’occupi ivi della cronologia, ma solo contrapponga l’operosità anche letteraria di Matteo in Palestina a quella soltanto orale di Pietro e Paolo a Roma: tuttavia la spiegazione non ha persuaso, specialmente per le limitazioni cronologiche che seguono (dopo la dipartita di costoro; ecc). D’altra parte Ireneo, ottimo conoscitore del Nuovo Testamento e delle sue origini, non poteva ignorare che anche prima dell’arrivo di Paolo esisteva a Roma una fiorente chiesa, come risulta sia dagli Atti (ivi) sia dall’anteriore lettera di Paolo ai Romani; perciò la menzione di Paolo, a proposito della fondazione della chiesa di Roma, non può essere interpretata nel senso di una rigorosa simultaneità cronologica. Ciò probabilmente offre la chiave di spiegazione. Ireneo, che abitualmente considera la chiesa di Roma come una fondazione collettiva di Pietro e di Paolo insieme, la ricorda come tale anche nel nostro passo, astraendo dalla esatta precedenza dell’uno sull’altro; egli perciò fissa la simultaneità cronologica tra la fondazione, presa in se stessa, e la composizione dello scritto di Matteo. In questa interpretazione il periodo degli anni 50-55, che assegnammo allo scritto di Matteo, sarebbe confermato, essendo appunto quello il periodo di pieno stabilimento e sviluppo della chiesa di Roma. [Torniamo, per un attimo, alla «libertà verbale degli evangelisti» ed agli errori della pretesa Riforma protestante: Già Sant’Agostino, col suo acume abituale, aveva richiamato l’attenzione su questo importantissimo criterio: «Da siffatte locuzioni degli evangelisti, differenti ma non contrarie, apprendiamo una cosa davvero utilissima e necessarissima: che cioè nelle parole di ciascuno non dobbiamo badare ad altro che all’intenzione (voluntatem), e che uno non mentisce se dice con altre parole ciò che ha voluto dire quell’altro di cui non dice le parole. Non vi siano perciò dei gretti uccellatori di vocaboli, i quali credano che la verità sia in qualche modo da incatenarsi con svolazzi di lettere, mentre certo è da ricercarsi unicamente il senso (animus), non soltanto nelle parole, ma anche in tutti gli altri segni dello spirito (De consensu evangel., II, 28)].
• § 124. L’esame interno dello scritto di Matteo conferma e schiarisce le notizie trasmesse dalla tradizione. Minuziosi e lunghi confronti, fatti recentemente e che sarebbe qui fuor di luogo riprodurre, hanno messo in luce i molti elementi tipicamente semitici, sia stilistici sia lessicali, che sono passati dal testo originale nella versione greca. Principale fra tutti è l’espressione regno dei cieli, che si ritrova soltanto in Matteo e certamente riproduce alla lettera la formula usata da Gesù in aramaico: questa espressione era sorta per la preoccupazione rabbinica di evitare l’impiego del nome di Dio, ed era perciò una sostituzione dell’espressione equivalente regno di Dio, che è la sola usata dagli altri evangelisti. Regno di Dio si trova in Marco 14 o 15 volte, in Luca 33 volte; ma occorre eccezionalmente 4 o 5 volte anche in Matteo, che è il solo ad impiegare l’altra espressione regno dei cieli (32 o 33 volte), e queste poche eccezioni all’uso costante di Matteo sono forse dovute al traduttore greco.
• § 125. Che Matteo si rivolga a cristiani provenienti dal giudaismo, risulta anche dall’indole della sua trattazione. Senza dubbio la sua mira è storica, volendo egli riferire circa la dottrina ed i fatti di Gesù; tuttavia egli fa ciò nel modo che gli appare più efficace ed appropriato per lettori che già ebbero fede in Mosè. Nel Vangelo di Matteo, più che in ogni altro, Gesù appare come il Messia promesso nell’Antico Testamento e che ha realmente adempiuto in se stesso le profezie messianiche: di qui l’assidua cura dell’evangelista di concludere molte narrazioni con l’avvertimento che ciò avvenne affinché si adempisse quello ch’è detto, ecc., riferendosi a qualche passo dell’Antico Testamento (cfr. Matteo, 1, 22-23; 2, 15.17.23; ecc.). Anche la dottrina di Gesù è presentata con riguardo speciale alle sue relazioni sia con l’Antico Testamento, sia con le dottrine e lo spirito dei predominanti Farisei. Riguardo all’Antico Testamento la nuova dottrina è, non già un’abrogazione, bensì un perfezionamento e una integrazione: solo Matteo riporta le affermazioni di Gesù ch’egli non sia venuto a disfare la Legge e i Profeti bensì a compierli e che non passi dalla Legge un solo jota o un apice fino a che tutto s’adempia (ivi, 5, 17-18). Riguardo alle dottrine dei Farisei, quella di Gesù è in antitesi perfetta: non soltanto la minaccia Guai a voi (Scribi e Farisei ipocriti!)... è ripetuta per ben sette volte in un solo capitolo (cap. 23; il vers. 14 è un riporto fatto da altrove), ma in tutto il resto di questo Vangelo l’abisso che separa le due dottrine è messo in luce più che negli altri Sinottici. Parimente soltanto Matteo fa notare che la missione personale di Gesù era rivolta direttamente alla sola nazione d’Israele (ivi, 15, 24; cfr. 1, 21), come pure che la missione preparatoria degli Apostoli mirava al solo Israele con precisa esclusione dei pagani e dei Samaritani (ivi, 10, 5-6). Perfino la designazione dei pagani gentili, dell’Antico Testamento, risente ancora nelle espressioni di Matteo di quell’inveterato disprezzo che il giudaismo aveva decretato ai non giudei, per cui «gentile» era praticamente sinonimo dell’aborrito «pubblicano» (ivi, 5, 46-47; 18, 17) e la condizione di un gentile in confronto con quella di un giudeo era come quella di un cane di casa in confronto con quella di un figlio del padrone (ivi, 15, 24-27): le quali espressioni o saranno attenuate o scompariranno presso i successivi Sinottici, che s’indirizzeranno specialmente ai cristiani provenienti dal paganesimo. Tuttavia, oltrepassata questa scorza giudaica, il Vangelo di Matteo si manifesta come rigorosamente universalistico: esso è, più che ogni altro, il Vangelo della Chiesa, come già apparve al Renan. La parola «Chiesa» è impiegata, fra gli evangelisti, dal solo Matteo (16, 18; 18, 17); e questa istituzione di Gesù è, non già riservata ai soli Giudei, ma aperta a tutte le genti che vi accorreranno numerose dall’Oriente e dall’Occidente per assidersi a mensa insieme con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli (ivi, 8, 11), e i confini di questo regno saranno i confini stessi del mondo (ivi, 13, 38): anzi i pagani gentili sostituiranno praticamente gli Israeliti nel possesso del regno di Dio (ivi, 21, 43).
• § 126. L’ordine seguito da Matteo nella sua composizione è, come già sappiamo, l’«ordinamento» sistematico gradito da Papia (§ 114). Scrivendo per lettori educati nel giudaismo, e avendo a loro riguardo uno scopo ben definito, Matteo subordina spesso a quell’«ordinamento» la consecuzione cronologica, e ricorre a procedimenti letterari ch’erano comuni nelle scuole rabbiniche e miravano specialmente a una utilità pratica mnemonica. Come egli raccoglie nei 5 grandi gruppi già visti i detti di Gesù (§ 116), così altrove riunisce in gruppi di 5, o di 7 o di 10, ma soprattutto di 3, le singole sentenze o i singoli fatti. Frequente è pure l’applicazione della legge del «parallelismo», fondamentale nella poesia ebraica, e specialmente del «parallelismo antitetico», per cui a una data affermazione si fa seguire, a guisa di conferma, la negazione del suo contrario. L’intero Discorso della montagna (capp. 5-7), cioè proprio il primo dei 5 gruppi di detti, è tutto una concatenazione di tali procedimenti letterari (§ 320). FINE.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.
























![[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1](/images/stories/virtuemart/product/resized/[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1_0x130.jpg)