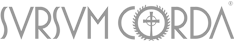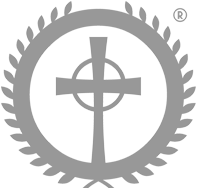Stimati Associati e gentili Sostenitori, ci eravamo salutati studiando l'approfondimento di Angelo Brucculeri S.J., «Moralità della guerra», per La Civiltà Cattolica, Roma, 1953. Riprendiamo il nostro percorso formativo dal capitolo secondo: «La necessità della guerra».
• Il primo problema, che s’impone al filosofo intorno alla guerra, è il suo rapporto con l’etica. È sottoposto l’evento bellico a valutazioni morali? Se esso è legato a cause fatali, a forze che sfuggono al dominio dell’uomo, non è possibile trattare di un diritto, di una giustizia, d’una moralità della guerra: essa è essenzialmente amorale, come è amorale la scossa sismica o la lotta delle formiche. Vi è una teoria, la teoria biosociologica, per la quale la prova del sangue fra gli Stati è una necessità di natura; ossia è una legge essenzialmente inerente alla vita sociale, legge del suo sviluppo, condizione sine qua non del suo progresso. Così nella concezione sociale hobbesiana lo stato permanente, la condizione che è normalmente imposta dalla natura all’uomo è il bellum omnium contra omnes; mentre la pace è una convenzione artificiosa, un espediente precario che si procurerà di conquistare a causa dei suoi vantaggi (Th. Hobbes, Leviathan, Londra 1885, pp. 63-65). «Come il soffio dei venti, scrive l’Hegel, preserva l’acqua del mare dalla putrefazione, nella quale la ridurrebbe una quiete durevole, così vi ridurrebbe i popoli una pace stabile e perpetua» (G. Hegel, Rechtsphilosophie, § 3124). Così ha insegnato il filosofo idealista, e il Principe di Bismarch, fedele all’insegnamento di un “tanto maestro”, nel 1891 respingeva una proposta sul disarmo, dicendo che la guerra è una legge di natura: è la lotta per l’esistenza nella sua forma generale, e finché gli uomini non diventino angeli, essa non cesserà. È questa la tesi, già assai in voga, sostenuta dal noto scrittore tedesco di dottrine militari Bernhardi, per il quale la lotta armata è un’esigenza biologica, una legge, che si svolge nel regno vegetale ed animale in un dramma muto ed incosciente, mentre fra gli uomini viene disciplinata ed inquadrata nell’ordine sociale (Von Bernhardi, Notre avenir, Parigi, p. 64). Successivamente Stegemann, nella sua voluminosa opera sulla guerra, sostiene ch’essa «fu nell’antichità il più grande propulsore delle nazioni e il loro naturale processo, al quale era impossibile il sottrarsi» (H. Stegemann, Der Krieg. Sein Wesen und seine Wandlung, già citato su Sursum Corda n° 244, vol. I, p. 3). Questa teoria anche in Italia ha trovato dei seguaci, fra i quali si segnala l’accademico Francesco Coppola. «Ogni popolo, scrive egli, ogni nazione, ogni Stato, per la legge stessa primordiale della propria vita, tende (...) a svilupparsi indefinitamente: ad affrancarsi, se è servo, a consolidarsi ed ingrandirsi, se è debole e piccolo; e, se già è forte e grande, a ingrandirsi ancora e a dominare, e col dominio a plasmare una sempre più larga parte del mondo secondo il proprio genio, la propria cultura, la propria concezione della vita, in una parola, secondo la propria civiltà». Di qui il contrasto, la guerra. «Questo che può chiamarsi il regime della libera guerra è la stessa legge della vita, è il procedimento della natura e della storia» (La pace coatta, Milano 1929, pp. 54-55). Anche Adriano Tilgher non pensava né scriveva diversamente. Nel Popolo di Roma egli così si esprimeva: «È nell’essenza più profonda dello Stato di cercare di ridurre il superiore ad uguale e l’uguale a inferiore; è nell’essenza più profonda dello Stato di tendere sempre ad una maggiore imperialità, e più lo Stato è Stato, più attua questa sua essenza. E se un giorno la guerra scomparisse del tutto dall’orizzonte, anche come semplice possibilità, quel giorno non ci sarebbero più Stati, non ci sarebbe più politica, ma semplice amministrazione» (II Popolo di Roma, 2 gennaio 1938). Questa concezione in fondo è la concezione marxista della lotta, sollevata però dal piano sociale al piano politico, dalle classi alle nazioni. Secondo il Marx le classi, elementi primigeni della società, sono necessariamente antagonistiche, e il loro cozzo fatale è la legge suprema dell’essere sociale, legge che costituisce il dinamismo perenne, il progressivo divenire, l’essenza stessa della società, giacché per il Marx, come per il suo maestro Hegel, l’essere non è che il divenire (Cfr. Doctrine communiste et doctrine catholique par le p. Ducattillon nell’opera collettiva Le communisme et les chrétiens, Parigi 1937, pp. 62-65).
• Per i bellicisti estremi le nazioni non possono sussistere e progredire, se non sono sospinte dall’essenziale loro impulso all’urto continuo, così come le classi del socialismo scientifico. Non sapremmo sottoscrivere a questa tesi per varie ragioni, che ci limitiamo ad indicare sommariamente. Primieramente il piedistallo su cui si regge, ossia il darwinismo sociale, con la legge selettiva della lotta per la vita, struggle for life, non è che una povera ipotesi, che è stata, dopo il suo quarto d’ora d’immeritata celebrità, respinta dalla scienza. Secondo questa teoria, le specie vegetali ed animali e gli stessi loro individui singoli distruggono quelli che sono inferiori nella lotta ed assicurano col sopravvento dei forti il progresso. Lo stesso avverrebbe mediante la guerra fra le nazioni: la guerra, giustiziera impeccabile, darebbe il primato a quelle che sono più dotate di forza e per questo stesso nel pieno diritto di dominare le sorelle minori. Tutta questa costruzione è in gran parte prodotto di fantasia, giacché la realtà ci attesta che le specie e gli individui anche più deboli spesso sopravvivono, mentre dispaiono talora i più forti. In ogni caso vi è fra il mondo animale e quello umano una frattura invalicabile, una differenza essenziale ed è l’elemento razionale che ci vieta di equiparare l’uomo al bruto, quasiché fossero l’uno e l’altro della stessa natura specifica. Non è possibile d’altronde, a rigore di logica, dedurre la necessità della guerra, ossia di una data lotta, per la semplice ragione che la vita sia una lotta. Dalla necessità dell’alimento per la vita, non si può sempre dedurre la necessità di un qualche determinato alimento. D’altronde la storia ci offre col fenomeno bellico anche l’inverso fenomeno del solidarismo fra i popoli, solidarismo la cui universalità e rispondenza alle esigenze sociali ha una ben netta e chiara significazione della sua natura profondamente umana. Di più, se la guerra fosse una necessità biologica delle collettività politiche, generatrice del progresso civile, essa dovrebbe stare alla base di qualcuno degli avvenimenti che hanno dato un gran balzo in avanti alla civiltà. Si sa che questa s’inizia non appena l’uomo, rinunziando al suo vagabondaggio, si fissa sulla terra per coltivarla. La civiltà sorge con l’aratro e la spiga in mano. Orbene, la scoperta degli strumenti agricoli e della cultura del suolo non è dovuta a Marte (alla guerra, ndr.). E così le altre grandi scoperte decisive per l’incivilimento, come l’alfabeto, la stampa, la pila elettrica, le Americhe e mille altre non hanno nulla a vedere, né direttamente né indirettamente, con gli scontri sanguinosi. Infine una legge biologica, qual è quella della guerra, dovrebbe riscontrarsi in uno stato cronico pressoché in tutti i popoli. Ma ciò non si è mai dimostrato, mentre si hanno prove in contrario. Se dobbiamo credere all’autore dell’opera Origine e sviluppo delle idee morali, al Westermarck, fra non poche tribù selvagge s’ignorano del tutto le costumanze guerresche. Tali sarebbero varie popolazioni della Groenlandia, dell’Australia, i Weddas del Ceylon e non poche altre (Westermarck, Origine et développement des idées morales, Parigi, tomo III, p. 342).
• Se dai primitivi passiamo alle comunità civilizzate, le guerre, ad esclusione dell’epoca moderna, sono state per lo più ad effetti limitati e ristrette a nuclei di combattenti. Le guerre di masse gigantesche sono piuttosto recenti, perché solo con gli odierni progressi tecnici delle comunicazioni e dei trasporti, si possono spostare moltitudini di uomini e quantità enormi di materiali ed armi di guerra. Gli scontri degli eserciti un tempo, se facciamo eccezione delle invasioni barbariche, si limitavano ai confini, e non veniva di punto in bianco sconvolta la vita sociale. Luigi XIV, che per vari decenni visse pressoché sempre in guerra, poteva benissimo attendere con la sua folla cortigianesca ai giochi e ai festeggiamenti continui, in cui sperperava la più gran parte del tesoro pubblico. Le guerre che paralizzano da cima a fondo l’organismo nazionale, le guerre di sterminio un tempo erano piuttosto rare. In base a queste e simili riflessioni, allo sguardo d’uno storico obiettivo la guerra appare piuttosto un fatto anormale, che l’umanità cerca sempre più di limitare, e di rendere, quand’è moralmente inevitabile, meno brutale. Di quel diritto consuetudinario, consacrato successivamente ed ampliato dal diritto positivo internazionale, con cui si vuole disciplinare l’impiego delle forze armate.
• Secondo il Bergson la guerra è naturale per la sua origine. «L’origine della guerra è la proprietà individuale o collettiva, e siccome l’umanità è predestinata alla proprietà per la sua stessa struttura, la guerra è naturale. L’istinto guerriero è sì forte che è il primo a manifestarsi, allorché si gratta la civiltà per trovare la natura. Si sa quanto i fanciulli amano di battersi» (Les deux sources de la morale et de la religion, Parigi 1934, p. 307). Può ben dirsi naturale la guerra, come potrebbe dirsi naturale, per esempio il furto, nel senso che risponde a qualche istinto della natura (corrotta, ndr.). Per l’appunto il furto risponde benissimo all’istinto del minimo sforzo, come la guerra risponde all’istinto della lotta. Ma l’istinto dell’uomo non costituisce, come nell’animale, la natura completa ed indomabile. Il fanciullo è portato di continuo a battersi, perché prevale in esso la natura inferiore, la parte animalesca; ma via via che la ragione si sviluppa, nell’età matura il suo istinto lottatore si modera, ossia si lascia a poco a poco dominare dalla parte superiore o spirituale. Ed è così che crea le leggi, i tribunali e razionalizza la lotta.
• Ma la teoria che accentua all’estremo il determinismo della guerra, è quella che ne fa senz’altro un’esigenza cosmica, una legge fisica. Quei filosofi per i quali Dio, spirito, libertà non hanno che un’esistenza nominale, non possono scorgere nella guerra che una delle tante espressioni del determinismo universale. «La guerra, scrive un cattedratico gallico, è un fenomeno, ma che l’uomo subisce istintivamente, incosciamente, né più né meno come gli animali nelle loro emigrazioni (...) Tutte le influenze cosmiche agiscono più o meno direttamente sull’uomo; ma fra quelle che ci sono note e che sono state oggetto di studio, alcune hanno una funzione preponderante, originale, fondamentale, come quelle che risultano dalle macchie solari, dalle grandi correnti magnetiche terrestri, dalla rotazione quotidiana della terra su se stessa e dal suo giro annuale attorno al sole» (Cfr. A. Eymieu, La Providence et la guerre, Parigi, 1917, p. 284). A queste influenze cosmiche e alle loro fondamentali funzioni, il materialismo è costretto a rivolgersi per spiegare la guerra. A questa stessa spiegazione parrebbe aderire un nostro scrittore, se pigliamo alla lettera una sua dichiarazione al Convegno Volta. «La guerra, ci dice Emilio Bodrero, non è un fatto politico, e tanto meno economico, ma addirittura fatto cosmico, che si produce, quando la sua necessità si scaglia sul genere umano, ed allora nessuno saprebbe impedirlo» (Atti del Convegno di scienze morali e storiche. Tema: L’Europa, Roma 1933, vol. I, p. 357).
• Per chi, come noi, respinge il monismo materialistico, nella guerra giocano degli atti liberi, soggetti quindi ad una valutazione morale. Certamente essa scaturisce bene spesso da una concatenazione di fatti che la rendono inevitabile, ma anche in questo caso non si tratta evidentemente di necessità fisica, ed in ogni modo rimane sempre, nelle sue cause, un fatto del tutto volontario, libero, turgido delle più gravi responsabilità. È questa la sola teoria che risponde al buon senso e che, per lo meno implicitamente o praticamente, è ammessa anche dagli stessi che la negano. Giacché quando costoro si appigliano alla difesa di una delle parti belligeranti e parlano del suo buon diritto e mettono in ballo la giustizia, che significato possono avere i sostantivi di diritto e di giustizia, se la guerra non differisce punto dall’urto dei flutti in tempesta o dall’incrocio delle stelle filanti nel cielo o dalla spinta istintiva di stormi d’uccelli che emigrano in date stagioni? Ma se per alcuni la guerra ha la stessa fatalità di una legge fisica o d’una imposizione dell’istinto, per altri invece la guerra è soltanto una necessità morale, ossia è una delle conseguenze ineliminabili e funeste delle passioni umane che a causa della colpa originale dell’uomo si sono disciolte dalla disciplina razionale. C’è in questo atteggiamento di pensiero qualche particella di verità, ma che non è sufficiente a convalidare l’inevitabilità del folle gioco di Marte. Che sia esso uno fra i germogli più velenosi dell’originario peccato umano, è questa una verità su cui s’impernia in buona parte il sistema dogmatico della Chiesa. Ma ciò non può affatto significare che la guerra non possa essere trionfalmente combattuta, in periodi almeno e fra popoli di una superiore cultura e d’una elevata coscienza giuridica. Anche la peste, la fame, la schiavitù, la pirateria sono in definitiva, per la concezione cristiana, sequela della colpa di Adamo, e possono essere in date condizioni storiche insopprimibili; ma non sono per se stesse, sempre, assolutamente inevitabili.
• Ciò che è inevitabile nel clima prodotto dalla prevaricazione originaria è il disordine, è il dolore in genere con qualche male singolarmente determinato, qual è la morte: ma non è già inevitabile una peculiare manifestazione del disordine o della sofferenza. L’uomo, checché faccia, non potrà mai sottrarsi al dolore; ma armato di scienza può sfuggire, come è già avvenuto, a questo o a quel dolore speciale. Alla stessa guisa la lotta fra gli aggregati politici è fatale, ma non per questo è fatale ogni specifica e concreta estrinsecazione di lotta (Cfr Stratmann, Weltkirche und Weltfriede, op. cit., p. 71). Quella, per esempio, cruenta può, a parere di studiosi egregi, eliminarsi, quale strumento giuridicamente lecito, nell’ambito, s’intende, più o meno vasto di popoli di una più vivace sensibilità morale e giuridica. In una società di Stati in cui per convenzione si eliminasse la guerra, rimarrebbe la possibilità della guerra di difesa, nell’ipotesi che uno Stato — mancando alla convenzione — aggredisse un altro Stato. Rimarrebbe inoltre la guerra di questa collettività statale contro uno degli Stati membri che venisse meno ai suoi doveri. Si noti però che in quest’ultimo caso la guerra sarebbe piuttosto una misura di polizia in grande stile. Nel primo caso la guerra di difesa sarebbe un procedimento giuridicamente lecito e formerebbe l’unica eccezione all’eliminazione della guerra in una società giuridicamente organizzata di nazioni. Come la rissa è dal punto di vista giuridico illecita nell’ambito dello Stato, eccetto nel caso in cui ci si debba difendere da un’aggressione immediata, — così la guerra diventerebbe illecita — e con la stessa eccezione— nella cerchia di una comunità di Stati giuridicamente organizzata. Ma si dirà che la storia si oppone alle nostre affermazioni ottimiste. Se s’interroga il passato, esso parrebbe attestarci che, dacché mondo è mondo, la guerra non è stata mai sloggiata dalla terra; essa sta di continuo sulla ribalta storica, dalla quale non scompare che per brevissimi periodi che hanno nome di pace, ed in realtà non sono che delle soste, delle tregue che preparano nuovi scontri sanguinosi, o meglio, sono anch’esse delle guerre in incubazione.
• Giovanni Bloch si è dato, da buon tedesco, la briga di rovistare negli angoli anche più riposti del passato, per conoscere quale proporzione vi sia tra gli anni di pace e quelli funestati dalla guerra. Mancando le statistiche dei singoli Stati, il paziente scrittore ha fatto del suo meglio per darci qualche ragguaglio complessivo sull’insieme del mondo. Egli calcola che dal 1496 a. C. al 1861 d. C., quindi nello spazio di 3357 anni, soltanto 227 anni scorsero in pace; il resto, vale a dire 3130 anni, è immerso nella guerra (Cit. dallo Stratmann, in Weltkirche und Weltfriede, cit., p. 70). La storia è dunque una guerra continua. Un parere non molto diverso professa un nostro scrittore. «Quanti millenni, si domanda egli, dobbiamo dare alla storia conosciuta dal genere umano? Diciamo dieci, diciamo sette. Ebbene, sono tutti pieni di guerre, sotto ogni cielo, per ogni popolo e stirpe» (Corradini, nel Giornale d’Italia, 7 settembre 1926). Questi attestati non possono accogliersi senza riserve non lievi. Uno sguardo complessivo sullo sterminato orizzonte di alcuni millenni storici facilmente induce in errori di prospettiva. Come osservando la via lattea si ha l’illusione di trovarla tempestata di astri, che parrebbero serrati gli uni agli altri, mentre in realtà sono separati da grandi distanze; così gli avvenimenti guerreschi mentre appaiono riempire da cima a fondo tutta la trama della storia, in realtà si dilungano più nel tempo che nello spazio, sulla totalità dei secoli ma non in quella dei popoli, giacché questi non danzano al tempo stesso la macabra danza di Marte. Se, ora non è molto, due piccole repubbliche d’America misero in moto alcune migliaia di soldati per questioni di confine, non pare che gli altri diciannove Stati transatlantici — come gli Stati degli altri continenti — si siano abbandonati allo stesso giuoco della guerra.
• La storia, ridotta alle sue dovute proporzioni, non è una ragione decisiva dell’assoluta necessità della guerra. Non vogliamo qui omettere che per alcuni la necessità morale della guerra è semplicemente ipotetica; se cioè si vogliono esercitare le virtù eroiche e dare un grande slancio in avanti al meccanismo sociale, fa bisogno la prova delle armi. Senza la guerra le nazioni si chiudono come molluschi nella propria conchiglia e non sanno altro che vegetare. Il Sombart, rinomato economista e sociologo tedesco, nel Convegno Volta, tenuto a Roma nel 1932, dichiarava che «l’avvenire è pregno di molte guerre fra gli Stati... Ma (aggiungeva) non è da rimpiangere questa sorte riservata ai nostri figli e ai nostri nepoti. Soltanto la pace nasconde dei pericoli, nella guerra invece si esercitano le nostre migliori virtù» (Atti del Convegno di scienze morali e storiche. Tema: L’Europa, cit., p. 421).
• La guerra, noi rispondiamo, può talora risolversi in un gran colpo di frusta, con cui l’uomo si sveglia dal lungo torpore, riacquista il senso obliterato della realtà e riaccende l’animo ad egregie cose. Sui solchi inaffiati di sangue non sboccia qua e là il fiore dell’eroismo? Ma sarebbe un procedimento assai fallace quello di voler determinare il valore etico della lotta armata, senza darsi pensiero del rovescio della medaglia. Tutta l’epopea della guerra, soprattutto della guerra moderna, si dissolve in sonora retorica, se si considerano i disastri e le devastazioni non soltanto di carattere materiale, ma soprattutto d’indole morale che da essa fatalmente fluiscono. «L’uomo (è definito da San Tommaso dietro le tracce di Aristotele), si sit separatum a lege et iustitia pessimum animalium, perché egli è armato non solo d’istinto, ma anche d’intelligenza, con cui eleva al massimo il potenziale esplosivo delle sue passioni» (Summ. theol., I-II, q. 95, a. 1). Appunto nello stato di guerra, l’uomo sospinto dalla violenza, dall’odio, dal panico della sconfitta e dall’orgoglio della vittoria è indotto a calpestare ogni senso di giustizia, ogni dovere d’umanità. Anche quando sono deposte le armi, le reazioni psicologiche dell’immane sforzo bellico, si manifestano nelle masse con la corsa al piacere e lo sfrenamento degli istinti peggiori. Il periodo, a cui abbiamo assistito, dopo la prima e dopo la seconda guerra mondiale, non è stato forse funestato da una profonda depressione morale della coscienza privata e pubblica, da un manifesto slittamento del costume? «Se la guerra, scrive il Folliet, permette ad alcuni di superarsi, essa fornisce alle masse le occasioni di deprimersi. La massa non va contro la corrente, ma piuttosto la segue, sia a causa della mollezza, sia a causa dell’odio e dell’invidia» (Morale internazionale, Parigi 1935, p. 60). Quanto poi al progresso che può collegarsi alle lotte cruente, è solo il progresso tecnico che sotto l’assillo della guerra riceve enorme impulso, ma non certo il progresso nella sua ampia sfera, ossia il progresso umano, che si estende in tutte le direzioni, dominate dal progresso morale, che è l’anima dell’incivilimento. Questo progresso solo nei periodi di pace trova le condizioni per attuarsi. Tutto sommato la guerra non è affatto inevitabile, perché non è una legge, ossia un effetto del peculiare determinismo biologico, né del determinismo generale del cosmo, e se talora ha una necessità morale, è solo in date condizioni storiche, in dati periodi della civiltà. Se quelle condizioni si modificano, se quei periodi si superano, anche date forme di violenza, di predominio, di sfruttamento spariscono o danno luogo a nuove forme.
• Le nazioni lotteranno sempre fra loro, giacché vi è sempre qualche divergenza d’interessi e di idee; ma la forma cruenta della loro lotta, che non è il mezzo unico, né, molto meno, certo, per il trionfo del diritto, potrà essere sostituita da forme razionalizzate e degne dell’uomo col crearsi di nuovi quadri politici. Ci si dirà che tutto ciò non è che un’utopia, perché, fra l’altro, cozza col problema demografico. Col progredire della popolazione di alcune nazioni — peggio ancora se l’aumento si avvera indistintamente in tutte — è impossibile che non si venga all’extrema ratio delle armi. «L’Europa, scrive il Bergson, è eccessivamente popolata, ben tosto lo sarà tutto l’orbe; se non si razionalizza la produzione dell’uomo, come si è cominciato a fare col lavoro, si avrà la guerra. Niente è così dannoso quanto abbandonarsi all’istinto. La mitologia antica l’aveva ben compreso, associando la dea dell’amore col dio della guerra. Lasciate fare a Venere, essa vi condurrà a Marte» (Les deux sources de la morale et de la religion, cit., p. 313). A questa obiezione, che spira d’un’aria prettamente malthusiana, rispondiamo coll’osservare anzitutto come le previsioni che più o meno presto la terra rigurgiterà di abitanti, sono ipotetiche: ossia suppongono che rimangano identiche le condizioni di ambiente e non si trovino nuovi e più redditizi metodi di coltivazione e di allevamento; soprattutto si suppone che la terra al presente coltivata sia pressappoco tutta la terra coltivabile, ciò che non è vero (...) Inoltre giocano purtroppo nella storia delle forze limitatrici della popolazione, come le passioni umane, particolarmente l’egoismo, che arresta o diminuisce all’estremo la prolificazione. Se stiamo non nell’astratto, ma nel concreto, se osserviamo che Venere non è l’unica passione dell’uomo, potremmo affermare che Venere più che ai conflitti delle armi porta al regresso demografico ed allo spopolamento. Intere civiltà sono disparse sotto i colpi del vizio, nessuna per ora a causa della sovrappopolazione. Ancora è ben lontano, ad eccezione di qualche popolo, il limite relativo di saturazione demografica, tanto più poi il limite assoluto. Anche oggi ha il suo valore il suggerimento biblico Replete terram et subiicite eam (Gen., I, 28).
• L’uomo si può moltiplicare e riempire la terra, purché la riduca al suo pieno potere. Se l’uomo cercherà di dominare sempre più la terra con l’emigrazione, con la colonizzazione, con la bonifica, con la generale applicazione delle scoperte tecniche, con l’organizzazione della distribuzione, non avrà a temere della sovrappopolazione, almeno per molto tempo ancora. Se i miliardi che s’impiegano negli armamenti o nelle guerre, fossero impiegati in opere produttive, nella conquista di tanta parte del suolo incolto, nel miglioramento delle culture agricole, nel valorizzare un gran numero di risorse, che pur giacciono sterili nella terra e nel cielo, nel favorire nuove invenzioni e progressi, l’umanità potrebbe procedere innanzi per molto tempo ancora senza alcuna preoccupazione malthusiana. (Cfr A. Brucculeri, Sul problema di Malthus, Roma 1928).
• Se la guerra non è una fatalità sottratta alla libertà dell’uomo, come abbiamo dimostrato nel capo precedente; se essa dunque ha un necessario rapporto con l’etica, qual è questo rapporto? Per alcuni è un rapporto di assoluta opposizione: la guerra è in se stessa sempre ingiusta, intrinsecamente inconciliabile con la norma etica. Per alcune sette ereticali come i manichei, i viclefiti, i quaccheri, come per i seguaci del pacifismo estremo, l’urto bellico è sempre illecito, perché essenzialmente immorale. Di qui la comoda teoria della non resistenza al male (Sulle concezioni del pacifismo V. Barthélemy de Light, Mobilitation contre la guerre, Parigi 1934. Dello stesso autore: La paix creatrice, due volumi, Parigi 1935). Per altri, invece, per gli idolatri della forza, la guerra è in se stessa moralmente bella e sacrosanta. «Voi, dite, scrive il Nietzsche, che la buona causa santifica persino la guerra. Ed io vi dico: la buona guerra santifica ogni causa. La guerra e il coraggio hanno operato cose più grandi che non l’amore del prossimo» (Così parlò Zarathustra, Parte prima: I discorsi di Zarathustra. Della guerra e dei guerrieri). Non mancano coloro che hanno addirittura divinizzato la guerra sotto i suoi vari aspetti, non escluso il furore belluino con cui si scaglia il soldato contro il nemico. II De Maistre, nel settimo intrattenimento delle Soirées de Saint-Pétersburg, scrive con solennità stilistica: «La guerra è divina in se stessa, perché è una legge del mondo. La guerra è divina per le sue conseguenze supernaturali (...) La guerra è divina nella gloria del mistero che la circonda (...) La guerra è divina per la maniera con cui si intima». Un po’ prima scrive: «L’uomo, invaso tosto d’un furore divino, estraneo all’odio ed alla collera, s’avanza sul campo della battaglia senza nemmeno sapere ciò ch’egli stesso vuole, né ciò ch’egli fa». Continuando l’apoteosi della guerra, aggiunge: «Se si getta uno sguardo sulla funzione che esercita nella guerra la moralità, bisogna pur consentire che in nessun’altra maniera, come nella guerra, si fa sentire sull’uomo la mano di Dio» (tomo II, Aversa 1821, pp. 23, 26, 31). Sul valore di questa divinizzazione della guerra fatta dal grande savoiardo si legga lo studio del p. Yves de la Brière nel volume: Église et paix, Parigi 1932, ovvero nel volume Le droit de juste guerre, Parigi 1938.
• Il cattolicesimo respinge queste due teorie e, pur abborrendo ogni e qualsiasi guerra, sostiene una tesi mediana: la guerra non è per la sua intima essenza un male morale, non ha una necessaria ripugnanza con la razionale natura umana, in date condizioni può ben comporsi con la norma etica. Le prove di ciò sono varie e decisive. Alcune si hanno nei libri sacri, sia dell’Antico come del Nuovo Testamento. Nel Genesi si parla della guerra del popolo eletto, e si plaude ad Abramo e si benedice Dio, quo protegente, i nemici sono caduti in mano di Abramo (Gen., XIV, 19-20). Dio stesso aveva ordinato a Mosè, a Giosuè, a Gedeone, a Sansone, a Davide, ai Maccabei e ad altri personaggi biblici di fare la guerra. Anche il Nuovo Testamento, sebbene esso promulghi una legge di amore ed insista, più che non si faccia nell’Antico Testamento, sull’attributo divino della bontà e della misericordia, in definitiva non si scosta, sul problema della moralità della guerra, dalla concezione ammessa nei più antichi testi sacri. Senza dubbio, alcuni passi evangelici parrebbero opporsi alla tesi della liceità della guerra. Ricordiamo i principali: Converte (disse Gesù Cristo a San Pietro) gladium tuum in locum suum: omnis enim qui acceperit gladium, gladio peribit (Mt., XXVI, 52) - Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. In base a queste parole Tertulliano pensa che Gesù Cristo abbia voluto disarmare tutti i soldati (De idololatria, XIX). Anche più recentemente critici piuttosto superficiali non hanno trovato in Gesù Cristo che un pacifista assoluto, Leone Tolstoi osa insegnare: «Il soldato può essere e deve essere il soldato di Cristo; egli sarà tale non già ubbidendo ai capi che lo preparano all’assassinio (...) ma solo se nel nome di Cristo, egli respingerà la condizione empia e vergognosa di soldato; sarà guerriero di Cristo se combatterà non il nemico esterno ma quello interno, che inganna lui e i suoi fratelli, e lo combatterà non con la spada, il pugno o i denti, ma con la ragione e la dolcezza; se subirà tutte le sofferenze ed anche la morte, anziché fare il soldato, ossia l’uomo pronto ad uccidere tutti quelli che gli saranno indicati dai suoi capi» (L. Tolstoi, Appel aux dirigeants, Parigi 1902, p. 100). E tra noi (l’eresiarca) Murri, atteggiandosi a critico autentico del Vangelo, trovò in esso la condanna assoluta della guerra, «che è la più evidente manifestazione, e quindi la più riprovevole (...) del regno di Satana in opposizione al regno di Dio (...) Uccidere essendo cristiani, avvicinarsi alla mensa dell’amore alla vigilia di una carneficina da compiere, ecco ciò che nessuna potenza di Chiesa riuscirà mai a fare accettare dal critico sereno del pensiero autentico di Gesù» (La croce e la spada, Firenze, p. 71).
• Eppure, con buona pace degli antichi e nuovi critici, il pensiero di Gesù Cristo nella sua interezza non ha il contenuto antibellicista che gli si vuole attribuire. Gesù Cristo infatti parla della spada che si brandisce per privata autorità (Cfr. S. Agostino, Contra Faustum, XXII, 70-74; Migne, P.L., 42, 444-447). «Non è senza ragione, dice San Paolo, che il principe porta la spada, giacché egli è il ministro di Dio, per eseguirne le vendette contro coloro che fanno il male» (Rom. XIII, 4). Ego autem vobis dico non resistere malo (Mt., V, 39). In questo detto ed in altri consimili, dice San Tommaso (Summ. theol., II-II, q. 40, a. 1), si parla di disposizioni d’animo; all’uopo si deve esser pronti a rinunziare alla propria difesa; nel fatto bisogna talora difendersi. È certo che lo stesso Gesù Cristo che disse di offrire la guancia a chi ci percuote nell’altra, si difese contro il soldato che lo aveva schiaffeggiato di fronte ad Anna. Anche San Paolo si difese quando fu battuto per ordine del capo dei sacerdoti. Va poi notato che questi speciali consigli del Redentore riguardano la santificazione degli individui, non furono rivolti alla società. — Nel Vangelo, va rilevato, il Battista fa delle raccomandazioni ai soldati, ma non riprova la loro professione militare (Lc., III, 14). Due centurioni, benché uomini di spada sono lodati come esemplari cristiani (Mt., VIII; Act., X). In genere Gesù Cristo appare nel Vangelo ossequente al potere costituito e alle pubbliche istituzioni. Non si può affatto dimostrare che egli condanni il diritto di spada, quasi fosse l’impiego delle armi per se stesso immorale (Cfr Yves de la Brière, Le droit de juste guerre, cit., p. 12).
• Un’altra prova non meno convincente di quella scritturale, è quella fondata sul diritto di natura, diritto che con tanta leggerezza oggi si nega o si confonde con la sua degenerazione del giusnaturalismo; diritto frattanto, che è stato riconosciuto dalla legislazione romana fino ad ammettere la sua prevalenza sullo stesso diritto positivo. Nel Digesto infatti si proclama questo principio: Nec enim naturalis ratio auctoritate senatus commutari potuit. È proprio questo diritto di natura che propugna con l’adesione della coscienza universale il principio che è permesso, e talora doveroso, rigettare l’ingiusto aggressore con la forza, servato tamen moderamine inculpatae tutelae. Cicerone doveva con la sua fastosa eloquenza illustrare questo principio, su cui si regge la sana concezione del diritto di guerra. « È questa una legge non scritta, ma naturale, che noi non abbiamo imparato, ricevuta o letta; ad essa non siamo stati istruiti, ma fatti; non addestrati ma impregnati; e dice questa legge che se noi ci trovassimo nella necessità di salvare la nostra vita da agguati, dalla violenza o dalle armi di briganti o di nemici, potremmo difenderla con ogni mezzo onesto. E questa la ragione ha insegnato ai colti, il bisogno ai barbari, la consuetudine ai popoli e la stessa natura agli animali (...)».
... prosegue la prossima settimana ...



























![[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1](/images/stories/virtuemart/product/resized/[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1_0x130.jpg)