Bibbia e non Bibbia, ab. G. Ricciotti, Morcelliana, Brescia, 1935. AIT DOMINUS?, parte 2. Dio non vede tutto? Non legge Egli distintamente nel nostro cuore, scoprendovi anche ogni debolezza umana e quanto vi può essere di minimamente imperfetto? Senza dubbio; ed è appunto ciò che vuole esprimere il salmista - stando ad uno scrittore moderno - allorché esclama verso Dio: Imperfectum meum viderunt oculi tui (Salmo 138 [ebr. 139], 16). Il salmo è fra i più sublimi del Salterio, e tratta in realtà dell’omniscienza di Dio. Tuttavia l’interpretare in quel senso il versetto citato non è che un’ammissibile accomodazione. Il termine imperfetto corrisponde infatti all’ebraico golem ed ha un senso fisico, «cosa incompiuta», «organismo imperfetto»; significa cioè l’embrione, il feto immaturo. Il salmista vuol dire che gli occhi di Dio lo hanno scorto anche quando egli era un «embrione imperfetto» nel seno di sua madre, là dove gli occhi dell’uomo non potevano giungere. Il senso di imperfezioni spirituali è quindi estraneo al testo. Anche i fervorosi della cristiana perfezione hanno i loro periodi di tenebre e di aridità; le biografie dei santi insegnano. In quei periodi l’ardente desiderio di Dio, che già infiammava l’anima, sembra spegnersi; non si sente più il bisogno di Lui, né si avverte più quello che sant’Agostino chiamava il pondus dell’amore che fa precipitare l’anima su Dio. In tal caso gli autori ascetici consigliano di insistere ancora nel desiderio di Dio; se non sarà un desiderio spontaneo, sia un desiderio riflesso, cioè provocato dalla considerazione che Dio è necessario all’anima e perciò questa deve desiderarLo. Insomma, un desiderio di desiderio. Consiglio eccellente in sé. Tuttavia esso non è fondato - come crede poter asserire un autore ascetico - sul passo Concupivit anima mea desiderare iustifcationes tuas, in omni tempore (Salmo 118 [ebr. 119], 20). Non si tratta qui di un «desiderio di desiderio», per cui David nei periodi di aridità avrebbe bramato per riflessione di desiderare Dio, come faceva spontaneamente nei periodi di fervore. È invece una semplice espressione semitica, che indica l’intensità dell’azione; noi potremmo tradurla l’anima mia anela di desiderio verso i tuoi decreti in ogni tempo; anzi se vogliamo essere un po’ meno fedeli alle parole, ma più esatti nella riproduzione del concetto, dobbiamo tradurre, come fa la versione del Pontificio Istituto Biblico (A. Vaccari, I libri poetici della Bibbia, Roma 1925, p. 187), io mi consumo dal desiderio ecc., sostituendo cioè il pronome io all’ebraismo anima mia, a motivo della corrispondenza che già facemmo osservare. Il passo del Salmo 42 (ebr. 43), 4: Introibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat iuventutem meam, ha commosso molti cuori. Dio è il naturale padrone di qualunque età della vita umana, dalla prima fanciullezza alla più estrema vecchiezza: ma quanto è indecoroso ricordarsi di Lui solo quando le forze vengono meno e la vita già sfugge! Dio, certo, accoglie anche gli operai dell’ultima ora, ma ci invita fin dal principiare della giornata: nella Sua misericordia accetta anche il tramonto umano, ma per il nostro bene ci chiama fin dall’aurora. E qual cosa è più nobile e più vantaggiosa per l’uomo che offrire a Dio in letizia l’aurora della propria vita, cioè la propria giovinezza? Egli, dunque, è veramente il Deus qui laetificat iuventutem meam. Ecco un motto che è per se stesso un programma, anzi il programma più nobile che un giovane possa prefiggersi. Esso quindi assai frequentemente viene stampato nelle immaginette che i sacerdoti novelli distribuiscono in occasione della loro prima Messa: anzi, in tal caso, corrisponde bene tutto il versetto, giacche la prima parte Introibo ad altare Dei, ricorda il nuovo sacerdote che per la prima volta si appressa all’altare di Dio, e la seconda parte qui laetificat iuventutem meam ricorda la sua giovinezza consacrata con letizia al Signore. Se, domani, un sacerdote novello venisse a chiedermi un motto da fare stampare sulle sue immaginette, probabilmente anch’io gli proporrei questo del Deus qui laetificat iuventutem meam: è così bello e così generoso! Ma nello stesso tempo lo avvertirei che quel motto, in realtà, proviene da una alterazione della «lettera di Dio», la quale in origine diceva diversamente. Infatti il testo ebraico di quel passo è il seguente: E verrò all’altare di Dio, al Dio della gioia della mia esultanza, e ti celebrerò sulla cetra, o Dio, Dio mio! Così infatti legge anche il testo aramaico del Targum; mentre il testo della Vulgata latina, come pure quello della siriaca Pescitta, dipende dal greco dei Settanta, il quale in realtà ha Dio letificante la mia giovinezza. Tuttavia anche il testo ebraico può destare qualche sospetto di aver sofferto una piccola alterazione, perché è alquanto strana l’espressione della gioia della mia esultanza né la metrica del passo sembra ben sicura; perciò, con una minima correzione, si potrebbe tradurre: E verrò all’altare di Dio, al Dio della mia gioia; ed esulterò e ti celebrerò sulla cetra, o Dio (Jahvé), Dio mio! La versione del Pontificio Istituto Biblico (p. 108) traduce in sostanza proprio così; non ha giovinezza, e legge il verbo (non il sostantivo) esultare. Quant’era soave e piena di serena pace quella chiesetta alpina, quasi nascosta in un canalone dolomitico, con la bianca guglia del suo campanile elevantesi come un grido di preghiera d’in mezzo al bosco nero! V’entrammo, dopo una lunga peregrinazione fra i monti, io ed un mio amico, per ristorarci insieme lo spirito e il corpo; dall’alzata dell’altare maggiore una statua di Maria Immacolata, tra uno scintillio di luci e di fiori, riguardava dolcemente e spargeva le sue benedizioni sul popolo che La festeggiava. Cessarono i canti, soffusi di tenerezza montanina, e il parroco salì sul pulpito a celebrare le lodi della Festeggiata. Conforme all’uso tedesco, l’oratore cominciò col citare il passo che aveva scelto a tema della sua predica, e fu: Non est caput nequius super caput colubri: et non est ira super iram mulieris (Ecclesiastico, 25, 22-23). L’applicazione del passo, che si protrasse per tutta la predica, procedette sempre più spontanea. Dall’alto la statua dell’immacolata, mentre riguardava benigna i fedeli, schiacciava pure la testa d’un multicolore serpente disteso ai suoi piedi e avvolgente con le sue spire schifose il globo terracqueo. Nessuna testa era stata dannosa al mondo intero - spiegava il buon parroco - più che la testa di quel maledetto serpente; ma per misericordia divina quella testa era stata schiacciata dallo sdegno della Donna Immacolata, giacché prima di Lei non era mai apparso sul mondo uno sdegno più santo e più vittorioso di quello mostrato da Lei contro il serpente infernale. La parola del vecchio parroco era semplice, mite, suasiva; scendeva al cuore, in forza della trasparente bontà di chi la pronunciava, e vi suscitava un desiderio di bene che trascendeva l’efficacia di ogni dialettica. E così, anche noi due pellegrini ci allontanammo dalla chiesetta rinfrancati nello spirito, e conservando negli occhi e nel cuore la visione della Donna che nel santo suo sdegno schiaccia la testa più infame. Tuttavia alcuni giorni dopo, quando ne avemmo la possibilità, andammo a riscontrare il passo preso a tema della predica, per vederlo illustrato autenticamente dal suo stesso contesto divino, meglio che da una pia statua. Ne cercammo il testo greco, lo confrontammo con la versione siriaca (dato che i frammenti ebraici non hanno il passo), consultammo i migliori commentatori cattolici moderni, e concludemmo che andava tradotto: [Come] non c’è veleno peggiore del veleno del serpente, [così] non c’è rabbia peggiore della rabbia della donna. Era insomma una delle tirate, non rare nella Bibbia e specialmente nell’Ecclesiastico, contro le donne sgraziate e maligne. Tant’è vero che segue immediatamente: Preferirei abitare con un leone o un dragone, anziché abitare con una donna cattiva. La cattiveria d’una donna le trasforma l’aspetto, e le oscura la faccia come quella di un’orsa ecc. O pace soave della chiesetta alpina, dove avevamo ammirato ed amato la Donna Immacolata, senza ricorrere al testo greco, a quello siriaco ed ai frammenti ebraici! La Bibbia infatti parla spesso delle donne. (Parecchie volte ho pensato che, se un giorno sarò libero da lavori più noiosi, farò una raccolta dei passi biblici sulle donne, opportunamente schiariti; si ripromette un libretto molto più interessante e piacevole di tanti che vanno per i salotti delle signore). Delle donne sagge e per bene la Bibbia parla con franca lode. Basti ricordare il noto cantico della Donna Forte contenuto in Proverbi 31, ed usato anche dalla Chiesa per esaltare le maritate proclamate sante. In quel cantico però, come suona nella Vulgata latina, c’è un intoppo grave proprio a principio. Esso comincia: 10. Mulierem fortem quis inveniet? Procul et de ultimis finibus pretium eius. 11. Confidit in ea cor viri sui, Et spoliis non indigebit etc. Ora, che senso si può ricavare dal secondo emistichio, con quel suo procul et de ultimis finibus? Nessuna difficoltà per il pretium: è la dote che presso gli Ebrei - al contrario che presso di noi - era pagata dallo sposo al padre della sposa; ma che senso ha il dire che questa dote matrimoniale è procul et de ultimis finibus? Il senso non corre, e sorge spontaneo il sospetto che ci sia stato un guasto. Se infatti ricorriamo all’originale ebraico (il vecchio consiglio che ci ha dato sant’Agostino!), non solo troviamo un senso giusto, ma scopriamo anche la maniera come è sorto il senso guasto della Vulgata. L’ebraico ha nel passo disputato, oltre che «pĕnīnīm» il prezzo di lei, cioè la dote di una donna saggia non si può adeguatamente pagare neppure con «pĕnīnīm», significhi questo vocabolo «perle» come ritiene il più dei moderni, ovvero «coralli» come con qualche altro io preferisco credere. San Girolamo, nel tradurre in latino, ha avuto evidentemente sotto gli occhi un codice difettoso, ove un copista sbadato, invece che pĕnīnīm, aveva scritto panīm, saltando una n (si ricordi che l’ebraico antico scriveva le sole consonanti). Ed ecco che san Girolamo ha tradotto panīm regolarmente con finibus, aggiungendovi un ultimis per cercare di dargli qualche senso con una specie di perifrasi: ma è stato incolpevole vittima dello sbadiglio - com’egli direbbe - d’un copista. ...
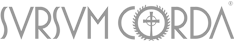
Organizzazione di Volontariato (O.D.V.)
C.da Piancardillo, snc - 85010 Pignola
Provincia di Potenza (ITALIA)
Redazione: editoria@sursumcorda.cloud
Donazioni: paypal@sursumcorda.cloud
Conto Postale n°
Iban:
Intestato a: Sursum Corda
Sursum Corda® - C.F. 01944030764
Prefisso Editore ISBN: 978-88-900747
Codice del Settimanale ISSN: 2499-6254 (Print)
Codice del Sito ISSN: 2499-6912 (Web)
Autorizzazione del Tribunale di Potenza:
Num. R.G. 281/2016 - N. R. Stampa 464
Direttore responsabile: Carlo Di Pietro
Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione: 26372/23.03.2016
Settimanale Sursum Corda®: Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% S1/PZ/1726 - Per associarsi cliccare qui
Libri di Sursum Corda®: Poste Italiane SpA - Tariffa ridotta Pieghi di Libri - Autorizzazione n° TRE/SMA/S1/01782/04.2016
Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato (settori Sociale e Culturale): 13AU.2017/D.00198 del 30/03/2017
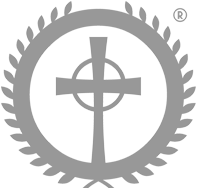













![[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1](/images/stories/virtuemart/product/resized/[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1_0x130.jpg)
